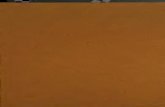Un frammento autografo dell’Ulisse di Giovan Battista della Porta
Frammento di sarcofago da Gioiosa Jonica
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Frammento di sarcofago da Gioiosa Jonica
NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE
La prima edizione del volume ‘Sculture da Locri Romana’ è stata promossa nel 2011 dal Rotary Club di Locri, come cadeau a tiratura limitata in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dalla fondazione.
L’interesse dell’opera, che raccoglie per la prima volta in un catalogo tutte le sculture conosciute di età romana provenienti da Locri e dal suo territorio, alcune finora mai presentate al pubblico, ha spinto l’editore Franco Pancallo a promuovere questa seconda edizione, che ha consentito un certo numero di precisazioni, aggiunte e talora correzioni (anche delle illustrazioni), inserite dagli stessi studiosi che licen-ziarono la prima edizione. Resta immutata la struttura del volume.
Un vivo ringraziamento va alla dott.ssa Simonetta Bonomi, Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria, e alla dott.ssa Rossella Agostino, Direttore del Museo Nazionale di Locri Epizefiri, per aver concesso ed agevolato in ogni modo lo studio e la pubblicazione dei materiali posti sotto la loro tutela, nonché a tutto il personale dei Musei di Reggio Calabria e di Locri.
Particolare gratitudine va alla famiglia Scaglione di Locri, alla sig. Natalina Belluzzi e al sig. Dante Totino di Gioiosa Jonica, all’avv. Francesco Mario Macrì di Marina di Gioiosa Jonica, al dott. Carlo Marconi di Roma e all’avv. Domenico Romeo di Siderno.
Come già detto, questo volume non avrebbe potuto essere senza il generoso sostegno del Rotary Club di Locri, che oltre ad aver promosso l’opera ha contribuito alla campagna fotografica delle sculture in essa raccolte.
Avvertenze:Delle sculture in catalogo viene data una scheda sintetica in cui sono indicati il materiale
impiegato, le dimensioni espresse in cm, la datazione, il luogo di provenienza, il luogo di conservazione con numero d’inventario e la bibliografia di riferimento, se il pezzo è edito; quindi un testo di descrizione e commento dell’opera, con riferimento alle fotografie. Nella descrizione delle figure con destra e sinistra si intendono quelle della figura stessa; se non riferite a parti di figure si intendono quelle dell’osservatore.
SCULTURE da
LOCRI ROMANAa cura di
Eleonora Grillo
TestiMassimo CardosaEleonora Grillo
Marilisa Morrone NaymoClaudio Sabbione
con un saggio“L’eredità di Locri nel Medioevo. La Cattedrale di Gerace” di Attilio M. Spanò
FotografieAntonio Sollazzo: figg. 4-10, 12-15, 17-42, 45, 49-51, 53-77, 86-91
Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria:figg. 1-3,11, 16, 48, 52, 79, 112
© Copyright per le immagini: Soprintendenza per i Beni Archeologici della CalabriaVincenzo Cataldo: figg. 98-105
Margherita Milanesio Macrì: figg. 43-44, 47Marilisa Morrone Naymo: figg. 92-97, 107-112
Vincenzo Naymo: figg. 83-85, 1090Attilio M. Spanò: figg. 113-129
Immagine di copertina: Antonio SollazzoImmagine sul retro: Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
Proprietà letteraria riservata
©by Franco Pancallo Editore - Locri- ItalyVia Mercurio, 1 / Corso V. Emanuele, 71Tel. - Fax 0964.29168e-mail: [email protected]: www.francopancalloeditore.it
Stampato in proprio
5
Sommario
Presentazione G. Monteleone pag. 7Introduzione P. Sansalone » 9Premessa R. Agostino » 11
TesTimonianze di eTà romana nella locride C. Sabbione » 15
sculTure dall’area urbana di locri • Il ‘togato di Petrara’ E. Grillo » 29• Frammento di base di statua di personaggio togato E. Grillo » 39• Frammento di testa femminile E. Grillo » 41• Piccolo busto femminile acefalo E. Grillo » 43• Frammento di piccola statua (mano) E. Grillo » 43
rinvenimenTi anTiquari• Torso maschile del tipo ‘Hermes Richelieu’ C. Sabbione » 47• Torso maschile con corazza di tipo ellenistico C. Sabbione » 54• Testa ritratto dell’imperatore Claudio C. Sabbione » 62• Figura femminile stante acefala, del tipo dell’ ‘Orante’ M. Cardosa » 68• Sarcofago strigilato di Caius Octavianus Crescens C. Sabbione » 70• Testa maschile con berretto frigio M. Cardosa » 72• Piccola statua di Serapide in trono E. Grillo » 73• Parte inferiore di statua femminile panneggiata E. Grillo » 76• Figura maschile stante (Dioniso?) M. Cardosa » 77• Peploforos (Demetra?) del tipo ‘Cariatide dell’Eretteo’ M. Cardosa » 79• Cippo iscritto dei Locresi M. Morrone Naymo » 80
sculTure dal TerriTorio di locri• Figura femminile (Kore?) del tipo ‘Abbondanza Grimani’ da Marina di Gioiosa Jonica M. Cardosa » 85• Ara circolare frammentaria M. Morrone Naymo » 87• Frammento di sarcofago da Gioiosa Jonica M. Morrone Naymo » 88• Sarcofago con scene pastorali e ritratto clipeato da Ardore C. Sabbione » 91
marmi romani nel TerriTorio di locri, dopo locri M. Morrone Naymo » 95
l’erediTà di locri nel medioevo. la caTTedrale di Gerace Attilio Spanò » 105
Bibliografia » 119Tavole » 127
88
Frammento di sarcofago da Gioiosa Jonica (RC)
Marmo biancoAlt. cm 10,5; largh. cm 8/8,2; spess. alla cornice cm 5; spess. alla frattura del rilievo cm 8; alt. della testa cm 6,5Tarda età antonina - inizi III sec. d.C. Da Locri? Da Marina di Gioiosa Jonica?Conservato in casa privata a Gioiosa Jonica (RC)
Si tratta della parte superiore di una lastra frontale di sarcofago (Figg. 83 – 85), con una traccia della cornice sommitale; nel frammento, a forma di parallelogramma, si conserva una te-sta di uomo adulto, barbato, vista di tre quarti, che volge lo sguardo verso sinistra, verosimil-mente verso il centro della composizione; la te-sta è tangente ad un lembo di panneggio perti-nente ad un mantello, che sfiora il volto dell’uo-mo (Fig. 83). La capigliatura e la barba sono realizzate con l’uso del trapano corrente; le cioc-che, tirate all’indietro lasciando scoperta l’ampia fronte solcata da due profonde linee orizzontali, sono rese in forte chiaroscuro da profonde e ben scandite occhiellature. Anche il panneggio del mantello è reso con larghe pieghe profonde e scanalate che producono un marcato effetto chiaroscurale. L’espressione del viso è intensa, lo sguardo penetrante con le orbite ben disegna-te e le iridi profondamente scolpite; gli zigomi ben pronunciati e la bocca evidente, sottolineata da una piega sul mento che accentua l’effetto chiaroscurale di tutto il volto. Il soggetto non è del tutto determinabile per la scarsezza delle figure rimanenti, ma si può senz’altro affermare che si tratta di una scena dinamica, dove forse un personaggio a cavallo con un mantello do-minava la fronte del sarcofago; dalla posizione decentrata non sembra che il personaggio effi-giato sia il defunto, ma si tratta sicuramente di un personaggio che viene raffigurato come do-tato di una certa personalità.
I particolari tecnici della scultura, l’effetto altamente pittorico ed ‛illusionistico’ del pezzo riconducono alla tarda età antonina-età seve-riana ed oltre, a quella fase della produzione scultorea romana che si vuole indicare come “barocca”1. Il pezzo si inquadra nella produ-zione micro-asiatica e in particolare in quella corrente artistica che fa capo al “Maestro di Marco Aurelio”, ovvero all’ignoto realizzatore dei rilievi reimpiegati nell’Arco di Costantino2. Il rilievo trova una serie di confronti con sar-cofagi datati tra la fine del II secolo e la prima metà del III. Il sarcofago con il mito di Fedra dei Musei Vaticani, datato al 220 d.C.,3 è simi-le nel rilievo delle teste, non completamente emergenti dal fondo, nell’uso del trapano cor-rente e nelle pieghe dei pepli ben scandite e morbide. Il sarcofago di Teseo che abbandona Arianna a Nasso, conservato a Cleveland ma proveniente da Roma, datato al 240 d.C.4, pre-senta il trattamento dei panneggi e della capi-gliature con identica tecnica. L’effetto chiaro-scurale dei capelli e della barba, in cui risalta il virtuosismo del trapano, viene enfatizzato ampiamente nel celebre sarcofago dei fratelli, del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, datato al 250 d.C. circa5, che però presenta i personaggi molto emergenti dal fondo del sar-cofago ed un linguaggio esasperato, sfociato nel barocchismo tipico degli esiti ultimi dell’ar-te antonina nell’età severiana e più avanti.
Le circostanze del ritrovamento6 del pez-
1. bianChi bandinelli 19693, p. 316.2. Ivi 19813 , p. 314 sgg.3. zanke-edward 2008, p. 224, fig. 202.4. Idem 2008, p. 46, fig. 31.5. Idem 2008, p. 187, fig. 169.6. Il frammento, custodito nel luogo stesso di rinvenimento, è stato individuato nel 1997 da chi scrive e da Vincenzo Naymo, su segnalazione della proprietaria della casa dove fu rinvenuto,
89
zo, non consentono di inquadrare esattamente la sua provenienza, per una serie di motivi. La lastra fu trovata rovesciata e adagiata sul piano di calpestio dei bassi del palazzo Barlaro7, che sono ricavati nelle mura di cinta quattrocente-sche del centro medievale di Gioiosa Jonica, arroccato sulla rupe a strapiombo sul Fiume Gallizzi8.
Risulta molto complicato stabilire con esattezza se si tratti di un reimpiego o di un semplice deposito in questo magazzino, avve-nuto in tempi più o meno remoti; tuttavia si possono al proposito formulare alcune ipotesi che, pur gettando luce sulle modalità del rinve-nimento, ne complicano ulteriormente l’inqua-dramento della provenienza primaria.
Nella cinta muraria di Gioiosa, che allo stato attuale si conserva alla base delle case svi-luppatesi su di essa nel corso dei secoli9, non è raro rinvenire materiali archeologici eterogenei, anche reimpiegati in secoli più prossimi a noi, ma con tutt’evidenza provenienti da sterri ef-fettuati in loco10. Si tratta di frammenti ceramici
sig.ra Natalina Belluzzi. Successivamente è stato oggetto di una comunicazione del prof. Felice Costabile nell’ambito di una con-ferenza pubblica tenutasi a Gioiosa Jonica nel 2003. Per la limita-tezza del tempo a disposizione per la stesura del presente saggio, non è stato possibile uno studio approfondito e maggiormente documentato del pezzo, come esso avrebbe meritato. Ci si ri-serva di farlo successivamente, dandone in questa sede soltanto una lettura preliminare ed una ricostruzione delle vicende del suo ritrovamento.7. Questo palazzo, di origine medievale, fu alienato negli anni ’50 all’attuale proprietaria.8. La cinta muraria di Gioiosa fu edificata tra il 1439 e il 1452, per proteggere l’abitato sorto sulla parte alta della rupe, intorno al Castello nato tra XIII e XIV sec.; dopo tale edificazione, il centro assunse il nome di Motta Gioiosa: naymo c.d.s. 9. Nei vani situati ai piani terreni e seminterrati di queste case e palazzi, si conservano ancora ben individuabili, interi tratti della cinta con i camminamenti. 10. Ormai da anni svolgo ricognizioni sulla cinta muraria, volte allo studio di essa, durante le quali ho avuto modo di classificare la tipologia di strutture e materiali presenti in essa.
o laterizi, a volte veri e propri butti accumula-ti nei piccoli orti sorti a ridosso della cinta nel lato est, oppure frammenti architettonici me-dievali o anche tardo-antichi11. Alla luce di ciò, la circostanza del rinvenimento del frammen-to di sarcofago, dunque, sembra avere una sua spiegazione come reimpiego, se non fosse che, però, a Gioiosa si verificò tra gli anni ’40 e ’50, un fenomeno particolare che investì una delle collezioni di antichità più cospicue della zona.
Nel primo ventennio del XIX secolo a Gioiosa si svolse l’attività di Francesco Anto-nio Pellicano12, rampollo di una delle famiglie maggiorenti del centro. Egli fin da giovanissi-mo coltivò l’amore per le antichità, forse anche scaturita dai continui rinvenimenti che si sus-seguivano nei fondi della sua famiglia a Marina di Gioiosa, a Locri, anche nella stessa Gioiosa, nell’area del Naniglio13. Ma l’impulso maggiore alla ricerca gli venne dalla acquisita familiari-tà con il conte Vito Capialbi di Monteleone14,
11. Di recente ho individuato una cospicua quantità di frammenti ceramici medievali e moderni, murati ai primi del’900 in una sca-letta situata all’esterno della Cinta muraria, nel palazzo Ripolo, oggi Marconi, adiacente allo stesso palazzo Barlaro.12. Per questo personaggio, si vedano CaPialbi 1835; aliquò lenzi-aliquò taverriti 1955, p. 78; barillaro 1976, pp. 36-37; Paoletti 1989, p. 481 n. 20 e p. 488 n. 47; Paoletti 2003, pp. XX-XXI, nota 45; GarGano 2009, p. 91, note 26-27. Per una più esaustiva trattazione del personaggio e della collezione, rimando al mio saggio in corso di pubblicazione insieme a Paola Papasi-dero: morrone-PaPasidero 2011.13. Nelle proprietà dei Pellicano dell’epoca si trovavano le ne-copoli di Romanò-Stracuso nonché il teatro romano a Marina di Gioiosa; la necropoli di contrada Lucifero a Locri; la Chiesa dell’Annunziata di Gioiosa Jonica e tutta l’area archeologica che dalla Chiesa stessa si estende fino al nucleo di rovine noto come “Terme” del Naniglio, alienata alla famiglia Laganà nel corso della prima metà del XX secolo. Nel 1871, alle proprietà dei Pel-licano, si aggiungerà anche il limitrofo feudo di S. Maria delle Grazie, su cui insiste la parte più consistente della Villa Romana del Naniglio.14. I vincoli di amicizia tra le due famiglie sono già testimoniate dalla corrispondenza tra Vito Capialbi e mons. Giuseppe Maria Pellicano, l’erudito prelato che fu Vescovo di Gerace dal 1818 al
90
con il quale intraprese scavi archeologici nelle sue proprietà. Frutto di quest’attività di ricerca, sfociata anche in pubblicazioni numismatiche e dissertazioni su vari monumenti antichi da lui rinvenuti15, fu soprattutto la formazione di una collezione16. Egli aveva raccolto i reperti provenienti dagli scavi da lui stesso eseguiti, principalmente nel palazzo di Gioiosa17, ma di cui si trovavano pezzi sparsi anche nel casino dello Scinuso a Marina di Gioiosa18, e un consi-stente nucleo nella Villa “Quisisana” di Castel-lammare di Stabia, dove la famiglia villeggiava periodicamente19.
La collezione seguì le vicende familiari, finendo frazionata fra i vari eredi e in parte di-spersa. Tale sorte toccò principalmente ai mar-mi, che si trovavano nell’androne del Palazzo di Gioiosa, e che per la loro non facile traspor-tabilità, furono abbandonati al loro destino. Il palazzo, nel periodo a cavallo della seconda guerra mondiale, rimase a lungo abbandona-to20, alla mercé di chiunque volesse asportare
1833, zio paterno di Francesco Antonio. Questi sposò Angiola Taccone figlia del marchese di Sitizzano, cugina di Vito, raffor-zando l’amicizia e la collaborazione tra le due famiglie.15. Sue opere furono: Catalogo delle antiche monete locresi, Napoli, 1834; Intorno ad un antico monumento di marmo, Napoli 1826. Si veda la recensione che ne fa Vito Capialbi, riportata in Paoletti 2003, pp. 203-204.16. Il Capialbi richiama la collezione in più occasioni, dalle lettere alle recensioni.17. Si tratta del vastissimo Palazzo in via Ieraci, noto come “pa-lazzo della ruota”, situato poco fuori la cinta muraria, costruito nel XVII secolo dalla Famiglia Deodino, poi alienato al padre di Francesco Antonio, Domenico Pellicano, agli inizi dell’800.18. Ad esempio la figura femminile tipo ‛Abbondanza Grimani’, pubblicata da Silvio Ferri e dal Barillaro (barillaro 1976, tavola non numerata), poi trasferita altrove dagli eredi (cfr. scheda di M. Cardosa, supra, p. 85).19. In questa Villa si trovava il nucleo della collezione che rag-gruppava le antichità rinvenute dal Pellicano nell’agro nocerino.20. Parte della famiglia si era ormai trasferita altrove, e quella parte che ancora risiedeva in Gioiosa, abitava nel castello feuda-le, alienato dai Marchesi Caracciolo agli stessi Pellicano nel 1871.
ciò che vi si trovava: fu in quella circostanza che i marmi della collezione presero ogni dire-zione21. Si ritrovano ancora oggi iscrizioni pro-venienti dalla collezione, murate all’esterno di case di Gioiosa (Figg. 107 – 108)22, nei recessi di magazzini e bassi, o custodite in migliore condizione da cittadini di più elevata cultura (Fig. 109)23.
In questo frangente potrebbe inquadrarsi la ‛migrazione’ del frammento di sarcofago nei magazzini di casa Barlaro.
Da questa ricostruzione, appare chiaro che
Ringrazio gli eredi Pellicano per le numerose notizie fornitemi in merito alla vicende familiari, oltre che per la consultazione di alcuni documenti familiari circa le proprietà immobiliari riguar-danti Francesco Antonio.21. Molte notizie sui marmi della collezione provengono da in-dagini locali presso testimoni diretti e da ricognizioni.22. Tra i materiali prelevati dall’androne del palazzo, sono note alcune epigrafi funerarie romane provenienti da Locri e da Mari-na di Gioiosa Jonica. Tra quelle provenienti da Locri una è per-tinente ad un magistrato della cassa alimentare, ed è oggi murata davanti ad un’abitazione del Rione Chiusa di Gioiosa Jonica. Si tratta dell’iscrizione edita da Vito Capialbi in Fata Morgana (Pa-oletti 2003, p. 304) che ne dà la provenienza dalla contrada Russo vicino alle mura di Locri. Il padre dell’attuale proprietario sosteneva di aver avuto dagli stessi Pellicano l’autorizzazione a portarla nella sua abitazione, quando essi svuotarono il palazzo per poi venderlo. L’epigrafe viene ripresa anche da Costabile, che la dà per introvabile, e ne fornisce la datazione al II secolo d.C.: Costabile 1976, pp. 20-21.23. Un’epigrafe, inedita, si conserva in casa privata, donata all’at-tulae propretario dagli stessi Pellicano negli anni ‘30. Questa la trascrizione: D(IS) · M(ANIBUS)./[...] LES · VIXIT/[ANN]IS · XXIII. ME/[NSIS...] · FELICULA. MA/[TER]. FILIO · KA-RISSI/[MO] ET PIENTISSIM/[O] · [B(ENE). M(ERENT]) · F(ECIT) ·. Dai caratteri epigrafici l’iscrizione si data al II secolo d.C. Il nome di una Felicula, morta a 19 anni, si ritrova su un cippo marmoreo frammentario del II secolo d.C. proveniente dalla necropoli di Marina di Gioiosa Jonica pubblicato da S. Fer-ri (1926, p. 338) e ancora conservato dagli eredi dell’Ispettore onorario Francesco Mario Macrì. Anche se non si può trattare dello stesso personaggio che dedica questa lapide al figlio dece-duto a ventitre anni, tuttavia identico sembra il nucleo nucleo dei due personaggi e il contesto di provenienza delle due epigrafi. La nostra epigrafe inedita, perciò, è attribuibile alla necropoli di Marina di Gioiosa.
91
stabilire l’esatta provenienza del pezzo risulta, allo stato attuale, quasi impossibile, sia nel caso in cui si tratti di materiale di risulta dei butti si-tuati nella cinta muraria, sia che si tratti di un pezzo della Collezione Pellicano. Se si trattasse di quest’ultimo caso, la provenienza si potrebbe restringere tra Locri e Marina di Gioiosa24 poi-ché in entrambe le località egli scavò contesti romani: nel primo caso, il Pellicano raccolse le epigrafi, alcune delle quali, come detto in pre-cedenza, ancora superstiti, nel secondo caso scavò la necropoli e le adiacenze del teatro e recuperò la statua custodita nel casino dello Sci-nuso25. Non c’è modo dunque, di stabilire una preferenza per l’una o l’altra ipotesi.
Il frammento, pur nella sua limitatezza e nei dubbi che accompagnano la determinazio-ne della sua esatta provenienza, tuttavia offre la possibilità di aggiungere un tassello alla co-noscenza dei manufatti artistici circolanti nel territorio di Locri in età romana nei primi se-coli dell’impero; esso, unito alla straordinaria ricchezza delle ville del territorio e alle altre testimonianze sparse e troppo poco conosciu-te ancora, dà contezza della circolazione di manufatti di tale qualità anche in questa parte dell’Impero, tutt’altra che periferica e in deca-denza. La presenza dei marmi africani utilizzati per le crustae, per le colonne, per le soglie, per i ritagli di pavimenti in opus sectile, e poi la presen-za di capitelli e di sarcofagi microasiatici, inclu-dono il territorio di Locri nel circuito privilegia-
24. Non abbiamo testimonianze di scavi del Pellicano nell’area del Naniglio, mentre con sicurezza possiamo affermare che sca-vò a Marina di Gioiosa e Locri, come attestato dal conte Capialbi in più scritti: Paoletti 2003.25. Sia che il pezzo di Palazzo Barlaro provenga dalla Collezio-ne Pellicano, o dai butti nella cinta muraria, risulterebbe difficile documentarne la provenienza originaria dal Naniglio, come ipo-tizzato da Felice Costabile.
to del traffico di marmi tra oriente ed occidente attivo nei primi tre secoli dell’impero26.
Marilisa Morrone Naymo
Sarcofago con scene pastorali e ritratto clipeato, da Ardore (RC)
Marmo bianco - giallastroFronte: alt. cm 63; lungh. cm 205. Lato: largh. cm 64. Ultimo quarto del III secolo d.C.Da contrada Salice, sulle colline nel territorio di Ar-dore (RC)Museo Nazionale di Locri EpizefiriBibliografia: Faedo 1994, p. 627-628, fig. 30.
Recuperato in un’area da cui provengono frammenti di colonne marmoree e altri ele-menti di una villa finora non oggetto di esplo-razione, il sarcofago (Figg. 86 – 91), scolpito a Roma nell’ultimo quarto del III secolo d.C., fu importato nel territorio locrese e mostra un chiaro elemento di prestigio e di capacità eco-nomica e culturale da parte di un grande pro-prietario terriero che evidentemente frequen-tava Roma e apprezzava le produzione artistica della capitale, ma abitava preferibilmente nei suoi fondi piuttosto che a Locri, e aveva predi-sposto una ricca sepoltura per una delle dame
26. Si può inquadrare in questa rete di traffici la presenza, nel tratto di mare tra Roccella Jonica e Marina di Gioiosa Jonica, di una serie di elementi architettonici sommersi sui bassi fondali a pochi metri dalla battigia. In seguito ad una segnalazione, ho ef-fettuato una ricognizione: il contesto di giacitura dei pezzi non è assimilabile un relitto, perché i blocchi, le cornici, sono allineati a distanza l’uno dall’altro; sembrerebbe piuttosto che essi siano stati gettati da un’imbarcazione in difficoltà, per alleggerirla. Gli elementi emergenti da questi dati sparsi, testimoniano comun-que una frequentazione anche della bassa costa jonica calabrese dei carichi di marmi provenienti dall’Oriente.
Fig. 83 - Gioiosa Jonica (RC), frammento di lastra frontale di sarcofago
Fig. 84 - Gioiosa Jonica (RC), frammento di lastra frontale di sarcofago. Particolare del lembo del mantello
Fig. 85 - Gioiosa Jonica (RC), frammento di lastra frontale di sarcofago. Particolare del volto
Finito di stampare nel mese di marzo 2011 nel Centro stampa Franco Pancallo Editore - Locri (RC) Carta Fedrigoni Arcoprint edizioni da 85 gr. / mq
Copertina carta Fabriano Acquerello da 160 gr. / mqPrinted in Italy
Collaborazione di Germana Curulli e Alessandro Origlia