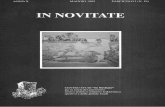Le cisterne dei castelli medievali di Molo Borbera e Sorli (Alessandria)
S. Daris, Alessandria d'Egitto: un mito?, «Paideia» 45, 1990, pp. 105-120
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of S. Daris, Alessandria d'Egitto: un mito?, «Paideia» 45, 1990, pp. 105-120
Sergio Daris
ALESSANDRIA D'EGITTO: UN MITO'
Le suggest ioni suscit ate dalla parola dei poeti e dalle ipe rboli degliscrittori d i prosa oppure i minuziosi dettagl i delle pagine del la Ptolcmaic Alexandria di P.M . Fraser ,' ci inducono a commentare conuna viva cu riosità, talo ra quas i non disg iunta da un sott ile senti mento di invidia, la not izia, che molte lettere su papiro ci offrono,del fresco arr ivo del loro auto re nella città di Alessandria d'Egit -,l O.
All'occhio della nostr a fantas ia, cori tut ta nat uralezza. si d ilatanostraord inarie prospettive su una met ropol i affollata e dall a imponente be llezza, così come abbiamo imp arato a raffigurarcela da iversi d i Teocrito e di Eroda o da lle descrizion i d i viaggiatori conteStrabonc.
Ma una lett ura completa ed att enta di quel le med esime lett ere ciobbliga, in realtà, a constatare come l'interesse nei confro nti dellacittà nella quale si trova immerso colui che le scrive, si esaur isceimmed iatamente con la so la comunicazione di aver raggiun to lameta del proprio viaggio . L'urgenza degli impegni contingent i mailascia trapelare una qualche attenzio ne speciale per la grande citt à,alla quale pi uttosto si guarda e si accenna con una indubitab ile d iffide nza, se non add irittura con dispetto o sos petto c si vedono inessa motivi di malc elata ost ilità. Non una parola - e questo atteggiamento vedremo essere co mune a tutt a la document azione papi racea - viene spesa dal viaggiatore ant ico per ma nifestar e una propria impressione su Alessandria e tanto rncno capita di regist rare
l. Ox tor d 1972: ,l questo Iil-n \> si rimanda per le fonti an tiche c per la hih lioJ(r'ltia moderna.Cfr. inoltre A. Rcrnand . Alt'Xa"drirla GTllI/dr, Paris 106. Cl. i'réaux , 1.1' ",o1/de hl'1lél/l~ll ·
qUI', Parh 1971\ nonché Ah: . Bowman, E?.ypfaifl'r fhl' Pharahos. l.o ndon 191\6. l'p. 101-1 H(Alexandri a. the Qu ccn of the ~lcd it erranean ) per una esposizione recente della mate ria.nei termini della più mualc mitin azione . Q uali cautele dehha no esse re :!(!ott ale, in ,1,S(OnZa(Ii una co nsistente documen tazione papiracca. i: ind icato da N Lewis, (; '''l'ks /11 l'lolmldil'Ef)PI, O xford 1')1\6, pp. 5-6.
l. p. l Iaun. Il 11\ la. Il d .C l: BG U Il 451 (sec. 1/11 ); l'SI XII 1141 (a. 159 d.C l: P. Amh. Il136, P Oxy . XIV 1670, P Tehl. Il 4 ,6 (sec III d.C ): l'SI IV Wl (' cc vl.
Sa ll,tfJDari ,
qualche t racc ia non equivoca d i apprezzamento. Si dov rebbe perciò concludere che il sentimento di Alessandria è un mito int ellet tuale tu tto moderno, est raneo ai contemporanei, un mito che larealtà documentaria papiracca porta alme no a ridimens ionare. Ilcompleto silenzio delle lettere private sulla città, rappresenta ce rta mente il polo OppOSW della celebraz ione ideologico-lett era ria, ma ,comunque lo si vogl ia interpretare, appare indiscutibi lmente comeun parametro d i giud izio mer itevole d i non essere t rascurato.
Le lettere private costitu iscono il momento privilegiato per la pi ùlibera espressione della soggettività del loro autore ma , accanto adesse, si d ispo ngono alt re cent inaia di document i che testimoniano,con una oggett ività per noi tutt a da interpretare, la frequenza d i uninte nso rappo rto t ra la ca pita le ed il resto del paese. ' 11 flusso di relazion i investe , in pari misura, la sfera della vita pubblica e dellestrutture ammin istrat ive quanto quella degl i interessi privati ed inter personali , ma , in ogni caso, questa corrente conosce una sola di rczionc e trascina verso Alessandria il mo ndo del la provincia : conuna fatalità di percorso che, anc he sul piano psicolog ico, non puònon essere stata origine di mal sofferta d ipe ndenza e di ost ile contrapposrzion c.
Un editto' come quel lo d i Cleopatra VII e Tolcmeo XIII (a. 50
a,C. ), con il quale era fatto obbligo ai mercanti di commercializzareil grano ed i legumi esclusivamente ad Alessand ria, pena la mortein caso di flagran te trasgressione, non er a certo provvedimento daalimenta re entusiasmi ne i confronti della capitale, qual i che fosser ole mot ivazion i d i una tale imposizione.
Il t rasporto d i merci ad Aless andria ed , in particolare , il com'ogliamento dci grano nei suo i magazzini è l'aspetto pi ù noto de ll'economia agricola dell'intero paese ed abbondante perciò risult a ladocument azion e pa piracca relativa, in ogni epoca." L'impressionedi una città che assorbe incessantemente larga pa rte del le riso rsedelle proprie campagne, acquista consistenza anche alla luce dell'imponen te materiale scritto che direttamente illustra i meccan ismi orga nizzanvi , mess i in opera allo scopo, da parte della ammin i-
l. I documcmi si trovano raccohi in t\ . Caklcrini. DiZ/OIlario dà lIomi lI,,'oll,r4ià, 1.1 p. }5 ,~.
c Supp!,'!!"",/" ,", l'. Il': ~~ .
-\. In questa prospceriva va vista la posizione dci cinadini di Alessandria. proprietari di tcr reni in provincia. Cf r. Bowman , op. àl.. p. [55.
}. HGU Vili 17\0 (a. }O a.c. j - C. Oro. Prol. 7\.6. Ca ldcrini. DiziO/wrm, I.J p. [l':}.
w,
-
strazi one cent rale. Non solo appare essere stata vivace la rich iestad i vettovaglie necessa rie alla città; nella svar iata massa d i prodotti od i materi e prime che vi approdano non mancano nep pure le colonne di granito , ricavate da lle cave di Siene e destinate dallo sviluppo edilizio all' abbel limento della capitale ad affermazione dellasua imponenza.' C'è da credere però - almeno a leggere i nost ripapiri - che la fama di tutte le bellezze architettoniche e l'att rattivadell'assetto urba nistico di Alessandria non fosse st imolo sufficient eo mot ivazione esclusiva da sedu rre gli abitant i de lla prov incia :11punto da sosp ingcrl i a mettersi su quella via. Un viaggio ad Alessandria ap pare sempre so llecitato da necessità reali del momento:quan do - fatto che si veri fica il più dell e volte - non viene impoS[O dalle superiori auto rità ed assume i contorni di un disag io senon d i una vera e propria iattura, assai d ifficile da evita re. Se nelcaso de lla scelta deliberata e personale , restava intatta per l'int eressato la libertà d i sceg liere il momento e le circost anze della propriapartenza, egli si trovava invece disarmato d i fronte alle scadenzeimposte da una eventuale convocazione d'autorità . Le incogniteche si legavano alla imprevedibilit à delle procedure rendeva no int'erti i tempi del soggiorno forzato in città che no n d i rado si dilatavano a d ismisura, proprio per la necessità di seguire le pratiche negli uffici competent i;" esperienza q uesta che sembra pienamentegiustificare la mancanza di ogni altro interesse o curiosit à per tuttoquanto fosse estraneo al caso t rattato.
D ich iarazioni espl icite della intenzione d i part ire alla volt a d iAlessa nd ria" pe r pure ragioni di d iletto, non si incont rano mai , ameno d i non conside rare come unica eccezione, nel complesso dcinostri documenti , P. Oxy. I 1 19 ." È qu esta una lettera co n la quale
7. Di particolare interesse è b testimonianza di l'. lkalt )" Panop. 2.45-46 ddl'anno ,uo dCCfr. anche P . J lnrris Il 197 (a. 169" 176 >-
Il. I I. Brauncn. Di.. Tlùm " ,m'amlt'fllff7" Bo nn 10/>-\.
') '-':c1la rcahà è completamente capovolta la situazione prospcuata dalla Lettera di Aristca.cap . 10<)'111 , secondo il quale, ad evitare ingiustificati soggiorni in Ak~~ ,lr1d ri~1 da part... dinon residenti. il sovrano n... ha fissato il limite perentorio a 20 giorni, ....1 ha imposto .li 1"'spomahili d,'gl i uftici di decidere i casi ...ntro cinque giorni.
I O. Il pt<l~"'!l<l di un \"i'lgllio ad Alessandria è chiaramente espn..'sso nei sqluellli papiri: l'.Ox y. x Il<)1 (<I w d C. l, P. Princ. m I(». (a. 1'!<)!')oJ.c. l, m;u xm rj so. l' ( Jxv. XI ll<)X I(st'C IIl, P ;\l ich. x1l6'i7 tscc . li/ III d.C. ), SB XII TOllo~ (sec. IV d .C. l.
I I. E. Sabbadini. R"maTtI!<t'S d'or!(Jgrapb ,' d grammli/rt' sur !t' papvms /101I ·/i!léralrt'. ()xyrhYl1chm Il'), Stud l''lp. 6 (19li7J pp. XI'')-\ (dr. BL I, p.~16, Il, p . 9~, III , p . ll<), IV, p. 51'! ,VI, p. <)'i1. Talora anche la presenza .IJ Alessandria per motivi di studio si rivela deludcnn(P. O xv. X"lJI l l <)O. cfr.:-J Lcwis. LI!<'ù/ E7..lpllllldaRo",all Ru /c, U xford l')XI, p . 6 i l.
,o(,
un giovane rivo lge al p roprio padre una richies ta tan to insistenteche sconfina in un atteggiamento ricat tato rio. e tutto questo pe ressere condotto ad Alessandr ia. «Se non hai intenzio ne di po rtarmi con te 'H.I Alessandria, non li stringerò la mano né, per il futuro,ricambierò i salut i» (righe ~-8), L'alto livello della pressio ne verba11.:, che ben risalta anc he da lla forme sconnesse di un greco malsicuro, trova natura le sp iegazione nel grande interesse che il giovaneannetteva a questa possibile esperienza, che no i poss iamo immaainare completamente svincolata da motivazioni pratiche. La giovanile esuberanza del figlio trova p recisi stimoli nelle attrattive dellagrande citt à, che li lui appare come il solo luogo adano a garantirel'appagumemc delle più d isparate esigenze.
Non sarebbe corret to escludere ap rioristicamente che anche inaltri casi , dove espressamente non viene addotto il morivo dci viag gio , si riproponaa la medesima situazione di P. Oxy. I 119, comenel caso di BGU XIII 2350 (sec. Il ). dove il racconto di un grave incidcnte subito (e ho avuto schiacciato il piede dii un cavallo. hocorso pericolo al punto da essere medicata e da spendere molt i denari e sino ad o~~i non ne sono usc ita», righe 7 -11 ), è collegato conuna visita ad Alessandria. Se - come pensa l'editore - soggettoprincipnle è la scrivente stessa, si può riconoscere nella notizia dcima lanno i segni dd ramma rico pe r un viagg io. al momento, nonancora real izzato ma che resta oggetto di desiderio . Dd puri . unospazio pe r una motivaz ione non pragmanca sarebbe da individuarein alcune righe della brevissima lettera P. Oxy. X 1291, scr itta, nel l' anno ~o d .C. , da una donna , Zois, al fratello Ischyrion. Dopo leconsuete rich ieste d i p rodott i leggia mo: «Ma se vuoi part ire allavo lta d i Alessandria, Apollos. figlio di Teone. parte doman i» (righe8 -12) . AI dest inatario si o ffre l'occasione d i t rovare un compagnod i strada od un passaggio alla volta d i Alessand ria e q uesta improvvisa q uanto immed iata disponib ilità si ad atta bene ad un viag gio di affari 4UilO lO ad un a visita disimpegna ta, in precedenza no nprevista.
II cent ralismo buroc rat ico d i Alessand ria cos tr ingeva gli ab itam idci paese ad una person ale presen za nella met ropoli, sia q uandofosse necessario rico rr ere agli o rga ni prepost i alla gestio ne dellagiustizia, sia per tu tte le speciali competenze dei molti uffici dellaamministrazio ne, affidata alla responsabil ità dci p refett o , dell'idioslogos, dci dikaiodores, dell 'archierus . Che il viaggio ad Alessan d ria, inevitabile per la tratt azio ne dei p ropri affari, fosse un'cs pe -
106 S"'f,ioDdW
un giovane rivo lge al proprio padre una richiesta tanto insistenteche sconfina in un atteggiam ent o ricatt arorio, e tutto questo peresse re condotto ad Alessandria. «Se non hai intenzione di po rta rmi con te ad Aless andria, no n ti st ringerò la mano né, per il futuro,ricambierò i salu ti» (righe 3-8). L'a lto livello del la press ione verbale, che ben risalta anche da lla for me sconnesse d i un greco malsicuro, trova nat ural e spieg azione nel gr ande interesse che il giovaneannetteva a questa possib ile espe rienza, che noi poss iamo immaginare completamente svincolata da motivazioni pratiche. La giovanile esuberanza del figlio trova precisi st imoli nelle attratt ive de llagrande città. che a lui appare come il solo luogo ada tto a garantire\'appagam ento delle più dis parate esige nze.
Non sare bbe corretto esc ludere aprioristicamente che anche inaltri casi, dove espressamente no n viene addo tto il mot ivo del viaggio, si ti proponga la med esima situazio ne d i P. Oxy. 1 1 ' 9 , comenel caso di BG U XIII 2350 (sec. Il ), dove il racconto di un grave incidente subito (<<ho avuto schiacciato il piede da un cavallo, hocorso pericolo al punto da essere medicat a c da spe ndere molti dc nari e sino ad oggi non ne so no uscita». righe 7 - 11 ), è collegato conuna visita ad Alessandria . Se - co me pensa l'ed ito re - soggetteprinc ipa le è la scrivente stessa, si può rico nosce re nella not izia dcimala nno i segn i del rammarico per un viaggio, al mome nto , no nancora realizzato ma che rest a ogget to d i desiderio . Dd pari, unospazio per una mot ivazione non pragmat ica sare bbe da individ uarein alcune righe del la b revissima let tera P. O xy. x 129 1, scritta, nell'a nno 30 d.C. , da una donna, Zois, al fratello Ischyrion. Dopo leconsuete rich ieste d i prodott i leggia mo: «Ma se vuoi pa rtire allavolta d i Alessandri a. Apollos. figlio d i Teonc, par te domani» (righe8 -12 ). AI dest inatari o si offre l'occasio ne di t rova re un co mp agnod i str ada od un passaggio alla volt a d i Alessand ria e questa improvvisa quanto immediata disponibilità si ad atta bene ad un viaggio di affa ri qua nto ad una visita d isimpegnata , in precedenza nonprevista.
Il cent ralismo buroc ratico di Alessand ria costringeva gli ab itant idel paese ad una personal e presenza nella metropo li, sia quandofosse necessario ricorre re agli o rgani preposti alla ges tione dellagiust izia, sia per tutte le speciali co mpetenze dci molli uffici dellaamministrazione, affidata alla responsabilità dci prefetto, dell'idioslogos, dci dik aiodores, dcll'archic rus. Che il viaggio ad Alessand ria, inevitab ile per la trattazione dei propri affari , fosse un'e-pc-
Alrssandrra d 'Egrno. tUl milo.'
-_ .._- - --- - - - - - - - - - - - -
'"7
rien za tutt 'altro che piacevole, non è difficile dedurlo dalla documentazione dei casi singo li, anco rché la loro angolazione si conti guri co me una tesumouiunza di pa ne.
Qualora no n fosse effemvamente poss ib ile assolvere alle necessi t à in prima persona, si provvedeva, olt re che co n forme amichevolidi incarico," con regolari documenti d i delega. Nell'agosto del 161d .C ,q tre ex gin nasiarch i d i Ossirinco avrebbero dovuto presentarsi dav anti al tr ibunale del Prefetto, Vol usius M aecianus, in Alessandria; nell' impossib ilità d i farlo, delegano a rap prcse ntarli unproprio libe rto , con una giustificazione del loro comportamento econ una strateg ia d ifensiva, che rappresenta quasi un luogo comune d i simili situazioni. «Poich é le pa rti che sottoscrivono l'accor do ,no n sono in grado, al mo mento presente, di navigare alla volta diAlessand ria, in q uanto ora si avvicina il raccolto ed a ca usa d i altriimpegni che riguardano le rendite , esse nomina no come lo ro rap present ante, co n questo atto , il predetto Sa rapion che navigherà alla volta di Alessandria e si p resenterà all'illus trissimo Prefetto , Volus ius Maccianus oppure a qualunque altro giud ice che egl i ritengaidoneo» (P. Merton I 18 . 19-31) . La giustificazio ne addotta prefigura ab ilme nte l'eventuale da nno che l' amministrazione pot rebbesubire da un raccolto tr ascurato o non del tutto perfetto.
Era l'ufficio alessandri no del l'a rch idikasres a confer ire l'indi spensabile pubblicità agli acco rdi pri vati, mentre al procu ra/or "siacm spettava, ad esempio, d i registrare l'effett ivo valore de lle proprietà ered itate . Le part i interessate che compaiono r ispettivamente in P. G renf. Il 71 (a. 24418) ed in P . Oxy. x 1274 (sec. III ), stab ilisco no di no mina re un delegato che si rechi ad Alessandria a seguire una prat ica in lo ro vece. q Q uale so mm a di inco nvenien ti fosseco nnessa, il più de lle volt e, co n uno spostamento dal proprio domicilio ad Alessandria , in dipendenza di una determ inata causa senza tener conto delle p reoccupazio ni co llegate alla causa stessa non soltanto è argom ento d i faci le ipotesi ma trova punt ua le conferma in una serie di test imo nianze esplicite. I fast id i pe r l' int eressato potevano incominciare anco r prima d i affrontare la t rafila del -
Il. Talc pare essere stato il caso dj P FIor III HX (scc III (I.c. ).l~ . P ;\'\"n on l I X.
1..\. Da ricordare anche P. O xv. Xl\' 16.j.~ ( a . l'olI! d .C. ), nel 4u <ll" si pT<K('do:,]lb nomina di undelegato per rmtrncciarc. in Alessandria, uno sch i<lvo fu~giIO . Per le pfJlirhe press o l' uff cio(Ielridi", logos v. SB r 51~1 c .\ 1. Chr. 6X ( a . [-VI,! l o: davanti <llrarchiereusv. P. Teht. 11 1';)1
(a. II!')/ <)O l.
ooX
la burocrazia, anzi poteva accadere che non incominciasse affatto.se le pone degli uffìci restavano imprevedibilmente sbarrate. Unco nt rattempo di q uesto gen ere tocca ad un certo Sabinus. autoredella lettera P. Mich. VIII 493 (sec. Il d .C. 1 che. arr ivato ad Ales.sandria per trattare davanti all'archidikastes la propria questione.non trova modo di rcaliz zame il disbrigo a causa dell 'assenza (leifunzionario responsabile. ..Voglio che voi sappiate - scrive alle suecorrispondenti rimaste od villaggio di Karanis - che da quando honavigato alla volta di Alessandria . ho trovato , per la maggior partegiornate nelle quali non si conclude alcun affare c. sino ad oggi , so no stato tirato per le lunghe, per quanto riguarda il processo. È capitato anche che se ne: sia anelato l'archidikastcs di prima t' siamo inattesa d i quello che deve veni re, Appena sar à portato qui. con dio,in fret ta. me ne verrò via'> (Il. Mich . VI II 49~.4 -15l. L'insofferenzape r una sosta non prevista ed il disappunto per l'impossibilità d iprevedere gli sviluppi dci caso in tempi ragionevoli, caratterizzanola lettera mentre l'impazienza di riprendere il cammino verso l'Arsinoire e la casa di Karanis provano quanto sgradevole risulti questo soggio rno nella capitale.
Ritardi ed indugi all'avvio della trattazione dei singoli casi potevano essere occasionati dalia normale chiusu ra degli uffici nel giorno di giovedì o "bi sovraccarico degli impegni dci fun zionari comperenti : talora le due circostanze coincidono e si assommano comerisulta dalla pet izione dell'irenarches Sepnmius Heraclides da O ssir inco. inoltrata al Prefetto da un suo mppresemame. ' Un primotentativo di abboccamento viene frustrato dalla festività tr ighe 81.)); un successivo fortunato (o meglio fortunoso ) incontro. il giornodopo, con il Prefetto sul punto di entrare in carnera di consiglio,non approda a sorte migliore perché il magistrato deve attendere aquestioni più serie (delegaz ioni. ambascerie? righe 9 -10) e di intcresse collettivo. Solamente nel terzo giorno il paziente apposta mento porta il posrulantc al colloquio con il l' referto . anche inquesto caso ap parentemente in una sede occasionulc, nella qualealme no ott iene indicazioni sulle procedure da segui re.
IS. P (hy. XXII l I.H I" 11'7 d _L ) nella nuova edizione di R Cok,. /'lh.l' XX/T. .l;.lJ ,,·r I,..d, ZPE n l ( l')l'sl l'I' 110-114: la scena dclla vicenda 1".1 Ct,lIoçar'1. "'Iva dubbio. ad Ak.,,·....ndria. anchc ,..,.' nlanCIIl<' nel 1<""10 inJiçazioni <"'pliçil<: re te. IA""\\·i,. lJ/t: cit.. p_ IX", c Id.,,,"O/.l/tu'I"! l.·g....I/Il. BASI' I I (l'Jì6) 1'1'_ 9 -10).
In_ P<: r un ah ro inçonrr.. con ìl Pectcuo. da parte di un t<","l.'nl<: ad Ak."",mdtia, in una >C
d." non istnuzjonalc v 1' .\1 Ft a,..,.'r . B :\"içh" la" Tb'·/Im.u" (,,,~J•." 0/ .\foUJol". rRS 411Il'''5111 pp- Il ì · l l ", - SE(; X\"III 646.". .
A!t'HaJldria d E?,li!u: un m/Io }
Non pare aver incont rato una sorte più felice nel proprio rap porto con l'amministr azione, un certo Kephalion, che deve rappresenta re interess i alt rui in una causa davant i al tr ibunale del Prefettod'Egitto." Se la sostanza della controversia per noi oggi non é in alcu n modo ricostruibile , evide nt i si most rano sia la complessità della procedura applicata nell'occ asion e" sia la tensione defatiga nteimposta all'i nteressato. Ne son o la prova le parole con le qual i ilprotagonist a stesso presenta la situazione a chi gli ha affidare tantamole d i impegni. «U na volta ad Aless andria ho presentato dci document i al signor Prefetto e fino a questo mom ento non mi ha datonessuna risposta scr itta. Ma il tuo avversa rio non si sta nca d i farsiavanti né io d i farmi avan ti a mia volta» (P. O xy. XXXI 2597.J -8 ).Queste vicende, narrare con l'animazione propria d i una personaleesperienza, potr ebbero rap presenta re l'iter ab ituale, prcsumihilmente tortuoso nell'ambito giud iziario, se non presentassero ilda nno di un ulterio re ritardo dovuto alla sospensione dell'attivitàlegislativa del Prefetto , sul punto d i lasciar Alessandria per raggiungere Errnopoli Parva per ammin istrare colà la giust izia. Alloscrivente non resta dunque che osservare: «Ma questa faccendanon sarà d i poco tempo, almeno com e la penso io. Infatt i il signorPrefetto va via il r" d i H athyr (28 ottobre) alla volta di Ermopoliper emettere le proprie decisioni c, rigua rdo a questo, ha reso pubblica un 'ordinanza» (r ighe 10 -15 ). Conseguenza inevitab ile dd rinvio non sarà so lamente il ritardo nella composizione de lla cau sa maanche l'inso rgere di nuove spese di soggiorno per le quali sembraessere avanzata una speci fica rich iesta, per quanto con d iscrez ione. .•e misura.
Le lungaggini burocratiche rappresentano frequente motivo perlamentele ufficiali da avanza re all'autorit à e questo momento aggiuntivo che si sovrappone e che comp lica la d iscussione della cau sa si rinnova , con maggior frequenza, nel caso di una convocazioned'a uto rità davanti agli uffi ci alessandrini. D i una tale cas istica particolarrnente sign ificativa è la pet izione SB IV 7367, ino ltrata da C.
17. P. O xy. XXXI l597 (S"'"<: . ut/rv ).
18. C. FUli Talamanca. Rscercbc sul processa nell'Egitto greco-romano. I , M ilano H)H. pp.195-198c II,p l-lXn. ,8-1.
Illa. 0:olizi c· di SP""st' di \'ia~io t' di S<.lggiorno ad Alessandria. sono forniI<' ,in dall'età role rnaica con P. Paeis. 60 bis (sec. IIth tl ; cfr. P. Sarap. 65 (sec. ti d,C. ), P. Ross. Gcc'rj.(. \' 56.~.
SB VI 9~09 (sec. lIt d.C. l; P. Oxy. x Illlll.17 tscc. IV d.Cn. In età bizantina suno riçord,uifrcq ucnremenrc i viaggi t' le relative SPI."'t' di gruppi eh...· appartengono alla organinazimll'Il..1 latifondo (ex . gr . PSI viu 9B6X,73 buccllarii, P. O xv. XV I 190-1 svmrnachoi).
" 0 Ser!!. /() DJr!.!
-
lulius Agrippianus. al d ikaiodotes, M. lulius Maximianus, nel corsodell'anno '39 d.C. 11 documento, per quanto assa i lacunoso e logo ro , è ben riconoscibile nei suoi co ntenuti c, rispetto ad ahr i testianaloghi, " conserva in più inte ressa nti riferi menti tem porali. Il presentato re dell'istanza rico rda d i essere stato costretto a prese ntarsiad Aless andria per o rdi ne dci dikaiodores , in segu ito a denunciadella parte avversa, una donna , propri o nel momento centrale dcilavori agrico li, quello dci raccolto , e che da l 21 di Pharruuthi ( 16aprile ) si trova ad Alessa ndria , dopo aver lasciato interrotte le ope razion i in campagna. «Pe rciò - continua testualmente - ti prt:go ,mio benefattore , di ascoltarmi a propos ito di quanto mi è capitatod i esporre co ntro di lei neg li allega ti, affinché dopo essermi d ifesodalle sue rivcndicazioni , possa ritornare ind ietro ed occupartui delracco lto per il pagamento delle tasse stata li, secondo la d isposizione dell'eg regio Prefetto , Pctronius Mamcrtinus. perché io ottengagiustizia» (5 13 IV 7367.20 -28). Scopo della richi est a è quello d i 0(
tenere un dibattito proccssualc solil'cito per rid urre al massimo idanni degli indugi, con l'avvio dell 'audizione delle parti. La sua fìducia , per una benevola accoglienza della propria istanza da partedel magistrato, resta soprattutto fondata su lla consueta motivazione economica, già vista in situazioni precedent i. La prolungata assenza da l luogo di lavoro riduce inevitabilmente le capacità centributivc della persona che l'amm inistrazion e stessa trattiene e de llaquale ostacola , in ultima ana lisi, la produttivit à. Ma una nota d'uflìcio, apposta dagli impiegati in testa al documento per segnare lareg istraz ione dell'ano , porta la data del t" d i Payni , cioè del 26 dimaggio , il che significa che almeno una quarantina di giorn i son odovuti passare prima che la rich iesta fosse presa in consideraz ionedal tribunale. t da esclude re perciò che le valutazion i sulla propriavicenda di C. lulius Agrippianus fossero di gran lunga dive rse daquelle che abb iamo visto angustiare il Sabinus di P. Mich . VIII 49~,
l'u no e l'alt ro ben lontan i da l cons ide rare condizione fortunataquella d i essere obbligat i a prolungare, senz a cene prospettive, illoro soggiorno in cit t à.
Con molta probabilità , la d urata della loro sosta forzata ad Alessandria, pe r motivi giudizia ri, si allineava ai r itmi consueti del la
l'' I n parti,obre P ( hy III 4!'>6 {a l Il d _C. I che contiene, <.jualc· allej!.alo ad una pcnzionca!repislralq:n Iri~h,' 1l!-\6 ), la richiesta di una donna rivoha ad ottenere ill,,"rJlK"SSO di .11lomanarsi <lA Ales,"mdria l'n occuparsi ddle sue proprietà danneggiate d alla pien a del:\iln.
Alcssandna d 'Egifio un "ilio ) '"procedura, scandita a tempi lent issimi se, come accade in P. Fuad24 , viene imposto ad una delle due parti , per ordine dell'archidikasres. di fermarsi 30 giorni ad Alessandria , in att esa della compari zione dell'avversario. Solo dopo la scadenza d i tale termine, l'ob.hligo di soggiorno verrà a cadere e si avrà il rinv io dci processo aduna data successiva al tempo dd raccolto.
Ai tempi lunghi adottati dall'amministrazion e per il disbrigo definitivo di una causa, fanno da contrasto i termini a breve scadcnza. che vengono normalmente fissati per la trattazione di una causanelle convocazioni d'ufficio. "
L. Vettius Epaphrodims. che abita ncll'A rsinoite , si impegna apresenta rsi al tribunale permanente del Prefetto ad Alessandria ,ent ro una ventina di giorni (P. H amb. 1 4, a. 87 d,C.) ; un giorno inpiù si concede Antiphancs, figlio di Ammonios , da Ossirinco lP.O xy. II 360 = M. Chr. 74, a.59 d.Cd , che deve sostenere la propria causa presso l'uffi cio dcll'archidikastcs, ment re contenuta adun periodo ancor pi ù raccorciato - [6 giorni solamente - {: la st'adcnza imposta ad alcune pe rsone dcll'Arsinoite . le quali dovrannorispondere alla convocazione presso il procurator usiacus (BG U II!
89 1, a. 144 d.C. ). Solamente in BGU 1 5 (a . 138 d.C. l si fa parola diun termine di più largo respiro , rappresentato dai 40 giorni entro iqual i alt ri abitanti dell'A rsinoitc" sono chiamati a reca rsi davant i aliuridicus.
Abbiamo visto che non mancano i segna li per capire quanto dicont raggenio fossero accettate queste soste forzate ad Alessandria,dalle quali le persone coinvolte non ricavavano vantaggio alcuno:al contrario dann i ceni de rivavano dall 'interruzione de lle atnvir ùabituali c dalla lontananza fisica, che impediva di sovr inrenderc aiconsuet i lavori . Poteva inoltre accadere che si verificassero situa zioni eccezionali a detrimento della persona assente, sul momento.dal proprio domicilio oppure favorite da questa circostanza , :.11punto che, anche quando la sosta ad Alessandria non viene do cu.mcn rata con ragioni giudiziarie , si attribuisce a questa l'intera C lU-
w. Un l~ntali\'<, Ji ,onmr,i all'obbligo di comparire dinanzi ,II di"ikdn. cmro il 24 lu~1i"
dd 21 0 d,C.. i: la richiesta di rinvio. prescnt.ua ,1110 sl~s'" funzionario da parte di un ;Ihilan re dcllErmopoltc. soltanto un l'domo prima .Id termine sLlbilito (d r Fori. op_ (II . t p. t)(>
». lo
1 1. In P. r uad II (a , 115 d.C, l. documento aìlinc ai il",ti citali. la 'c<I(k'nz:1 i: indicata in rcr mini pcncrici: «giuro ... di essere presente ad Alessandria dopo il r'Kcolt" dc'] C"ff,'nt~ no"o.lIm" Ji Adriano Ccs crc Signore» ( r i ~ ht' K·IM.
'"sa dd danno pento. in una consequenzial ità più psicologica cherea le. Va no tato che non solo di danni materia li si trana - comefurt i," danneggiamento della proprietà" - , i pi ù prevedihili e natu rali in mancanza d i una p resenza fisica che potesse prevenirh , maanche di complicate manovre legal i che la persona lontana non erain grado di percepire ." Quale esempio singo lare ed istrutt ivo di simili sit uazioni può essere opportunamente rico rdato P. En t. 55,degli anni 223/2 a.C c. sia per le vicende prospettare sia per le partiche vi figurano coinvolte. Nella pet izione rivo lta al sovrano , un clefUCO lam enta il grave danno subito, in quanto la stessa ammin istra zio ne stat ale, durante la sua assen za in Alessandria , ha ripreso laproprietà dd fondo che era stato a lui concesso dal re e ne ha asse gnata in affit to ad altri la metà. In questa sede non interessano tan to gli aspet ti pa rtico lari te molto inte ressanti l della questio ne sollcvara da part e del clcruco , di rito rno da Alessandria, quanto la motivazione della lontananza da lla p roprietà : egli si trovava ad Alessand ria per un processo e non aveva nessuno che lo rappresentasseal proprio domicilio . Una lunga assenza che l'amministrazion e, daun lato , ha imposto con le more procedurali e che, da ll'altro, sfrut ta a proprio vantaggio con la confisca e la ridisrribuaionc dellaproprietà.
Mille c mille mot ivi conducevano una persona ad Alessandria," ,ma qu esta osmosi tra la capita le e la provincia non era problemache lasc iasse del tutto ind ifferente l'amministrazione ce ntrale . specialm cnte q uando nel flusso de lla geme, il viaggio verso la cinà siconfigurava come un vero trasferimento a tempi lunghi se non de finitivo. Sarebbe mo lto interessante stab ilire sino a che puntopreoccupazioni di esclusivo carattere fiscale sugge rissero alle aurorità un controllo allento degli spostamenti all'interno del paesedell e persone soggette alla tassazione. Infatt i nel momento stesso incui due abitanti d i Ossirinco dich iarano ad alcuni funzionari dellacittà che il lo ro figlio si trova , al momento, ad Alessandria" ed è re-
lI. Ex, gr, H(; U I 'll ·'lI~' SB I li (,1, 116 d,C. ), che ri~lmrdan" uno stnso caso,
l, .Ex. gr . SB n'I 11Xl\ ( ,l. 115 a.C ): mentre rillleres"lIo è ,Id Ak-s"lIldrLI . ;lkllll~ personeragliano la kgn;, nd suo fondu.
14, P. Er a. 1 9 1s~"c. 1II a,C. I. P. '\ Iil. Vogl. IV 119 (<1. 14° d.C I.
15· B"wm'lIl , op. ar., p. 155-16 Cfr. l'elenco p Pnnc 1 14 11 1.10 ss. con le t<lSS~ r;lgat~ <hl "hitant i del villaggio di Filadelfia lllUl1WllUlll',llllenle ad AI~s"lIldria (a. 13/ 4U); in P .\1kh. IX BI - SB XIV 11141 la,174 d.C. l lo M;ri!l ,l <Idla metropoli dichiara ch~' una don na riç,:rcal 'l. si uova ad AI~'s;lndria
(righe 9-1/ 1; una identica suuazion c i.. ripropos tn da P. O xy. XV III llyg f>l"C Il d.C. l.
'"
-
golarmentc iscr itt o nelle liste dei contri b uenti a l p roprio d omi cilio ,sottolineano d i produrre il documento in ottemperanza alle disposiz ion i dd Prefe tto «rela tivamente a co lo ro che soggiornano adAlessa ndria» (p. O xy. X XXVI 2756.8-9, a. 78/9 d. C. ; cfr. N . Lewis.HA5J> 9. [972, p. 31 l, La d izione appare molt o precisa e ben le ntana da ll'omologare ogni qual un que luogo d i soggiorno d iverso dallapropr ia ab ituale abitazione. La presenza in Alessand ria d i perso nanon residente i: soggett a ad una se rie d i p rovved iment i che tr ascendono la p ura sfera della fiscalità. L 'assenza d i no rm e dest inatea rego lare l'afflusso d i nuo vi immigrali in cit tà avrebbe d i fan o resoimpossib ile ogni controllo dd complesso della cittadinanza, perchéness un luogo era più adatto d i u na mcgalopoli , come Alessand ria.ad o ffrire accoglienza ed ano nimato a ch iunque avesse vol uto con fon dersi nella su a folla . Per q ua nt i vedevano in Alessan dria un app rodo sicu ro per le loro diffi colt à" ed avevano intra visto in quellala so luzione dei prob lemi del vive re quotidiano," basterà cita re P.l Iarr. 134, un testo frammentario e di ince rta natura, scritto nel se colo II I d .C. , che r iferisce d i un avvenimen to ninda mcruc ricostruibile. Un cale Dcmetr ios appa re soggetto ad una liturgia che eglinon intende, in alcun mod o , onora re ; l'unica via di uscit a da ll' impaccio è l' ab band o no d el propr io domicilio con una fuga ch e lore nda irreperibi le. M éta ideale è Alessa ndria; si imbar ca con l' intenzione d i approdarvi, ma non la raggiungerà ma i perché, lu ngo last rada, il suo p rogetto è sopraffatto da una se rie d i im p revist i. C'èda credere che se il nos tro Dcmctri os avesse avuto miglior fort u nae si fosse in urbato nelle grande citt à, probab ilmente avrebbe evirato i fastid i d ella liturgia, ma, nel contem po, avrebbe d ovut o affronrare d iffico ltà d i alt ra nat ura, p ro p rie dei rit mi d i vita di una metropoli.
Not izie d i occas io ni fo rt unate o d i situazion i gio iose, co llegate osuscitate d alle esperienze alessa nd rine, sono una assenza costantedai nost ri documenti ; se sentiment i od emozioni fanno 1:1 lo rocomp ars a ma n ifesta, apren dosi la via nel co m patto int reccio dellenecessità ma te riali, so no d i segno negativo e semb ra no trad ire ilpeso d i una vita d i solitud ine , in mezzo alla folla." Si fa insistenteallora l'esigenza d i tenere vivo e saldo il rapporto con il luogo d i
27. Ca!{!erini.1Jlzum arw . I. 1 p. 11';1,
zx. Pe r io:1i schiavi fu~gili ad Alcssa nd ria \ '. UI'Z [l I., ( ,l 156 a.C.J, I' . O w. xrv 16H (, l l')l\d,C. l. P. Lil'" li - ,\1. Che 55 (a , 6H), I.,·wis. l.!/,·dI . p [(' l
2\), Cf r. B( ;U Il , 8 5 - \X'. Chr. 100 (SC{·. 11/111 ).
" 4
o rigine t: viene sollecit ato lo scambio co nt inuo d i co mu nicaz io ni acon forto d i una lontananza che be n di rado permette il ricongiu ngimento del le pe rsone' .
In sede ufficiale. l'occasio ne naturale di contatto tra la provinciaC'O Alessand ria è connaturata alle necess ità dell' amministrazione didisporre costantemente dei dati , relativi ad ogni Se'UOTe della vitapubblica. elaborat i in sede locale a questo scopo, ed ino ltrati dafunzionari specificame nte prepost i a q uest o comp ito; ' tali at t ivitàufficiali vcrisimilmente non impegnavano gli interessati a tempimolto lunghi . A livello infer io re. nell'ambito dci lavori a te rmineche risultano essere stati impost i agli art igiani ed ai lavoratori dellaprovincia , alla fine- dd secolo III , " troviamo un costruttore ed ile,originario da un villaggio dell'Ossirinchi te . che giura davant i allost ratcgo dd proprio dist retto «d i recarsi nella splendidissima Alessan dria e di fermarsi nel bagno colà in allest imento, esercitando lamedesima attività di costruzione per il tempo fissato» (l'S t il I ,62,9 141. Per un intero an no , un cittadino d i O ssirinco ( Il, O xy. VIII
1116 = \ '\' . Chr. 403 , a . 363 1 dovrà svolgere una funz ione non me glio determi nabile. nel tem pio d i Augusto della capitale, come riSU h~1 dall a proposta di no min a da pane d i un magistra to della suacitt à.
Sarebbe dci tuno fuo ri luogo rich iedere a quella pa rte della noSIni document azio ne pa piracea prodotta sempre e solamente pernecessit à concrete , notizie che ad essa so no tota lme nte es tr anee .(ome quelle che rigua rdano la sfera della soggettività. Importanteinvece i: rilevare che nelle de cine e decine d i lettere private, sicur ament e spedite da Alessandria e scr itte per sol lecitazio n i co m ingc nti - mat eriali per lo più , ma anche talo ra emoz ionali - sarebbe at d uo sco prire qualche accenno alla me tropoli. Alessand r ia è un pa no rama d isso lto e senz a co nto rni per ch i in essa scrive c tale da nonese rcitare impression i che il mittente ritenga opportuno trasmetten: al proprio destinatario ; nulla d i quel mo ndo colpisce la fant asiad i chi vive la p rop ria quot idia nit à, al punt o da assu merlo nel qua d ro degli interessi per son ali, da farlo proprio e da pancciparlo a
\0. l' Tcbr. Il ~ lil lsl'C III J ,C.I : l'aurore Ji questa ku<:ra ~paa ch,' sua 111,,~li<: 11< '"'' <:~'l'rl'
alrOllll"l~n ,lla ;Id AI<'~"lIldTia da l d<:Sl inalarjo,
\ 1 Com,· "Iud li .. rhH11in;ui pe r il ricevimento ,-J il trasporto de i volumi ~1',....[iti ad Ak's~an '
d ria~ II' Atn], II (~, P FIor . III nS, p , l' rinc. III Il ] , p , Rvl. Il s~ ,!><:ç. Il J .C J.p l'SI III 1(,2 la. ~S(, J.c. ),\ l, Arll~lani , 1ll;lIld~li ad Al~·,,,nl<ltia. fi~ur..no an <,'h~' in l'. SaL"," ~~ . ~ ,~(, La. I~] ),
A!eHI.mdria d 'EF.ilto un mito .' "5
quant i vivono nella lontananza della provincia, in una realtà incomparab ilmente diversa. Che cosa resta, negli occhi del l'uomodella strada, del paesaggio urbano di una citt à «che supera tutteper gra ndezza e per prosperità»" e che proprio in virt ù della propri a be llezza e ricchezza aveva riemp ito di ammi razione moltegrandi personalità? Asso lutamente nulla o almeno d i nessun momento perché non avviene mai che si parli d i qualche particola reprospettiva della città, che, secondo la trad izione letteraria, ponevasoltanto l' imb arazzo de lla scelta, Ad essere ricordati sono solamente gli edifici che il mo ndo della burocrazia ren deva giocoforza familiari; tali erano il ginnasio li ed il suo portico" nonché l'A tr iumMagn um .l7 Sulle paret i del l'uno il cit tad ino poteva ritrovare espos tein pubblico, ai fini della regolare no tificazione, i provvedimentiprcfettizi,' ment re l'altro er a normalmente luogo di affissione de llafabula albi profcssionum, con le d ichiarazio ni d i nascita dei cittadi ni romani . L'affollato concorso di cittad ini a questi uffici statal i,per reperire la comunicazione o la norma d i legge da consult are etrascrivere , probab ilmente non forniv a stimolo ad abbandon i co ntem plat ivi o ad annotazion i d i natura estet ica sugli edi fici forzat amente frequentati e tanto meno si pensava di dare relazione ad alt ri su questo tema. Ad incalzare è piutt osto il b isog no di ricava re estilare copia del testo necessario al proprio intento , come fa lo serivenre di P. O xv. VI II 1 15 5 (a. 104 d.C. ), che appena arrivato adAlessan dria, assolve al proprio incarico e può d ire al dest inatario:«t i ho man dato le disposizioni stesse del Prefetto perché ti affrettassi, pe r quanto ti riguarda» (righe 11-13).
Tra gli ed ifici di culto più celebrati, se non ad di rittura il più importante in assoluto per la d ivinità vene rat a e per la grandiositàdell'imp ianto arch itettonico, si ergeva il Serapeo," luogo d i pietàreligiosa ma anche di st raord inaria attrattiva esteri ore, che ta nta
~4 AriSlea cup 10'); per l'impianl<> della cina \'. CalJerini. Diziollario, r.r, p. n , s .
n . Calderini, Dizionario , r.r, pp. I07-1011 , Rem and . op. dI. , pp. 141-1.;.5. rrascr. "p cit, l.
p. zl:\ ss.
16. Calderini, Dizionario, 1,1, p. I.;.ll. A. Lukaszcwicz, fA:J Cdlfin:J puhlin da'H In viI/n di'ttXJPI<'romainc, Varsavia 191:\6, p. Ilio , P. Apo ke., p. z6.
~ì· Calderini. Di;:ùm ario. 1.1. p. 95·
~8. 1'. Flor. ili }81. P. Apokr. 1.21 . SB IV ì 350 \'CN J 14; in tutti I(li altri casi non è mai ricordato illuogo preciso di Alessandria. dove è avvenuta la pubblicazione.
~9 . Calderini. Dizionario. l , l pp. 1.;.0'1.;.6, Bcenand . op. cir., pp . 1l~ · 1l9. Bowman. op. ciI..pp. Z06-10ì ·
116 S('ff,io D<l1/.I
---
eco solleva nella letteratura." L'impianto imponente, la decorazionefastosa, le sofisticate soluzioni tecniche, la preziosità degli ornamenti ed, infine , la prodigiosa starua di Serapide, colossale nelleproporzioni e preziosa per gli ornamenti, lasciano negli scrittoriuna stupefatta meraviglia, della quale però non esiste t raccia neidocumenti su papiro. Fatto tanto più rimarchevole in quanto ab biamo la certezza che molti degli scrivent i, se non tutti , almeno unavolta, hanno realmente esercitato le loro prat iche di culto nel tem pio tanto famoso. Visitare il Serapeo appare essere stata una delleprime preoccupazion i per qua nti fossero appena arrivati ad Ales sandria, come test imonia la lettera di un tale Erode (P. Brem. 48,sec . Il d .C. ). Egli , dopo aver narrato le peripezie sofferte durante ilviaggio e dopo una estesa relazione degl i affari trattati con la mas sima urgenza , conclude la propria lettera con questa pa role: «Prima di tutto , domani farò il mio atto di adorazione per te nel Serapeo, perché oggi non vi sono salito, a causa di gravi fastidi e di pe ricoli» (righe 29 -32 ). A questo caso che manifesta l'esp licito proposiro d i visitare il santuario, si contrappongono i numerosissimiesem pi nei quali il rito è già avvenuto, ma, in nessuno di essi, ind ividuiamo parola o il benché minimo accenno all 'ambiente tantosolenne nel quale le pratiche rel igiose hanno trovato concreta rea lizzazione.
G li avven imenti di vita cittad ina non sembrano quasi mai supe rare la soglia (o meglio la barricra l degli int eressi privati; escluse daquesta sfera , le notizie su lle vicende collettive di Alessandria , per lopiù , sfumano nell'ind ifferenza dei singoli e, ben raramente, filtranotra le pieg he delle test imonianze accettabilmente legate alla città.Due sole notizie" stanno a documentare la quas i totale assenza diinformazioni al proposito ; ent ram be riecheggiano fatti sgradevoli erelativi ad avven iment i che non potevano lasciare indifferenti larghi gruppi socia li o l'i ntera comunità dei cittadini. La prima testi mon ianza (P . Mich. VIII 477,28-3°) ci dà not izia di un tumulto c diuna som mossa scoppiata in città" ed a fornircela è un testimoneoculare, un soldato che, in qualche modo, ha partecipato di persona all'episodio o, add irittura , se accettassimo senza riserve la con-
40. l'n tutti Arnrn. Marc., XXII. 1 6, 1 2 · 1 ~ .
41. Non è suno tenuto conto di P. O xy. xr.u ,065 ( s~ c . m d .C.1. in quanto non è ussohna lan>t1~zza ~'he ilE avv~'n im ~n t i narral i si siano svo lti ad Alc" ,tndrhl. donde lo s.-riverlte I~nta
di fll~ir~"
42. AImedesimo fa\lo è falta allusionc anche in P Mich. VI II 47RI4
=
Alt'Hal/dr/tI d' EfI,llIu' III/ mi/o? "7
-
gettura dell' ed itore, ha avuto ruolo diretto nelle repressione dellasommossa. È certo però che uno dei verbi usat i a descrivere l'operazione, non lascia dubbi su lla pesantezza adottata nell ' interventoper stroncare la ribellione. Mancano dci tutto ind icazioni cronologiche esplici te od implicite ed incerto è il significato da at tribuireall'avv enim ento , che non si lascia megl io ident ificare e che va collocato ne i pri mi decenni dd secondo seco lo dopo Cristo.
Ad un per iodo più recente (sec. II/IlI ) è datato P. Mic h. V I II
510, anche questo una lettera su papi ro, nella quale compare la no tizia che una gra nde morta lità si è verificata ad Alessand ria (r ighe13-14). I guast i dci testo nelle righe che preced ono questo passo."nulla permetton o di inferire circa la misura del coinvolgimento diretto dello scrivente nella vicenda calamitosa ma l'episod io sem braessere stato di gravità non comune e tale da infrangere il silenzio sud i esso anche di quant i non ne avevano patito in prima persona lado lorosa espe rienza. Come nel caso di P. Mich. VIII 477, per noi sirivela ines istente ogni possibilità di identificare il fatto con una piùmarcata evidenza storica."
Per una cap itale quale Aless andria, sede di og ni st ruttura am ministra tiva, la stabile presenza in essa degli uom ini d i gove rno costi tu iva parte integrante della realtà cittadina ed un aspetto consuetode lla esperienza quot id iana, che nat ura lme nte no n rich iamava sud i sé specia le interesse d i cronaca. Ma anche episodi d i alt ra risonanza, quali le visite nella metropoli d i personaggi eccellenti, o add irittura del massimo rango, come - per l'età romana - il soggiorno dell'imperatore stesso, non assumono nei nos tri documentiquel risalto che li caratterizza nella tradiz ion e letteraria. L'atmosfera rnitizzante che circo nda questi event i nelle narrazioni storiche èlontana da lla realtà d i un presente abitualmente condizionato da ibisogni del momento che non lasciano spazio ad alt re attenzioni ,Q uale sia stat a l'eco dell'arrivo e della visita, presumibilmcntc adAlessand ria," da parte d i T ito, risu lta da P. O xy. XXXIV 2725, chepure deve essere ritenuto documento molto attento verso l'avvenimento:" una pura regist razione d i cronaca, contenuta nello spazio
,H· :-':uo rcsra che '-I uJk he lettera delle due ri~he pre(e demi-1-1 . Ci. Casanov a , ì a peste n,.{1a dnw""'II/azlo1/!'l/,raa d 'El/,II/O, Ani X\ '11 Cun~r. imo Ji Papi.rul,,~ia , N apo li 198-1, 111 , l'. 9-19-956; IJ " Ep,d"tnù: (' famt' III EfI,IUo, Acgvptus 64 (191'\-1).pp . 16J-lOI; IJ " Altre ft'Slùm",ùmZt' stilla p"SI<: III f:g,lUo, Aegyptus 61'\ (191'\8) pp . 9J·97.
-1 5. Non c'è dubbio che si tratti p ro prio di qucsra città.-16. O . Monrcvecchi, Tito alla luce dà papiri, Ani dd Congr. int. di studi Flaviani, Rieti198" pp. H'j-JH·
d i pochissime r ighe , a conclusione d ì una lett era , infarc ita d i not izie su affari correnti . La testimonianza de ll'evento, per il quale,sen za d ubbio , era stato messo in moro il co mplesso apparato de lleaccog lienze ufficial i (cf r. riga 2 1 l, si riso lve tutta in una qu asi peda nte reg istrazione dell'ing resso del Cesa re in città (alla secondaora del 30 dd mese ), che - pe r la dat a espressamente posta in calce - co rrisponde alle 7 dci matt ino del 25 aprile dell' ann o 71 d .C.Con la stessa me ticolos ità, è descritto l'itinerario seguiw nel corsodella visita: punti toccat i sono l' acc am pamento, il Serupeo e l' ippodromo. Notizie queste non accompagnate da commento alcun o ,che non co nservano perciò , nem meno in minima pane, la riso nanza d i q uella che dovette essere la cerimonia pubblica; fatto tantopiù rilevante ne lla co nsiderazione che, posto che i festeggiamentinon ab biano assunto le proporzi on i d i q uelli riservat i a Vespasi ano , nel 69 d. C. : ; p rocla mato imperato re nella stessa Alessandria, sipossono immagina re non t rascurab ili, se erano stati affidat i allamemo ria dci posteri , con la reg istr azione negli alt i uffic iali, come èdetto ne lla stessa lettera. Sebbene il rapporto pe rso nale con la cittàd i Alessandria d i alcuni imperato ri - come Adria no , AntoninoPio , Diocleziano - abbia rap present ato mo ment i d i no n poco rilievo ne lla loro storia personale, il r icordo della loro presenza in cit tà ." è p revalentemente legato alle figu re di Settirnio Severo e d i Caraca lla; ma quelli che pe r gli sto rici del periodo si configurano co me avven imenti d i notevole risonanza" o d i te rri bi le evidenza" pe ril regno dei Severi, ne lla docu mentazio ne papiracea si rid uco no atracce irrilevanri. co nnesse esclusivamente co n le for ma lità dellap rassi legislat iva." In una circostanza" unica - e solame nte perch éla persona che ce ne dà notizia è anche attr ice dell'evento - hl fi gu ra d i un sovra no, pu rt roppo pe r noi, non identificab ile ne lla denominazion e d i «re , nostro signore» (SB II I 622 2. 14), acquista un
.+7. Testimoniare dd P . l-uad 8; per '-IU~"IU <: Iwr Il, C>X ~· . XX XI\" 1.71.} v. 0 , ,\Iom<:wl"l"hi, V,,·S{>dHI/J/f) dCC/,Wld/n JdfJ/ A/"HdllJrlm, Aq.~yp l ll s 61 1198 1l . l'P, 1..\ l ' r-o.
41'\ . Sulk vi,i ll' dq:l i imper atori in Ej:illo v. Bowman. op al,p. oH <: . sul prnhkma in j:l·n<: ·rak I I. I lalfmann l 1111a d pr/IIC1{>um, Stuttga rt 1<)1'\6, ('<I in pa rticolare. per l'Eguto le pp. 1'\1.-
"4\1 . Ad , Span.. S'T. lì.
So. Ad , Spart . Carac. 6; dr, A. Lukaszcwicz. Alcxandne W/t5. /esSh'èr..s t'! l'hi5/urlOgrd{>hit,.
in Egino e sllmd antica Ja//' El/"lIl"'lIo d/l'elà araba, Bologna 198\1. pp . 49 1·4o,.i, .
SI P Apok r. p. .lì, P Ox y U J6 1..\ imr.: inolt re \'. p , Chy. XUI W194"S. U \6 1..\1.. P ColIl. J . I
51. . SB III 6lH ('l'l· III dC).
l H)
-
connotato meno indefi nito. Allora sappiamo che , per esplicito de siderio dd principe in occasione della sua visita ad Alessan d ria, sono indette gare atlet iche, " per le qua li sono post i in palio premi indenaro cd in vesti ; in giorni successivi , durante la celebrazione del Li festa nel Lagcion," ha luogo la premiazione dei vincitori.
Sempre per ragion i personali, appare ricorda to l'arrivo ad Alessandria del Prefetto di nuova nom ina T. Furi us Victorinus. il giorno IO luglio dell 'anno 159 (PSI XII I2_p ), mentre la per "ma da llaquale provi ene l' informazione, ha raggiu nto la cap itale il giornosuccessivo. La rilevan za data all 'episodio può trova re la propria ragion d 'essere tanto nella riso nanza di una cerimon ia recent issima elargamente pubblicizzare - soprattutto se sole nnizxava. come pare , il primo ingresso del Prefetto in citt à e la sua presa di potere-," quanto nell'i nteresse, per chi ce ne riferisce, per la presenza dciPrefe tto in Alessandria , nel la prospettiva di question i personali darisolvere presso quel magistrato e nel suo ufficio.
Solo Alessandria , quale cent ro nodale della vita ammin istrat ivadel paese, poteva assicurare come abituale la presenza di quas i tut ti i personaggi di rango ed era naturale che so lamente qui avvenissero le occasioni di important i incontri e di fortu nati abboccamen ti, de cisivi per la carriera dei singo li. Una simile circostanza affio ranella lettera d i Amm one di Panopoli a sua madre (P . xv Congr.22 ) , scritta nei primi anni del secolo IV, Q uesto Ammone scolasticbns, perfettamente inserito nella società che conta , riferisce dcipropri contatti ad alto livello con quant i possono esse rgli d i aiutonel tentativo d i assicura re al nipo te una carica d i rilievo, nei quadridella ammin istraz ione del culto, In un complesso giuoco di relaz ioni, si promuove l'intervento di personalità influenti e tali da condizionare la scelta del sommo sace rdote, al qua le istituzionalmenteera affidata la decisi one del caso, Quest 'ultimo si era trov ato pe rmolto tempo lontano dalla propria sede alessand rina. alla qu ale rito rna per una celebrazione religiosa: immed iatamente Ammone intende incent ra rlo. con la fi ducia ormai di condurre a buon fine la
• •quesnone.Ad un livello socia le più modesto c ad ambizioni più contenu te,
51. :--:<:1 c"",pus (Cal d~·rini, Dizionario, U , p. 11 9l.
54 . Ca ldcrin , Di2/<JI1<lrlo. t.r , pp . 124.125. Fra,n, op (11, l, p. ~I
55. l'. O~\" . LV ~ lh l. IX · W, d r. F.c;.tt ;"lil1 ar, Th,' Rm'/(11/ Empln' d'Id I/J .\'('[f,hbol/ ." Lon do n 1907, p . 6~ .
56. [l. xv Coog r. H 111 .10·11.
•
risponde la storia del giovane Pausania (P. Oxy. X IV 1666, sec. III
d.C.1 che. arruolato nel le t ruppe legionarie, aspira invece ad unasistemazione nei reparti ausil iari delle ali. Madre e sorella ne condividono il proposito e fanno pressioni sul rispettivo padre c marilo il quale, con qualche riluttanza. decide di giocare la carta delviaggio 'Id Alessandria; qui interviene al cuore dci potere dccisionule c filggiungc effettivamente il suo scopo. «Sceso ad Alessandria- scrive il padre - mi sono impegnato in molti tentativi, sino aquando ha avuto il trasferimento nell'ala di stanza a Copro» (P.Oxy. XIV 1666.9-11 l. Dal che appare evidente che "assegnazione alpresidio di Copro nell'Alto Egitto, risponde...'a alle aspettative delgiovane Pausania meglio che ogni altra sede Iegionaria nella stessaAlessandria.
LI totale scomparsa della documentazione pupirucea alessandrina ha cancellato per sempre tutte le voci che, dalla viva realtà delquotidiano. avrebbero potuto darci i segnali dai quali conoscere inquale modo cd in quale misura, sia stata vissuta dai contemporaneil'esperienza della grande città. A questo appello di voci, per sempre affievolile, mancano, in particolare, quelle dei cittadini di Alessandria. cioè di quanti effettivamente furono nelle condizioni di vivere pienamente la città; è giusto credere che tra essi non pochiappartenessero alla schiera convinta degli arnatores urbis. di oraziana memoria, e fossero pronti a. far propria l'ammirata celebrazione della metropoli, quale balza sulle labbra delle siracusaneGor~o e Prassinoa. Ma, nella reale impossibilità di attingere conelusioni generali ed attendibili, sarebbe pariment i comportamentoleggero quello di igno rare le test imonianze disponibili - icasticamente tutte riassunt e da. una frase, nella lett era d i P. Menon Il
X3. IO (sec. Il d.C.l 'J:; !J.~ ~x~i:(,:, ~~:; ·Ai.EE:t'J~~Ei::X'J - e negamel'interp retazione sin q~i ~fferta. Questa Iettl;ra che carica di un segno negativo l'atteggiamento dell'uomo della strada, quasi sem pred i l'S i razione prov incia le, nei confronti d i Alessandria e sottolineail tot ale capov olg ime nto della prospettiva nei co nfro nt i della tradizionc let teraria, è resa possibile dalla qualità e da lla ricchezza dellefont i pnpi racce. Considerazione questa forse assai più impo rta ntedi ogni singola ce rtezza eventualmente raggiunt a.
•