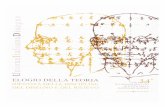Logica e dialettica nei commentatori neoplatonici della scuola di Alessandria
Transcript of Logica e dialettica nei commentatori neoplatonici della scuola di Alessandria
COLLANA DIRETTA DACarmelo CrimiRenata GentileLisania GiordanoMaria Dora Spadaro
COMITATO SCIENTIFICOFilippo BurgarellaAntonio CarileKristoffel DemoenClaudia GiuffridaMichael GrünbartJean-Noël GuinotSergej P. KarpovEwald KislingerSanto LucàChryssa MaltezouRamón Teja
COMITATO DI REDAZIONEMargherita CassiaPaolo CipollaTiziana CreazzoGiovanna GiardinaDaniele IozziaCarmela MandolfoBeatrice MarottaArianna RotondoGioacchino Strano
Studi e rassegne su ANTICO, TARDOANTICO
E MEDIOEVO
a cura diCarmelo Crimi, Renata Gentile,
Lisania Giordano, Maria Dora Spadaro
BONANNO EDITORE
ISBN 978-88-7796-999-6
Proprietà artistiche e letterarie riservateCopyright © 2013 - Gruppo Editoriale s.r.l.
Acireale - Roma
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Volume stampato con il contributo del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania
EMANUELE MAFFI
Logica e dialettica nei commentatori neoplatonici della Scuola di Alessandria*
1. In questo studio intendo analizzare la trattazione che i commen-tatori neoplatonici della scuola alessandrina riservano al ruolo chela logica ricopre in relazione alla filosofia, con l’obiettivo di mostrareche la discussione su questo argomento è un caso esemplificativodell’impossibile tentativo di armonizzare i due maggiori pensatoridell’età classica. L’armonizzazione di Platone e Aristotele operata daineoplatonici alessandrini avviene al prezzo di una forte confusionedei significati di logica e dialettica1. Questa confusione finisce ine-vitabilmente col deformare il pensiero platonico e col dimostrare ilcontrario di quanto gli alessandrini si erano prefissati: la loro solu-zione – che fa della logica sia una parte sia uno strumento della fi-losofia – più che la superiorità di Platone su Aristotele testimoniainvece l’impossibilità di rispondere, platonicamente, a problemi einterrogativi propri dell’aristotelismo.
173
__________________* Questo studio è un primo risultato della mia attività di ricerca svolta al-
l’interno del progetto La dialectique aux Écoles platoniciennes d’Athènes et d’Ale-xandrie du V au VI siècle après J.-C. diretto dalla prof. Angela Longo egenerosamente sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scien-tifica. Un grazie particolare va perciò ad Angela Longo e ai colleghi del gruppodi ricerca (Lorenzo Corti, Nicolas D’Andres e Davide Del Forno) per la di-sponibilità, la competenza e la pazienza con cui hanno discusso con me di que-sti argomenti. È superfluo ricordare il grande giovamento che ho tratto daqueste discussioni. Mi preme inoltre ringraziare Mauro Bonazzi, David Sedleye Franco Trabattoni che hanno letto una prima versione di questo lavoro: iloro puntuali commenti mi hanno evitato ben più di un errore. Di quelli ri-masti invece io sono l’unico responsabile.
1 È stato P. Hadot, La logique partie ou instrument de la philosophie?, inHadot I. (éd.), Simplicus. Commentaire sur les Categories, Vol I., Leiden 1987,pp. 183-188, a mostrare che la causa del dibattito sullo statuto della logica èriconducibile a questa confusione di significati.
2. Il problema dello statuto della logica è discusso dagli alessan-drini nel Proemio ai loro commenti agli Analitici Primi2, con la solaeccezione di Olimpiodoro che invece affronta il problema nei Pro-legomena alle Categorie (p. 14, 13-18, 12)3. Data la somiglianza dellosviluppo argomentativo userò come guida il testo di Ammonio, se-gnalando i punti in cui Olimpiodoro, Filopono ed Elia integranoquanto scritto dal loro predecessore. Ciò che rimane invariato è loschema tipico della loro analisi della questione: 1) l’enunciazione delproblema con relativa esposizione sintetica delle posizioni principaliin gioco; 2) la presentazione delle argomentazioni principali di que-ste posizioni e poi le loro confutazioni; 3) la soluzione “platonica”proposta dal commentatore.
Ammonio introduce la trattazione sulla logica dopo aver adem-piuto uno dei sei punti introduttivi che il maestro doveva trattarenel presentare l’opera, ossia la spiegazione del titolo: poiché già perPlatone delle quattro parti (diairetica, oristica, apodittica e analitica)della dialettica l’analitica era il metodo più completo, non deve stu-pire che per questo motivo Aristotele abbia intitolato due sue opere“logiche” Analitici (8, 9-14).
Troviamo un discorso analogo anche in Filopono: costui pergiunta ricorda che ancor prima che Aristotele ordinasse i ragiona-menti in schemi e figure «il divino Platone procedeva in maniera sil-logistica e apodittica nel Fedone e in quasi tutti i suoi dialoghi» (6,14). Prima di affrontare lo statuto della logica, è così già affermata
174
__________________2 Diversi sono però i luoghi in cui la trattazione è inserita: Ammonio (in
An. Pr., p. 8, 15-11, 21 [Wallies]) e Giovanni Filopono (in An. Pr., p. 6, 19-9, 20 [Busse]) la sviluppano dopo l’esposizione dei sei punti introduttivi al-l’opera, Elia invece tratta subito la questione, ancora prima di introdurre l’opera(in An. Pr., p. 67 (134, 4)-71 (138, 13). Per quanto riguarda il proemio di Eliaagli Analitici Primi farò riferimento all’edizione di Westerink in Elias on ThePrior Analytics, Mnemosyne 14, 1961, pp. 126-139.
3 Olimp. Prolegomena et in Categorias Commentarium, p. 14, 13-18, 12(Busse): egli più precisamente colloca la discussione sul ruolo della logica tral’introduzione generale alla filosofia di Aristotele e l’introduzione specifica alleCategorie. Sul contenuto di queste introduzioni cfr. I. Hadot, The role of thecommentaries on Aristotle in the teaching of philosophy according to the prefaces ofthe neoplatonic commentaries on the Categories, Oxford Studies in AncientPhilosohy, Suppl. Vol., 1991, pp. 175-189.
la superiorità di Platone rispetto allo Stagirita: dei due è il primo, defacto, il fondatore dei metodi del corretto ragionamento, dei quali ilsecondo è piuttosto il formalizzatore4.
Per introdurre il problema dello statuto della logica Ammonio sipropone di esaminare i ragionamenti sottesi alle principali opinioniin gioco: «allora, per quanto riguarda coloro che su questo argo-mento hanno opinioni differenti, elenchiamo dunque le loro con-vinzione e i ragionamenti grazie ai quali, come credono, rendonoforti le loro convinzioni» (8, 18-20). Egli illustra così le tre posizioniprincipali: quella degli Stoici i quali ritengono che la logica non siané strumento né una sottoparte ma una vera e propria parte dellafilosofia, quella di alcuni Platonici i quali sostengono addirittura chela logica sia la parte più nobile della filosofia e quella dei Peripatetici(in particolare di Alessandro d’Afrodisia) secondo cui la logica è stru-mento della filosofia.
La prima posizione presentata da Ammonio è quella degli Stoici.Il loro primo argomento si fonda sul seguente assunto: posto che lalogica ha una relazione diretta con la filosofia in quanto suo pro-dotto, tale relazione può essere intesa solo in una forma che facciadella logica una parte o una sottoparte della filosofia5. Sulla base diquesto assunto gli Stoici spiegano il rapporto tra la medicina e lachirurgia: la medicina ha prodotto e usa la chirurgia, e poiché nes-sun’ altra scienza o tecnica ha prodotto e usa la chirurgia come suaparte o sottoparte, bisogna concludere che la chirurgia non è stru-mento della medicina. Analogo è il ragionamento concernente la fi-
175
__________________4 Un argomento di questo genere è proposto anche da Elia (136, 26-32) e
Olimpiodoro (18, 3-10), di cui riporto il passo in traduzione perché mi sembraun’efficace formulazione di una tesi comune a tutta la scuola. «E non bisognaritenere per questo [per il fatto che Platone non ha formalizzato gli schemi delsillogismo] che Platone sia inferiore ad Aristotele, ma al contrario che sia anchemigliore; infatti Platone nelle dimostrazioni non ebbe bisogno del metodo apo-dittico di Aristotele, ma al contrario Aristotele ebbe bisogno delle dimostrazionidi Platone. Così dunque anche Omero e Demostene non hanno avuto bisognoné della Poetica di Aristotele né dell’arte di Ermogene, ma al contrario questiultimi hanno avuto bisogno di quelli [Omero e Demostene] per formalizzare imetodi a partire dalle loro opere». Le traduzioni dal greco sono mie.
5 Cfr. 9, 1-2: «Gli Stoici dunque affermano che la filosofia stessa ha pro-dotto la logica e che perciò quest’ultima dovrebbe essere una parte di quella[della filosofia]».
losofia e la logica: poiché la filosofia ha prodotto e usa la logica chenon è parte o sottoparte di nessun altra scienza, bisogna dunqueconcludere che la logica non è strumento della filosofia ma una suaparte o una sua sottoparte (9, 7-15).
A questo punto Ammonio menziona tanto una possibile obie-zione a questo ragionamento quanto la relativa controreplica: qual-cuno potrebbe sostenere che anche altre arti si servono della logicadal momento che la medicina e tutte le altre arti si servono dei me-todi sillogistici; ma a costui si può replicare che, sebbene anche quellearti utilizzino i metodi logici, esse non sono vere conoscitrici di que-sti metodi perché non se ne occupano nella maniera migliore. Il me-dico, per esempio, non s’interessa principalmente del metodosillogistico e per tale ragione non si oserebbe mai dire che la logicaè parte o sottoparte della medicina. È solo per quanto gli serve nelladimostrazione dei teoremi medici che il medico apprende dal dia-lettico la logica e la usa come suo strumento. La logica può così esserestrumento della medicina ma può essere solo parte (o sottoparte)della filosofia poiché solo il filosofo è il massimo conoscitore di que-sta disciplina (9, 16-20).
Una volta riportata l’argomentazione stoica sulla natura non-strumentale del rapporto logica-filosofia, Ammonio presenta poi leragioni per cui costoro non ritengono possibile che la logica sia sot-toparte della filosofia. All’interno di un quadro di divisione della fi-losofia che ricorda molto quella di Alcinoo6 la logica non può certoessere né una delle tre parti della filosofia pratica (etica, politica ed
176
__________________6 Cfr. la divisione proposta in Didasc., 3, pp. 153-154: una divisione che,
come notato da I. Hadot (Simplicius. Commentaire sur les Categories, vol. I, p.77-79), verrà in gran parte ripresa (soprattutto per quanto riguarda la tripar-tizione delle sezioni teoretica e pratica) dai commentatori neoplatonici di Ari-stotele, come sembra fare appunto Ammonio. Che questa divisione dellafilosofia possa accordarsi con la classificazione degli Stoici – giustificandoquindi il fatto che Ammonio la applichi nell’esposizione delle loro tesi – è sug-gerito dal fatto che la tripartizione della filosofia offerta nei manuali platonicidi età imperiale risente fortemente dell’influsso delle dottrine stoiche; non acaso, per riprendere un’espressione di Ilsetraut Hadot, in questi manuali laterza parte della filosofia (la parte dialettica) viene ad essere una qewriva tw~nlovgwn. Sull’influsso della tripartizione stoica sulla divisione della filosofia neisistemi medioplatonici cfr. P. Hadot, La division des parties de la philosophiedans l’Antiquité, Museum Helveticum 36, 1979, pp. 211-212.
economia) né una delle tre parti della filosofia teoretica (teologia, fi-sica e matematica). La logica differisce da entrambe sia per la materia(u{lh) che per il fine (tevlo"): la materia della logica non concernené le cose umane (parte pratica) né gli affari divini (parte teoretica)ma i lovgoi (le proposizioni e i discorsi); mentre il suo fine non è néla felicità della vita umana, né la divina felicità della contemplazionema la conoscenza dei metodi apodittici, giacché le parti della logicasono volte al solo obiettivo di fornire dimostrazioni veritiere. Poichédunque la logica si occupa tanto delle cose divine quanto di quelleumane, ma non unicamente né delle une né delle altre, come fannoinvece le due parti della filosofia, la logica non potrà essere una sot-toparte della filosofia ma sarà la sua terza parte (9, 30-35).
Se si riassume tutta l’argomentazione degli Stoici da un puntodi vista complessivo ci si rende conto che Ammonio l’ha presentata,come probabilmente facevano gli Stoici stessi, nella forma dellaquinta figura del sillogismo stoico (il quinto degli anapodittici): lalogica è o parte o sottoparte della filosofia; ma sottoparte non è, dun-que è parte. Il primo argomento (o prima premessa) è volto a mo-strare che la logica in quanto prodotto della filosofia non può cheesserne o sua parte o sua sottoparte, ma che di certo non è un suostrumento, dal momento che non vi può essere una relazione stru-mentale tra due scienze di cui la prima (logica) è stata prodotta dallaseconda (filosofia).
Il secondo argomento (o seconda premessa) elimina il secondocorno della dicotomia: poiché la logica non condivide con le altredue parti della filosofia né i fini né la materia, non può in alcunmodo essere considerata sottoparte delle altre due parti. Che la logicasia la terza parte della filosofia è perciò la conseguenza di quantoesposto nelle due premesse.
Molto simile a quella di Ammonio, che rimane l’esposizione piùorganica, è la presentazione degli argomenti stoici a favore della lo-gica in quanto parte della filosofia offerta dai brani di Filopono,Olimpiodoro ed Elia.7
177
__________________7 La differenza è soprattutto a livello terminologico e riguarda la materia
della logica: per Filopono essa consiste nelle protavsei", per Olimpiodoro eElia nelle fwnaivmentre per Ammonio nei lovgoi (lo stesso termine usato daAlcinoo (III, p. 153, 30) per indicare il dominio della dialettica).
Ammonio formula due obiezioni contro le argomentazioni deisostenitori della logica-parte della filosofia; due obiezioni che, intro-ducendo la possibilità che la relazione logica-filosofia possa avere uncarattere strumentale, sono volte a introdurre la posizione dei Peri-patetici. Di costoro vengono perciò presentati due argomenti. Ilprimo si basa sulla natura del rapporto parte-intero: se a un interotogli una parte esso viene meno, se alla filosofia togli la logica essanon viene meno, dunque la logica non è parte della filosofia.
Il secondo afferma che la superiorità della filosofia sulle altrescienze è garantita solo dal fatto che la logica è considerata un suostrumento: se, al contrario, la logica fosse parte della filosofia allora sidovrebbe giungere all’assurda conclusione che tutte le altre scienze etecniche (comprese quelle meccaniche), le quali si servono della logicacome loro strumento, sono superiori per valore e dignità alla filosofia.
Subito dopo il commentatore rivolge la sua attenzione ad alcuniPlatonici (tine;" tw~n Platwnikw~n) i quali, in virtù di quanto Pla-tone afferma sulla dialettica nel Fedro e nel Filebo, sostengono chela logica non è solo una parte della filosofia, ma è fra tutte la partepiù nobile. Una volta concesso a costoro che la logica può essereparte della filosofia, ma che di certo non è la parte più nobile poiché«di essa ci serviamo per la costruzione e la dimostrazione delle altreparti della filosofia, di quella teoretica e di quella pratica» (10, 26-27), Ammonio procede alla soluzione del problema: per Platone lalogica può essere sia parte sia strumento della filosofia.
Si tornerà in seguito su questa soluzione, ora conviene concen-trare l’attenzione sulle obiezioni che Ammonio solleva contro le ar-gomentazioni stoiche e sulla posizione dei Peripatetici così com’èpresentata e recepita all’interno della scuola alessandrina.
Contro il primo argomento, ossia quello per cui se la logica èprodotta dalla filosofia allora tra le due può esistere solo la relazioneparte-intero o sottoparte-intero, Ammonio porta il caso, già presen-tato da Alessandro (in An. Pr. 2, 20-22), del fabbro: anche se il fab-bro produce l’incudine, non si potrà certo affermare che l’incudinesia parte dell’arte del fabbro, della quale essa è solo uno strumento.
Da tale considerazione nasce la replica al secondo argomento. Se“parte o sottoparte” non è la sola forma del rapporto tra logica e fi-losofia allora l’assunto per cui, se una scienza ne produce un’altra al-lora quest’ultima è o sua parte o sua sottoparte, è in realtà incompletopoiché nella costruzione dell’argomento gli Stoici non hanno consi-
178
derato l’ipotesi che ciò di cui si serve una scienza possa anche esserestrumento, e non solo parte o sottoparte, di quella scienza8.
Nella possibilità che la logica sia strumento della filosofia risiedela condizione fondamentale per salvare la superiorità della filosofiarispetto a tutte le altre scienze e tecniche. E proprio in questa direzioneAmmonio menziona il secondo dei due argomenti peripatetici da luiriportati. Quest’ argomento, ampiamente ripreso dai suoi successori,parte dalla seguente constatazione: se qualcosa è fattore costitutivo diuna certa tecnica ed è strumento di un’altra, quella che se ne serve inquanto strumento è migliore di quella che l’ha prodotto come suofattore costitutivo. Tale è, ad esempio, il caso – anch’esso già men-zionato da Alessandro (in An. Pr. 2, 29-30) – dell’arte di fare le briglierispetto all’ippica: della prima, le briglie sono il fattore costitutivo eil prodotto, della seconda invece lo strumento (10, 11-14).
Se però applichiamo questo assunto al caso logica-filosofia par-tendo dal presupposto che la logica è parte e prodotto della filosofianon si può che giungere a un esito manifestamente assurdo: che lafilosofia, arte delle arti e scienza delle scienze, è inferiore a tutte lealtre arti e scienze, le quali si servono come strumento di una suaparte e prodotto (10, 18-20).
Se la medicina si serve della logica, allora la medicina è superiorealla filosofia dal momento che utilizza una parte di quest’ultima comesuo strumento. Il discorso vale ovviamente per tutte le scienze e learti, persino, come ricorda Filopono, per le arti meccaniche: «anchequelle infatti, secondo il pensiero comune, ragionano per sillogismideducendo da qualcosa che viene prima qualcosa che ne consegue»9.
Così per salvare la superiorità della filosofia rispetto a tutte le altrescienze bisogna ammettere, recuperando l’immagine già utilizzata daAlessandro, che la relazione tra la logica e la filosofia è in tutto similealla relazione tra l’incudine e il fabbro, ed è pertanto una relazione
179
__________________8 Così Ammonio: «in risposta al secondo argomento affermeremo che essi
[gli stoici] hanno commesso un errore: non bisogna infatti dire che, se unatecnica si serve di qualcosa che non è parte o sottoparte di un’altra, questoqualcosa di cui si serve è sua [della tecnica che se ne serve] parte o sottoparte,bisogna invece aggiungere anche “lo strumento” e dire “qualora ciò di cui siserve non sia parte, sottoparte o strumento di un’altra tecnica”» (10, 2-5).
9 L’esempio suggerito da Filopono è quello dell’architetto, un esempio uti-lizzato con lo stesso intento anche da Elia (135, 23-25).
strumentale: la filosofia, pur avendo prodotto la logica, se ne servecome suo strumento nello stesso modo in cui il fabbro, pur avendocostruito l’incudine, se ne serve come strumento della sua arte.
Anche il primo argomento peripatetico riportato da Ammoniotrova in Filopono uno sviluppo interessante. Il ragionamento di Am-monio suona così: la logica è strumento della filosofia perché non èun fattore costitutivo della filosofia nella sua essenza: se si toglie lalogica la filosofia rimane in sé compiuta (10, 9-11).
Nel testo di Filopono invece ciò che è interessante è la riflessioneche segue da questa argomentazione:
Se dunque la filosofia, essendo per natura teoretica e pratica, si costi-tuisce in se stessa anche senza la logica, e se gli uomini [in passato]hanno avuto bisogno della dimostrazione [logica] per una compren-sione chiara della filosofia, adesso la logica non sarà parte della filosofia.Inoltre la parte è impiegata per se stessa, lo strumento invece per qual-cos’altro. La logica non viene considerata per se stessa ma ai fini delladimostrazione (8, 23-27).
Da questo brano sembra emergere che la filosofia ormai sia in séqualcosa di compiuto e definito e che la logica, una volta esaurita lasua funzione apodittica volta a costruire l’edificio argomentativo dellafilosofia, non possa fare parte di un intero (filosofia) già provvistodelle parti (teoretica e pratica) che lo costituiscono. È interessante chetra le parti proprie della filosofia non compaia né la logica né la dia-lettica: si tratta di un primo sintomo di quello che sarà il grave limitedella soluzione platonica degli alessandrini, cioè la difficoltà di indi-viduare l’ambito specifico della logica in quanto parte della filosofia.
Attraverso le decisive argomentazioni peripatetiche Filopono ri-tiene conclusa e confutata la tesi stoica: «Ma poiché abbiamo con-futato a sufficienza la dottrina degli Stoici e abbiamo dimostratosenza mezzi termini che la logica è strumento della filosofia, affron-tiamo ora anche l’insegnamento di Platone» (9, 3-4)10.
In più di un’occasione i neoplatonici alessandrini si oppongonoalle tesi stoiche attraverso le argomentazioni peripatetiche, vale a direriprendendo gran parte delle argomentazioni di Alessandro controi fautori della logica-parte della filosofia. Non è azzardato ritenere
180
__________________10 Lo stesso discorso vale per Ammonio (9, 3-5) e Olimpiodoro (17, 4-6).
che questi commentatori considerino la funzione strumentale dellalogica più confacente allo statuto della filosofia. Ciò è dovuto al fattoche solo una relazione strumentale tra logica e filosofia salva il pri-mato della filosofia rispetto a tutte le altre scienze.
3. Nonostante quest’accordo non bisogna però concludere chegli alessandrini ritenessero la logica uno strumento della filosofianello stesso modo in cui la intendevano Aristotele e in seguito Ales-sandro d’Afrodisia.
Recentemente Correia ha messo in luce che la concezione stru-mentale della logica che emerge dal proemio di Filopono11 è piutto-sto diversa da quella aristotelica e peripatetica. Per Correia Filoponointende la logica (inclusa la logica peripatetica) come una disciplinache non s’interessa dei contenuti per occuparsi solo degli schemi edelle regole meta-logiche dell’argomentazione apodittica. E in pro-posito cita il passo 9, 9-11 del proemio di Filopono: «il dedurre dadue premesse universali affermative una conclusione universale af-fermativa, questo sarà per lui [Platone] usare la dialettica come stru-mento non unito al contenuto».
Ma questa non è un’idea del solo Filopono, bensì un topos pro-prio di tutta la scuola alessandrina12. Al riguardo inoltre basta ricor-dare tanto il già citato passo di Olimpiodoro (18, 3-10) in cui egliafferma chiaramente che Aristotele ha estrapolato, e formalizzato inregole e schemi, i procedimenti apodittici già presenti nelle argo-mentazioni di Platone, quanto il suo analogo nel testo di Elia (136,26-29): al fine di non violare le proprietà delle figure logiche Platone,dimostrando, sembra attenersi alla sillogistica di Aristotele, ma inrealtà è Aristotele che ha imparato dai dialoghi di Platone, «per riu-nire insieme, da essi, le proprietà delle figure [dei sillogismi]».
181
__________________11 Mi riferisco a Philoponus on the Nature of Logic, Apeiron 37, 2004, pp.
251-54.12 Formulazioni quasi identiche si trovano in Elia (136, 17-19: « [la logica
è] strumento negli schemi, ad esempio nella prima figura: da due [premesse]universali affermative segue una [conclusione] universale affermativa»; e inAmmonio (11, 5-7): «[Aristotele] infatti propone meri schemi senza conside-rare gli oggetti che ad essi (agli schemi) si riferiscono ma applica questi schemialle lettere. Per fare un esempio: A si predica di ogni B, B si predica di ogni G,quindi A si predica di ogni G».
All’interno della scuola di Alessandria quindi la logica aristotelicacome strumento della filosofia è concepita come una disciplina chesi occupa delle forme e delle figure delle argomentazioni senza alcunriferimento ai contenuti propri della filosofia. Né Aristotele né Ales-sandro però intendono la logica in quest’accezione13.
Tuttavia Correia trova strano che Filopono non si accorga di avertravisato il valore della logica aristotelico-peripatetica riducendola auna disciplina formale e senza utilità euristica proprio quando perAristotele e Alessandro ciò che è formale e privo di utilità non puòessere considerato strumento. Lo studioso però chiude il suo lavorosenza domandarsi quale fosse la causa di questa errata comprensione.
Per rispondere a questo interrogativo occorre riflettere sull’in-tento e sul fine che muove la riflessione di Filopono e degli altri com-mentatori e sulla conseguente immagine che essi hanno dellafilosofia di Platone.
4. Fare della logica in quanto strumento una tecnica dei metodiargomentativi è per i commentatori una esigenza funzionale a mo-strare che nel pensiero di Platone troviamo testimonianze tanto dellalogica intesa come parte della filosofia quanto della logica consideratacome strumento della filosofia. Va da sé però che, affinché in Platonesi possano trovare operanti entrambe le “nature” della logica, la lo-gica in quanto strumento debba essere intesa come una scienza co-stituita essenzialmente di mere strutture meta-argomentative.
Il che, in seconda battuta, serve agli alessandrini per rimarcare lasuperiorità e l’onnicomprensività della posizione platonica rispettoa quella aristotelico-peripatetica e stoica: se i secondi, ciascuno a suo
182
__________________13 Non c’è qui lo spazio per prendere in esame la concezione della logica
presentata da Aristotele e poi ripresa da Alessandro. Mi limito a rimandare ailavori di K. Ierodiakonou, Aristotle’s use of examples in the Prior Analytics, Phro-nesis 37, 2002, in part. pp. 135-137, di J. Barnes, Osservazioni sull’uso dellelettere nella sillogistica di Aristotele, Elenchos 27, 2006, pp. 277-304 e dellostesso Correia, Philoponus on the Nature of Logic…, pp. 253-254. In questi ar-ticoli sono spiegati alcuni passi aristotelici che lasciano intendere sia un usonon formalistico delle lettere nella costruzione del sillogismo sia un uso del sil-logismo costantemente legato a termini che hanno un significato preciso nellarealtà empirica e dove la forma sillogistica mette in luce l’universalità del tipodi argomentazione.
modo, sostengono in maniera unilaterale una sola della due funzionidella logica, solo il primo invece riconosce l’ampiezza di questa di-sciplina che può essere parte e strumento della filosofia
A sostegno di una tale tesi si possono portare numerose evidenzetestuali. Olimpiodoro, ad esempio, immagina che Platone, erigen-dosi ad arbitro della contesa tra Stoici e Peripatetici, così si rivolgaloro:
Entrambi, dice, per me vincete; per questo ciascuno di voi è ricco diargomentazioni, perché la logica è sia parte sia strumento della filosofia;e dite la verità, uomini, e combattete senza combattervi, infatti la logicaè sia parte sia strumento [della filosofia]. E non pensiate che io dicaquesto, che sono parte e strumento allo stesso modo, infatti [la logica]sotto un certo aspetto è parte sotto un altro aspetto è strumento […].È strumento quando viene formulata in vuoti schemi come quandodico che “da due premesse universali affermative si deduce una con-clusione universale affermativa”; è parte quando viene considerata in-sieme ai contenuti stessi, come quando dico “l’anima è se-movente,ciò che è se-movente è immortale, dunque l’anima è immortale”, e dinuovo “tutto ciò che è giusto è buono, tutto ciò che è buono è bello,dunque tutto ciò che è giusto è bello (17, 20-24; 32-37).
In Platone trovano così spazio tanto le istanze che fanno della lo-gica una parte della filosofia quanto le istanze che la ritengono unostrumento. Come non manca di notare Ammonio, a differenza diAristotele che propone meri schemi a cui applica le lettere:
Platone invece usa la logica sia come parte sia come strumento: quandoinfatti applica questi schemi alle realtà e si avvale su di esse di sillogismi,ad esempio quando afferma «l’anima è se-movente, ciò che è se-mo-vente è in moto perpetuo, ciò che è in moto perpetuo è immortale,quindi l’anima è immortale», in questo caso, nell’usare la logica insiemeagli oggetti che ad essa soggiacciono, la usa come parte. Quando inveceanche lui propone solamente metodi formali e meri schemi senza realtàcui applicarli, usa la logica come strumento (11, 8-14).
Ecco dunque esplicitata la superiorità di Platone: una superioritàconfortata dal fatto che egli può affermare che la logica è parte estrumento della filosofia senza cadere in contraddizione. Per dimo-strare che Platone non è accusabile di diafwniva i commentatori ri-corrono all’“omonimia”: ci sono molti casi in cui si usa lo stessonome per indicare una cosa che può essere sia parte sia strumento.
183
Ecco la spiegazione di Ammonio:
Non c’è nulla di meraviglioso se la medesima cosa si chiama con lostesso nome sia in quanto parte sia in quanto strumento; in molti altricasi infatti accade una cosa analoga: si chiama cubito, per esempio, sial’unità di misura sia ciò che misurato risulta essere lungo un cubito, epoco importa che si tratti tanto di un pezzo di legno quanto di qua-lunque altra cosa [chiamiamo cubito sia la misura sia il misurato] oche si tratti di qualcosa di umido oppure di qualcosa di secco. E così,qualora si consideri l’attività logica insieme alle realtà che ne sono og-getto, la si chiami parte della filosofia, qualora invece si considerino imeri schemi senza le realtà corrispondenti, la si chiami strumento (11,14-21).
Non c’è allora di che stupirsi se Platone chiama con lo stessonome lo strumento e la parte della filosofia perché egli ha compiutoun’operazione analoga a quella svolta quotidianamente dal linguag-gio comune quando si chiama cubito sia l’unità di misura sia ciòche è misurato, di qualunque materiale esso sia fatto.
Si trova un uso dell’omonimia del tutto simile anche in Filopono(9, 13-17), Olimpiodoro (17, 27-29) ed Elia, con la sola differenza,per gli ultimi due, che al posto del cubito è citato quale tipo di unitàdi misura il sestiere. Elia chiarisce bene il rapporto analogico tra ilsestiere e la logica: «e il sestiere, anche se è parte e strumento dellostesso liquido, non è però lo stesso [sestiere]; parte infatti [è il sestiere]in quanto liquido che è stato misurato, strumento invece [è il se-stiere] in quanto vaso che misura» (136, 13-15). Se perciò il sestierenon è lo stesso sestiere, allo stesso modo la logica, che è parte e stru-mento della filosofia, non è la stessa logica: la logica è parte quandoè accompagnata dai contenuti, è invece strumento quando è privadei contenuti e consiste solo di vuoti schemi.
Nell’argomentare in favore del doppio valore della logica l’esem-pio del cubito sembra essere un esempio pensato ad hoc perché di-mostra che rispetto allo stesso oggetto (la filosofia) la logica in quantoparte non è la stessa cosa della logica in quanto strumento.
La domanda cui l’omonimia vuole dare risposta è ben espressaancora da Elia:
«e com’è possibile, o Platone, che una medesima cosa sia tanto partequanto strumento di uno stesso oggetto? […]E anche adesso Platonerisponderebbe: ma la logica è parte, [quando è inserita] nelle realtà in-
184
tellegibili, ad esempio [quando si afferma] “l’anima è se-movente, ciòche è semovente è sempre in movimento, l’anima dunque è sempre inmovimento”, [la logica è] invece strumento negli schemi, ad esempionella prima figura: da due [premesse] universali affermative segue una[conclusione] universale affermativa» (136, 10-19).
Ma da quali testi di Platone i commentatori alessandrini dedu-cono la risposta del maestro sulla natura della logica, ricavandonecosì la sua superiorità rispetto ad Aristotele? In che senso poi la logicaè parte della filosofia? E, in ultimo, perché sia possibile compierequesta operazione, come deve essere intesa la filosofia di Platone?
5. Il testo di Ammonio in questo caso non è di grande aiuto, poi-ché il commentatore, quando espone la posizione di Platone, nonmenziona né i dialoghi in cui la logica è usata come parte della filo-sofia né quelli in cui è considerata come strumento solo nella formadi vuoti schemi. Si può tuttavia desumere che Ammonio reputi ilFedro un dialogo in cui la logica è parte della filosofia a partire dalfatto che l’esempio da lui scelto come emblema della logica legata aicontenuti non è altro che una sintesi della prova dell’immortalitàdell’anima offerta da Platone in Phdr. 245 c-246 a.14 Ora l’esempioscelto da Ammonio per mostrare la logica in quanto parte della fi-losofia è in Platone un chiaro esempio di dialettica.
Ciò significa che Ammonio tratta come sinonimi i termini di lo-gica e di dialettica: la dialettica è la logica in quanto insieme dei modi
185
__________________14 Come mostrato da A. Longo, La réécriture analytico-sillogistique d’un ar-
gument platonicien en favour de l’immortalité de l’âme (Plat. Phaedr. 245 c 5-246 a 2): Alcinoos, Alexandre d’Aphrodise et Hermias d’Alexandrie, PhilosophieAntique 9, 2009, pp. 145-163, l’argomento dell’immortalità dell’anima trattodal Fedro è stato oggetto di numerose traduzioni in forma sillogistica anche daparte di autori “platonici” al fine o di mostrarne la sua coerenza con i metodipropri della dialettica esposti in astratto nel Parmenide (Alcinoo) o di ordinarelogicamente l’argomento di Platone così da esplicitarne la sua inconfutabilitàe la sua capacità di comprendere al suo interno l’apparentemente diversa po-sizione aristotelica (Ermia). È plausibile pensare che questa riscrittura anali-tico-sillogistica dell’argomento platonico fosse ben nota ad Ammonio e aglialtri commentatori alessandrini e che essi l’abbiano utilizzata come esempiodella dialettica in quanto parte della filosofia, in cui ai meri schemi di conca-tenazione logica si accompagnano i contenuti filosofici.
del corretto argomentare riempita dagli oggetti della filosofia15. Ciòd’altro canto era già emerso quando Ammonio parlava di quei Pla-tonici che considerano la logica la parte più nobile della filosofia.Posta questa identificazione dei significati di logica e dialettica è plau-sibile individuare in questi tine;" tw~n Platwnikw~n Plotino e i suoiallievi16. Da “buon platonico” Plotino, distinguendo l’ambito dellalogica da quello della dialettica, faceva della prima una disciplinapropedeutica alla seconda: in questo quadro la dialettica era la partepiù nobile (timiwvtaton) della filosofia (enn. I 3, 5, 23) e la logica,in quanto insieme di yila; qewrhvmata kai; kanovne" (I 3, 5, 11),uno strumento introduttivo alla dialettica. Una volta sancita l’iden-tità di logica e dialettica la soluzione plotiniana è per Ammonio ina-deguata sia per difetto – è troppo riduttivo fare della logica a unostrumento introduttivo, sia per eccesso – è esagerato ritenere che essasia la parte più nobile della filosofia.
Questa equivalenza di logica e dialettica è comune a tutta la scuolaalessandrina come si può notare da questo passo di Filopono17:
Costui [Platone] infatti, senza avere in se stesso opinioni contrastantie senza cadere in contraddizioni, afferma che la dialettica è sia partesia strumento della filosofia. Ma qualora egli esamini la dialettica in sée per sé separata dalla materia e dai contenuti, cioè la dialettica consi-derata in relazione alla ragione e al pensiero priva della sua applicazionepratica, allora la prende come strumento; qualora invece la considerinella sua applicazione e nel suo esercizio di contenuti, allora essa adem-pie, secondo lui, la sua funzione di parte […]. Così anche la dialetticain Platone: nel Fedone e nel Fedro infatti egli la considera come parteinsieme alla materia, mentre nel Parmenide come strumento senza lamateria. E in una “parola” a prescindere dalla materia [la dialettica]
186
__________________15 Proprio in riferimento a questo passo di Ammonio P. Hadot, La logique,
partie ou instrument de la philosophie?…, p. 188, parla di una «confusion totale»tra logica e dialettica che darà luogo a quelle «ambiguïtés du vocabulaire» checaratterizzeranno tutta la storia del problema concernente lo statuto della logica.
16 Cfr. P. Hadot, La logique, partie ou instrument de la philosophie?…, p.187. Sulla possibilità che Ammonio apprenda dell’esistenza di questi tine;"tw~n Platwnikw~n non dalla lettura diretta del testo plotiniano ma dalla me-diazione di Proclo il quale cita la posizione di Plotino senza nominarlo diret-tamente cfr. le interessanti osservazioni di A.C. Lloyd, The Anatomy ofNeoplatonism, Oxford 1990, pp. 19-20.
17 Lo stesso fanno Olimpiodoro (14, 20-27) e Elia (136, 3-7).
verrà usata come schema di ragionamento e come strumento, applicataalle realtà sarà invece parte (9, 3-9, 17-20).
Il primo dato di fatto è che il passaggio da logica a dialettica è peri neoplatonici alessandrini un passaggio del tutto naturale, come se sistesse parlando della medesima cosa. È probabile che l’origine di questaconfusione tra i due termini sia stata originata dalle tripartizione dellafilosofia operata dal platonismo imperiale in cui la dialettica occupavail posto che nella tripartizione stoica spettava alla logica; ma è altrettantoprobabile che nei commentatori alessandrini questa confusione sia di-venuta canonica: logica e dialettica sono semplicemente due sinonimi.
Una volta accettata l’equivalenza di significato tra logica e dia-lettica, gli alessandrini individuano un’accezione della logica inquanto parte (schemi del ragionamento più contenuti teoretici), eun’accezione della stessa in quanto strumento (semplici e vuotischemi di ragionamento).
Ma è davvero riscontrabile nei testi di Platone questa duplice na-tura della logica?
Certamente non è difficile trovare numerosi brani platonici incui si parla della dialettica e in cui la dialettica è effettivamente usata,legata ai contenuti, come scienza propria del filosofo: la dimostra-zione dialettica dell’immortalità dell’anima del Fedro è per gli ales-sandrini l’esempio paradigmatico. Ben più difficile è invece trovarebrani dei dialoghi in cui Platone si occupa della logica come stru-mento, come insieme di meri schemi di ragionamento, soprattuttoalla luce del fatto che nel pensiero di Platone non si trova niente disimile all’analitica aristotelica o alla logica stoica. Eppure nell’esegesidei commentatori alessandrini vi è un dialogo che svolge questoruolo: come esplicitato da Filopono questo dialogo è il Parmenide.
La scelta di quest’opera potrebbe inizialmente destare qualcheperplessità, dal momento che l’esegesi del Parmenide ha costituitouno dei fondamenti della filosofia neoplatonica fino a divenire conProclo l’apice supremo della teologia platonica18. Com’è possibile
187
__________________18 Cfr., ad esempio, H.D. Saffrey, Recherches sur le néoplatonisme après Plo-
tin, Paris 1990, pp. 173-184, il quale mostra che la teologia platonica di Procloè l’esito finale delle diverse interpretazioni della seconda parte del Parmenide,partendo da quella “metafisica”di Plotino e passando per le esegesi di Teodorod’Asine e Siriano.
allora che proprio a quest’opera sia attribuito il valore di “spiegazionetecnica” della logica di Platone?
Il fatto ha tuttavia una sua ragion d’essere perché, come suggeritoda Proclo19, vi è stata una corrente di pensatori platonici, attivi neiprimi due secoli della nostra era, che aveva interpretato il Parmenidecome un esercizio logico senza scorgere in esso la sua dimensionemetafisica e teologica.
Nelle divisioni di età imperiale delle opere di Platone il Parmenidefa parte dei dialoghi logikoiv, i quali sono una sottospecie dei dialo-ghi uJfhghmatikoiv, ossia i dialoghi “istruttivi”. Perciò questi dialoghidevono istruire il lettore sulla dottrina logica di Platone: «ils nousenseignent les différents moyens de connaître la vérité: la démons-tration, la définition, la division et l’analyse»20. Il Parmenide si ritrovain questo gruppo perché costituisce una presentazione importantedel metodo dialettico e del sillogismo ipotetico. Non è allora un casoche Alcinoo utilizzi proprio il Parmenide per illustrare la logica diPlatone che egli presenta nel suo manuale21.
Non deve quindi stupire che, nel tentativo di trovare un dialogo incui la logica sia trattata solo nella sua funzione strumentale, i commen-tatori alessandrini abbiano guardato con interesse all’esegesi mediopla-tonica che vede nel Parmenide una logikh; gumnasiva, un eserciziodialettico e una tecnica dell’argomentazione per alcuni aspetti antici-
188
__________________19 Cfr. in Parmen. 631, 5-14 (Cousin). Per quanto concerne la testimonianza
procliana di questa lettura logica del Parmenide in età imperiale cfr. l’eccellentearticolo di C. Steel Proclus et l’interprétation “logique” du Parménide, in L. Be-nakis (ed.), Néoplatonisme et philosophie médiévale, Turnhout 1997, pp. 68-92.
20 Così C. Steel, Proclus et l’interprétation “logique” du Parménide…, p. 78.Do qui per accettate le osservazioni di Steel sull’effettiva esistenza di questainterpretazione “logica” del Parmenide e rimando al suo lavoro per quanto ri-guarda le ragioni della ricezione del Parmenide nel cosiddetto medioplatonismo(in part. pp. 74-80). Sulle ragioni di questa lettura “logica” del dialogo si vedaanche quanto scritto da Dillon nella General Introduction alla sua edizione in-glese dell’In Parmenidem (Proclus’ Commentary on Plato’s Parmenides, transla-ted by G.R. Morrow-J. M. Dillon with introduction and note by J.M. Dillon,Princeton 1987) alle pp. XXV-XXVI.
21 In più di un passo del Didaskalikos Alcinoo fa riferimento al Parmenidee alle ipotesi in esso trattate presentandoli come esempi dei differenti tipi didimostrazione e di sillogismo. Ecco un elenco dei passi principali: V, p. 156,24-33; VI, pp. 158, 42-159, 3; 159, 4-6; 9-14; 16-19; 25-27; 42-43.
patrice dei Topici aristotelici22. Recuperare un’interpretazione logica delParmenide significava trovare nella filosofia di Platone un dialogo nelquale egli si occupava in senso tecnico-strumentale della logica, e quindiavere la possibilità di opporre all’analitica e alla dialettica aristotelica unanalogon platonico, che attesti, già in Platone, l’esistenza di una dialet-tica come studio delle corrette forme dell’argomentazione accanto auna dialettica intesa come scienza dell’intellegibile.
Se è indubbio che i commentatori neoplatonici abbiano attintoa piene mani dal proemio agli Analitici Primi di Alessandro d’Afro-disia nella loro disamina sulla natura della logica, è anche molto pro-babile che, oltre all’esegesi medioplatonica del Parmenide, glialessandrini accettino anche il legame istituito da Alessandro tra laconcezione e l’uso della dialettica nei Topici e la concezione e l’usodella dialettica nel Parmenide. Anche la relazione tra i due testi sta-bilita da Alessandro confermava, nella sua esegesi, il fatto che in Pla-tone era presente un’idea della dialettica, intesa come studio suimetodi argomentativi da utilizzare in una discussione, da contrap-porre a quella di Aristotele.
È chiaro che in una prospettiva di questo genere Platone potevaessere considerato la sintesi delle istanze peripatetiche e stoiche sullanatura della logica, giacché nei suoi testi dimorava una concezioneche rendeva ragione della logica sia in quanto parte sia in quantostrumento della filosofia. Per di più l’interpretazione logica del Par-menide rendeva altrettanto manifesta la superiorità filosofica di Pla-tone rispetto ad Aristotele.
Queste ragioni spiegano il motivo in forza di cui i neoplatonicialessandrini abbiano privilegiato l’interpretazione logica del Parme-nide e abbiano considerato platonica la tesi che la logica sia tantoparte quanto strumento della filosofia.
D’altro canto che il Parmenide potesse essere letto in chiave logicaera reso necessario dalle parole stesse con cui Platone indicava l’eser-cizio dialettico di Parmenide, ossia gumnasiva e ajdolesciva. Elia
189
__________________22 Sulle possibili affinità tra l’esercizio del Parmenide e i Topici si veda Alex.
Aphr. In Top., p. 27, 27-31 (Wallies). Al riguardo non posso che rimandare dinuovo alla disamina di C. Steel, Proclus et l’interprétation “logique” du Parmé-nide…, pp. 70-73, il quale mette in luce, usando come spettro il commentoprocliano al Parmenide, somiglianze e differenze fra la dialettica di Parmenidenel dialogo omonimo e quella descritta da Aristotele.
spiega che i due termini non erano affatto casuali: «perciò egli [Pla-tone] chiama la logica che consta di schemi “esercizio” e “vana chiac-chiera”: “esercizio” nella misura in cui essa ci prepara alle cose, “vanachiacchiera” nella misura in cui essa ci allontana dalle cose»23.
Per Elia però non è solo il Parmenide a certificare l’esistenza, inPlatone, di una logica come tecnica dell’argomentazione: come faAristotele nei Topici «è possibile che anche Platone affermi che la lo-gica è strumento della filosofia quando sostiene che la dialettica ècoronamento di tutte le cose che sono; e infatti gli schemi, dal mo-mento che sono giustamente fuori dal coronamento, custodisconoi contenuti» (137, 1-3).
Elia qui sembra fare un ragionamento di questo genere: la dia-lettica, in quanto sistemazione e disposizione dei contenuti della fi-losofia, costituisce, per questo suo legame con i contenuti, ilcoronamento di tutte le cose che sono, ma nel coronamento nonc’è spazio per i kanovne", i quali, pur ordinando i contenuti, sonoaltro da essi e quindi, presi di per sé, non possono fare parte del co-ronamento delle cose che sono.
Questa battuta di Elia, insieme a un già citato passo di Filopono(8, 23-27), è un prezioso segnale che rivela a costo di quali defor-mazioni della sua filosofia Platone può essere considerato la sintesidelle posizioni stoiche e peripatetiche sulla natura della logica.
Nella prospettiva dei commentatori alessandrini si può ipotizzareche Platone esponga la sua dimostrazione sull’immortalità del-l’anima, che è una dottrina di natura teoretica, attraverso i metodiargomentativi da lui stesso presentati nel Parmenide.
Ma in un quadro di questo genere resta irrisolta la natura di taledimostrazione: quale parte della filosofia concerne se, per contenuti,essa dovrebbe rientrare nella parte teoretica ma, in quanto dimostra-zione, dovrebbe piuttosto rientrare nella parte logico-dialettica incui, appunto, ai vuoti schemi di ragionamento si accompagnanocontenuti filosofici positivi?
Nei termini del cubito e del sestiere si può dire che intesi inquanto parte il cubito e il sestiere possono certamente essere fatti diqualsiasi materiale solido o liquido e poi essere usati per definire tale
190
__________________23 Cfr. al riguardo anche Olimpiodoro (14, 24-27).
materiale: un legno di quattro cubiti o tre sestieri di vino. Ma ciònon toglie che il contenuto di queste parti è soltanto o legno o vino.
Se trasponiamo l’esempio nei termini del rapporto tra la dialetticae le due parti della filosofia si può asserire che la dialettica in quantoparte, proprio per il suo legame con gli oggetti della filosofia, deverientrare o nella parte teoretica o nella parte pratica della filosofia:non basta sostenere che un determinato argomento è espresso in unaforma dialettica perché esso appartenga alla parte dialettica della fi-losofia, in forza delle realtà di cui tratta esso rientrerà necessariamentein una delle altre due parti. In sintesi: un argomento teoretico veroè automaticamente anche un argomento vero e corretto dal puntodi vista logico e dialettico, per cui tale argomento ha naturalmentein sé entrambe le nature (teoretica e dialettica); non può tuttavia va-lere l’inverso perché un argomento corretto sul piano logico non ènecessariamente un argomento corretto sul piano teoretico.
Se ciò è vero allora quel che rimane della dialettica, una volta chei commentatori alessandrini ne hanno sancito la sua identità con lalogica, è il suo carattere di tecnica dell’argomentazione, di teoriadegli schemi di ragionamento: ciò che rimane della dialettica è, inuna parola, la sua funzione di strumento ma si perde del tutto il suovalore di parte.
Questo svuotamento della dialettica platonica è dovuto al fattoche i neoplatonici alessandrini, sulla scia delle divisioni in parti dellafilosofia, fanno della filosofia di Platone un sistema di dottrine ca-pace di raccogliere al suo interno tutte le posizioni apparentementedivergenti.
La filosofia di Platone però non è uno strutturato insieme di teo-rie positive catalogabili nella tripartizione ellenistica della filosofia,dal momento che il pensiero platonico più che teoretico e pratico èsostanzialmente dialettico: dialettico è infatti il procedimento euri-stico che porta alla formulazione di logoi, che sappiano descriverenel modo più veritiero possibile l’oggetto che si è scelto di indagare.
Perciò una difficoltà di cui i commentatori sembrano non tenereconto nella loro ricostruzione, ma che in realtà emerge chiaramentedai loro stessi presupposti, è la difficoltà a individuare con chiarezzail campo specifico e autonomo della dialettica in quanto parte dellafilosofia – dal momento che tutto ciò che concerne la sfera dialetticaappartiene, ultimamente, alla parte teoretica o a quella pratica chesono, come scrive Filopono, ciò che «per natura è la filosofia». Que-
191
sta difficoltà è dovuta al fatto che in Platone vi è soltanto la partedialettica della filosofia, o meglio, che la filosofia di Platone è essen-zialmente dialettica.
Ora, poiché il punto di partenza dei neoplatonici alessandrini èinvece la tripartizione di quel sistema dottrinale compiuto che è lafilosofia, va da sé che essi non possano farvi rientrare la filosofia diPlatone se non al prezzo di quella confusione totale tra dialettica elogica che emerge nei loro proemi; tale confusione non è solo il sin-tomo di una perdita dell’effettivo significato che Platone attribuiscealla dialettica ma è anche il segno di un paradosso: se portata fino allesue ultime conseguenze la soluzione dei commentatori alessandrinifa della logica in quanto parte della filosofia un insieme vuoto, o me-glio un insieme che non c’è. Così la dialettica, che era il cuore dellafilosofia platonica, è la parte che meno si accorda con la concezionedella filosofia di Platone elaborata dai commentatori alessandrini.
6. Il desiderio di fare di Aristotele un’introduzione a Platone –elemento che accomuna il neoplatonismo alessandrino a quello ate-niese – è il motivo che spinge i commentatori alessandrini a recupe-rare le soluzione teoriche del platonismo di età imperiale poiché essisembrano considerarle le soluzioni più funzionali a fronteggiarequello che è l’interlocutore cui è necessario rispondere, ossia Ales-sandro di Afrodisia. In risposta ai problemi da lui sollevati gli ales-sandrini articolano una soluzione del problema della logica che vuolecertificare la superiorità di Platone rispetto ad Aristotele.
Il prezzo da pagare per questa superiorità è tuttavia salato e mo-stra come il tentativo di rispondere more platonico a istanze peripa-tetiche si riveli del tutto incompatibile con una rispettosa esegesidella filosofia di Platone24.
192
__________________24 Il tentativo di rispondere “platonicamente” a problemi posti dalla tradi-
zione peripatetica accomuna la scuola neoplatonica alessandrina a quella ate-niese. M. Bonazzi (Siriano, gli efettici e l’orthe doxa, in A. Longo (a cura di),Syrianus et la métaphysique de l’Antiquité tardive, Napoli 2009, pp. 439-460)dimostra che anche Siriano, per eliminare lo scetticismo come opzione filoso-fica, non esita ad armonizzare Platone e Aristotele integrando argomentazioniaristoteliche con dottrine platoniche e chiarendo dottrine platoniche sulla basedi riflessioni di Aristotele. Il che se da un lato conferma una certa unità d’in-tenti e una certa continuità di pensiero tra le due scuole, soprattutto riguardo
ABSTRACT
The paper intends to examine the discussion on the role that the logic playsin relation to philosophy in the commentaries of the commentators of theneoplatonic school of Alexandria. The aim of this analysis is to show that theirtreatment of the status of the logic is a paradigmatic example of the impossi-bility to harmonize the two main philosophers of the Antiquity. The assimi-lation of Aristotle’s philosophy in the Plato’s one can be obtained only byassigning the same meaning to two different theoretical activities as the logicand the dialectic. This confusion of meanings implies a complete misunder-standing of Plato’s philosophy and points out the opposite goal to the one theAlexandrian Neoplatonics want to reach: instead of highlighting the superiorityof Plato towards Aristotle, their treatment of logic shows that it’s impossibleto answer, more platonico, to an Aristotelian problem.
193
__________________l’interpretazione di Aristotele da un punto di vista neoplatonico (come affer-mato da I. Hadot, The role of the commentaries on Aristotle…, pp. 176, 188-189); dall’altro segnala che proprio il ricorso ad Aristotele, a cui fare spazioall’interno di un unitario sistema platonico, rischia di rivelarsi per un platonicodogmatico «un abbraccio mortale» (così M. Bonazzi, p. 460).