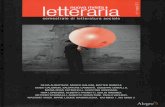I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra. Giacomo Lercaro (1947-1968)
Transcript of I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra. Giacomo Lercaro (1947-1968)
I VESCOVI ITALIANI E LA DIALETTICA PACE··GUERRA.GIACOMO LERCARO (1947-1968)'"
Giuseppe Battelli
Nel panorama degli studi dedicati ai vescovi italiani e alla loro attività pastorale e di governo nel corso del Novecento! il problema relativo allo svolgimento di quella attività in situazioni di guerra risulta ripetutamente affrontato: talvolta in specifiche ricerche di storia episcopale, tal' altra nel quadrodi indagini di l'ili largo profilo riferite all'insieme della Chiesa italiana. Si potrebbe dunque concluderne, per estensione, che l'atteggiamento dell'episcopato nazionale di fronte alla dialettica pace-guerra sia già stato analizzato insede storiografica. Non è cosi. Obiettivo prevalente di quegli studi è stato infatti mettere a fuoco la partecipazione l'ili o meno velata alla propaganda, lamediazione con i belligeranti e soprattutto l'assistenza alla popolazione, nelle quali si profuse la gerarchia cattolica durante gli eventi bellici che coinvolsero in modo diretto il nostro paese, in particolare le due guerre mondiali e subordinatamente le operazioni militari connesse alle iniziative colonialiin Africa. Le acquisizioni che ne sono scaturite hanno cosi gettato luce su unaspetto specifico: la disponibilità dei vertici cattolici a dare un contributo all'impegno bellico italiano nelle suddette circostanze.Tale aspetto tuttavia, se risulta centrale nello studio dei rapporti tra Chiesa,Stato e nazione in Italia, non sfiora se non incidentalmente l'altro problema:quale fosse in sé la posizione dell' episcopato riguardo alla dialettica paceguerra. Quali fossero cioè - al di là dell'inserimento della guerra nel quadrodelle manifestazioni del castigo di Dio, alla stregua dunque della tradiziona-
" Questo contributo costituisce un sensibile ampliamento della relazione presentata a Milano nell'ambito del convegno su Chiesa e guerra. Dalla «benedizione delle armi» alla Pacemin terris (aprile 2003), organizzato dal Centro ecumenico europeo per la pace e dall'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.l Per uno sguardo generale sull'episcopato italiano nella prima metà del Novecento G. Battelli, Santa Sede e vescovi nello Stato unitario. Dal secondo Ottocento ai primi anni della Repuhhlica, in Storia d'Italia, Annali, 9: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 809··854; A.Monticone, L'episcopato italiano dall'Unità al concilio Vaticano II, in M. Rosa (a cura di),Clero e società nell'Italia contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 257-330.
368 Giuseppe Battelli
le lettura delle catastrofi naturali o delle epidemie i suoi orientamenti diprincipio; e quale risultasse il suo giudizio di fronte a concreti scenari bellici lontani tuttavia dal nostro territorio e dai problemi e condizionamenti adesso connessi. Scenari bellici nei cui confronti poter esprimere pertanto unavalutazione non filtrata dagli alterni rapporti tra Santa Sede e realtà politicosociale nazionale che fecero da sfondo nei primi decenni del Novecento aiconflitti mondiali e alle iniziative espansionistiche in Libia ed Etiopia. Mentre un caso in certa misura a sé stante risultò quello della guerra civile spagnola, per lo più vissuta dalla gerarchia cattolica italiana in termini di contrapposizione ideologica al comunismo e di plauso al sostegno militare offerto a Franco dal governo fascista.Rispetto a un'indagine storiografica su quegli orientamenti di principio, quindi ancora largamente inedita', è di un certo interesse ricostruire il percorsodi Giacomo Lercaro. Esponente autorevole del collegio cardinalizio, tanto darisultare tra i principali candidati e quantomeno tra i maggiori elettori di Paolo VI al conclave del 1963. Figura di rilievo nella storia religiosa internazionale di metà Novecento e dello stesso Concilio Vaticano II. E, riguardo allatematica pace-guerra, protagonista di una scelta unica nel panorama episcopale italiano del tempo: la decisione di chiedere pubblicamente il I" gennaio1968 la sospensione dei bombardamenti americani sul Vietnam del Nord.Esteso tra il 1947 e il 1952 a Ravenna e tra il 1952 e il 1968 a Bologna il suogoverno episcopale non passò mai inosservato. Spesso, infatti, l'opinione pubblica si trovò di fronte alle iniziative atipiche di questo presule: coreografieper accentuare l'impatto sociale di talune celebrazioni liturgiche o per connotare religiosamente certe ricorrenze popolari; tentata conquista elettoraledell' amministrazione civica bolognese giocando nel 1956, contro il tradizionale e vincente blocco delle sinistre, la carta a sorpresa del ritorno alla poli.tica di Giuseppe Dossetti; plateale manifestazione del proprio sdegno anticomunista o antilaicista, affidata all'addobbo alutto degli edifici religiosi della città e al rintocco funebre delle campane nella duplice circostanzadell'invasione sovietica dell'Ungheria e della condanna del vescovo di PratoFiordelli per la vicenda dei coniugi Bellandi'. Al di là tuttavia del clamore e
2 Un raro contributo è offerto da G. Vecchio, Pacifisti e obiettori nell'Italia di De Gasperi(1948-1953), Roma, Studium, 1993, in particolare pp. 133 sgg., che esamina la presa di posizione di alcuni vescovi italiani che si verificò nel 1950 di fronte al rischio di proliferazione nucleare.3 Per tali iniziative e il profilo complessivo di governo episcopale al cui interno si inserirono G. Battelli, Tra chiesa locale e chiesa universale. Le scelte pastorali e le linee di governo dell'arcivescovo di Bologna Giacomo Lercara (1952-1968), in Chiese italiane e Concilio.Esperienze pastorali nella chiesa italiana tra Pio XII e Paolo VI, a cura di G. Alberigo, Ge ..nova, Marietti, 1988, pp. 151·185, e G. Alberigo, Un vescovo e un popolo, in Araldo delVangelo. Studi sull'episcopato e sull'archivio di Giacomo Lercara a Bologna (1952-1968), Bo..
369 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
dei consensi/dissensi suscitati nelle diverse circostanze, qual era davvero lacifra di quel governo episcopale?Se un giornalista nordamericano nel maggio 1955 affermò a riguardo che nonc'era probabilmente nella Chiesa cattolica dell' epoca un prelato altrettantocontroverso", Lercaro scelse l'immagine veterotestamentaria dei soldati dell'esercito di Esdra: che con una mano costruivano le mura della nuova Gerusalemme, mentre con l'altra combattevano'. Costruttore e combattente, dunque. In ogni caso nulla a che vedere con un profilo anche solo remotamente riconducibile alla problematica della pace. Né si può dire che la successivaevoluzione di quella prima immagine lercariana abbia ruotato sin dall'inizioe in via prioritaria attorno al motivo della pace. Perché, qualora si osservi l'idea pur composita che si venne formando di Lercaro chi lo conobbe da vicino solo alla vigilia o durante il Concilio, ci s'imbatte certamente nella ecodella figura costruita negli anni precedenti dalla stampa, nel riconosciuto specialista di liturgia, nel propugnatore della «Chiesa dei poveri» e in generale - nell' appartenente al novero dei leader della maggioranza conciliare diorientamento progressista"; ma si cercherebbero invano chiari segni di unasua vera o presunta identità di uomo di pace.Poi, il I o gennaio 1968, Lercaro pronunciò nella cattedrale bolognese di SanPietro un' omelia destinata a rimanere famosa, perché contenente la richiestadi sospensione dei bombardamenti americani di cui si è detto. Ritorneremotra poco su quelle parole e sul contesto specifico nel quale furono pronunciate. Ora invece vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che tale discorso, assai noto e non a caso recentemente richiamato da Giovanni Miccoli in un'estesa panoramica su La guerra nella storia e nella teologia cristiana', è già sta-to oggetto di analisi o perlomeno di ampie sottolineature". In tali circostanze
logna, Il Mulino, 2004, pp. 103-132. Manca a tutt'oggi un valido studio sul quinquennioravennate.4 V.R. Tortora, Cardinal Lercara of Bologna, in «The Catholic Worker», maggio 1955, p. 5.5 Durante gli anni Cinquanta Lercara si richiamò più volte ai «soldati di Esdra». L'edizione di uno di quei testi la collega a 2 Esdra 4,11. Il rinvio è corretto rispetto alla tradizione della Vulgata: «Aedificantium in muro et portantium onera et imponentium, unamanu sua faciebat oPUS et altera tenebat gladium». Nelle versioni dell'Al' che seguono invece la Bibbia ebraica il brano è presente in Neemia 4,11.6 Indicativi, riguardo a questa fisionomia sfaccettata, gli incontri che Lercaro ebbe a Romacon vescovi extraitaliani nella fase iniziale del concilio (G. Lercara, Lettere dal Concilio1962-1965, Bologna, Edb, 1980, pp. 75, 96,110-111, e passim).7 Per un riferimento d'insieme G. Battelli, Lercaro, Dossetti, la pace e il Vietnam: «1° gennaio 1968», in Araldo del Vangelo. Studi sull' episcopato, cit., pp. 185-306.8 G. Miccoli, La guerra nella storia e nella teologia cristiana. Un problema a molteplici facce, in Pace e guerra nella Bibbia e nel Corano, a cura di P. Stefani e G. Menestrina, Brescia, Morcelliana, 2002, pp. 103-141, in particolare p. 138.9 In particolare M. Toschi, Pace e Vangelo. La tradizione cristiana difronte alla guerra, Bre-
370 Giuseppe Battelli
una particolare chiave interpretativa si è delineata in modo del tutto prevalente. La predicazione sulla pace vi è stata infatti individuata come coronamento quasi simbolico della fase postconciliare e finale dell'episcopato diLercaro; fase recepita come insieme e con fisionomia esemplare, momentopro/etico per eccellenza dell'intero ministero lercariano ai vertici della diocesi di Bologna.È una chiave di lettura suggestiva, ma non costituirà il perno essenziale diquesto contributo. Nel quale - analizzando sia gli elementi prettamente religiosi sia i fattori di natura ideologica e politica che entrarono in gioco simirerà piuttosto a ricostruire il percorso complessivo secondo il quale 1'0melia del I" gennaio 1968 e altri interventi di Lercara della fase postconciliare si inserirono con linearità o con scarto nel quadro della riflessione sulla pace e la guerra da lui proposta durante l'intera arco del suo episcopato.Prospettiva che, rispetto al panorama degli studi sui vescovi richiamato inapertura, potrebbe anche fornire elementi di confronto con altre coeve esperienze episcopali; pur non sottovalutando il fatto che il carattere a vario titolo singolare dell' esperienza episcopale di Lercara rende la stessa solo in par-te rappresentativa rispetto al percorso pastorale e di governo della maggio-ranza dei vescovi italiani.
1. La «non tematizzazione» della pace nelle diocesi lercariane del secondo dopoguerra. Come si è già detto, il tema della pace risultò marginale in una primae lunga fase dell'episcopato lercariano. La cosa può forse stupire se vista inrapporto allo sviluppo successivo di quella riflessione, ma non in sé e riferitaal secondo dopoguerra. I repertori delle lettere pastorali a tutt'oggi disponibili suggeriscono infatti di considerare il fenomeno come assolutamente comune ai vescovi italiani del periodo" e in linea con il loro tipico arroccamento",Eccezionale nell'Italia dell'epoca fu semmai il caso di Firenze, dove peraltro
scia, Queriniana, 1980, pp. 133-134; G. Dossetti, Memoria di Giacomo Lercaro, in Chieseitaliane e Concilio, cit., pp. 281-312, in particolare p. 309; G. Ruggieri, La profezia dellapace, in Giacomo Lercara Vescovo della Chiesa di Dio (1891-1976), a cura di A. Alberigo,Genova, Marietti, 1991, pp. 165-183, specialmente p. 166.lO Secondo l'ordine cronologico di edizione: Lettere pastorali dei vescovi dell'Emilia-Romagna, a cura di D. Menozzi, Genova, Marietti, 1986; Lettere pastorali dei vescovi della T'oscana, a cura di B. Bocchini Camaiani e D. Menozzi, Genova, Marietti, 1990; Lettere pastorali dei vescovi torinesi, a cura di W. Crivellin e G. Tuninetti, Torino, Quaderni del cen-tro studi «c. Trabucco», 1992; Lettere pastorali dei vescovi della Lombardia, a cura di X.Toscani e M. Sangalli, Roma, Herder, 1998; Lettere pastorali dei vescovi di terra d'Otranto, a cura di D. Del Prete, Roma, Herder, 1999; Lettere pastorali dei vescovi dell'Umbria,a cura di B. Bocchini Camaiani e M. Lupi, Roma, Herder, 1999; Lettere pastorali dei vescovi del Veneto, a cura di M. Malpensa, Roma, Herder, 2002.11 G. Miccoli, Sul ruolo di Roncalli nella Chiesa italiana, in Papa Giovanni, a cura di G. Alberigo, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 175-209, specialmente p. 209.
371 I vescovi italiani e la dialettica pace- guerra
l'impegno che in tal senso vide coinvolti vari settori del cattolicesimo locale silegò più alle iniziative del sindaco La Pira e a un non comune dinamismo della base che non alla declinante guida del cardinale Dalla Costa". Nella Bologna cattolica - in quegli anni e rispetto a Firenze assai più conformista, nellalinea del lungo moderato governo di Nasalli Rocca" - non solo non si ebbetutto questo, ma non si registrò nemmeno un' assenza di richiami alla pace chescaturisse, secondo un atteggiamento diffuso nell'episcopato italiano, da undato di fatto: il non coinvolgimento del paese in alcuno dei conflitti allora inatto, nel quadro o della latente guerra fredda (come la guerra di Corea) o della tentata conservazione (nel caso francese) di ormai fragili domini coloniali.In realtà la Bologna cattolica, inserita in un territorio ora saldamente controllato da amministrazioni locali di sinistra, si sentiva del tutto in una situazionedi frontiera. È dunque a partire da questa specifica percezione che a mio parere si spiegano in negativo 1'assenzadi sostanziosi richiami alla pace come valore in sé e in positivo una linea episcopale riconducibile alla ricordata immagine dei soldati costruttori/combattenti dell'esercito di Esdra.L'esercito di Esdra, dunque. Se si fosse trattato di un estemporaneo richiamo biblico la cosa avrebbe poco rilievo. Era invece una immagine che, purutilizzata da un Lercaro sorprendentemente attento al problema comunicativo", accanto a formule quali «Bologna, diocesi malata», «Bologna cristianarisorge», ecc.", e dunque in un quadro di conflitto ideologico affidato anchea formule ad effetto, svelava per il suo ripetuto ricorrere" (e anche per il suo
12 B. Bocchini Camaiani, Ricostruzione concordataria e processi di sccolarizzazionc. L'azionepastorale di Elia Dalla Costa, Bologna, Il Mulino, 1983, specialmente pp. 336-346, e Id.,La Firenze della pace negli anni del dopoguerra e del Concilio, relazione presentata al convegno su Chiesa e guerra ricordato in apertura.13 Mancano delle convincenti ricostruzioni complessive. Per una descrizione essenziale delsuo sviluppo I. Cassoli, Sulla cattedra di S. Petronio. Il card. G. Battista NasaIli Rocca diCorneliano arcivescovo di Bologna, Bologna, 1975. Ho inserito alcune pagine di analisi nelsaggio Fra età moderna e contemporanea (secoli XIX e XX), in Storia della Chiesa di Bologna, a cura di P. Prodi e L. Paolini, voI. l, Bologna-Bergamo, Bolis, 1997, pp. 285-372, inparticolare pp. 332·342.14 «Per parlare di metodi, ritengo che nello spirito dell'Evangelo L..J ogni forma di accostamento alle popolazioni sia non soltanto utile, ma per il rilievo che ho già fatto sopra, inquesta regione necessaria. Perciò, precisando, direi che la predicazione dev'essere, anzitutto, portata a coloro che non l'ascoltano mai e resa loro accessibile e gradita: quindi, portata anche fuori di chiesa, aiutata con tutti i mezzi che la tecnica moderna può offrire: dall'altoparlante, alla proiezione, alla coreografia» (Come guarisce una diocesi malata. Intervista de «La Rocca» con il Card. Giacomo Lercaro, in «La Rocca», XIII, 1954, n. 11, pp. 1-2,a p. 1 la citazione).15 G. Battelli, VescovI; diocesi e città a Bologna dal 1939 al 1958, in Le chiese di Pio XlI,cit., pp. 257·282, specialmente pp. 265·267.1(, In almeno tre circostanze: a Bologna il 17 gennaio 1954 in occasione dell'85° anniversario della Giac (<<Bollettino della diocesi di Bologna» [d'ora in poi «BDB»], XLV, 1954, p.
372 Giuseppe Battelli
collegarsi a passi neotestamentari come Matteo 10,34: «Non crediate che iosia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, mauna spada», che l'arcivescovo petroniano interpretò nella medesima prospettiva)" una radicata mentalità attivistica e una conseguente forma di governo e di linea pastorale nel quadro dell'Emilia «rossa» del secondo dopoguerra. Un quadro che, secondo la richiamata percezione di essere in «frontiera», alimentava ottiche e strategie e linguaggi di conflitto invece che dipace", Tanto più che, nel clima di istintiva reciproca diffidenza alimentatosi a Bologna dopo la guerra tra il cattolicesimo e le forze politiche di sinistraora dominanti, il tema «pace» si considerava inserito in forma più o menoesplicita tra i veri o presunti stratagemmi cui erano ricorse le organizzazionicomuniste per indebolire il fronte avversario mediante il richiamo a una sorta di sentire trasversale, accomunante soprattutto le ultime generazioni al dilà delle originarie appartenenze ideologiche". E Bologna, nel 1950, era risultata la città italiana in cui era sorto il maggior numero di comitati locali
115); a Milano il 12 marzo 1954 al I" convegno nazionale di studi di sociologia religiosa(G. Lercaro, Sociologia religiosa e azione pastorale, in Discorsi del cardinale Giacomo Lercaro, voI. I, Cristianesimo e mondo contemporaneo, Roma, Herder, 1964, pp. 201--211, lacit. a p. 210); di nuovo a Bologna il 27 novembre 1955 rivolgendosi ai partecipanti all'assemblea diocesana di Ac (<<BDB», XLVI, 1955, p. 357).Il Il legame tra Mt 10,34 e l'immagine dell'esercito di Esdra risulta tra l'altro esplicito inciò che Lercaro disse nella ricordata circostanza del 17 gennaio 1954: «Questo è il compito dell' apostolato cristiano; apostolato che sente l'istanza della parola di Gesti: "Non sonovenuto a portare sulla terra la pace, ma la spada". Apostolato che, oggi specialmente, è necessariamente lotta. Voi dovete essere, dunque, come i soldati di Esdra, dei quali dice laScrittura che con una mano lavoravano a ricostruire Gerusalemme e con l'altra combattevano» (<<BDB», XLV, 1954, p. 115).18 «Ora, la nostra azione apostolica, soprattutto in regioni come la mia, e in molti settori,è azione di combattimento... Noi siamo come i soldati di Esdra, che con una mano costruivano le mura della nuova Gerusalemme, e coll'altra combattevano. Questa è la nostrasituazione di lotta, quotidiana, senza quartiere, in tutti i settori... Penso che non sempresia prudente pubblicare i risultati delle nostre inchieste e le nostre statistiche, perché l'avversario non abbia a farne suo pro» (Lercaro, Sociologia religiosa e azione pastorale, cit., p.210).19 La netta indisponibilità a ogni forma di collaborazione venne ribadita da Lercaro ai giovani della Giac il 17 gennaio 1954: «Su questo settore non c'è possibilità di collaborazione; assolutamente no. E ve lo sottolineo in questo momento, mentre voi, iniziando questavostra celebrazione, avete ricevuto un invito, a firma della Federazione Giovanile Comunista Bolognese, che vi dice: "Ognuno conservi pure la sua autonomia ideale ed organizzativa, conduca la sua azione di propaganda e di proselitismo, ma si lavori insieme ognivolta che è possibile per far sentire la voce e le esigenze dei giovani, per stabilire intese edazioni comuni". Ogni volta che è possibile ... Purtroppo, questa "volta" non può venire!Non ci sono possibilità di collaborazione quando le idee e le finalità sono cosi diverse,profondamente, irrimediabilmente diverse, distanti, opposte!» (<<BDB», XLV, 1954, p.115).
373 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
dei cosiddetti Partigiani della pace", mentre il suo sindaco comunista Giuseppe Dozza faceva parte del massimo organismo mondiale espressione diquelle iniziative".Il riferimento alla peculiare situazione politica bolognese e alla tradizione episcopale incarnata da Nasalli Rocca spiega tuttavia solo in parte l'atteggiamento di Lercara verso la pace e la guerra evidenziato durante i primi anni dell'episcopato petroniano. Un ulteriore decisivo elemento rappresentò infatti laprecedente esperienza di arcivescovo di Ravenna e Cervia vissuta nell'immediato dopoguerra. Essa, per affinità di contesto ideologico e forme di rispostaattivate da Lercara, costituì un banco di prova fondamentale e a lungo condizionante il successivo ministero bolognese, tanto che, rispetto alla nostra tematica, ritengo si possa senz'altro affermare che Ravenna preparò Bologna.Tra il 1947 e il 1952, infatti, il nuovo arcivescovo si mosse all'interno di unoscenario particolarmente complesso: che sul piano locale vedeva i cattolici incondizioni di forte rnarginalità e tensione rispetto a un contesto egemonizzato soprattutto nelle campagne dalla tradizionale presenza delle forze di sinistra e dal diffuso anticlericalismo popolare"; sul piano nazionale attraversò lascadenza elettorale dell'aprile 1948 e la contrastata adesione italiana al Pattoatlantico dell' anno successivo; su quello generale, infine, venne segnato dalpieno manifestarsi della guerra fredda e del conseguente bipolarismo mondiale. Tutto questo favori un'accentuata ideologizzazione della linea pastorale lercariana, che se non mancò ovviamente di esprimersi in specifiche presedi posizione e concrete iniziative di fronte a eventi di un certo rilievo, comele elezioni dell'aprile 194823 o la pubblicazione nel 1949 del decreto di sco-
20 R. Giacomini, 1 partigiani della pace. Il movimento pacifista in Italia e nel mondo neglianni della prima guerra fredda, Milano, Vangelista, 1984, p. 148.21 Il Consiglio mondiale della pace (Vecchio, Pacifisti e obiettori, cit., p. 204).22 «Già da quando accompagnai nelle Parrocchie del Forese la Vergine Greca, il mio penosiero si volse con particolare preoccupazione alla campagna [...] L'impegno è forte, comevedete, figliuoli; e l'opera, cui ci accingiamo per la bonifica spirituale delle nostre campagne, è opera eminentemente soprannaturale [..,] Cosi, nel nome potente di Maria, Sacerdoti e Fedeli carissimi, incominciamo questa S. Crociata per riportare a Cristo Gesù le nostre campagne» (G. Lercaro, Lettera al Venerando Clero e ai Fedeli delle due Diocesi, 24maggio 1950, in «Rivista diocesana. Organo ufficiale per gli atti ecclesiastici delle diocesidi Ravenna e Cervia» [d'ora in poi «RD»] , XL, 1950, pp. 38-39).2J In quella circostanza la «RD» pubblicò la lettera «al clero e al popolo» sottoscritta collettivamente da tutti i vescovi della regione ecclesiastica f1aminia (comprendente le diocesi della Romagna, oltre a Bologna, Ferrara e Comacchio). In essa, oltre ad esprimere l'obbligo di recarsi a votare e di votare secondo i criteri stabiliti dalla Congregazione concistoriale («i cattolici possono dare il voto soltanto a quei candidati, di cui si ha la certezzache rispetterranno e difenderanno l'osservanza della legge divina, i diritti della religione edella chiesa nella vita privata e nella pubblica»), si riprendevano alcuni passi del messaggio natalizio di Pio XII del dicembre 1947: «Nei giorni di lotta il vostro posto è in prima
374 Giuseppe Battelli
munica del Sant'Uffizio contro gli aderenti e sostenitori del cornunismo'", videsoprattutto il sedimentarsi progressivo di un clima e di un habitus mentaleprofondamente conflittuali", Il problema non era più la guerra in sé, ma laguerra latente rappresentata dallo scontro ideologico; e dunque anche il temadella pace, per quanto ripetutamente evocato in quegli anni da Pio XII difronte al conflitto arabo-israeliano e poi alla guerra di Corea, entrò in pieno inquella prospettiva di «non tematizzazione». Tanto che Lercaro, in una Ravenna che si sarebbe particolarmentedistintaneUa raccolta delle firme in favore del cosiddetto «appello di Stoccolma» dei Partigiani della plj,cecontro laproliferazione nucleare", quasi mai ne fece oggetto di richiami pubblici e in
fila sul fronte del combattimento. I timidi, gli imboscati sono vicini a diventare disertori etraditori L.] Disertore e traditore sarebbe chiunque volesse prestare la sua collaborazionemateriale, i suoi servizi, le sue capacità, il suo aiuto, ilsuo voto a partiti ea poteri che negano Dio L..], che rendono impossibilela pace internaed esterna» (NQti/icaziQI1Ji,l° tnarzo 1948, in «RD», XXXVIII, 1948, pp. 2-5/ alle pp. 3e 4 i brani citati). Quantoalle foncrete iniziative di Lercara, egli tra il 10 e U18 aprile t94i'\.- visitò i comitati civicidellacampagna, presiedette due riunioni di quelli di città e infine alla mezzanotte tra il 17 e il18 celebrò la messa appositamente per loro (Ditm'odi S. E. MOrls. Arciuescooo, ivi, pp. 4344).24 G. Lercaro, [Notificazione], 30 ottobre 1949, ivi, XXXIX, 1949, pp. 124-127. Lo stessofascicolo della «RDi> pubblicava alle pp. 116-118 il testo latino e italiano del decreto delSant'Uffizio, seguito da altra documentazione in merito.25 In un'analisi dei risultati del 18 aprile 1948 ci si esprimevacosf: «Sel1za la presenza el'organizzazione della A.c. - che ha preparato gli uomini e ne ha coordinato gli sforzi !'Italia sarebbe oggi travolta dai senza Dio» (Id., Notificazioni, [s.d. ma giugno 1948], ivi,XXXVIII, 1948, p. 28). Salutando l'inizio dell'anno santo .indetto da Pio XII per il 1950ci si lamentava che i «nemici dichiarati della Chiesasvedessero con disappunto l'iniziativa (Id., Per l'Anno Santo, 25 dicembre 1949, ivi, XXXIX, 1949, pp. 143"145, in panicolare p. 143). Ma lo stesso governo .ordinario della diocesi ne veniva condizionato, tantochese nel questionario inviato ai parroci in preparazione alla visita pastorale si chiedeva «Quali [sono] le condizioni politiche della parrocchia? Quale l'atteggiamento delle varie autorità verso la vita parrocchiale ed il clero?» (Questionario per la Sacra Visita Pastorale, ivi,XXXVIII, 1948, pp. 81-93, a p. 82 la domanda indicata), un testo del locale Ufficio catechistico esordiva in questi termini: «Non tutti sanno che uno dei punti più inculcati nell'Associazione Pionieri Italiani di pretta marcasocialcomunista, è precisamentela lotta contro l'insegnamento religioso L..] I nostri avversari sanno che, allontan.ando i fanciullie igiovani dal Sacerdote, dalla Religione, costringendoli a crescere nell'ignoranza di ogni verità, troveranno un terreno ben preparato per farvi.facilmente attecchire le menzogne piùspudorate e le calunnie più infami» (Discorsetto diprincipio anno, ivi, XL, 1950, p. 62).26 La provincia di Ravenna, dun.que il territorio più o meno corrispondente alla omonimadiocesi, risultò in termini assoluti la nona tra le province più efficaci a livello nazionale,mentre alla VI Conferenza nazionale dell'Unione donne .italiane del settembre 1950Ravenna venne preceduta sempre a livello nazionaledalla sola .Reggio Emilia come numerodidonne impegnate nella raccolta delle firme(Giaeomini, I partigiani dellapace, cit., pp.148 e 150).
375 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
una rara circostanza ne invocò significativamente l'affermarsi nel mondo comeconseguenza della conversione della Russia",Tra la fine anni Quaranta e l'intero corso degli anni Cinquanta, pertanto, iltema «pace» non risultò per nulla centrale nelle diocesi lercariane impegnatenel confronto ideologico/organizzativo con il locale dominio delle sinistre e votate a una pastorale largamente sorretta dal criterio della «presenza»; come erastato esplicitamente dichiarato a Ravenna nel 195FS e come confermò tra l'al·tro il fatto che a Bologna dal 1955 in poi il messaggio rivolto ai fedeli nella circostanza del Natale, invece di essere occasione di richiamo alla pace, secondouna consuetudine consolidata nell'omiletica cattolica e derivante dal commen..to al passo del racconto della natività relativo alle parole degli angeli rivolte aipastori (Luca 2,14: «... e pace in terra agli uomini di buona volontà»), vennesempre utilizzato per raccogliere fondi in vista della costruzione di nuovi edifici sacri nella periferia urbana che si andava espandendo". E tale complessivamarginalità, che evidenzia come Lercaro restasse per ora al di fuori di quel pro..cesso di lenta modifica delle posizioni cattoliche maturato secondo GiorgioVecchio a partire dal 19523°, mi pare risulti del tutto confermata nonostante inalmeno due circostanze pubbliche il cardinale intervenisse con discorsi che, purnon incentrati in modo esclusivo su quel tema, vi si soffermavano abbastanzadiffusamente. Vediamole con qualche attenzione, anche perché si apre con esseun nodo interpretativo che ci accompagnerà costantemente in queste pagine:il peso della visione di Dossetti nello sviluppo complessivo del pensiero e delle concrete scelte lercariane in merito alla dialettica pace-guerra.
2l «Questa devozione [il cuore immacolato di Maria], già precedentemente approvata e indulgenziata dalla Chiesa, fu con particolari promesse avvalorata dalla Vergine stessa a Fatima: promessa di morte cristiana, e quindi di salvezza eterna, per chi la pratica; promes ..se della conversione della Russia, e perciò di pace al mondo, se il popolo cristiano accoglierà il desiderio della Vergine» (G. Lercaro, Ai venerandi Sacerdoti e diletti fedeli..., 26aprile 1951, in «Rl)», XLI, 1951, pp. 45-50, a p. 49 il passo citato).28 «Sempre [la missione] fu una efficace e spesso mai vista affermazione di presenza» (ivi,p.47).29 Anche qui è registrabile un chiaro legame con la precedente esperienza di Ravenna. Fuproprio riflettendo sulla situazione di quella diocesi, vista attraverso il risultato elettoraledel 1948, che Lercaro scrisse: «Localmente i risultati del 18 aprile hanno rivelato una condizione buona al centro Città, meno buona nei sobborghi, meno ancora, in genere, nellacampagna. È evidente, anche fuori di ogni esclusivismo, il rapporto direttamente proporzionale alla possibilità di assistenza religiosa e sociale: Clero e chiese in maggior numero einiziative molteplici al centro, che gradualmente diminuiscono allontanandoci. Questo rilievo impone all'Autorità religiosa la necessità di provvedere ai sobborghi e alla periferia»(Id., Notificazioni, cit., p. 28).'0 Vecchio, Pacifisti e obiettori, cit., pp. 305 sgg. In tal senso Lercaro sembrava in fondorestare sulle dure posizioni anticomuniste emblematicamente espresse nel corso ciel 1952dal gesuita Brucculeri sulle pagine de «La Civiltà cattolica» (ivi, p. 308).
376 Giuseppe Battelli
2. Pio XII, l'ordine internazionale e la pace. Nel primo caso, datato 14 marzo 1954, si trattò di un'illustrazione alla cittadinanza bolognese del messaggio natalizio di Pio XII del 24 dicembre 195)31, riguardante una lettura diampio orizzonte della situazione internazionale; nel secondo di una conferenza sul medesimo argomento tenuta il 28 febbraio 1956 all'Università cattolica di Milano in occasione dell' ottantesimo genetliaco dello stesso Pacelli32
• Proposti a un paio d'anni di distanza l'uno dall' altro, ma incentrati comes'è detto su tematiche del tutto affini, i due testi scaturirono chiaramente daun'unica riflessione. In un duplice senso. Estrinseco, dato che la struttura dientrambi appariva in larga parte simile ancorché caratterizzata da una diversa disposizione delle parti principali", mentre interi passaggi dello scritto piùtardo riprendevano alla lettera o costituivano uno sviluppo di quello più anotico. Intrinseco, dato che l'estensore originario dei due interventi fu con ogniprobabilità unico: non lo stesso Lercaro bensì Dossetti", che da poco più diun anno aveva dato inizio a Bologna all'esperienza del Centro di documentazione ponendo le basi per una collaborazione sempre più intensa con l'arcivescovo petroniano",
II Il messaggio natalizio del Sommo Pontefice solennemente illustrato dall'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo, [14 marzo 1954], in «BDB», XLV, 1954, pp. 99-112.)2 Ne esistono varie edizioni a stampa, la prima delle quali apparve sul quotidiano cattolico «L'Avvenire d'Italia» (d'ora in poi «Ad'I») che si pubblicava allora a Bologna (Pio XIIe i problemi sociali del nostro tempo in una acuta analisi del Card. Lercaroi, con il testo sud ..diviso in due parti e pubblicato il4 e il 6 marzo 1956. Considerando le minime differen..ze tra le diverse versioni farò riferimento a G. Lercaro, Pio XII e i problemi sociali del nostro tempo, in Discorsi del cardinale Giacomo Lercaro, vol. I, Cristianesimo e mondo con..temporaneo, cit., pp. 3·28.JJ Dalla verifica della suddivisione presente nei dattiloscritti utilizzati da Lercaro per la lettura pubblica risulta quanto segue. Il testo del 1954 era cosi articolato: 1. «Le condizionidell'ordine internazionale» 2. «Le condizioni dell'ordine interno» 3. «Spirito tecnico espi..rito cristiano». Il testo del 1956 era invece cOSI suddiviso: 1. «Le condizioni dell'ordine interno dei singoli stati» 2. «Spirito tecnico e spirito cristiano» 3. «Le condizioni dell'ordi ..ne internazionale». Copia dei due dattiloscritti si trova sia in Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII-Istituto per le scienze religiose, Fondo Lercara, XXXIV/1138 (iltesto del 1954) e 1137 (il testo del 1956); sia in Fondazione Giacomo Lercaro, ArchivioLercaro, Discorsi, b. Messaggio natalizio del Sommo Pontefice illustrato dall'Em.mo Card.Arcivescovo, Bologna Cinema Astra, Domenica 14 marzo 1954, e b. Pio XII e i problemisociali del nostro tempo, Milano 28 febbraio 1956 (qui si trovano le copie utilizzate da Ler ..caro e contenenti dunque le sue correzioni autografe finali).14 Oltre ai materiali d'archivio di cui parleremo si ha a riguardo la testimonianza diretta diuno stretto collaboratore di Dossetti (G. Alberigo, Rinnovamento della chiesa e partecipazione al concilio, in Giuseppe Dossetti. Prime prospettive di ricerca, a cura di G. Alberigo,Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 41-117, in particolare pp. 47 nota 14 e 104 nota 3).J5 D. Menozzi, Le origini del Centro di documentazione (1952-1956), in «Con tutte le tueforze». I nodi della fede cristiana oggi. Omaggio a Giuseppe Dossetti, a cura di A. e G. AI-
377 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
Prendiamo innanzitutto in esame l'intervento relativo al radiomessaggio natalizio del dicembre 1953. Le prime parole costituivano sul piano dei contenuti una forte premessa riguardo al metodo di analisi dei documenti papalipresi in esame, ma possiamo anche intravvedervi la conferma e in certo qualmodo la giustificazione del lavoro preparatorio che venne in effetti svolto: «IlMessaggio natalizio del 1953 non può essere valutato appieno se non inserito nel quadro costituito da tutti gli altri messaggi natalizi...»J6. Sulla base dialcuni materiali presenti tra le carte di Dossetti - e tenendo conto che egliaveva personalmente partecipato a Milano nel 1943 a un'iniziativa di studiopromossa dal rettore dell'Università cattolica Agostino Gemelli e incentrataappunto sull'analisi di un importante radiomessaggio da poco promulgato"- possiamo infatti accertare che lo stesso Dossetti smontò il testo dei radiomessaggi degli anni 1950-1953, suddividendone un esemplare a stampa di ciascuno in frammenti che corrispondevano ai successivi capoversi di ogni radiomessaggio. Successivamente egli iniziò ad annotare ciascun frammentoallo scopo di metterne a fuoco le parole-chiave e i concetti portanti. Sul suoesempio questo lavoro di minuta annotazione venne proseguito e completato da altri, che elaborarono poi un indice sistematico nel quale tutte le annotazioni vennero raccolte attorno a voci o immagini maggiori, consentendocosi il formarsi di un unico indice tematico relativo all'insieme dei quattroradiomessaggi presi in esame". Manca a questo punto un esplicito trait d'union documentario che porti dai suddetti materiali preparatori al dattiloscritto finale che corrisponde di fatto al testo letto da Lercaro, ma il suddetto dattiloscritto reca tracce manoscritte, rare eppure riconoscibili, della gra-
berigo, Genova, Marietti, 1993, pp. 333-369. Il giorno precedente la diffusione del radiomessaggio del 24 dicembre 1953, e dunque poche settimane prima che iniziasse il lavorodi analisi del testo papale confluito nel discorso lercariano del marzo 1954, Dossetti aveva portato in visione all'arcivescovo il «Piano di studi» contenente le direttive di fondo delCentro (Giuseppe Dossetti. Prime prospettive, cit., pp. 109-117).36 Lercara, Il messaggio natalizio del Sommo Ponte/ice, cit., p. 99. Abbiamo qui la primaformulazione esplicita di un criterio che Dossetti avrebbe utilizzato in altre circostanze, legate alla preparazione di testi per Lercaro e riferite almeno in un caso alla stessa ternaticadella pace (Battelli, Lercaro, Dossetti, la pace e il Vietnam, cit., p. 276).37 Il ricordo di uno dei protagonisti e la ricostruzione di vari studiosi concordano nel datare il suo svolgimento nei primi mesi del 1943, avendo come obiettivo l'analisi del radiomessaggio natalizio di Pio XII del dicembre 1942 (e. Colombo, Nel ventennio di un messaggio natalizio, in «Vita e pensiero», LXVI, 1963, pp. 78-89; P. Pombeni, Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana [1938-1948], Bologna, Il Mulino, 1979,pp. 80 sgg., e recentemente M. Bocci, Oltre lo Stato liberale. Ipotesi su politica e società neldibattito cattolico tra fascismo e democrazia, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 310 sgg.).J8 La procedura che ho sopra riproposta è deducibile nelle sue successive fasi da vari blocchi di fogli conservati in Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII-Istituto perle scienze religiose, Fondo Dossetti, VI/487-490 (ivi, VI/492, materiali simili scartati).
378 Giuseppe Battelli
fia di Dossetti", Disponiamo inoltre della copia del dattiloscritto realmenteutilizzata dall'arcivescovo di Bologna perla lettura pubblica, e da essa possiamo ricavare che Lercara non operò che minimi interventi correttivi al documento, facendolo pertanto ~ almeno formalmente ---del tutto proprio40
,
Il passaggio tra il testo del marzo 1954 e quello del febbraio 1956Mn è ricostruibile in dettaglio sulla base di eventuali materiali preparatori", .Ètuttavia ragionevole ipotizzare che la stesura finale del primo eostitui la baseessenziale del secondo, come confermano le ampie parti riprese a.llaletterae per lo più integrate con i radiomessaggi natalizi del dicembre 1954 e dicembre 1955 nel frattempo divulgati", L'aspetto però di vero interesse ri-
39 lvi, Fondo Lercara, XXXIV/11.38, in particolare f. 2.3.40 La copia del dattiloscritto rivista da Lercara è conservata, come s'è detto, in Fondazione Giacomo Lercaro, ArchivioLercara, Discorsi, b. Messaggio natalizio delSommo Pontefice, cit, Le modifiche più numerose rispetto alla stesura di Dossettì riguardano l'ampio ricorso al corsivo. A parte i ritocchi di mero carattere letterario, l'unica modifica almeno inparte di sostanza riguarda ll seguente passo: «"Conge/Sno" non è solo uno o più principiteorici, ma tutta una complessa realtà materiale che si muove ormai secondo un precisosusseguirsi di previsti movimenti e reazioni, tese ad un certo scopo, l'espandersi della potenza dei gruppi capitalistici, e che nella sua complicata e quasi meccanicaattività schiaccia e blocca inesorabilmente tutto quanto non corrisponde a tale giustificazione [Lercaromodificò con: espansione] finale» (ivi, dattiloscritto del 14 marzo 1954, p. 17, che corrisponde nel testo ufficiale a stampa a «EDB», XLV, 1954, p. 105, ultimo capoversodel .~
22). Modifica certo marginale, ma che andò soggetta a una curiosa vicenda .. Proponendoinfatti a Lercaro nel febbraio 1956 il testo su Pio XII e i problemisociali del nostro tempoDossettì si servì - lo si è già rìlevato ~ di ampie partì del discorso del 1954, compreso ilpasso citato, e non essendo probabilmente a conoscenza della modifica apportata dal cardinale ripropose il brano esattamente com'era nelproprio dattiloscrittodel I's'ì-l. Questavolta, invece di limitarsia cambiare una parola, Lercaro eliminò l'inteto capoverso,41 L'unica traccia è costituita da un manoscritto presente in Fondazione per le.scienze religiose Giovanni XXIII-Istìtuto per le scienze religiose, Fondo Dossetti, VI/491, che contìene la sintesi del radiomessaggio natalizio di Pio XII.del 1954; essa corrisponde come genere a quelle rinvenibili nello stesso fondo e relative all'analisi dei radiomessaggi 1950195.3..Presso la stessa istituzione, ma nel Fondo Lercaro,.XXXIV/11.38, è presente unesemplare del dattiloscritto del marzo 1954 (del tutto corrispondente .al testo editoIn«BDB») che reca l'erronea annotazione manoscritta: «I redazione preparatoriadel discorso di G. Lercaro all'Ll.C. de128.2.l956»,La grafia non è di Dossettì.42 Il legame di fondo tra i due testì è confermato dal fatto che chi li predispose siserviinmodo pressoché esclusivo di un unico genere di auctoritates: i radiomessaggi pacelliani,Nel caso deldiscorso del marzo 1954 la scelta era naturale (il tema era appunto il radiomessaggio del dicembre 195.3), ma nel 1956 (dove l'argomento era l'intero pensierosocialedi Pio XII) il criterio poteva risultare, nella sua esclusività, meno ovvio e richiesedunque di essere motivato: «Questa progressiva .dilatazionedi orizzonti risultaevidentissimaachi legge in continuità la serie di Messaggi natalizi rivolti al mondo intero. A .questi infatti noi principalmente ci rifaremo L.,] È indubbio che in essi, più chein qualsiasi altroatto,il Supremo Pastore si è proposta la considerazione globale deiproblemi dell'umanasocietà
379 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
guarda gli interventi a mano effettuati sul dattiloscritto che con ogni probabilità Dossetti aveva predisposto per la lettura di Lercaro. Una copia"contiene rari ritocchi formali: forse dovuti a un'ultima rilettura dossettianaprima della consegna all'arcivescovo. Ma la copia effettivamente utilizzatada Lercaro a Milano presenta diversi interventi autografi del cardinale e inparticolare l'intera eliminazione di due passi. Uno breve e già inserito nell'intervento del 1954, dove peraltro Lercaro aveva apportato uno dei ritocchi di cui si è detto. L'altro invece ampio, inedito e riguardante il cuore diquella che secondo Dossetti era la sempre più netta presa di distanza di PioXII dal mondo occidentale e dal suo sistema di vita e di valori. Una presadi distanza che si traduceva inoltre in un chiaro pessimismo, a fronte dell'atteggiamento ottimistico di larga parte del mondo cattolico, e addiritturanell' accusa a una parte dei cattolici di essere pervenuti a una sorta di riconciliazione colliberalismo, contravvenendo in tal modo alla LXXX proposizione del Sillabe".Attraverso la soppressione di questo passo si veniva in qualche modo a toccare, togliendole una parte del vigore d'analisi e anche della forza retorica,l'idea che costituiva la maggiore novità apportata da Dossetti nel testo del
L..) Noi pensiamo che proprio nella serie dei Messaggi, visti nel loro insieme e nel lorosviluppo, sia da ricercare la vera posizione dottrinale di Pio XII in ordine al problema sociale» (Lel'caro, Pio XII e i problemi sociali, cit., p. 4).43 È conservata in Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII·Istituto per le scienze religiose, Fondo Lercara, XXXIV/ID7. Presenta pochissimi corsivi. Quelli che si tro ..vano in grande quantità nelle prime edizioni a stampa vennero aggiunti da Lercaro nellapropria copia.4" «In ultima analisi ci vorremmo arrischiare a fare un' affermazione molto grave: se cioèmolta parte del cattolicesimo attuale non intende il messaggio elementare di Pio XII perché in fondo in fondo ha sposato una visione ottimistica della forma complessiva della civiltà occidentale, cioè della civiltà liberale, visione ottimista che contraddice proprio al giudizio non ottimista che alla fine è sotteso a tutto l'insegnamento del Papa. Nonostante moloti dissensi particolari su questa o quella modalità o istituzione (per esempio le istituzionidemocratiche certo non sono gradite a tutti i cattolici), tuttavia nell'insieme il mondo cattolico di questi nostri paesi d'occidente ha assimilato (e se ne è lasciato incantare) l'ortimismo illuminista, cioè naturalista che sta alla base delliberalismo superstite; ossia non siè sempre riconciliato con le istituzioni o con lo stato liberale, ma paradossalmente, proprio contro la proposizione LXXX del Sillabo, si è riconciliato col liberalismo (non tantocome ideologia politica quanto come visione generale della vita). E questa riconciliazione,stentata e quasi preterintenzionale, ma non per questo meno cattivante, è avvenuta proprio quando il senso della storia ha cominciato a invertirsi e a marcare la decadenza mondiale del naturalismo liberale (da non confondersi con i valori naturali di [ibertà)» (Fon ..dazione Giacomo Lercaro, Archivio Lercara, Discorsi, b. Pio XII e i problemi sociali, cit.,dattiloscritto del 28 febbraio 1956, pp. 8·9). Rispetto al testo a stampa (nella ricordata edizione del 1964) il passo caduto si trovava prima del capoverso di p. 7 che si apre con leparole: «Ora tutto lo sforzo ...».
380 Giuseppe Battelli
1956 rispetto a quello del 1954. Là infatti si tentava soprattutto di insistere sulla presenza e legittimità di un «giudizio» da parte del papa", ora invece - portando ancora più avanti rispetto al 1954, dove pure se ne parlava, un criterio di lettura dei radiomessaggi complessivo e non per singoli testi o passaggi isolati" - si metteva a fuoco quello che a parere di Dossettirisultava il «messaggio dei Messaggi», la sintesi essenziale del pensiero pacelliano: e cioè il «giudizio negativo sui principi, meglio sulla forma, di entrambi i sistemi (non solo geopolitici, ma culturali) che si contendono il dominio della terra, dell'uno come dell' altro, di quello cosidetto orientalecome di quello occidentale»:". Un giudizio che l'autore sapeva condiviso dapochi" e che in effetti venne ripreso con patente intenzione riduttiva in undiscorso dell' arcivescovo di Milano Montini tenuto a pochi mesi di distanza da quello lercariano". L'intervento montiniano, infatti, prima sottolineava il dialogo intercorso tra Pio XII e i vari popoli della terra «ad esclusione dei grandi Paesi avversi alla Chiesa cauolica»:", poi - riprendendo appunto le parole lette da Lercaro nella stessa Milano pochi mesi prima chiariva:
Notiamo come il pensiero pontificio parta da una visione acuta e sincera dei mali cheaffliggono la umanità - tanto che l'E.mo Cardinale Lercaro, nella sua Conferenza all'Università Cattolica su Pio XII ed i problemi sociali del nostro tempo, ha potuto affermare che «il senso globale dei messaggi (pontifici) è un giudizio negativo sui principii; meglio su la forma di entrambi i sistemi (non solo geopolitici, ma culturali) chesi contendono il dominio della terra dell'uno come dell'altro, di quello cosi dettoorientale, come di quello occidentale». Ma, a guardar bene, oltre questa visione ne-
45 Questa preoccupazione emergeva con chiarezza soprattutto nella Introduzione (Il messaggio natalizio del Sommo Pontefice, cit., pp. 99-101).46 Cfr. sopra, nota 36.47 Lercaro, Pio XII e i problemisociali, cit., p. 7. È forse plausibile vedere a monte di questo giudizio ciò che Dossetti aveva già affermato nel 1949 avversando la prospettiva di un'adesione incondizionata al Patto atlantico: «Premesse della nostra politica, orientata versomalafede della Russia (ed è d'accordo); buonafede dell'America (non si può essere pienamente d'accordo e molti esempi storici si possono citare)» (verbale riunione del gruppoDc alla Camera, 11 marzo 1949, in G. Dossetti, La ricerca costituente 1945-1952, a cura diA. Melloni, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 388).48 «Un simile giudizio sul sistema occidentale non è di fatto condiviso che da pochi, o, selo è, lo è solo per gli aspetti ancora relativamente più estrinseci (per esempio certi aspettidel costume, specie della morale sessuale corrente, del macchinismo, al più dell'economicismo, e simili), ma non è invece normalmente inteso nella sua portata più profonda e totale» (Lercaro, Pio XII e i problemisociali, cit., p. 7).49 G.B. Montini, Pio XII e l'ordine internazionale, in «La Scuola cattolica», LXXXV, 1957,pp. 3-24. Si trattava di una lezione tenuta il4 giugno 1956 all'Istituto per gli studi di politica internazionale.50 Ivi, p. 6.
381 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
gativa si scopre nello stesso pensiero pontificio una simpatia, una fiducia, per dir tutto un amore del mondo a cui Egli parla, che sembra conferirgli la libertà di un linguaggio, sf.uccusatore, ma assai più scrutatore e confortatore".
L'interpretazione del pensiero pacelliano nei confronti dell'Occidente era direttamente collegata al problema della pace", Sia nel discorso del 1954 chepiù ampiamente in quello del 1956 la tematica era infatti affrontata da Dossetti secondo uno schema di lettura COS1 esemplificabile: il problema dellapace era di natura essenzialmente spirituale; le varie forze in campo ma so-prattutto l'Occidente, pervaso di tecnicismo e da una visione materiale dellavita, ne facevano invece una questione di maggiore disponibilità di mezzi materiali; l'Occidente confermava in questo di aver perduto e dunque al momento di non possedere quella superiore unità di spirito, connessa al pensiero cristiano, che sarebbe portatrice della pace.Prima Lercaro e poi lo stesso Montini non mancavano di condividere questaimpostazione del problema, ma indubbiamente la posizione di Dossetti, sorretta da una riflessione sul tema della «crisi» che lo vedeva impegnato da nu-
51 Ivi, p. lO. Il corsivo è mio. Appare ipotizzabile che la «correzione» appartata al pensiero di Lercaro nel senso di chiarire che non si trattava di linguaggio accusatore bensì scrutatare e confortatore, sulla base di quella simpatia e fiducia che prima si ricordavano, nonriguardasse tutto il mondo ma solo appunto il «mondo cui Egli parla»: cioè «ad esclusione dei grandi Paesi avversi alla Chiesa cattolica» e dunque - secondo i parametri del tempo - essenzialmente il mondo occidentale. Se questo è vero, Montini non condivideva unalettura del pensiero pacelliano che si spingesse a ricavarne una sorta di equidistanza tra idue sistemi contrapposti; e inoltre non condivideva il «pessimismo» che Dossetti intravvedeva (e il passo che Lercaro aveva tolto dal dattiloscritto dossettiano era ancora più duro)nel giudizio di Pio XII riguardante il mondo occidentale. La questione dell'ottimismo naturalistico insinuatosi nel pensiero di molti cattolici sarebbe riemerso in modo decisivo nella discussione conciliare sulla futura costituzione Gaudium et spes e - come vedremo avrebbe indotto Lercaro e Dossetti ad assumere nell'ottobre 1965 una posizione differenziata sia rispetto agli estensori dello schema preparatorio della costituzione sia rispetto allostesso Paolo VI.52 In effetti sia nel discorso del 1954 (Il messaggio natalizio del Sommo Pontefice, cit., pp.102-103) che in quello del 1956 (Pio XII e i problemisociali, cit., pp. 20-23) lo spazio maggiore riservato a questa tematica era inserito nella sezione intitolata Condizioni dell'ordineinternazionale. Nella parte introduttiva del testo piùdatato poi, a differenza del successivo (dall'introduzione profondamente modificata), era presente un ulteriore esplicito richiamo al problema della pace: «La Chiesa rivendica il suo diritto, il suo titolo giuridico ademettere il suo giudizio non solo circa i doveri delle singole coscienze, ma veramente sulproblema globale del!'umanità nella sua situazione presente: problema che converge criticamente nel problema della pace» (Il messaggio natalizio del Sommo Pontefice, cit., p. 100). Iripetuti corsivi visibili nel testo a stampa edito in «BDB» e sopra riprodotti risultano tutti aggiunti nella copia con le rifiniture manoscritte di Lercaro e non erano dunque previsti da Dossetti (Fondazione Giacomo Lercaro, Archivio Lercara, Discorsi, b. Messaggio natalizio del Sommo Pontefice, cit., dattiloscritto del 14 marzo 1954, p. 3).
382 Giuseppe Battelli
merosi anni", si spingeva fino a una condanna del mondo occidentale e deisuoi valori che risultava sia al proprio arcivescovo che a quello di Milano eccessivamente radicale e pessimistica, e dunque non del tutto condivisibile.Tanto più che tale interpretazione veniva riferita a un insieme di interventipapali ai quali Dossetti non saprei dire se per effettivo convincimento o peraumentare l'impatto della propria chiave interpretativa -- attribuiva più volteun carattere «dottrinale», dunque magisterialmente assai importante", Ma ildiscorso, anche perché coinvolgente aspetti che esulano dal tema centrale diqueste pagine, andrà ripreso e approfondito in altra circostanza".Tornando invece alle posizioni di fondo in merito alla pace e alla guerra mipare che in ultima analisi nella Bologna cattolica di quegli anni esistesserodue visioni, non contrapposte ma certo ben diversamente caratterizzate. Esseriguardavano molteplici aspetti della vita religiosa e sociale, e finirono conl'estendersi anche al nostro tema. Per semplicità potremmo ricondurle da unlato all'immagine dei soldati combattenti/costruttori dell'esercito di Esdra edall' altro al magistero «profetico» della Chiesa, cui faceva da sfondo una concezione complessiva, sistemica, del genere umano. Nel primo caso la prospettiva era piii delimitata e l'impegno prioritariamente volto all'attivismo nelsociale, con il supporto di un approccio di sedicente tipo «scientifico» legato alla forte fiducia nelle indagini di sociologia religiosa; nel secondo la prospettiva aveva un profilo più universale (sia geografico che ternatico) e l'impegno si misurava innanzitutto con la necessità di formulare un giudizio «profetico» che si pretendeva fosse di natura eminentemente religiosa e che nellaconsapevolezza di Pacelli era comunque «profezia» papale". In realtà le duediverse prospettive partivano da un presupposto condiviso: il ruolo comunque centrale della Chiesa e del suo insegnamento rispetto alla vita degli Stati e delle società", oltre che dei singoli individui. Diverse erano semmai le
53 Vari interessanti materiali in Giuseppe Dossetti. Prime prospcttiue, cit., pp. 87-108.54 «Ma, appunto per questo, noi pensiamo che si errerebbe, se non si appuntasse lo sguardo, nell'esposizione del suo pensiero, sull'insegnamento propriamente dottrinale, sul giudizio magisteriale supremo dato dal Pontefice nei confronti della umana società deI nostrotempo L.,] Noi pensiamo che proprio nella serie dei Messaggi, visti nel loro insieme e nelloro sviluppo, sia da ricercare la vera posizione dottrinale di Pio XII in ordine al problema sociale» (Lercaro, Pio XII e i problemi sociali, cit., pp. 3-4).55 Anche tenendo conto ad esempio di ulteriori materiali messi ora a disposizione dalla raccolta G. Dossetti, Due anni a Palazzo d'Accursio. Discorsi a Bologna 1956-1958, a cura diR. Villa, Reggio Emilia, Aliberti, 2004, dove tra l'altro il tema del giudizio sull'Occidenteè espresso con particolare forza nel discorso tenuto in consiglio comunale il 3 novembre1956, dopo i fatti di Ungheria e del canale di Suez (pp. 52-66).
51> A. Riccardi, Governo e «profezia» nel pontificato di Pio XII, in Pio XIT, a cura di A. Riccardi, Roma-Bari, Laterza, 1984, pp. 31-92, in particolare pp. 54 sgg.57 In apertura al discorso letto da Lercaro il 14 marzo 1954 si leggeva: «Il valore di questiMessaggi è tanto grande proprio perché oggi è veramente l'unica espressione cosciente del-
383 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
conseguenze che se ne traevano: più concrete, incidenti sul piano sociale eanche politicamente vincolanti per taluni"; prioritariamente circoscritte alpiano complessivo della riflessione intellettuale e dell' esperienza spirituale inaltri.Tenendo conto delle molteplici sfaccettature del pontificato di Pio XII misembrerebbe azzardato concludere che o l'una o l'altra costituissero da soleil proprium pacelliano. In ogni caso nella Bologna degli anni Cinquanta Lercaro portò avanti con tutta evidenza la prima prospettiva. Certo: egli non rinunciò a spostarsi in singole circostanze a livello della seconda, assumendoformalmente il pensiero di Dossetti nella duplice ricordata circostanza. Maquei due discorsi, che nell'orizzonte delle idee e dei comportamenti lercariani degli anni Cinquanta appaiono come massi erratici (per il tipico impiantosistematico dossettiano, per la dossettiana insistenza sul tema della crisi e perquella dossettiana auspicata equidistanza dai due blocchi che risultava del tutto smentita dall' aspro confronto con il comunismo condotto da Lercaro a Bologna), mi pare attestino che da parte del cardinale si trattò allora di un' as-similazione non profonda, segnata da una non piena condivisione di talunispecifici contenuti, e forse e ancor più da una sottovalutazione delle potenzialità e delle implicazioni sostanziali di quel pensiero". Lo confermò quellafiducia lercariana nel ricorso alla sociologia religiosa e alle sue analisi quantitative che si era largamente manifestata a Bologna negli anni precedenti eche avrebbe ininterrottamente segnato parte della pastorale locale sino aglianni Sessanta", laddove il testo preparato da Dossetti e letto da Lercaro nel
la crisi in cui versa l'umanità: la Chiesa si dimostra in essi veramente qual è, la regola assoluta e la fonte sovrana del giudizio radicale sulla sorte dell'umanità e deI mondo di oggi»(Il messaggio natalizio del Sommo Pontefice, cit., pp. 99-100). Il passo venne riproposto,con minime varianti iniziali, anche nel testo del 28 febbraio 1956 (Lercara, Pio XIl e i problemi sociali, cit., p. 5).58 Emblematico a riguardo il ben diverso sentire di un Dossetti che intendeva il partito cattolico come puro e semplice partito, seppure ispirato da un'integrale concezione cristianadell'uomo (G. Miccoli, L'esperienza politica (1943-19511, in Giuseppe Dossetti. Prime prospettive, cit., pp. 9-39, in particolare p. 20) e un Lercaro che sollecitava i vertici della Dcsulla base di considerazioni come la seguente: «Mi limito ora a ricordare a V.E. e a tuttigli eletti della Democrazia cristiana, S.E. Gronchi compreso, che siete eletti con i nostrivoti ed inviati al potere per rappresentare il nostro pensiero e le nostre istanze» (G. Lercaro a F. Tambroni, 19 agosto 1955, in Battelli, Vescovi, diocesi e città a Bologna, cit., p.280 nota 77).59 A confermarlo può bastare il confronto, d'impianto, linguaggio e contenuti, con il coevo testo, scritto di proprio pugno da Lercara lo attesta il relativo manoscritto (Fondazione Giacomo Lercara, Archivio Lercaro, Discorsi) -, Principi cristiani per il superamentodel proletariato [21 aprile 1954], in Discorsi del cardinale Giacomo Lercara, vol. I, Cristianesimo e mondo contemporaneo, cit., pp. 63-76.60 Ancora ne11962 il «piccolo sinodo» dedicato alla pastorale nei confronti del comunismo
384 Giuseppe Battelli
febbraio 1956 denunciava tra l'altro .... citando Pio XII ... la deviazione di un«uomo moderno» che misurava il suo potere dalla «precisione dei suoi caloeolie". Lo confermò, quanto al rapporto con Dossetti, la decisione di giocare la carta della sua candidatura a sindaco di Bologna nelle amministrativedel 27 maggio 1956, dunque dopo entrambe le circostanze di cui si è detto.Lo confermò infine, sul piano dello stile personale, la veemenza espressa daLercara parlando nella piazza centrale di Bologna il 31 maggio dello stessoanno, avendo da poco conosciuto l'esito negativo del voto:
Sei ritornato anche quest'anno, o Signore, su questa piazza che ti ha accolto ospitegià negli anni passati [per la festività del Corpus Domini]. E, a questo tuo ritorno, civien fatto di pensare ad una tua accorata parola quando all'apostolo Filippo tu haidetto: «Pensi tu che al mio ritorno io troverò ancora della fede sulla terra?». Ci vienfatto di pensare con amarezza a questa parola tua, vedendo l'apostasia di tanti nostrifratelli che sono corsi follemente a sbattezzarsi".
Né il clima degli anni immediatamente successivi parve proficuo a un cambiamento di rotta, e all' attenuazione di quella linea di scontro e dunque dievidente mancanza dei presupposti per una pacata riflessione sul tema dellapace. Si ebbero anzi da parte di Lercara ulteriori riprese dei motivi che sinda Ravenna erano stati presenti nel suo ministero: dai duri attacchi contro lafiacchezza «di cristiani mediocri, di pavidi, facili al compromesso e alla transaziones"; alle ricordate manifestazioni di lutto per i fatti di Ungheria dell'autunno 1956, cui segui nell'Avvento dello stesso anno una diretta accusacontro un parlare bugiardo di pace"; alla decisione di reagire pubblicamen-
si apriva con una parte intitolataLa obiettiva conoscenza del fenomeno comunista nella qua·le si parlava di un'inchiesta da condursi «con severo metodo di indagine sociologica» (Piccolo sinodo diocesano 1962. Norme e direttive per l'azione pastorale nei confronti del comunismo. Emanate nell'assemblea generale del clero dell'archidiocesi di Bologna, 3-4 gennaio1962, Bologna, Utoa, 1962, p. 11). Sul ricorso di Lercara all'indagine statistica, risalentegià agli anni Trenta, N. Buonasorte, Giacomo Lercaro: contributo alla conoscenza del periodo genovese (1891·1947), in «Cristianesimo nella storia», XX, 1999, pp. 91·145, specialmente pp. 117 e 128 nota 107.61 Lercara, Pio XII e i problemi sociali, cit., p. 16.62 Id., Discorso in Piazza Maggiore a chiusura della solennità del Corpus Domini, 31 maggio1956, in «BDB», XLVII, 1956, pp. 184-186, la citazione a p. 184. Il Pci raccolse il 45,2%dei consensi --aveva ottenuto il 40,4 nelleprecedenti amministrative ", mentre la Dc salida25,8 del 1951 a 27,7 (P.P. D'Attorre, La politica, in R. Zangheri, Bologna, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 65-188, a p. 181 i risultati delle amministrative del secondo dopoguerra).6J Parole pronunciate a Correggio, il 17 giugno 1956, nell'ambito di un'orazione funebrein ricordo di don Pessina e altri sacerdoti uccisiall'indomani della fine della guerra (Il discorso di Sua Em. il Card. Arcivescovo, in «BDB», XLVII, 1956, pp. 205-209, la citazionea p. 206)." «L'Avvento di questo anno però non può a meno di guardare con particolare attenzione ed intensificato fervore di attese a tre obiettivi, che sono aspetti particolari della pre-
385 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
te nel 1958 contro la condanna del vescovo di Prato Fiordelli. Decisione, quest'ultima, che venne cosi comunicata alla diocesi:
Vista la insopportabile e paradossale condizione creatasi in questi ultimi tempi alla libertà e alla dignità della Chiesa in Italia, ordiniamo: 1) la Chiesa bolognese prende illutto da oggi fino alla Domenica delle Palme, quando celebrerà con l'osanna dei bimbi, il trionfo di Cristo Signore; 2) di conseguenza, tutte le chiese della città e Archidiocesi terranno, da oggi a quella giornata, addobbati a lutto i loro portali; 3) tutte lesere, da oggi al sabato avanti le Palme, alle ore 18, le campane di tutte le chiese, suoneranno a morto per lo spazio di cinque minuti".
L'esibizione plateale e volutamente provocatoria di quel lutto era in fondo lareazione di una Chiesa che, lungi dal proporsi come messaggera di pace, sisentiva sfidata -- sia in generale che nella fattispecie del caso dei coniugi comunisti Bellandi, suscitato com'è noto dall'accusa di «pubblico concubinaggio» lanciata da Fiordelli rispetto al proprio rivendicato diritto di esprimereun «giudizio» che si pretendeva di natura esclusivamente religiosa.
3. La «Pacem in terris» e ti dibattito conciliare sullo schema XIII. Nella primafase del pontificato di Giovanni XXIII le cose non parvero cambiare", Sulpiano degli interventi pubblici di Lercara non risulta anzi alcuna sostanziosa riflessione in merito alla pace nel periodo compreso tra la fine del 1958(elezione di Roncalli) e l'inizio aprile 1963 (emanazione dell'enciclica Pacemin terrisi. È semmai in fonti di altra natura che troviamo elementi per la nostra analisi. Si tratta delle annotazioni che l'arcivescovo di Bologna proponeva ai giovani di modesta condizione sociale accolti presso la residenza episcopale e poi in una struttura debitamente predisposta al fine di garantireloro la possibilità di accedere agli studi superiori e universitari. In queste annotazioni, scritte e affisse ogni giorno nelle due sedi ricordate", troviamo unLercaro che parlava in effetti di pace ma secondo una prospettiva che non
senza del Salvatore nel mondo. Il primo è la pace. Quanto si è parlato bugiardamente dipace in questi anni da coloro che, ripudiato Dio e il suo Cristo, con l'odio nel cuore, lapace non vedono se non come il facile miraggio con cui illudere e attrarre nell'orbita lorola povera gente inorridita dagli scempi della guerra» (Il SacroAvvento. Notificazione di SuaEminenza, 18 novembre 1956, ivi, pp. 396-397).65 Lutto della Chiesa bolognese, ivi, IL, 1958, p. 50.66 Si vedano in G. Battelli, Annotazioni in margine al problema continuità/svolta nell' episcopato bolognese di Giacomo Lercara, in L'eredità pastorale di Giacomo Lercaro. Studi e te..stimonianze, Bologna, Edb, 1992, pp. 423-450, specialmente pp. 429-435, vari testi lercariani che confermano almeno sino al 1960-1961 il chiaro permanere dell'ottica di cui si èdetto.67 La Fondazione Giacomo Lercaro ne ha edita di recente un'ampia raccolta: G. Lercaro,«Vi ho chiamato figli». Foglietti di meditazione 1958-1973, Cinisello Balsamo, S. Paolo,2001.
386 Giuseppe Battelli
contraddice quanto abbiamo rilevato nel suo coevo magistero pubblico. Nelquadro privato e formativo di quella che venne allora descritta come una sorta di «famiglia adottiva» la pace alla quale ci si richiamava era infatti immancabilmente interiore, spirituale, tendenzialmente personale: sia pell~ re·lazioni tra individuo e individuo, sia nella pro~pettiva intimistica del rapporto con Dio. Mi pare esemplare a riguardo .che quando la sitl.(azioneinternazionale dell'epoca venne segnatadaur, dima di potenziale conflitto inoccasione della vicenda della Baia dei porci (aprile 1961), Lercaro proponesseai propri figli spirituali una lettura certo nonsotprendente nelle parole di unecclesiastico e tuttavia estranea a ogni approfondimento anche lato se~stl«po
liticos". E l'anno successivo, mentre con 1'episcopato mondiale da pochigiorni riunito in Concilio scoppiò la crisi di Cuba, egli scriveva:
Si è aggiunto in tutti un senso di timore per gli avvenimenti internazionali [...] Ab.biamo fiducia che i! Signore, guardando alla Sua Chiesa riunita in Concilio,13uideràle cose in modo che si ristabilisca e si saldi nel mondo la tranquillità [...] Viviamo ancora con qualche trepidazione per gli avvenimenti di questi giorni: pregate i! Signoreche la serenità ritorni, anzi si schiarisca sempre di più il Cielo: si arresta ogni slancio,quando manca la serenità".
Tenendo conto di quanto sinora si è detto, con riferimento a un'esperienzaepiscopale che a quel momento si prolungava ormai da una quindicina d'anni, occorre pertanto chiedersi a questo punto quando e perché Lerearo iniziòa collocare il tema della pace in una posizionepiù centrale nel proprio magistero: Il quesito ha un'intrinseca pertinenza, ma si inserisce anche nel 1'1'0
blema piu generale delle varie fasi in cui si articolò l'intero episcopato bolognese di Lercaro", Urr'ipotesiapparentemente scontata suggerirebbe il legame diretto con la diffusione dell'enciclica Pacemin tern» il lO aprile 1963.Tuttavia, se esaminiamo mediante il:bollettitlo .diocesano e la stessa pagina
68 «Gli uomini più avveduti si mostrano pensosi di frante alla situazione attualmente creatasi nel mondo. Pochi, se pur ve n'è, peròguardanopiù in là del fatto politico e del gioco diplomatico. Ma il cristiano sa che sono i fattori morali e spirituali ad agire in profondità. E sente che alla radice della sconcertantevicenda di oggi c'èlosganciamentoda Dio,l'abbandono e il rifiuto di Cristo, il peccato!» (Letcaro,«Vi ho chiamato.figli». Fogliettidimeditazione, cit., 24 aprile 1961, p. 217).69 Ivi, p. 396, e anche in Lercara, Lettere dal Concilio, cit., p. 90.)0 La questione si pose già all'epoca, sulla base sia di un effettivo cambiamento di. linea daparte dell' arcivescovo petroniano sia di un passo del testo letto da Lercara i! 26 novembre1966 in occasione del conferimento della cittadinanza onorariadi Bologna, avvenimentosul quale ritorneremo: «Orbene, nel ripropormi punto per punto tutti i capitoli dei mieidoveri pastorali in questo secondo esordio del mio episcopato bolognese...» (G. Lercara,Discorso in occasione del conferimento dellacittadinanza onoraria, in Id., Discorsi sullapace.189H991 nel centenario della nascita, Reggio Emilia, San Lorenzo, [1991], pp. 4h50, lacitazione a p. 47).
387 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
locale del quotidiano cattolico «L'Avvenire d'Italia» allora edito a Bolognagli atti pubblici di Lercara nei mesi immediatamente successivi a quella datanon troviamo nulla che riguardi la ripresa e la diffusione del documento roncalliano". Al contrario di quanto era invece avvenuto per la Mater et magistra". Certo, a inizio maggio Lercaro si recò a Roma in udienza e presenziòpoi alla consegna a Giovanni XXIII del premio Balzan", assegnato al pontefice proprio per il suo impegno a favore della pace. Ma al di là di questo, etenendo conto che la piena valorizzazione dell'enciclica la ritroveremo si intesti letti da Lercaro ma nel quadro particolare del dibattito dell' autunno1965 sul cap. V dello schema XIII e poi soprattutto nel postconcilio bolognese, ritengo che l'ipotesi di un cambiamento di prospettiva suscitato direttamente e in tempi brevi dalla divulgazione dell'enciclica roncalliana nonabbia allo stato attuale dei solidi supporti documentari.Né mancano conferme in tal senso. La menzionata raccolta di discorsi [ercariani edita dalla Herder nel 1964, incentrata sul rapporto tra cristianesimo emondo contemporaneo e aperta tra 1'altro dal testo su Pio XII e i problemisociali del nostro tempo letto da Lercara all'Università cattolica nel 1956, nonconteneva alcun intervento anche marginalmente riferibile all'enciclica Pacemin terris. È anzi da notare come ancora a fine 1964 l'immagine dell' arcivescovo petroniano non fosse affatto messa in relazione alla tematica della pace:è sintomatica a riguardo la Prefazione alla citata raccolta, firmata dal cardinale belga Suenens ma scritta con ogni probabilità a Bologna nell' entouragedi Lercaro e di Dossetti", Mentre l'impegnativa ricostruzione della figura di
71 Il testo dell'enciclica venne riprodotto integralmente in «Ad'I», 11 aprile 1963, pp. 1 e3-5, mentre una rara iniziativa - che non coinvolgeva in ogni caso Lercaro, pur interessando in parte persone a lui vicine venne segnalata nell' articolo Commento del pro! Calogero all'Enciclica «Pacem in terris», ivi, 2 giugno 1963, p. 6. Il catenaccio precisava: «Neldibattito che ha fatto seguito all'esposizione del filosofo è intervenuto don Dossetti, cheprobabilmente riprenderà l'argomento in una prossima occasione». Lo spoglio del giornale per i mesi successivi non ha però dato alcun esito in merito.72 Rispetto alla divulgazione/promozione dei contenuti della Mater et magistra la rubrica«Diario di S.E. il Sig. Cardinale Arcivescovo» inserita in «BDB» registra nel luglio-agosto1961 due discorsi lercariani di presentazione dell'enciclica (uno di questi, del 24 luglio1961, risulta edito in Discorsi del cardinale Giacomo Lercaro, val. I, Cristianesimo e mondocontemporaneo, cit., pp. 119-136) e nel febbraio-marzo 1962 almeno cinque ulteriori circostanze pubbliche di divulgazione dell'enciclica alla presenza di Lercaro (<<BDB», LUI,1962, pp. 72-73 e 144).13 «BDB», UV, 1963, p. 424.74 «Si potrebbe dire che Egli è il Cardinale della Liturgia? Certo, ma non sarebbe tutto.Né si potrebbe dire che Egli sia solo la voce della "Chiesa dei poveri", né che abbia tutto concentrato sui problemi delle strutture essenziali della Chiesa, né che sia tutto nellaSua visione profonda e magnanima del problema ecumenico. Tanto meno si potrà dire chesia il Cardinale" sociale e progressista per eccellenza", come pure tante volte in Italia è sta-
388 Giuseppe Battelli
Roncalli proposta dall' arcivescovo petroniano a Roma presso l'Istituto Sturzo il 23 febbraio 196575 accennava certo al «servizio per la pace nel mondo»offerto dal defunto papa e citava espressamente la Pacem in terris", senza tuttavia riconoscerle alcun ruolo di particolare rilievo all'interno del pontificato e precisando inoltre:
Non è mio compito ora, ma io sono profondamente convinto che è possibile ritrovare in moltissimi discorsi di papa Giovanni, anche sotto le apparenze più elementari,fortissime tesi teologiche e storiche e che è possibile, attraverso di esse, ricostruireuna vasta sintesi a un tempo semplice e concretissima, più originale, più personale,più giovannea di quello che non siano le stesse due maggiori encicliche Mater et magistra e Pacem in terns".
Indubbiamente la verifica dell'impatto della Pacem in terris sulla riflessione diLercaro in ordine alla pace dovrà essere ulteriormente approfondita, anche perché l'influsso complessivo dell'enciclica e l'incidenza specifica del suo contenuto sugli orientamenti degli stessi vertici cattolici - influsso e incidenza forseinizialmente attenuati dal declino finale di Giovanni XXIII e dall'incalzare deiproblemi legati alla sua successione e alla prosecuzione o meno del Concilioavrebbe assistito a una forte ripresa con l'aprirsi della discussione conciliare attorno allo stesso tema della pace e della guerra. Per ora, tuttavia, ritengo chegli elementi raccolti suggeriscano di formulare un' altra ipotesi: la connessione,cioè, con la terza e quarta sessione del Vaticano II e con lo svilupparsi del dibattito su quello che allora era denominato schema XIII e poi in stesura definitiva assunse il nome di costituzione pastorale Gaudium et spesoLercaro vi partecipò sia a ottobre-novembre 1964 che a ottobre 1965, condue interventi letti in aula conciliare (uno sullo schema in genere, l'altro sulla parte riguardante il rapporto tra Chiesa e cultura)" e con un testo (relati-
to considerato. Tutte queste cose sono vere, ma sono vere tutte insieme, c tutte insiemecostituiscono la Sua fisionomia» iDiscorsi del cardinale Giacomo Lercaro, val. I, Cristianesimo e mondo contemporaneo, cit., p. IX).75 G. Lercara, Linee per una ricercasu Giovanni XXIII, in Per la forza dello Spirito. Discorsiconciliari del card. Giacomo Lercaro, Bologna, Edb, 1984, pp. 287-310. A p. 287 nota 1 elementi per l'attribuzione a Dossetti della stesura del testo.76 Ivi, pp. 292 e 304, rispettivamente.77 Ivi, pp. 303-304. L'assenza di una valorizzazione specifica della Pacem in terris all'interno del pontificato giovanneo è d'altronde verificabile in un discorso dell' anno precedente, dal linguaggio più lercariano che dossettiano (G. Lercara, Commemorazione di GiovanniXXIII tenuta nella cattedrale di Bergamo [3 giugno 19641, in «BDB», LV, 1964, pp. 201208).78 I testi ufficiali latini in Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Cittàdel Vaticano, Poliglotta Vaticana, 1970-1980, val. III/5, pp. 223-226, e vol. III/6, pp. 249252. Le versioni italiane originali, ricostruite sulle stesure preparatorie, in Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, cit., pp. 215-223 e 225·230.
389 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
vo appunto alla pace e alla guerra)" destinato anch'esso alla lettura in SanPietro ma che - come vedremo tra poco .... venne prima rimandato e poi solamente consegnato scritto alla segreteria del Concilio per non interferire conun discorso sul medesimo argomento tenuto nel frattempo da Paolo VI difronte all'assemblea dell'Onu. Nell'insieme delle riflessioni pubbliche di Lercaro riguardo al tema della pace e della guerra quello dell'ottobre 1965 risultò il primo ampio intervento dopo i due proposti a Bologna il 14 marzo1954 e a Milano il 28 febbraio 1956. Ora come allora l'autore della stesuraoriginaria del testo era Dossetti".Il fatto non può sorprendere vista la piena e pressoché continua collaborazione registratasi nel corso del Concilio. Ma nella circostanza dell'ottobre1965 agi anche una specifica competenza che Lercaro riconosceva a Dossetti, forse in riferimento ai due testi predispostigli una decina d'anni prima. L'anno precedente, infatti, in preparazione al proprio intervento sull'intero schema XIII l'arcivescovo di Bologna aveva annotato: «Pregherei ilnostro perito, prof. Dossetti, a riferire sugli altri capi della parte II (vita economica, politica) e specialmente sul problema della pace e, conseguentemente, degli armamenti: problemi sui quali egli ha cornpetenza»:". Lo svolgimento dei lavori del Vaticano II avrebbe poi fatto slittare all'anno successivo la trattazione del problema, con una sequenza di vicende e di strategieche possiamo trovare ricostruita in un recente corposo volume di GiovanniTurbanti"; ed è proprio allora, durante la preparazione di quello che sarebbepoi divenuto l'intervento scritto di Lercaro sulla pace, che Dossetti scrisseall' arcivescovo di Bologna: «Ancora prima di avere la sua comunicazionepensavo che fosse indispensabile un suo intervento, avevo raccolto materiale, richiesto libri a Bologna e riflettuto [...] La materia è difficile: ma in sostanza i principi e le esigenze più vere dell'ora sono chiari: ciò che ho scritto potrà stupire qualcuno, ma non è azzardato». Per poi concludere: «Misembra proprio che questa sia per tutti un'occasione "unica", che per ognuno si dà una sola volta nella vita: o diciamo queste cose ora o non le potremo dire mai piu»8J.
79 Testo ufficiale latino in Acta Synodalia, cit., val. IV/3, pp. 761-764. Versione italiana emateriali preparatori sia in La pacecome testimonianza evangelica, in «Cristianesimo nellastoria», IV, 1983, pp. 461-470, che in Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, cit., pp.253-261.80 Per tale attribuzione cfr. le annotazioni sui materiali preparatori in Per laforza dello Spirito. Discorsi conciliari, cit., p. 253 nota 1.81 Ivi, p. 216 nota 2.az G. Turbanti, Un concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzionepastorale«Gaudium et spes» del Vaticano II, Bologna, Il Mulino, 2000, in particolare pp. 471 sgg.83 G. Dossetti a G. Lercara, 27 settembre 1965, in Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, cit., pp. 253-254 nota 2.
390 Giuseppe Battelli
Il testo predisposto da Dossetti" espresse anche in termini letterari del tuttoconseguenti lo stato d'animo di quelle settimane e la sua percezione che ci sitrovasse di fronte a un' occasione unica. Certamente unica dal punto di vistaecclesiale: dato che il Concilio era ormai avviato alla sua conclusione e ovviamente, per un vescovo, non si sarebbero date circostanze ulteriori nellequali poter presentare all'intero episcopato mondiale alcuni capisaldi di natura dottrinale relativi alla dialettica pace-guerra", Ma unica anche rispettoal dialogo tra Chiesa e mondo contemporaneo espressamente perseguito dallo schema XIII: perché ci si trovava in una stagione nella quale le questionidottrinali sembravano particolarmente incalzate da una congiuntura storicache in quei mesi assisteva al progressivo e sino ad allora inedito aggravamentodel conflitto in Vietnam, sollecitando tra l'altro l'azione frenante svolta da alcuni cardinali e vescovi nordamericani di fronte a un documento conciliareche nelle intenzioni di vari esponenti dell'episcopato mondiale avrebbe dovuto esprimere un rifiuto complessivo dello strumento della guerra e forrnulare dunque un'implicita condanna delle iniziative belliche che vedevano almomento protagonisti gli Stati Uniti nel Sud-Est asiatico".Con toni particolarmente vibranti Dossetti attaccò pertanto l'intero schemaXIII nella versione che era al momento in visione ai padri conciliari", misein evidenza il carattere naturalistico e non cristiano dell' ottimismo che lo permeava" e infine pervenne all' affermazione centrale dell'intero intervento e insostanza della propria visione complessiva del problema pace-guerra:
La chiesa oggi non deve solo parlare di pace, pregare per la pace, scongiurare gli no-
84 Per una sua analisi si vedano anche Ruggieri, La profezia della pace, cit., pp. 171..173, eTurbanti, Un concilio per il mondo moderno, cit., pp. 683-686. Disponiamo inoltre di unarilettura fattane dallo stesso Dossetti, vari anni dopo, in G. Dossetti, Alcune linee dinamiche del contributo del Cardinale G. Lercara al Concilio ecumenico Vaticano II, in Id., Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione, a cura di di F. Margiotta Broglio, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 103-190, in particolare pp. 175-180.85 Sul clima conciliare di quelle settimane si è soffermato G. Routhier, Portare a terminel'opera iniziata: la faticosa esperienza del quarto periodo, in Storia del concilio Vaticano II,diretta da G. Alberigo, val. V, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 73-195, rilevando tra l'altrocome il dibattito apertosi «in un clima di estrema tensione, finiva nella calma generale, senza dubbio a causa della stanchezza diffusa. Si capiva che il concilio, divenuto un' assemblea votante più che deliberante, avrebbe facilmente accettato tutto ciò che gli fosse statosottoposto» (p. 189).86 Turbanti, Un concilio per il mondo moderno, cit., pp. 682·683 e 731-732. Vi avrebbe fatto riferimento anni dopo anche Dossetti (Alcune linee dinamiche, cit., p. 182).Wl «Intervenendo per parlare solamente dell'ultimo capitolo dello schema [...J non voglioripetere cose che sono state già dette da molti nella discussione generale: però dichiaroapertamente il mio intento di mettere in questione attraverso l'esame di questo capitolo,tutto lo schema» (Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, cit., pp. 253-254).88 Ivi, pp. 255-256.
391 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
mini perché facciano la pace, ma deve farsi con un immenso coraggio con l'audacia di papa Giovanni, il profeta della pace facitrice di pace: per le vie non umanee tutte spirituali che le sono proprie essa, ed essa sola, può dare al mondo la pace«che è Cristo stesso» (Ef 2,14-17), il quale ha stabilito e stabilisce la pace non attraverso i compromessi o i buoni uffici umani ma «per mezzo del sangue della sua croce» (Col 1,20). Ma per fare questo essa deve incominciare col giudicare il mondo contemporaneo: L..] portare su di esso, cosi come è oggi, il suo giudizio, deve secondo la parola di Isaia ripresa dal vangelo (Mt 12,18) -- «annunziare il giudizio allegentb-".
Per Dossetti quel doveroso giudizio della Chiesa non doveva essere timido,moralistico e casistico, come appariva nello schema di documento conciliare,ma «assoluto, sintetico, evangelico» e comprendente almeno tre enunciatifondamentali: unità sovrannaturale del genere umano, che impediva tra l'altro di escludere taluni popoli dal consesso internazionale"; estensione delgiudizio negativo della Chiesa dall'utilizzo delle armi atomiche al loro possesso; superamento della distinzione tra guerre difensive, singoli atti di guerra, ecc. ecc., e formulazione di una completa condanna della guerra in ognisua forma. La chiusura riprendeva l'affermazione centrale prima richiamata:
Noi non possiamo nel presente testo dire meno di questo. È il minimo indispensabile. Non solo per il problema pur cosi universale della pace e della guerra ma ancheper qualche cosa che è ancora più importante, cioè finalmente la testimonianza quella che ora storicamente tutta la chiesa è chiamata a dare della sua fede nel CristoGesti. Non possiamo dare all'ateismo contemporaneo risposta piu semplice, piùespressiva, più coerente di questa: affidarsi, in questo estremo pericolo dell'umanitànon alla difesa delle armi e della prudenza politica, ma unicamente alla protezione delSignore Gesù".
Erano passati circa dieci anni dai discorsi del 1954 e 1956 sull'ordine internazionale nella visione di Pio XII e più elementi del testo del 1965 sembravano confermare l'esistenza in Dossetti di una sostanziale linearità di pensiero: esemplificata dai richiami al dovere da parte della Chiesa di esprimere ungiudizio, al problema dell' ottimismo e alla valutazione critica riguardo all'Occidente". Altri elementi segnalavano però che era anche intervenuta una
89 Ivi, p. 257.90 Ruggieri (La profezia della pace, cit., p. 173) ha opportunamente riferito quella considerazione alla situazione specifica del momento, che vedeva la Cina comunista al centro diun dibattito internazionale sulla sua ammissione o meno all'Onu.91 Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, cit., p. 261.92 Il tema della equidistanza tra i due sistemi ideologici formulato a metà anni Cinquantaritornava qui sotto forma di accusa allo schema XIII di esprimere «mancanza di vero universalismo e piuttosto orizzonte ristretto ad alcuni settori della problematica e della mentalità, culturale e politica, del solo occidente» (ivi, p. 255).
392 Giuseppe Battelli
parziale evoluzione. La visione pessimistica dossettiana, e che Dossetti avevaattribuito a Pacelli suscitando la reazione in parte di Lercara e poi dello stesso Montini", si ripresentava di nuovo, per quanto sotto forma ora di distinzione tra un ottimismo superficiale e naturalistico da un lato (che si rovesciava in pessimismo) e un ottimismo veramente cristiano dall' altra. Il fattotuttavia che uno dei fattori fondamentali che li distingueva fosse costituitodalla fiducia che il primo riponeva anche nell'azione dell'uomo mentre il secondo solo in Dio diventava un nodo essenziale della posizione di Dossettinel 1965: una posizione che mi pare modificata rispetto a un decennio prima. Allora infatti, in linea con il pensiero di Pio XII, la possibilità di raggiungere la pace passava anche attraverso la costruzione di un nuovo ordineinternazionale, cui dovevano partecipare con forte spirito di iniziativa gli stessi cristiani". Ora invece la pace poteva venire solo dalla Chiesa, ma non comepromotrice di un particolare ordine interno agli Stati o esterno e regolante iloro reciproci rapporti - nel quadra dunque della cosiddetta dottrina sociale della Chiesa e in un' ottica nutrita anche di elementi giuridici" bensì comeportatrice di un messaggio puramente e sinteticamente evangelico: Cristo erala pace, il suo regno era la pace in atto, solo in lui occorreva confidare difronte al rischio crescente di una nuova guerra generale.Questo passaggio, da una sostanziale assunzione di alcuni fondamenti delpensiero sociale pacelliano a una concezione del problema pace-guerra inchiave prettamente evangelica, non avrebbe probabilmente determinato particolari conseguenze qualora fosse rimasto patrimonio della riflessione personale di Dossetti. Ma il testo era stato preparato per la lettura in Concilioda parte di Lercara e il suo contenuto venne inoltre a trovarsi di fronte a ciòche il 4 ottobre 1965 Paolo VI aveva dichiarato all'Onu: in un discorso largamente impegnato a riconoscere all'Onu stessa una funzione fondamentale,e tutt'al più da perfezionare, nel mantenimento della pace tra gli Stati". Un
93 Cfr. sopra, nota 51.94 «Il Santo Padre non si limita a fare delle constatazioni negative, bensi intende dare a tutto il complesso dei Suoi avvertimenti un senso positivo, il senso di uno stimolo alla invenzione e alla creazione di un nuovo ordine sociale piu giusto, piu umano, piu cristiano [' ..J IlSanto Padre ha più volte indicato per i militanti cristiani di ogni condizione e di ogni stato, questo compito, che la situazione storica oggi loro impone, di sforzarsi e di impegnarsia nuove elaborazioni e a nuove operazioni storiche rigeneratrici della vita sociale» (Il messaggio natalizio del Sommo Pontefice, cit., pp. 106-107, e senza i corsivi in Lercaro, Pio XIIe i problemi sociali del nostro tempo, cit., pp. 11-13).95 «Ma d'altra parte ed altrettanto vigorosamente la Chiesa rivendica il suo diritto, il suotitolo giuridico ad emettere il suo giudizio non solo circa i doveri delle singole coscienze,ma veramente sul problema globale dell'umanità nella sua situazione presente: problema checonverge criticamente nel problema della pace» (Il messaggio natalizio del Sommo Pontefice,cit., p. 100).96 «Notre message veut ètre tout d'abord une ratification morale et solennelle de cette hau-
393 [vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
discorso, dunque, che si muoveva sulla linea della contrapposizione tra la viadella forza militare e quella invece della diplomazia nella soluzione delle controversie internazionali e che, nel suo evidente tentativo di aprire in meritoun dialogo tra credenti e non credenti, evitava con cura sia di sottovalutarela possibile iniziativa umana in favore della pace" sia di ricordare il doveredella Chiesa cattolica di esprimere un giudizio sul mondo contemporaneo".Da un certo punto di vista l'antico sostituto nella Segreteria di Stato di PioXII e ora pontefice manifestava una linea che, attraverso la valorizzazione delpiano giuridico e politico nei rapporti internazionali", veniva a confermare ilpeso che la passata esperienza diplomatica tuttora esercitava in lui.Dossetti, del tutto consapevole che il proprio testo conteneva affermazioniche avrebbero potuto suscitare scalpore in taluni'", mentre era altrettantochiaro che altri le avrebbero senz' altro apprezzate se teniamo conto del dibattito conciliare di quei giorni'", tentò in ogni caso di convincere Lercaroche vista l'irripetibilità della circostanza occorresse comunque esprimersipubblicamente in quei termini; tanto più che nella percezione dossettiana cisi trovava non su posizioni estreme ma semmai tra i «due fuochi» dei conservatori e dei progressisti'". Nelle more delle modifiche che intervennero
te Institution [...J convaincu camme Nous le sommes que cette Organisation représente lechemin obligé de la civilisation moderne et de la Paix mondiale» (Summi Pontificis allocutio in Consilio nationum unitarum, [4 ottobre 1965J, in «Acta Apostolicae Sedis», LVII,1965, pp. 877-885, la citazione a p. 878). Questo specifico passaggio del discorso di Montini sarebbe stato ripreso da Dossetti anni dopo proprio come esempio della dottrina infieri espressa dalla Gaudium et spes (Dossetti, Alcune linee dinamiche, cit., p. 183 nota 139).97 Dossetti stigmatizzava invece gli «argomenti di buon senso e di prudenza carnale» e i«compromessi o i buoni uffici umani» (Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, cit., pp.256-257).98 «De fait, Nous n'avons ricn à demander; aucune question à soulever; tout au plus un désir à formuler, une permission à solliciter: celle de pouvoir vous servir dans ce qui est denotre compétence, avec désintéressement, humilité et amour» (Summi Pontificis allocutioin Consilio, cit., pp. 877-878).99 «Qui ne voit la nécessité d'arriver ainsi pragressivement à instaurer une autorité mon ..diale en mesure d'agir efficacement sur le plan juridique et politique?» (ivi, p. 880).100 «Ciò che ho scritto potrà stupire qualcuno, ma non è azzardato» (G. Dossetti a G. Lercaro, 27 settembre 1965, cit.). Vari anni dopo, in un testo a lui attribuito (Ruggieri, La profezia della pace, cit., p. 165 nota n, Dossetti affermerà invece a proposito del passaggiosull'ottimismo ingenuo: «Questo pensiera di Lercara fu allora tanto originale da sembrare quasi isolato» (Nota alla prima edizione, in Lercara, Discorsi sulla pace, cit., pp. 11..26,la citazione a p. 15).101 Routhier, Portare a termine l'opera iniziata, cit., pp. 185 sgg.102 «La parte introduttiva del discorso che può sembrare un po' lunga è tuttavia necessariaa questo punto della discussione sullo schema XIII: dice una parola chiarificatrice su tutte le premesse teologiche ed evita, mi pare, possibili equivoci nelle interpretazioni del nostro atteggiamento posto tra due fuochi (i conservatori e i progressisti)» (G. Dossetti a G.
394 Giuseppe Battelli
nella programmazione del dibattito conciliare la situazione tuttavia cambiòper il sopravvenire del discorso montiniano all'Onu, portando l'arcivescovopetroniano alla definitiva decisione di non leggere l'intervento di fronte all'assemblea conciliare e alla scelta, sollecitata da Dossetti103, di consegnare almeno il testo scritto alla commissione che stava lavorando alla revisione dello schema XIII.Riguardo a quella decisione non abbiamo una testimonianza esplicita di Lercaro. Scrivendone ai ragazzi della propria «famiglia» adottiva si espresse intermini necessariamente generici'?', che evitavano di toccare il problema reale della linea palesemente differente che caratterizzava il proprio intervento eil discorso letto da Paolo VI all'Onu. Nel ricordo di Dossetti la possibilità direndere pubblica quella divergenza venne risolta dall' arcivescovo petronianocon un atto di «delicata deferenza» nei confronti del pontefice che si tradusse appunto nella rinuncia alla lettura in aula conciliare'"; nemmeno in questocaso abbiamo tuttavia un chiarimento di quale fosse nello stesso Dossetti e inLercaro la percezione effettiva e dottrinalmente definita del dissenso rispettoa Montini, Ruggieri l'ha colto anni orsono nel fatto che all'Gnu Paolo VI avesse espresso «una posizione, analoga a quella del documento conciliare, chenon aveva valicato la soglia della guerra di difesa-'". È una considerazione cherispetto al dibattito teologico di quei mesi è certamente valida. Mi pare nondimeno che quella specifica divergenza, tra l'altro circoscritta a uno solo deitre enunciati finali dell'intervento di Lercaro e dunque per sé risolvibile attraverso una parziale modifica del testo, vada inserita nel quadro di una dif-
Lercara, 27 settembre 1965, cit.). In uno scritto posteriore, attribuito come s'è detto a Dossetti (cfr. sopra, nota 100), si precisava ulteriormente che quel testo «non si identificavacol pessimismo "controriformista" della cosiddetta minoranza conciliare, ma nemmeno colpensiero della maggioranza che appare oggi non perfettamente centrato sui dati della rivelazione» (Nota alla prima edizione, in Lercara, Discorsi sulla pace, cit., pp. 11-26, la citazione a p. 15).lOJ «Continuo ad essere abbastanza persuaso che convenga mandare il testo preparato sulla pace alla commissione dello schema XIII: può restare cosi, al massimo con una piccolapremessa di richiamo al discorso del Papa» (Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari,cit., p. 254 nota 2).104 «Avrei dovuto parlare, ma mi sottrassi, dato che l'argomento era stato trattato dal S. Padre ed era quindi ormai superato» (Lercara, Lettere dal Concilio, cit., p. 359).ios «L'intervento di Lercara era stato pensato come da pronunziarsi nell'aula, cioè nellaCongregazione generale per uno dei giorni intorno al 30 settembre 1965. Fu poi rinviatoper un diverso ordine dato alla discussione e quindi fu ulteriormente rinviato per il sopravvenire del discorso di Paolo VI all'Gnu (4 ottobre 1965). Per una delicata deferenza,Lercara decise di astenersi dal pronunziarlo, ma non rinunciò a fare presente il suo penosiero e a inviarlo per iscritto alla commissione competente» (Dossetti, Alcune linee dinamiche, cit., pp. 174175 nota 128).106 Ruggieri, La profezia della pace, cit., p. 170.
395 I uescoui italiani e la dialettica pace-guerra
ferenza di concezioni più ampia e profonda che, aggirata al momento dalla rinuncia di Lercara, si sarebbe riproposta negli anni immediatamente successivi per portare all'epilogo del dicembre 1967-gennaio 1968.
4. Il postconcilio a Bologna: Chiesa e città tra pace e guerra. In ogni caso, e inqualsiasi modo la si voglia valutare, quella visione parzialmente diversa nonprodusse al momento altre conseguenze: né in negativo, nei rapporti tra i variprotagonisti della vicenda, anche se si stava evidenziando una crescente distonia di vedute tra il pontefice e una parte della maggioranza progressistadel Concilio'"; né in positivo, rispetto cioè alla possibilità che i tre «enunciati» dell'intervento di Lercara fossero presi in considerazione dall'organismo conciliare incaricato di rivedere lo schema Xlll'?". Incombeva infatti laconclusione dell'intero Vaticano II e la data dell'8 dicembre 1965 - giornodella cerimonia finale e per molti presuli, tra cui Lercara, di rientro nella propria sede episcopale avrebbe comunque segnato uno spartiacque non sottovalutabile. Dopo di esso ciascun vescovo, pur tenendo conto delle eventuali direttive di Roma, avrebbe potuto aprire localmente la strada a processi di riforma o invece attivare una linea di solido ancoraggio alle posizionitradizionali, magari attraverso una recezione sbiadita e minimalista (senzadunque la necessità di un palese rigetto) delle indicazioni scaturite dai documenti del Concilio.Quell'8 dicembre 1965 ebbe a Bologna una fisionomia particolare. Venuta aconoscenza probabilmente attraverso la stampa delle iniziative che la Chiesadiocesana aveva predisposto per accogliere Lercaro di rientro dal Concilio'?',l'amministrazione civica, ancora guidata dallo stesso sindaco comunista Dozza che già la governava all'epoca delle clamorose iniziative lercariane deglianni Cinquanta, si consultò con gli organi centrali del partito per avere vialibera alla decisione di presenziare ufficialmente all'arrivo del cardinale'", Ne
107 G. Alberigo, L'esperienza conciliare di un vescovo, in Per la forza dello Spirito. Discorsiconciliari, cit., pp. 9·62, in particolare p. 35.108 Questa la diretta testimonianza/interpretazione offerta da Dossetti anni dopo: «1 treenunciati lercariani, come è ben noto, non sono stati recepiti nel testo definitivo della Gaudium et spes, ma errerebbe chi credesse che essi siano stati scartati dal Concilio come unaposizione di punta di un inguaribile e isolato utopista. Di fatto essi corrispondevano esattamente al pensiero di molta parte dei Padri e particolarmente di alcune delle personalitàpiù rilevanti e di maggiore statura spirituale, teologica e pastorale, dell'assemblea conciliare» (Dossetti, Alcune linee dinamiche, cit., p. 180).109 La notizia apparve a Bologna per la prima volta sulla stampa cattolica locale a fine novembre 1965, precisando: «Alla stazione centrale, il Cardinale sarà ossequiato da una rappresentanza dell'Archidiocesi» (Omaggio al Cardinale Lercara al suo ritorno dal Concilio,in «Ad'I», 30 novembre 1965, p. 6). Per la successiva rettifica cfr. oltre, nota 111.no Se ne può vedere il ricordo di G. Fanti, allora segretario della locale federazione del Pcie poi successore di Dozza quale sindaco (G. Fanti-G.c. Ferri, Cronache dall'Emilia rossa.
396 Giuseppe Battelli
scaturì una circostanza non priva d'imbarazzo!", eppure ricca di significatoda un punto di vista simbolico: perché suggeriva, anche se ancora non la determinava nei fatti, una chiara svolta rispetto al passato!". Il comunismo bolognese ne aveva certamente bisogno. La crisi dell'alleanza storica con i socialisti, ora confluiti a livello nazionale nel Psu, aveva infatti inaspettatamente aperto a livello locale quella prospettiva di un rovesciamento degli equilibripolitici a vantaggio della Dc che Lercaro aveva invano perseguito nel 19561l3
•
Ma la stessa Chiesa bolognese si trovava ora, a Concilio concluso, a misurarsicon la propria disponibilità a dare concreta fisionomia a quegli intenti di dialogo ripetutamente espressi sia dal Vaticano II che dai due pontefici che avevano voluta e portata a termine l'assise ecumenica.Mi sono attardato su tali aspetti, apparentemente estranei al centro tematicodi queste pagine, perché in realtà essi costituirono il contesto specifico all'interno del quale maturarono i successivi decisivi passaggi verificatisi nell'itinerario di Lercaro rispetto alla dialettica pace-guerra. Le novità che intervennero a Bologna nel periodo compreso tra la fine del Concilio e la conclusione dell'episcopato Ìercariano nel febbraio 1968 non si manifestaronotuttavia secondo un percorso rapido e lineare. Come si è potuto rilevare, iltema della pace e della guerra aveva senza dubbio una propria dimensionedottrinale, ma si intrecciava anche con schemi mentali consolidati e congiunturali questioni di politica interna ed estera. Aspetto tanto più rilevantein un momento nel quale la recente escalation nel conflitto vietnamita alimentava letture fortemente ideologizzate del suo svolgimento. Il fatto cheLercaro avesse partecipato nei termini che abbiamo visto al dibattito su pacee guerra nella fase finale del Vaticano II, cosi come la volontà di dialogo sottesa all'accoglienza riservatagli da Dozza 1'8 dicembre 1965, rappresentavano
L'impossibile ri/ormismo del Pci, Bologna, Pendragon, 2001, p. 128).Jll Lo stesso quotidiano cattolico, allora diretto da un Raniero La Valle del tutto vicino alleposizioni di Lercaro, ripropose in modo sostanzialmente generico .. senza cioè alcun riferimento alla presenza in realtà ben rilevante per Bologna del sindaco comnnista - la notiziamodificata della manifestazione dell'8 dicembre per il rientro del cardinale: «[Il Cardinale]ricevuto alla stazione centrale l'ossequio delle autorità e delle rappresentanze, proseguirà ...»(I bolognesi si apprestano a ricevere il Cardinale, in «Ad'I», 7 dicembre 1965, p. 6).112 Lercara ne riferi in questi termini alla propria «famiglia» adottiva: «Alle 21.10 eravamoa Bologna, dove, per la prima volta il Sindaco con la Giunta e i rappresentanti dei varigruppi consiliari, unitamente alle autorità tutte, mi diedero il benvenuto» (Lercaro, Lettere dal concilio, cit., p. 423). Fanti avrebbe parlato in seguito di una porta che si era «socchiusa» (Fanti-Ferri, Cronache dall'Emilia rossa, cit., p. 129),113 Il catenaccio di un articolo apparso in quei giorni sulla pagina bolognese del quotidiano cattolico già ricordato lo affermava esplicitamente: «Volontà di accelerare la modificadegli attuali rapporti fra le forze politiche a livello locale secondo la linea seguita in camopo nazionale» (Rinnovato impegno della D.C. per i problemi della città, in «Ad'I», 14 dicembre 1965, p. 6).
397 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
pertanto dei passaggi di indubbia rilevanza ma non comportavano affatto unascontata e tanto meno immediata e generalizzata modifica di posizioni. A livello locale infatti tali posizioni risultavano sedimentate in profondità e oltretutto riconducibili, da parte cattolica, all'atteggiamento a lungo tenuto inproposito dal Lercara preconciliare, emulo dei soldati costruttori/combattenti di Esdra. Gli inviti roncalliani di inizio anni Sessanta avevano forse contribuito a mitigare quell' atteggiamento'", senza tuttavia che la cosa fosse recepita o accettata ovunque'", E una possibile spiegazione è forse da intravvedere nel fatto che mentre in Lercara la lunga e intensa esperienza delConcilio aveva determinato una sorta di distacco e di cesura rispetto al clima bolognese favorendo un rientro più disponibile a una revisione delle passate posizioni, in città tale cesura non era stata vissuta, se non come eco lontana o come partecipazione di ristretti circoli innovato l'i, e venne pertantosolo in parte condivisa.In ogni caso i mesi immediatamente successivi all'8 dicembre 1965 diederoconferma dell'inedita convivenza tra una linea nuova tutta da costruire e unapassata tuttora saldamente in auge. Un indizio della maturazione della primasi registrò in realtà nell'aprile 1966. In occasione della nomina di Guido Fanti a successore di Dozza si ebbe infatti uno scambio di lettere, probabilmente convenute, in cui il tema della pace veniva proposto al cardinale dal nuovo sindaco come terreno specifico per «un apporto spirituale e civile semprepiù ampio dei cattolici» e nella risposta si affermò per la prima volta che laChiesa bolognese «nell' ordine che le [era] proprio» si dichiarava disponibile a un «impegno sincero di concreta operosità costruttiva»116. Era un indiziosolidamente fondato, perché si stava delineando proprio allora la scelta di intrattenere tra Comune e Chiesa locale rapporti riservati intesi appunto a su-
11·1 Se ne ha una netta percezione esaminando gli atti del Piccolo sinodo diocesano 1962.Norme e direttive per l'azione pastorale del comunismo, cit., contenente sia materiali rappresentativi della tradizionale linea anticomunista sia considerazioni come la seguente: «Inun momento storico in cui la Chiesa Cattolica, nella luce dell'insegnamento del suo augusto Capo, il Papa Giovanni XXIII, guarda con particolare materna attenzione alle Comunità cristiane separate, potremmo noi dimenticare tanti nostri fratelli, come noi battezzati,a noi vicini, gomito a gomito con noi nel nostro lavoro quotidiano e pur lontani da Cristoe dalla sua Chiesa? Forse troppo spesso abbiamo pensato soltanto ad una lotta contro ilComunismo e abbiamo atteso l'eliminazione del Comunismo dalla vita nazionale, riguardando, inconsapevolmente, i comunisti come avversari irriducibili» (p. 99).115 D'altronde i segnali a riguardo restavano notevolmente contraddittori. Se infatti nel piccolo sinodo sopra citato ci si esprimeva nei termini riportati, nell'Avvento del dicembre1961 si era tenuto nella principale basilica cittadina, San Petronio, un intero ciclo di celebrazioni in ricordo delle cosiddette «chiese del silenzio» (<<BDB», LII, 1961, pp. 496-497),mentre poche settimane prima lo stesso Lercaro aveva celebrato una messa «per i cadutidella Rivoluzione Ungherese» (ivi, p. 494).ll6 L'omaggio del Sindaco e la risposta del Cardinale, in «Ad'I», 5 aprile 1966, p. 6.
398 Giuseppe Battelli
perare le annose pregiudiziali del passato'". A impedire tuttavia che potesserapidamente derivarne una nuova prospettiva anche sul piano di concrete iniziative o pubbliche prese di posizione contribui tra l'altro la particolare situazione istituzionale di Lercaro quale arcivescovo di Bologna. Secondo unarecente normativa della Santa Sede egli avrebbe dovuto infatti lasciare la guida della diocesi nell'ottobre 1966, al compimento dei settantacinque anni, ei pochi mesi restanti se erano certo idonei alla formulazione di auspici complessivi'" non lo erano per fare progetti o ipotizzare svolte: né in genere, nénella fattispecie di delicati rapporti che avrebbero potuto mettere in difficoltàil successore di Lercara sulla cattedra episcopale di San Petronio.Tra l'inverno 1965 e la tarda estate del 1966, perlomeno in superficie, tuttoparve dunque restare come prima: con un forte contrasto ideologico nella vitapolitica locale in merito ai recenti drammatici sviluppi nel Sud-Est asiatico'"e un cattolicesimo bolognese arroccato in taluni suoi settori su posizioni didiffidenza verso le iniziative in favore della pace ritenute di matrice comunista'", e comunque polemico nei confronti del nuovo sindaco e della sua pre-
l17 Un esplicito riferimento in Fanti-Ferri, Cronache dall'Emilia rossa, cit., p. 129. Sembraipotizzabile in proposito, per ciò che riguarda Dosserti, un collegamento con la collaborazione con leader comunisti già sperimentata ai tempi della Costituente e poi, a livello locale, durante l'attività da lui svolta in consiglio comunale tra il giugno 1956 e il marzo 1958(Dossetti, Due anni a Palazzo d'Accursio, cit.),118 Per lo più ruotanti attorno alla necessità di mettere in opera gli insegnamenti concilia..ri: come nel caso della conferenza tenuta a Vicenza il 22 gennaio 1966 su La Chiesa e ilmondo dopo il Vaticano II (cfr. oltre, nota 122), o le esortazioni in diocesi del maggio ..giugno successivo (Fede nel Concilio - esorta il Cardinale e rigorosa fedeltà al suo insegna..mento, in «Ad'I», 17 maggio 1966, p. 6; Solenne impegno della Chiesa bolognese a viverepienamente il magistero conciliare, ivi, lO giugno 1966, p. 6). Sempre sul Vaticano II si ten ..ne inoltre in cattedrale un ciclo di conferenze nel marzo 1966 (per informazioni, ivi, 22febbraio 1966, p. 6). Lo chiuse Dossetti, con un intervento dal titolo La presenza del Ve·scovo è unità della Chiesa sul quale dovremo ritornare.119 A metà luglio 1966 si registrò ad esempio in consiglio comunale la presentazione contemporanea di ben tre diversi ordini del giorno relativi alla situazione internazionale: unodal Pci, uno da Dc, Psi, Psdi, uno infine dal Pli. Tutti e tre vennero approvati, medianteun gioco di voti e astensioni (In un o.d.g. sulla situazione vietnamita riuniti i partiti del cenotra-sinistra, ivi, 20 luglio 1966, p. 6). Il secondo degli odg venne ripresentato esattamenteidentico a metà settembre in uno dei quartieri della città, la Bolognina, a maggiore presenza comunista (Uniti la DC il PSI e il PSDI sul problema del Vietnam, ivi, 16 settembre1966, p. 7).120 Di uno di questi episodi fu protagonista Luigi Pedrazzi, allora presidente di uno dei quartieri della città e redattore della rivista «Il Mulino». Invitato a partecipare a una manifestazione organizzata da un comitato universitario per la cessazione del conflitto in Vietnam,legato alla docenza accademica di sinistra, aveva rifiutato chiedendo che le sue motivazioni- il manifesto degli organizzatori denunciava l'iniziativa militare statunitense senza alcun riferimento alla Cina .- fossero rese note ai partecipanti. Ne segui una polemica sulla stampa
399 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
sunta linea innovativa'". Rispetto agli anni precedenti una novità a dire il veroc'era, ma al momento non parve essere percepita o ricondotta alle ragioni effettive. La novità che in quello scenario, a livello locale quasi evocativo delclima ideologicamente conflittuale degli anni Cinquanta, il vertice della Chiesa bolognese restasse sostanzialmente silenzioso, se si eccettua la calorosa adesione d'inizio anno ai tentativi di Paolo VI di pervenire a una sospensione delconflitto in Vietnam'"; e sembrasse in fondo affidare l'espressione indirettadel proprio pensiero ad alcuni articoli di fondo sulla guerra in Vietnam firmati dal direttore de «L'Avvenire d'Italia» Raniero La Valle. In quegli articoli si invitavano i lettori a non valutare le vicende belliche in questione soloattraverso l'ormai stereotipa e semplificante contrapposizione comunismo/anticomunismo'", e a distinguere tra un legittimo orientamento ideologico difondo e il giudicare comunque ogni singolo episodio di guerra sotto il profilo della sua liceità dal punto di vista meramente religioso'". Concetto quest'ultimo che, come vedremo, sarebbe stato ripreso alla lettera mesi dopo in
cittadina contraria all'iniziativa del comitato (Solo i consensi e non i dissensi, Una lettera delpro! Pedrazzi che il Comitato per la pace nel Vietnam non ha reso noto, ivi, 3 dicembre 1965,p. 6). È da rilevare come quella di Pedrazzi non fosse certo tra le posizioni cattoliche piùoltranziste in quel frangente, Mesi dopo un francescano, già appartenente ai cosiddetti «frati volanti» che nei primi anni Cinquanta avevano sostenuto in diocesi una forte iniziativaanticomunista su mandato di Lercaro (Battelli, Vescovz; diocesi e città a Bologna, cir. in particolare pp. 277-278 nota 61), celebrò una messa in ricordo dei caduti «per la libertà» nell'Ungheria del 1956 «assieme alle vittime del conflitto che infuria nel Vietnam» (Rito per iCaduti in Ungheria e nel Vietnam, in «Ad'I», 6 novembre 1966, p, 6),121 Già mesi prima della nomina effettiva di Fanti la pagina locale dell' «Ad'I», almeno inapparenza non del tutto in linea con l'orientamento del direttore La Valle e vicina alle posizioni della corrente «dorotea» allora maggioritaria nella Dc locale, intitolava Guido 'Fanti succede a Dozza. Lorenzini si ritira a vita privata (30 dicembre 1965, p, 7), annotando velenosamente: «Ha vinto il funzionario di partito, l'uomo d'ordine, che si fece araldo del"rinnovamento" fintantoché ebbe coperte le spalle da Amendola e sconfessò poi i rinnovatori, e quindi lui stesso (ma fu perdonato) quando Togliatti, alcuni mesi prima di morire, non ne volle più sapere della "fronda" bolognese», Seguirono, dopo la nomina a sindaco, articoli dal titolo emblematico: Fanti eletto sindaco da una maggioranza che non hachiarito i rapporti politici interni (3 aprile 1966, p. 7); Obiettivi generici e poche novità neldiscorso programmatico di Fanti (20 aprile 1966, p. 6); La Giunta comunale è incapace digarantire la crescita della città (13 maggio 1966, p, 6).122 Grata adesione dei bolognesi all'opera del Papa per la pace. 1 sentimenti della cittadinanza interpretati dal Cardinale Lercara, ivi, 3 gennaio 1966, p. 7. Poche settimane dopo, tenendo un discorso a Vicenza il 22 gennaio, Lercaro avrebbe ribadito: «Oggi la Chiesa staoperando, come non ha mai fatto, per la pace: al di là e al di fuori degli schemi diplomatici tradizionali, tutto viene tentato perché in quell'angolo di mondo, anch'esso abitato dafigli di Dio, gli uomini non muoiano più» (G. Lercaro, La Chiesa e il mondo dopo il Vaticano n, Vicenza, Favero, [1966], p. 53).123 R La Valle, Il demone della guerra, in «Ad'I», 19 maggio 1966, p, 1.124 Id., Bombe sul Vietnam, ivi, 4 luglio 1966, p, 1.
400 Giuseppe Battelli
un' omelia sulla pace e la guerra redatta da Dossetti per Lercaro e inviata atutte le parrocchie della diocesi.Gli eventi subirono invece una forte accelerazione a fine estate 1966, in unfitto intreccio di implicazioni che non riguardarono in origine la dialetticapace-guerra ma che le avrebbero conferito, nella situazione bolognese, unacentralità sempre più chiara. Elemento innescante fu tra 1'agosto e il settembre la decisione di Paolo VI di confermare Lercaro alla guida della diocesi,togliendo dunque quel velo di indeterminatezza sull'immediato futuro del governa episcopale bolognese che aveva caratterizzato i mesi precedenti. E chesi fosse appunto in attesa di un segnale, in un senso o nell'altro, lo attesta ilfatto che appena venne ufficializzata la conferma il vertice diocesano emanòun decreto che apriva una complessa fase di studio per l'attuazione in diocesi dei documenti conciliari'". Un' altra e più generale iniziativa assunta dalpontefice in quelle medesime settimane, e relativa questa volta al tema dellapace'", fece si invece che la giornata del 4 ottobre, tradizionalmente riservata a Bologna all'annuale celebrazione del patrono, si trasformasse nel 1966 inun appuntamento pubblico di portata inedita per la città: con il sovrapporsi/intrecciarsi delle celebrazioni per la festività religiosa e civile di San Petronio, dei festeggiamenti per la conferma dell' arcivescovo alla guida delladiocesi, delle pubbliche preghiere per la pace richieste da Montini.Si apriva di fatto una nuova stagione dell' episcopato di Lercaro a Bologna enon a caso in quelle settimane si parlò di «ricominciare da capo»!" e di «secondo inizio»!". Perno essenziale doveva essere la riforma della Chiesa loca-
125 L'udienza papale durante la quale si ebbe la conferma si tenne il 22 settembre 1966. Ildecreto di istituzione dei gruppi di studio per la riforma recava la data ufficiale del giorno successivo. Nella stessa udienza Lercara otteneva inoltre dal papa il consenso alla nomina del proprio ausiliare L. Bettazzi quale vescovo di Ivrea, aprendo dunque la stradaalla auspicata nomina quale vicario generale e vescovo ausiliare a Bologna di Dossetti (Battelli, Tra chiesa locale e chiesa universale, cit., pp. 180 sgg.). La nomina di Dossetti nonvenne poi accolta da Roma e Lercaro gli affidò a gennaio 1967 l'incarico di provicario generale in attesa dell' arrivo, a settembre 1967, di quello che sarebbe divenuto il «coadiutore con diritto di successione» dello stesso Lercara: Antonio Poma.126 Paolo VI, letto enc. Christi Matri, 15 settembre 1966, in «Acta Apostolicae Sedis», LVIII,1966, pp. 745-749. L'enciclica, pur ruotante attorno alla devozione per il rosario cui erariservato il mese di ottobre, chiedeva che il 4 ottobre, primo anniversario della visita papale all'Gnu, venisse dedicato a preghiere per la pace.127 «In un certo senso, il card. Giacomo Lercara veniva a ricominciare da capo, anche sepiù affaticato e dopo quattordici anni di lavoro e di preziose iniziative, la sua missioneevangelica nella grande diocesi di San Petronio» (Invocata la pace nel mondo, in «Ad'I», 5ottobre 1966, p. 6).128 L'espressione ricorse due volte nel testo letto dallo stesso Lercaro ricevendo l'onorificenza il 26 novembre 1966: «secondo inizio» e «secondo esordio» (Lercara, Discorsi sullapace, cit., p. 47).
401 l vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
le secondo le indicazioni del Concilio Vaticano 11'29, ma la problematica della pace e della guerra avrebbe finito con il ricoprirvi un ruolo le cui dimensioni non erano forse inizialmente previste. Due eventi, uno pubblico 1'altroprivato, le aprirono la strada. Nel primo caso la decisione da parte del sindaco Fanti e del consiglio comunale di contribuire a propria volta a dare rilievo alla nuova fase episcopale di Lercaro conferendogli la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione: «a riconoscimento solenne dell' alto magistero espresso in seno al Concilio Vaticano II a sostegno delle aspirazioniuniversali alla pace, alla cooperazione fraterna tra i popoli e al civile progresso; del nobile impegno a contribuire solidalmente, alla guida della Chiesa bolognese, alla costruzione di un più avanzato modello di civiltà»!", Nelsecondo il costituirsi in città di un Centro di azione per la pace nel quale, accanto alle maestranze di alcune fabbriche bolognesi che già in passato eranostate attive in favore della pace, entravano ora alcuni cappellani del lavoro ealtri rappresentanti del mondo cattolico locale che risultavano vicini alle posizioni di Lercaro e Dossetti'",L'iniziativa del sindaco e del consiglio comunale si inseriva nella ricerca didialogo aperta dall'accoglienza di Dozza a Lercaro nel dicembre 1965 lJ2
• Seallora tuttavia 1'anziano sindaco aveva parlato di pace in riferimento alla tradizione del popolo bolognese, ora la motivazione della cittadinanza onorariacollegava tra loro il magistero di Lercaro e la pace, dopo che lo stesso Fanti- intervenendo in consiglio comunale poche settimane prima aveva plaudito alla decisione papale di indire preghiere per la pace nella giornata del 4ottobre 1966133
• Il giorno 26 dello stesso mese, quando il sindaco e altri rap-
129 «Il primo compito nostro in questo momento è evidentemente l'attuazione tempestiva,generosa ed equilibrata degli indirizzi e delle norme del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo; ed anzitutto la conoscenza e l'approfondimento della sua dottrina e del suo spirito» (Discorso di S. E. il Card. Arcivescovonella solennità del patrono S. Petronio [4 ottobre19661, in «Bollettino dell'archidiocesi di Bologna» [d'ora in poi «BAB»], LVII, 1966, pp.490-493, la citazione a p. 491).130 Il Cardinale Arcivescovo Giacomo Lercaro cittadinoonorario di Bologna, in «Bologna. Rivista del Comune», giugno 1967, p. Il. Lo stesso testo in Bologna onora il Cardinale Lercaro come il piu illustre dei suoi cittadini, in «Ad'I», 27 ottobre 1966, p. 6. Nel riprodurrela motivazione il «BAB» introdusse una variante: il «solidalmente» delle versioni sopra riportate divenne - forse senza intenzionalità - «solidamente» (Conferimento della ciuadinanzaonoraria di Bologna all'Em.mo Card. GiacomoLercaro, in «BAB»,LVII, 1966, p. 591).131 Battelli, Lercaro, Dossetti, la pace e il Vietnam, cit., pp. 207··209 e 289·293. L'esponente cattolico più in vista era Paolo Prodi.132 Al momento della nomina di Fanti il giornale cattolico si chiese: «È difficile dire quanto di lui c'è dietro le più recenti manifestazioni della Giunta comunale, quali ad esempiola decisione di porgere il benvenuto al Cardinale Arcivescovo al suo ritorno a Bologna dalConcilio» (Domani Guido Fanti sarà il nuovo sindaco, in «Ad'I», l" aprile 1966, p. 7).lJ3 Ivi, 9 ottobre 1966, p. 6.
402 Giuseppe Battelli
presentanti del governo della città si recarono al palazzo arcivescovile perinformare ufficialmente Lercaro della decisione del consiglio comunale, e il26 novembre successivo, giorno della cerimonia di conferimento, furono inmisura diversa ma nella medesima direzione altrettanti segnali di una svoltache ormai era sotto gli occhi di tutti; una svolta che, a prescindere dalle intenzioni dei suoi protagonisti, non poteva non suscitare un crescente allarmein chi vedeva a portata di mano -- nella primavera 1968 si sarebbero dovutetenere le elezioni politiche - la possibilità di un rovesciamento dei rapportidi forza nella politica locale, con tutte le conseguenze di trascinamento che1'eventuale crollo della leadersbip comunista a Bologna avrebbe potuto de-terminare in prospettiva in altre zone del paese tradizionalmente legate allasinistra. Quando dunque il Centro d'azione per la pace si predispose attorno al dicembre 1966 a organizzare una manifestazione/celebrazione che prevedeva un raduno nella piazza centrale della città, il saluto del sindaco, lamessa celebrata da Lercaro, un appello letto da un operaio e un ulteriore appello letto da un componente del Comitato universitario per la cessazionedella guerra in Vietnam'", si ebbe una reazione riservata ma del tutto esplicita della Dc 10cale135
, preceduta, forse non casualmente, da un intervento della segreteria della Conferenza episcopale italiana che segnalava a Lercaro cheRoma era stata anonimamente informata della nascita del Centro d'azione edelle sue iniziative'".
134 Battelli, Lercara, Dossetti, la pace e il Vietnam, cit., p. 292.135 «La manifestazione della Pace. È stato da me il Dr. Tesini per la questione della manifestazione della Pace. È piuttosto allarmato. Ho cercato di ridurre un po' le proporzionidella cosa: ma non sono riuscito a tranquillizzarlo. Sin dal principio del colloquio, del resto, mi aveva avvertito che voleva esprimermi le sue preoccupazioni e poi venire da V. Eminenza per manifestare direttamente a Lei il suo pensiero. Secondo il suo giudizio, partedei cattolici impegnati in politica non riuscirebbero a comprendere la nuova linea o perlomeno avrebbero bisogno di più tempo per assimilare la cosa. Ne ho semplicemente avvertito il Prof. Pro di, in attesa di poter conferire con Lei e precisare meglio l'atteggiamentoda seguire» (G. Dossetti, Appunto per Sua Eminenza, 17 gennaio 1967, in Fondazione Giacomo Lercaro, Archivio Lercara, b. Giornata pace e adesioni, fase. Comitato per la pace).Tesini era all'epoca segretario provinciale della Dc.136 Il 13 gennaio 1967 A. Pangrazio aveva scritto a Lercaro informandolo che alla segreteria della Cei era pervenuta una nota, che si trasmetteva in allegato. Si trattava di un «Appunto» anonimo, datato 29 dicembre 1966 e avente come oggetto «Bologna - Costituzione del "Centro d'Azione per la Pace"». Alla propria lettera, Pangrazio allegava inoltre copia delle risoluzioni che il consiglio di presidenza della Conferenza episcopale aveva presosu indicazione dello stesso Lercaro nell' aprile 1966. Intitolate Il dialogo con i comunisti esseerano improntate a grande prudenza e soprattutto distinguevano tra il dialogo privato (incentivato, come forma di apostolato personale) e quello pubblico (da condursi invece con«estrema cautela»). Il significato del loro invio a Lercara - che ne era stato il principaleestensore - assieme all'appunto anonimo che segnalava la nascita a Bologna del Centro d'azione per la pace mi pare vada interpretato nel senso di avvertire il cardinale che Roma
403 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
Dopo essere stata negli anni Cinquanta occasionale terreno di riflessioni teoriche sull' ordinamento internazionale nel quadro della dottrina sociale proposta da Pio XII, ed essere poi divenuta oggetto di vibrato confronto dottrinale nell'ultima fase del Concilio, la tematica della pace e della guerra sitrovava cosi a Bologna al centro di un delicato intreccio di problematiche:che andavano dalla riflessione di natura essenzialmente religiosa elaborata daDossetti per Lercara, alla recente prospettiva di dialogo tra i vertici dellaChiesa diocesana e il governo della città, alle implicazioni di politica internaed estera che tutto questo comportava dato che l'intera questione si stava dipanando sullo sfondo del conflitto in Vietnam. Senza trascurare la circostanzache mentre sul piano politico nazionale il conflitto costituiva un terreno discontro sistematico tra il governo a guida democristiana e 1'opposizione di sinistra, su quello ecclesiale riguardava non solo le questioni di principio maanche le concrete iniziative, religiose e diplomatiche, nelle quali la Santa Sedee in prima persona il papa si erano da tempo impegnati.È in questo quadro particolarmente complesso che il 26 aprile 1967, per laprima volta dopo la stesura del testo del settembre-ottobre 1965 sullo schema XIII, si presentò a Lercaro e Dossetti l'occasione di tornare a rifletterepubblicamente sulla tematica pace-guerra'". L'uditorio risultava in sé assaimeno importante rispetto a quello che sarebbe stato presente nell'aula conciliare di San Pietro un anno e mezzo prima, la situazione tuttavia - per le
era informata e non gradiva l'iniziativa, ritenendola oltretutto non componibile con quanto lo stesso Lercaro aveva scritto nelle risoluzioni relative al dialogo con i comunisti fatteproprie dal consiglio di presidenza della Cei. Il materiale sopra indicato si conserva in Fondazione Giacomo Lercaro, Archivio Lercara, b. Giornatapacee adesioni, fase. Comitato perla Pace. Le risoluzioni redatte da Lercaro sono parzialmente edite in F. Sportelli, La Conferenza Episcopale Italiana (1952·1972), [Galatina, Congedo, 1994], p. 233.m Il discorso venne presentato all'Archiginnasio di Bologna nell'ambito di un ciclo di conferenze dedicate alla Gaudium et speso La sua pubblicazione seguiun iter accidentato e forse non estraneo al clima in cui quelle vicende si inserirono. Sul «BAB», ad esempio, il testo non vide mai la luce. A pubblicarne la prima versione integrale fu «Testimonianze»con la seguente nota introduttiva: «Siamo vivamente grati a S. Em. il cardinale GiacomoLercara per averci concesso di pubblicare il testo integrale del discorso da lui pronunciato il 26 aprile di quest'anno all'Archiginnasio di Bologna. Il testo, cosi come è stato letto,non è ancora definitivo, poiché - come è stato esplicitamente dichiarato - esso dovrà essere perfezionato nella parte conclusiva» (Lercaro, La Chiesa e la pace, cit., p. 279). Taleperfezionamento non avverrà mai. Nel settembre 1967 l'editore Favero di Vicenza pubblicava una versione sostanzialmente identica a quella apparsa su «Testimonianze» (G. Lercaro, La Chiesa e la pace, Vicenza, Favero, 1967). Sempre da «Testimonianze» risulta infine ripreso il testo edito in Lercaro, La Chiesa e la pace, in Id., Discorsi sulla pace, cit., pp.53-76. Per le successive citazioni mi servirà della versione proposta sulla rivista fiorentina,la più affine al dattiloscritto riveduto dal cardinale (Fondazione Giacomo Lercaro, Archivio Lercara, Discorsi, b. Chiesa e pace, Bologna Archiginnasio, 26 aprile 1967).
404 Giuseppe Battelli
ragioni suddette - era comunque delicata. Forse anche per questo lo scrittoche venne predisposto rivela caratteristiche particolari e almeno in apparenza contraddittorie. Da un lato infatti si possono cogliere vari indizi di unastesura che venne accelerandosi verso la fine e che probabilmente si svolsein due diverse tasi'"; dall' altro per converso si ha la netta percezione di trovarsi di fronte alla riflessione piu impegnata che venne predisposta da Dossetti per Lercaro sul tema in questione'". Ne scaturi un testo che, destinatoin origine (e nel quadro dell'iniziativa che lo ospitava) a essere essenzialmenteun commento alla parte della Gaudium et spesche riguardava appunto la pacee la guerra, si era invece sviluppato nella seguente direzione: esplicita relativizzazione del valore magisteriale assoluto dei contenuti della costituzioneconciliare 140, sottolineatura del legame di fondo tra le «parti più profonde epiù ricche» della stessa e l'enciclica roncalliana Pacem in terris'", articolata
I3R Già Lercaro vi fece cenno durante il discorso. Ma la stessa situazione dei materiali preparatori mi pare indicativa. La copia del dattiloscritto conservata presso la Fondazione perle scienze religiose-Istituto per le scienze religiose (Fondo Lercaro, XXXV/1I6l) risulta infatti mancante dell'intera seconda parte (quella che iniziava appunto dopo la precisazionedi Lercaro). In sua vece è presente il ritaglio di «Ad'I», 28 aprile 1967, p. 3, che la riproduceva. Alla Fondazione Giacomo Lercaro si conserva invece la copia del dattiloscrittousata da Lercaro per la lettura pubblica del 26 aprile e 11 il testo è si completo ma la pagina che si apre con la precisazione di cui si è detto e che poi inaugura l'intera parte biblica del discorso contiene- accanto alla corretta ripresa della numerazione - il numero«2». Si può inoltre rilevare che la prima parte presenta sottolineature e segni di lettura deltutto simili a quelli presenti nelle copie di lettura lercarianc dei discorsi del 14 marzo 1954e del 28 febbraio 1956, mentre la seconda parte ne è del tutto priva ed evidenzia solo raretracce di interventi. In merito a tutto questo formulerei la seguente ipotesi. La parte deltesto relativa all'analisi della Gaudium et spes venne redatta rapidamente, anche considerando le riflessioni in merito sia durante il concilio che nell'immediato postconcilio, e consegnata a Lercaro come in altre circostanze per un'agevole lettura ed eventuali modifiche.Diverso invece il discorso relativo all'indagine biblica sul tema «pace» e dunque alla stesura della parte dell'intervento che la riguardava. Evidentemente i tempi si strinsero al punto che Dossetti e i suoi collaboratori consegnarono solo in extremis a Lercaro l'unico esemplare disponibile di questa ulteriore parte, sul quale si registra - come s'è detto l'assenza di accurate note di lettura lercariane.]J9 Il «discorso teologicamente più articolato» secondo Ruggieri, La profezia dellapace, cit.,p. 176.140 Tra i vari passi che proponevano questa lettura «rninimalista» del documento conciliare si trovava anche il seguente: «Più che per qualunque altro argomento trattato dal Concilio, quel che da esso è stato sancito intorno alla pace nelle ultime pagine della Gaudiumet spes, rappresenta un punto di partenza e non un punto di arrivo, è ancora suscettibilee bisognoso di sviluppi: invero esso resta non solo al di qua (come è ovvio e giusto in ogni,atto di magistero) delle punte più avanzate del pensiero cristiano contemporaneo, ma anche al di qua della coscienza media dei Padri Conciliari» (Lercaro, La Chiesa e la pace, cit.,pp. 280-281).141 Ivi, p. 281.
405 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
riflessione sulla ricchezza e centralità del messaggio biblico in ordine alla paceper dedurne che la pace è in ultima analisi il regno di Dio in atto e dunqueche l'annuncio della stessa «può essere soltanto profezia, e non frutto di induzione o di programma umano»!".Anche qui, come già nell'ottobre 1965, dopo una serie di considerazioni generali e di principio si arrivava a deduzioni concrete: ad esprimere, cioè, quelgiudizio su basi evangeliche che secondo il pensiero di Dossetti affidato allaparola e alla autorevolezza di Lercara - costituiva il proprium della Chiesa. Il26 aprile 1967 il giudizio si espresse tra l'altro in questi termini:
Appare con tutta evidenza che rifiutarsi di prendere un'iniziativa di pace unilateraleo di desistere da una iniziativa di guerra -- fino a che non sia stata dalla controparteaccettata preventivamente una certa riparazione e reintegrazione può essere forse (enon sempre, neppure da un punto di vista meramente umano) un discorso di buonsenso: ma non è certo un discorso cristiano, tanto meno un discorso che possa invocare a conferma la parola di Dio!".
Il riferimento poteva sembrare generico, ma tenendo presente l'acceso dibattito di quei mesi attorno alla guerra in Vietnam, non può non sorgere ildubbio che già in quelle parole si alludesse alla posizione degli Stati Uniti.Un indizio in tal senso mi pare d'altronde venga dall'accenno in quello stesso testo alle questioni attuali più controverse, tra le quali veniva inserito unrichiamo solo apparentemente astratto ai bombardamenti aerei massicci'".Tutto questo porta necessariamente a collegare tra loro l'intervento del 26aprile 1967 e la successiva omelia del 10 gennaio 1968, che vedremo trapOCO' 45
• Prima peraltro di soffermarci su questo va ancora notato come il te..sto dell' aprile 1967, riprendendo e articolando più ampiamente il contenutodi quello dell'ottobre 1965, contenesse elementi di continuità rispetto ai discorsi degli anni Cinquanta che abbiamo esaminato, a fianco peraltro di indizi di chiaro allontanamento dal clima di quel periodo. Da un lato infattiesso lasciava intuire sullo sfondo un metodo di lavoro che si richiamava a
142 Ivi, pp. 292-293.143 Ivi, pp. 297-298.144 «Ci soffermeremo, per un rapidissimo cenno, su due punti, particolarmente importantiper dirimere gli equivoci, che sono anche tra i cristiani, di frante a qualcuna delle fattispecie attuali più controverse (per esempio: cosiddetta guerra di legittima difesa; obiezio-ne di coscienza; non violenza, bombardamenti aerei massicci, ecc.)» (ivi, p. 296).145 Un collegamento proposto tra l'altro nella stessa omelia del l " gennaio 1968, dove Lercara affermava: «Vorrei ora, in particolare, richiamare .alla mia coscienza e riproporre a voiil discorso in cui, alcuni mesi or sono all'Archiginnasio, ho cercato di esporre i temi principali della dottrina conciliare e della visione biblica sulla pace: penso che quel discorsotrovi ora, al di là del previsto, una verifica e una nuova attualità in tutto quel che accadee viene detto da tante parti in questi ultimi giorni» (Lercara, Omelia del 1o gennaio 1968,cit., p. 82).
406 Giuseppe Battelli
quello già adottato da Dossetti un decennio prima per l'analisi dei radiomessaggi natalizi di Pio XII 146
; dall' altro evidenziava un chiaro punto di contrasto rispetto a quanto si è rilevato nel contenuto di alcuni testi lercarianidegli anni Cinquanta, con particolare riguardo per l'interpretazione di Matteo 10,34. In almeno due testi del 1954 infatti, nel quadro di una concezione della pastorale esemplificata dalla ricordata immagine dell' esercito diEsdra, la «spada» portata sulla terra da Cesii era stata interpretata e proposta dall' arcivescovo bolognese come simbolo della necessaria lotta da condurre contro i nemici dell'Evangelo e della Chiesa'"; nel testo dell'aprile 1967,al contrario, quella stessa «spada» non era simbolo di una lotta contro qual-cuna o qualcosa bensì segno della scelta per il Cristo, impegno alla testimonianza e al conseguente sacrificio condiviso col Cristo sconfitto e crocifisso.E se lotta c'era, era contro la propria ignavia'". Quasi un passaggio, dunque,da una pastorale combattiva, sociologica e al fondo specificamente anticomunista, a una sorta di «theologia crucis».A distanza di ore dalla sua lettura all'Archiginnasio il discorso di Lercarovenne fatto oggetto di un pubblico riferimento, velato ma inequivocabilmentepolemico, da parte del vicesegretario nazionale della Dc Flaminio Piccoli'".
146 «Ma dopo queste premesse, è ormai tempo che incominciamo ad affrontare i testi [...]In realtà, se si scompone per una analisi minuta tutto il capitolo V della Gaudium et Spese poi lo si ricompone per un giudizio globale, sembra di poter dire [...] Finalmente possiamo fare un'ultima constatazione. La ricomposizione sistematica sin qui compiuta...»(Lercaro, La Chiesa e la pace, cit., pp. 281 e 289).147 Per uno dei due testi si veda sopra, nota 17. L'altro è il seguente: «ll Regno di Dio (equindi la nostra azione pastorale, che tende ad instaurarlo nel mondo, nelle anime e nellasocietà) è lotta. Gesù ha detto di non essere venuto a portare la pace, ma la spada; e haindicato il principe di questo mondo come un nemico che non demorde e che ha al suoausilio eserciti» (Lercara, Sociologia religiosa e azione pastorale, cit., p. 202).148 «La pace del Cristo non lascia posto per illusioni, sino al punto di coesistere (e non ècontraddittorio) con aspre inimicizie e contraddizioni da parte del mondo che non aderisce al Cristo: "Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra: non sono venutoa portare la pace, ma la spada" (Mt 10,34). Questo ed altri simili testi non vogliono essere una smentita del Vangelo, annuncio di pace: ma ne costituiscono un decisivo chiarimento. La spada qui significa la scelta impegnativa per il Cristo, la testimonianza, e la sof.ferenza che essa comporta. La pace del Cristo non è dunque banale tranquillità, benessere terreno, facile consenso, conformismo, ma adesione a Dio mediante la scelta del Cristosconfitto e crocifisso» (Lercaro, La Chiesa e la pace, cit., pp. 295-296).149 Piccoli reagì immediatamente al discorso di Lercara, parlandone già il 28 aprile a Lucca durante un convegno di studio della Dc. L'intervento fu pubblicato sul quotidiano dipartito «Il Popolo», 29 aprile 1967, p. 4; ma soprattutto se ne offri un resoconto, comprendente l'esplicito contrasto con Lercaro, nell' articolo L'ispirazione e il ruolo della DCnel dibattito al convegno di Lucca, in «Ad'I», 29 aprile 1967, p. 1. Abbiamo una traccia,posteriore di un anno, della reazione del cardinale: «Politica, Strategia o... Vangelo? Alconvegno DC di Lucca (1967) ci fu una censura al discorso sulla Pace che il Card. Lerca-
407 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
Dopo le reazioni bolognesi e romane del gennaio 1967 anche la Dc nazionale metteva dunque sotto osservazione l'evolvere della situazione bolognese150.
E non era il solo e più grave episodio di quel periodo. Nelle settimane precedenti, infatti, era stato distribuito a Roma un opuscolo a stampa che, accompagnato dalla prefazione di un cardinale della Curia romana, attaccavaviolentemente Lercaro in quanto promotore della riforma liturgica'". Ne eraseguita una vivace polemica che aveva coinvolto anche la stampa laica e dalla quale era emerso con tutta evidenza che l'episodio, lungi dall' essere circoscritto, era sintomo di un complessivo attacco contro la linea di rinnovamentoportata avanti dal Concilio. Ma il problema riguardava la stessa situazione in·tema alla Chiesa bolognese, dato che sempre a inizio aprile 1967 Lercaro aveva comunicato alla diocesi il rinvio della ratifica del lavoro compiuto nei mesiprecedenti dai gruppi di studio da lui istituiti nel settembre 1966 per traeciare il programma dell' applicazione locale della riforma postconciliare: chiaro sintomo che anche a Bologna non mancavano resistenze in proposito'". Iltutto mentre di 11 a poco la decisione americana di penetrare in forze nellazona smilitarizzata tra i due Vietnam avrebbe suscitato a Bologna ampie reazioni popolari, evidenziando l'ennesima e sempre più palese spaccatura delcattolicesimo locale: emblematicamente riconducibile da un lato alla lineadella Dc bolognese, che in consiglio comunale votò contro un odg antiarnericano della maggioranza di sinistra ed espresse invece solidarietà alle forzedell'ordine che erano intervenute per disperdere i dimostranti'", e dall' altroa posizioni come quella del Centro d'azione per la pace, che all'opposto condannò il comportamento americano e propose uno sciopero simbolico nellefabbriche della città'".
ro aveva poco innanzi tenuto all'Archiginnasio: un discorso, apparve al Convegno, non basato sulla realtà, discorso di Profeta sprovvisto... E quella censura riecheggiò in altri discorsi... Come il discorso di Lercara continuò e si concluse con quello del 1o gennaio '68»(Lercara, «Vi ho chiamatofigli». Foglietti di meditazione, cit., 8 aprile 1968, p. 1056). Ilracconto in terza persona potrebbe far pensare a un estensore diverso da Lercaro, ma laverifica del manoscritto conservato in Fondazione per le scienze religiose-Istituto per lescienze religiose, Fondo Lercara, 390, Foglietti, 3, scioglie ogni dubbio in merito.150 Pochi giorni prima, d'altronde, il segretario Rumor aveva affermato al consiglio nazionaIe Dc: «Non sono possibili e concepibili da parte nostra, su questo tema cosi impegnativo, posizioni a senso unico di condanna e di pesante riserva nei confronti degli Stati Uniti» (Rumor illustra i compiti della D.C nelle prospettivedi sviluppo del Paese, in «Ad'I», 19aprile 1967, p. 2).151 T. Casini, La tunica stracciata. Lettera di un cattolico sulla «Riforma liturgica», Firenze,1967. La prefazione risultava firmata dal card. Antonio Bacci.152 Battelli, Tra chiesa locale e chiesa universale, cit., p. 183 e note.153 Le reazioni dei bolognesi alle vicende del Vietnam, in «Ad'I», 21 maggio 1967, p. 7, eDeplorati dalla DC gli episodi di violenza, ivi, 25 maggio 1967, p. 6.154 Il Centro diffuse un comunicato nel quale si diceva tra l'altro: «[Il Centro] ritiene che
408 Giuseppe Battelli
5. 10 gennaio 1968: l'epilogo inatteso. Nei mesi immediatamente successivi all'aprile 1967 e alle vicende connesse al discorso dell'Archiginnasio non vi furono ulteriori prese di posizione pubbliche sulla pace e la guerra da parte delvertice ecclesiastico bolognese. Non che il problema avesse perduto d'interesse: lo confermavano gli strascichi locali legati all'aggravarsi del conflitto inVietnam'", Ma accanto alla permanente centralità richiesta in quella fase dalproblema dell' attuazione in diocesi del Vaticano II altri avvenimenti assorbirono l'attività e le energie dell' ormai anziano prelato, conferendo anche alleannuali celebrazioni petroniane del 4 ottobre un profilo del tutto ordinarioe decisamente sottotono rispetto al 1966: dall'ingresso in diocesi del nuovoarcivescovo coadiutore uo settembre 1967), con il delinearsi di un non facile reciproco adattamento tra Lercara e Poma; alla preparazione e svolgimento(17-24 settembre) del decennale congresso eucaristico diocesano, evento legato a lontane tradizioni devote ma che conservava tuttora un ruolo importante per le esigenze di visibilità e presenza della Chiesa in una società dimassa; alla partecipazione a Roma alla prima assemblea del sinodo dei vescovi, prolungatasi per l'intero mese di ottobre e non senza problemi per lostesso cardinale di Bologna'",A dicembre però la questione riemerse in tutta la sua rilevanza, portando inpoche settimane a un epilogo repentino e imprevedibile. A innescare la sequenza di quelle ultime vicende fu una nuova iniziativa di Paolo VI, che dopomesi di relativo silenzio sulla situazione internazionale, coincidenti tra l'altrocon problemi di salute che consigliarono un intervento chirurgico, promosse un'ulteriore iniziativa in favore della pace. Non espressamente incentratasul conflitto vietnamita, anche se chiaramente originata dal suo svolgimentosempre più drammatico, essa consisteva nell'indizione di una giornata mondiale della pace da celebrarsi il l " gennaio 1968 e da ripetersi ogni anno _.questa in fondo era la vera novità, dato che già per il 4 ottobre 1966, anniversario della sua visita all'Gnu, il papa aveva indetta una giornata di pre-
senza alcun indugio si debba prendere posizione di fronte all'opinione pubblica per denunciare la drammaticità della situazione aggravatasi in seguito al nuovo passo dell'escalation militare americana nel Vietnam» (Le reazioni dei bolognesi alle vicende del Vietnam,cit.).155 A settembre 1967 si tenne tra l'altro in città il processo ad alcuni manifestanti antiamericani del maggio precedente, e una parte del mondo cattolico bolognese diffuse un manifesto in cui si dichiarava «moralmente illecito che si colpisca una manifestazione pacifista con il pretestuoso argomento che essa potrebbe degenerare nella violenza» (Solidarietàdi gruppi con i giovani arrestati, in «Ad'I», 15 settembre 1967, p. 7).156 Ci fu durante i lavori un chiaro attacco contro la riforma liturgica elaborata dall'organismo postconciliare presieduto dallo stesso Lercara (G. Caprile, Il sinodo dei vescovi. Prima assemblea generale [29 settembre-29 ottobre 19671, Roma, Civiltà cattolica, 1968, p.507).
409 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
ghiere per la pace nella medesima circostanza. La comunicazione ufficialedell'iniziativa e delle sue motivazioni venne affidata a un messaggio papaledatato 8 dicembre 1967157
• I contenuti erano essenzialmente religiosi, anchese per buona parte non rivolti al mondo cattolico bensi a «tutti gli uomini dibuona volontà». Ma che le affermazioni montiniane si mescolassero inevitabilmente con prospettive di natura diplomatica lo confermava la strada seguita dalla Santa Sede per la diffusione del messaggio e per la preparazionedella giornata del I" gennaio!", mentre la valenza anche politica che quest'ultima poteva assumere -- soprattutto dopo l'improvviso annuncio sullastampa che il 23 dicembre il papa avrebbe ricevuto in udienza il presidenteamericano Johnson - fece S1 che la questione venisse esaminata in quei gior-ni anche dalla dirigenza nazionale del Pd59
•
A Bologna l'arrivo del messaggio di Paolo VI e delle connesse istruzioni daparte della Santa Sede venne accolto con particolare entusiasrno'", visto l'im-pegno che come si è visto i vertici della diocesi e anche vari settori del mondo cattolico avevavo profuso a riguardo. Proprio in relazione a quell'impegno, tuttavia, si ritenne che l'accoglienza e la promozione in città dell'iniziativa montiniana dovessero svolgersi secondo una linea di continuità con ciòche localmente già era stato fatto. L'espressione cui ricorse in quella circostanza Dossetti (<<non calpestare i semi e le piantine già nate. Segnare unacerta continuità sia pure in modo non polemico ma positivoxl'" era un segno chiaro della volontà di recepire la linea tracciata dal pontefice ma senzamodificare la strada che si era scelta e in parte percorsa. Una strada caratterizzata da due elementi di fondo. Sul piano prettamente religioso e intraecclesiale dare priorità assoluta alla testimonianza dell'Evangelo, affidata- secondo una specifica concezione ecclesiologica -- soprattutto al magistero del
[57 Messaggio di Sua Santità Paolo VI per la celebrazione di una «Giornata della pace», in«L'Osservatore romano», [d'ora in poi «Olì»], 16 dicembre 1967, p. 1.158 Nel caso dell' episcopato italiano il segretario di Stato Cicognani, attraverso la Nunziatura apostolica d'Italia, incaricò la Cei di trasmettere ai vescovi del nostro paese il testodel messaggio con relative istruzioni (Battelli, Lercara, Dossetti, la pace e il Vietnam, cit.,pp. 201-202 e 295-296).[59 Fondazione Istituto Gramsci, Archivio del Partito comunista italiano, 1967, Segreteria,Resoconto riunione Ufficio politico e Ufficio segreteria sull'appello di Paolo VI per la «Giornata della Pace» - 22 dicembre 1967, mf. 019, 1024-1027. Uno stringato commento anchein ivi, Riunione ufficio di segreteria del 22 dicembre 1967, mf. 019, 1396.160 Lercaro mandò probabilmente un telegramma a Roma, perché l'«OR» (nell' articoloDopo l'appello dell'S dicembre. Verso la «Giornata della pace», 27,28 dicembre 1967, p. 2)pubblicò la notizia che il cardinale bolognese esprimeva «l'entusiastica adesione del Clero, delle autorità e del popolo di Bologna, all'iniziativa del Santo Padre e alle alte intenzioni che l'animano».161 G. Dossetti, appunto del 18 dicembre 1967, citato in Battelli, Lercara, Dossetti, la pacee il Vietnam, cit., p. 207.
410 Giuseppe Battelli
vescovo: fulcro della vita religiosa diocesana'". Sul piano invece del rapporto tra la Chiesa e la società civile mantenere aperto quell'inedito dialogo conl'amministrazione civica che aveva segnato il superamento della precedenteconflittualità ideologica. Il tema della pace risultava a riguardo del tutto idoneo, tanto più che a quel valore si erano richiamati nelle diverse ricordatecircostanze prima Dozza e poi Fanti, accennando ora alla naturale propensione del popolo bolognese ora al magistero lercariano.Nella pianificazione delle iniziative che avrebbero dovuto preparare in diocesi la giornata del I? gennaio 1968 entrambi quegli elementi entrarono decisamente in gioco. Per ciò che riguardava i rapporti con la società civile venne infatti scartata l'eventualità di un semplice invio del messaggio papale alle«comunità dei non credenti», e sulla base di un accordo con il sindaco chetrovò un pieno assenso da parte dei vertici nazionali del Pei-· si optò per unaconsegna ufficiale del messaggio papale che il cardinale avrebbe dovuto farea Palazzo d'Accursio il 22 dicembre'", Per quello che riguardava invece laChiesa locale si concentrò l'attenzione sulla giornata del l " gennaio, articolandola in due distinti essenziali momenti: la lettura nelle chiese parrocchiali di una sintetica catechesi sulla pace sostitutiva dell' omelia del giorno, affinché nell'intero territorio diocesano venisse presentata un'univoca interpretazione del messaggio di Paolo VI e in generale del recente magistero dellaChiesa in merito alla pace'"; la lettura in cattedrale da parte di Lercaro di
162 L'ecclesiogia del Vaticano II l'aveva senza dubbio ribadita, ma già in precedenza se netrovano evidenti tracce sia in Lercaro che Dossetti. In Lercaro con un taglio più disciplinare: «Vorrei che vi leggeste le lettere di S. Ignazio martire: sono l'eco della parola degliApostoli, che egli ascoltò e che lo consacrarono Vescovo: e vedrete cos'era per gli Apostoli, e per le Comunità che avevano ascoltate le loro parole, il Vescovo nella sua Chiesa;e come nulla del lavoro apostolico deve essere in contrasto con le direttive e la disciplinada lui segnata» (G. Lercaro, omelia del 4 gennaio 1961, in Piccolo sinoda diocesano. Norme e direttive pastorali de re liturgica et pastorali, emanate nel!'assemblea generale del clerodell'archidiocesi di Bologna, 3-4 gennaio 1961, Bologna, Utoa, 1961, pp. 128-129). In Dossetti, attorno alla metà anni Cinquanta, secondo un'impostazione decisamente teologica:«Non è vero, o almeno non è normale, non è fisiologico nel corpo della Chiesa che le iniziative di rinnovamento debbano venire prevalentemente"dalla base": dalla base del popolo fedele sale "la fame e la sete della Parola di Dio", cioè della vita divina. E questa lavora laici e Clero, ma di per sé è dai Pastori preposti alle Chiese particolari che deve venire l'atto rivoluzionario cristiano che è l'atto di fede» (Battelli, Tra chiesa locale e chiesauniversale, cit., p. 172 nota 102).16J G. Pajetta: «Se Lercaro va al Consiglio comunale è cosa interessante» (Resoconto riunione Uffz'do politico e Uffiao segreteria sull'appello di Paolo VI, cit., 1024); F. Di Giulio:«Il problema della risposta del Partito possiamo risolverlo con la replica di Fanti a Lercaro, impostata in un certo modo» (ibidem). Altre consegne riguardarono poi i vertici dell'amministrazione provinciale, l'università e le autorità municipali del forese.164 Battelli, Lercaro, Dossetti, la pace e il Vù!tnam, cit., pp. 274-278 (analisi) e 299·304 (testo integrale).
411 l vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
un'omelia mediante la quale effettuare la consegna simbolica del messaggiornontiniano ai fedeli della Chiesa di Bologna.Dossetti preparò per le varie circostanze cinque diversi testi, due dei quali il discorso in Palazzo d'Accursio e l'omelia in cattedrale -- risultarono di granlunga i più impegnativi. Nel primo occorreva adempiere all'esigenza che abbiamo ricordata (<<Segnare una certa continuità sia pure in modo non polemico ma positivo»). E Dossetti vi fece fronte attraverso un non facile equilibrio tra la necessità di valorizzare l'iniziativa montiniana e la scelta di cono.fermare il cammino che a Bologna si stava da tempo compiendo; l'esito,particolarmente audace dal punto di vista ecclesiologico'", raccolse con poche modifiche il consenso di Lercaro e suscitò invece l'allarmata reazione delnuovo coadiutore Poma166
• Ma fu soprattutto attorno all'omelia in cattedraleche si giocò la partita più importante di quell'ultimo passaggio del camminoqui ricostruito: era infatti evidente che nella situazione creatasi in quelle settimane, e negli stessi due anni precedenti, non era possibile restare coerentirispetto alla scelta di un vero dialogo con la città e le sue maggiori istituzioni pubbliche senza affrontare quella che nella stessa omelia sarebbe stata indicata come la «precisa questione dirimente»: i bombardamenti americani sulVietnam del Nord.La decisione di parlarne, e dunque di prendere posizione, era emersa conogni probabilità già all'interno dei contatti tra Dossetti e il sindaco che avevano portato alla consegna del messaggio a Palazzo d'Accursio il 22 dicembre 1967. Rispetto tuttavia all'impegno che forse venne preso già allora subentrarono nei giorni successivi vari eventi che rendevano sempre più difficile tenervi fede. In quello stesso 22 dicembre infatti Paolo VI intervennesulla questione dei bombardamenti, ribadendo la sua nota posizione ufficiale: sospensione dei bombardamenti americani bilanciata da un «un segno diseria volontà di pace» da parte nordvietnamita'". Il 23 dicembre «l'Unità»mise in prima pagina, l'uno accanto all'altro, un fondo di Berlinguer e un articolo senza firma nei quali si manifestava delusione per le parole papali delgiorno prima, e a fianco un terzo articolo di valorizzazione dell'incontro chesi era tenuto a Bologna in Palazzo d'Accursio tra Lercara e Fanti'". La sera
165 Nella stesura dossettiana originaria si diceva: «Nell' ambito della universale Chiesa diCristo, è soprattutto la Chiesa locale - come comunione, immediata e direttamente sperimentabile, di fede, di culto e di opere, -- che può avere una particolare forza di magistero, in proporzione della sua capacità concreta di coerenza e di esemplarità» (Battelli, Lercaro, Dossetti, la pace e il Vietnam, cit., p. 229).166 Ivi, pp. 220-239, l'intero percorso delle vicende e delle modifiche che portarono alle tresuccessive redazioni.167 Allocuzione di Paolo VI al Sacro Collegio e alla Prelatura Romana, in «OR», 23 dicembre 1967, pp. 1-2.168 E. Berlinguer, Simbolo di guerra, in «l'Unità», 23 dicembre 1967, p. 1; Delude il Papa
412 Giuseppe Battelli
dello stesso 23 Montini ricevette in udienza Johnson, affrontando la questione del Vietnam e le vie per una risoluzione del conflitto'". Il prendere posizione in merito implicava dunque in quello specifico momento, ben più chein fasi precedenti, un'inevitabile esposizione di Lercaro rispetto a uno scenario che, a prescindere dalle motivazioni dell'arcivescovo bolognese, avevain sé delle chiarissime implicazioni politico-diplomatiche. Dossetti parve voler desistere, anche perché un'ulteriore vicenda occorsa nelle settimane precedenti non lasciava margini di dubbio sulle ricadute anche non religiose chene sarebbero derivate'". Lercaro invece decise di andare avanti'" e il l" gennaio 1968 lesse in cattedrale, con poche ma rilevanti modifiche, l'omelia predisposta da Dossetti nell'immediata vigiliamoL'omelia era stata pensata, già prima del 22 dicembre, come momento culminante dell'intero programma di iniziative da attivare in diocesi per dare risonanza al messaggio papale per la giornata della pace. E tale rilevanza, coni problemi che poteva comportare il suo contenuto, impresse nel testo tracce evidenti; tanto che, nonostante l'assoluta compattezza e coerenza di un tessuto espositivo che intendeva ricalcare quello del discorso a Palazzo d'Ac ..cursio del 26 novembre 1966 per il conferimento della cittadinanza onorariae che produsse un esito che ancora oggi colpisce per la rara efficacia, non èdifficile individuare i diversi piani!elementi di cui Dossetti tenne conto nella costruzione e che attraversano, spesso intrecciati tra loro, l'intero docu-
sul Vietnam, ibidem; S. So., Incontro di pacea Bologna tra Lercara e il Sindaco, ibidem (l'occhiello precisava: Il cardinale in visita a Palazzo d'Accursio).ie Il contenuto dell'incontro sarebbe stato ovviamente conosciuto solo in seguito. Un comunicato convenuto tra Paolo VI e Johnson apparve sulla stampa nei giorni successivi, mail vero contenuto, per quanto attraverso un resoconto di parte americana, è consultabilein Memorandum 0/Conuersation, 23 dicembre 1967, in Foreign Relattons0/the United States, 1964-1968, voI. XII, Western Europe, ed. by J.E. Miller-D.S. Patterson, Washington,Usgpo, 2001, pp. 660-666.170 Il 5 dicembre precedente due funzionari d'ambasciata americani si erano recati a Bologna per conoscere la situazione politica locale in vista delle elezioni del 1968 e avevano tral'altro parlato con Dossetti, riportandone la netta sensazione di una sua forte ostilità rispetto all'azione militare statunitense in Vietnam (A. Melloni, Un discepolo nella storia. Pergli studi su GiuseppeDossetti, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LI, 1997, pp. 421450, specialmente p. 444 nota 98). In un giorno non precisato, ma ragionevolmente con~cabile tra il 23 e il 31 dicembre 1967, Dossetti scrisse in tal senso a Fanti: «Gentile SignorSindaco, [oo.J due notizie, una in un senso e l'altra in un altro, mi danno da pensare: nonvorrei che una cosa che deve essere pura e serena, possa prestarsi a colorazioni meno puree chiare .... Riflettiamo un momento ancora» (citato in Battelli, Lercara, Dossetti, la pace eil Vietnam, cit., p. 257 nota 191).171 Battelli, Lercara, Dossetti, la pacee il Vietnam, cit., pp. 257 ..258.172 Il testo è stato edito in varie sedi. Farò riferimento a G. Lercara, Omelia del 1o gennaio1968, in Discorsi sulla pace, cit., pp. 79-87.
413 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
mento. Innanzitutto il fine prioritario, se non in fondo unico, di esprimereun giudizio in merito ai bombardamenti americani sul Vietnam del Nord: superando perlomeno su quel punto il confine impalpabile, ma resistentissimonel linguaggio e nei comportamenti dei vertici cattolici anche di quei giorni,tra astratte affermazioni di principio in favore della pace e concrete e chiareprese di posizione contro specifiche azioni di guerra. In secondo luogo il raggiungere quel fine all'interno di un discorso che intendeva in ogni caso ri.chiamarsi il più possibile ai pronunciamenti papali delle ultime settimane:non tanto per mescolare le carte attraverso un abile gioco di citazioni o innome di un'astuta ironia'", quanto per manifestare in un'occasione pubblica e di particolare significato per la Chiesa bolognese: la messa episcopale introdotta un anno prima nel quadro del programma formulato ricevendola cittadinanza onoraria!" - una volontà di sintonia nei confronti del pontefice che attenuasse il più possibile la percezione delle palesi differenze cheLercaro e Dossetti non potevano non avvertire tra la propria posizione e quella di Paolo VI. Infine il riprendere concetti e orientamenti riguardanti la pacee la guerra che erano già inseriti negli interventi letti da Lercaro o nei giorni precedenti o in passate occasioni: quasi ad esprimere una sintesi complessiva del suo pensiero in merito alla questione sul tappeto.La presa di posizione sui bombardamenti americani venne affidata alle parole:
Intendo riferirrni, come voi ben capite, alle insistenze che si fanno in tutto il mondopiù corali e delle quali si è fatto eco il Papa nel recentissimo discorso ai Cardinali- perché l'America (al di là di ogni questione di prestigio e di ogni giustificazionestrategica) si determini a desistere dai bombardamenti aerei sul Vietnam del Nord'".
A questo seguiva ciò che Paolo VI aveva detto nella circostanza del 22 dicembre. L'esplicita citazione montiniana - non presente nella stesura di Dossetti e aggiunta in extremis da Lercaro o altri - invece di dare forza a quanto aveva letto poco prima il cardinale mise in realtà e maldestramente anco-
. l'a più in risalto la dissonanza tra la richiesta lercariana, riferita solo allasospensione dei bombardamenti statunitensi, e il passo dell'allocuzione montiniana: che al contrario si rivolgeva a entrambi i contendenti e che oltretutto - a differenza dell' omelia letta a Bologna, nella quale si chiedeva espres-
173 Sono d'accordo con le considerazioni in merito di Ruggieri, La profezia della pace, cit.,p. 175.174 G. Lercaro, Discorso in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, in Id., Discorsi sulla pace, cit., pp. 41-50, specialmente p. 49. E in effetti l'omelia accennava esplicitamente a questo particolare aspetto: «Qui, stasera in questa Messa episcopale, lo consegniamo idealmente a tutti i fedeli della nostra Chiesa bolognese» (Lercara, Omelia dellogennaio 1968, cit., p. 80).l75 Lercara, Omelia dello gennaio 1968, cit., p. 85.
414 Giuseppe Battelli
samente all'«America» di sospendere i propri bombardamenti non chiamava mai esplicitamente in causa né l'«America» né gli «americani»?".Tornando tuttavia al contenuto essenziale dell'omelia va sottolineato comeDossetti applicasse nel passaggio sopra ricordato il principio del «giudizio»che la Chiesa, per coerenza rispetto alla propria dottrina sulla pace, non poteva non dare sui bombardamenti americani: che andavano giudicati in sé,per quello che erano, e non rispetto ad altro'". Paolo VI invece, nell' allocuzione ai cardinali, applicava innanzitutto il principio della posizione superpartes della Chiesa; poi, forse per non suscitare l'impressione di seguire nella fattispecie la linea americana ufficialmente ribadita ancora in quei giorni dal presidente johnson e ripresa come si è visto dallo stesso quotidiano della SantaSede, puntualizzava che la sua richiesta era avanzata in nome di coloro chesu entrambi i fronti erano vittime delle azioni militari. La differenza era dunque e in ultima analisi tra lo schierarsi non a favore di qualcuno e a stavore di qualcun altro, bensi contro il male: perché la via della Chiesa era quella della profezia e non quella della neutralità, come chiariva un passaggio dell'omelia bolognese sul quale tra poco ritorneremo .- e il non schierarsi,concentrando l'impegno nel formulare auspici di profilo universale, nell'invocare la pietas nei confronti degli inermi, nel richiamare l'attenzione sullanecessità di pensare alla pace anche come problema essenzialmente interiore. Lo confermavano gli altri due punti nei quali l'omelia si riferiva in modochiaro agli interventi montiniani di quelle settimane, tentandone certo un'assunzione ma svelando anche il proprio diverso orientamento.Si trattava di due punti essenziali per l'impostazione complessiva del testo. Ilprimo riguardava la scelta di proporre all'ascolto dei fedeli una riflessione chescaturisse da uno «scavato» esame di coscienza. Era una via già seguita daDossetti nel discorso letto da Lercaro il 26 novembre 1966 per I'accettazio-
176 La differenza appare evidente se si confrontano la stesura completa del passo di Montini e la citazione che ne fece Lercara. Montini (22 dic. 1967): «Molte voci Ci giungonoinvitandoCi ad esortare una parte belligerante a sospendere i bombardamenti. Noi lo abbiamo fatto e lo facciamo ancora a nome degli inermi che, pur involontariamente, sonovittime di tali azioni militari. Ma contemporaneamente invitiamo di nuovo anche l'altraparte belligerante - e amiamo pensare di essere in ciò seguiti da quanti possono autorevolmente esercitare determinante influsso in questo senso - a dare un segno di seria volontà di pace. E lo facciamo ancora in nome di colora che sono colpiti da atti di terrorismo e di tutto un popolo che soffre, di vite umane inutilmente sacrificate. Cessi la violenza in qualunque forma» (Allocuzione di Paolo VI al Sacro Collegio, cit., p. 2). Lercara (logenn, 1968): «Molte voci ci giungono invitandoci ad esortare una parte belligerante a sospendere i bombardamenti. Noi lo abbiamo fatto e lo facciamo ancora... Ma contemporaneamente invitiamo di nuovo ora l'altra parte belligerante... a dare un segno di seria volontà di pace» (Lercara, Omelia del 1o gennaio 1968, cit., p. 85).177 Era, nella sua sostanza, lo stesso principio sostenuto oltre un anno prima da La Vallenel ricordato articolo Bombe sul Vietnam, in «Ad'I», 4 luglio 1966, p. 1.
415 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
ne della cittadinanza onoraria e di nuovo, e questa volta con riferimento di~
retto alla pace, nel «Te Deum» del 31 dicembre 1966 l78, ma che ora trovava
un ulteriore motivo di applicazione perché sollecitata dal messaggio papaledell'8 dicembre 1967. Un'espressione di quest'ultimo, in particolare, venneripresa nell' omelia del 10 gennaio 1968 e cosi riproposta, con un rafforzamento mediante il corsivo che risulta inesistente sia nella versione montiniana che nell'unica stesura preparatoria di Dossetti di cui al momento si dispone: «Vorremmo che non mai ci fosse rimproverato da Dio e dalla storia diavere taciuto davanti al pericolo di una nuova conflagrazione fra i Popoli»:".Queste parole sarebbero «entrate più a fondo nell' anima» dell' arcivescovobolognese, ma è interessante notare come dopo averle citate nell' omelia incattedrale egli ne fornisse un'applicazione a se stesso cosi formulata:
Anche a me, secondo la mia misura e responsabilità!", anche a me, da tanti anni vostro Pastore e vostro Maestro, voglia il Cielo che non si debba mai rimproverare diavere taciuto qualche cosa che potesse essere essenziale alla valida testimonianza dipace della nostra Chiesa, nel contesto - umano, sociale, culturale in cui essa vivee opera!",
Il confronto, tra l'altro guidato dai corsivi, mette in chiara evidenza come deldiscorso generale svolto da Montini si prendesse in sostanza soprattutto ilconcetto del silenzio da evitare (il «tacere»), per poi svilupparlo seguendouna linea già anticipata nelle parole lette da Lercaro in Palazzo d'Accursio il22 dicembre. Era infatti dalla prima delle tre «affermazioni ben precise» formulate a Palazzo d'Accursio che veniva ricavata con piccoli ritocchi l'espressione «nel contesto...», con la particolarità che Dossetti ripristinò la forma originaria «opera» laddove il probabile intervento di Poma lo aveva trasformato in «spera»; e dove la specificazione «qualche cosa» può essereinterpretata come intenzionalmente anticipatrice della richiesta di cessazionedei bombardamenti americani formulata nel prosieguo dell' omelia.Il secondo dei punti prima indicati prendeva invece spunto dal radiomessaggio natalizio del 23 dicembre 1967. In esso Paolo VI era ritornato sul pro-
178 «E ora al momento in cui due anni si congiungono nella continuità del tempo che volge sarebbe incoscienza disperdersi, senza provvedere doverosamente ad un esame cii coscienza. La pace l'abbiamo invocata. Ma l'abbiamo avuta nel cuore, nell'intelligenza, l'abbiamo vissuta nei rapporti familiari?» (<<Sarebbe triste se il nostro spirito non insorgesse contro la guerra», ivi, 2 gennaio 1967, p. 7).179 Messaggio di Sua Santità Paolo VI per la celebrazione, cit.180 Qui si parlava di Paolo VI e ciiLercaro, ma può essere interessante notare come nel te·sto letto il 22 dicembre in Palazzo cl'Accursio una formula simile fosse stata utilizzata nelpunto in cui si toccava la dialettica tra Chiesa universale e Chiesa locale (<<La Chiesa diBologna si sente investita, per la sua parte cii responsabilità...»).181 Lercaro, Omelia del .1 o gennaio .1968, cit., p. 81.
416 Giuseppe Battelli
blema della pace, ma per chiarire che dopo aver parlato spesso della paceesteriore, «della pace politica, militare, sociale, comunitarias-'", si sentiva oraautorizzato dalla spiritualità del Natale a parlare della pace interiore e personale. Il testo letto a Bologna il l o gennaio 1968 recuperò quello spunto, marimanendo in linea con il criterio di contemperare ancora una volta le dueprospettive (quella suggerita da interventi di Montini e quella più tipicamentebolognese) e spianando decisamente la strada al cuore tematico e problematico dell'intera omelia. Lo fece a partire dall'ulteriore riferimento a una sorta di pubblico esame di coscienza: «Mi chiedo se quel che ho detto sinorapuò bastare o se ancora non vi sia qualche cosa da aggiungere ...»183. Si riproponeva dunque il problema del tacere o del dire che abbiamo già vistoprima, e di nuovo si accennava al «qualche cosa». Poi prosegui: «Mi vadoconvincendo sempre più che il compito della Chiesa al riguardo è duplice,consta di due elementi complementari e inscindibili», Il primo di questi dueelementi era appunto relativo a quello che stava facendo Montini: cioè continuare a spiegare l'«insegnamento generale cristiano sulla pace», guidandoinoltre credenti e non credenti «a ricomporre in se stessi quella pace personale e interiore che l'uomo moderno poco conosce-'". Ma c'era un secondoelemento, complementare e - secondo Dossetti - inscindibile dal primo:
La Chiesa non deve far mancare il suo giudizio dirimente non politico, non culturale, ma puramente religioso - sui maggiori comportamenti collettivi e su quelle decisioni supreme dei Responsabili del mondo, che possano coinvolgere tutti in situazioni sempre più prossime alla guerra generale e che possano, a un tempo confonderele coscienze [...] La Chiesa non può essere neutrale, di fronte al male da qualunqueparte venga: la sua via non è la neutralità, ma la profezia [...] Il profeta può incontrare dissensi e rifiuti, anzi è normale che, almeno in un primo momento, questo accada [...] È meglio rischiare la critica immediata di alcuni che valutano imprudenteogni atto conforme all'Evangelo, piuttosto che essere alla fine rimproverati da tutti dinon aver saputo quando c'era ancora il tempo di farlo -- contribuire ad evitare ledecisioni più tragiche o almeno ad illuminare le coscienze con la luce della Parola diDio l8
' .
Tornava dunque, a distanza di quindici anni, il principio formulato nel 1954riflettendo sulla concezione dell'ordine sociale esposta nei radiomessaggi natalizi di Pio XII. E proprio questa ulteriore formulazione, anticipata peraltronell'intervento che Lercaro aveva rinunciato a leggere in Concilio a ottobre1965, attesta in modo evidente l'evoluzione che si era compiuta: da una vi-
l" L'augurio e la guida per la pace integrale dono di Dio agli individui e alle nazioni. Radiomessaggio natalizio di Sua Santità Paolo VI, in «OR», 24 dicembre 1967, p. 1.183 Lercara, Omelia del 10 gennaio 1968, cit., p. 82.184 Ivi, p. 83.185 Ivi, pp. 83-84.
417 I vescovi italiani e la dialettica pace-guerra
sione ancora societaria e velatamente «giuridica» del ruolo della Chiesa nella storia a una visione che si appellava a un mandato prettamente evangelico. Era un passaggio notevole: forse spiegabile sia sulla base dell'evoluzionedi Lercaro e Dossetti, sia con il clima decisamente diverso che pur a distanza di pochi anni aveva segnato il passaggio da uno scenario storico all'altro,dentro e fuori il cattolicesimo. La stessa possibilità che si verificassero a Bologna eventi come il conferimento a Lercaro della cittadinanza onoraria periniziativa di una giunta monocolore comunista o che si immaginasse di poterorganizzare una manifestazione pubblica in favore della pace nella quale porre in sequenza un saluto del sindaco comunista, la messa di un cardinale, discorsi di un operaio e di un docente universitario, era in fondo il segno dell'inedito incontro tra una «profezia» religiosa e una «utopia» laica. Quasi chesi realizzasse una seconda volta l'esperienza di dialogo tra le due visioni integrali dell'uomo (cattolica e comunista) che Dossetti aveva già prospettata esperimentata all'epoca della Costituente, e dove la pace veniva ora a costituire quel valore condiviso che allora fu incarnato dall' anteriorità della persona rispetto allo Stato'",Quell'esperienza nuova di dialogo non ebbe futuro. Poche settimane dopo lalettura dell' omelia in cattedrale Lercaro apprese da un emissario vaticano cheil suo governo episcopale era finito. Sul piano storiografico il nesso causaletra le due circostanze - la denuncia dei bombardamenti americani e la destituzione - non è mai stato effettivamente documentato, né forse potrà maiesserlo in modo risolutivo. La percezione che ne ebbe Lercaro sembra tuttavia non lasciare dubbi sostanziali. Un paio di mesi scarsi dopo l'ufficializzazione delle forzate dimissioni dell' arcivescovo di Bologna, nella residenza cheospitava i giovani da lui accolti venne infatti esposto un foglietto di meditazione che conteneva proprio il passaggio fondamentale dell'omelia del 10
gennaio 1968 relativo alla non neutralità della Chiesa e al compitaidestinodel profeta che abbiamo prima messo a fuoco'". Il fatto mi pare emblemati ..co. In sé perché confermava, anche a distanza di tempo e dopo la drammatica vicenda della destituzione, la consapevolezza con la quale Lercara avevadeciso il 10 gennaio 1968 di prendere posizione su una tematica e in un momento decisamente delicati. Rispetto invece al cammino complessivo qui descritto perché, se negli anni Cinquanta e ancora a inizio anni Sessanta la riflessione pubblica sulla pace che Lercara propose sembrava in fondo nonestranea ma certo staccata dalla linea prevalente del suo governo, ora invecesi evidenziava una chiara saldatura tra quei diversi piani; e il contributo dipensiero e di sensibilità religiosa offerto da Dossetti dava voce a un sentirepersonale davvero lercariano.
186 Miccoli, L'esperienza politica, cit., p. 22.187 Lercara, «Vi ho chiamato figli». Foglietti di meditazione, cit., 4 aprile 1968, p. 1054.