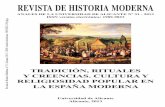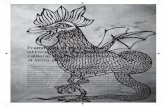P.-J. Proudhon, L'idea generale di rivoluzione nel XIX secolo (edizione e traduzione)
"Popolarità e influenza dei farisei nel giudaismo palestinese del I secolo", in M.B. Durante...
-
Upload
storiadelcristianesimo -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of "Popolarità e influenza dei farisei nel giudaismo palestinese del I secolo", in M.B. Durante...
13
Popolarità e influenza dei fariseinel giudaismo palestinese del I secoloMarco Vitelli
Introduzione
Per un corretto approccio al problema affrontato in questo volumenon si può prescindere da un attento esame della situazione del giudai-smo palestinese nel quale il movimento dei seguaci di Gesù è nato e colquale si è confrontato. In questo contributo intendo affrontare un aspettospecifico ma assolutamente centrale di questo tema, ovvero il ruolo delfariseismo nella società palestinese all’alba del cristianesimo: la storiadella ricerca insegna che il modo in cui si ricostruisce questo ruolo co-stituisce un fattore determinante per l’interpretazione del giudaismo delSecondo Tempio e dunque del rapporto tra questo e il cristianesimonascente.
Fino a qualche decennio fa era consuetudine nelle ricostruzioni stori-che della realtà religiosa palestinese del Secondo Tempio attenersi al qua-dro offerto da Flavio Giuseppe. Questi, com’è noto, distingue quattro hai-reseis: farisei, sadducei, esseni e il gruppo di Giuda il Galileo. Lo stessostorico ebreo chiarisce tuttavia che tali “scuole” non hanno un pari gra-do di influenza nella società giudaica: i farisei sono l’hairesis più popola-re (Ant. 13,288.298.401ss), godono fama di essere il gruppo più precisonell’interpretazione della Legge (Bell. 1,110; 2,162; Ant. 17,41; Vita 191) edettano le regole circa tutto ciò che riguarda il culto divino (Ant. 18,15);i sadducei, invece, costituiscono un’élite aristocratica minoritaria, chedeve piegarsi ai dettami farisaici se vuole essere accettata dal popolo(Ant. 13,298; 18,17); quanto alle due rimanenti “scuole”, gli esseni appa-iono come un gruppo tutto sommato marginale, settario (Bell. 2,120ss;Ant. 18,18ss), e la “scuola” di Giuda il Galileo, per quanto non priva diseguito, figura come una sorta di filiazione dal fariseismo (Ant. 18,4.9.23).
Tale quadro appariva confermato dalle altre due principali fonti let-terarie: il NT e la letteratura rabbinica. Nel NT, infatti, mentre gli essenisono assenti e i sadducei in quanto tali, come anche i seguaci di Giuda ilGalileo, sono una presenza alquanto evanescente, ai farisei è assegnatoun ruolo di primo piano: siedono autorevolmente sulla «cattedra di Mosè»(Mt 23,2), vantano una posizione di preminenza nella sinagoga (Lc 11,43//Mt 23,6), sono temuti persino dai «capi» (Gv 12,42), esercitano grande
14
autorità nel sinedrio (Gv 11,47; At 5,34ss; 23,6ss) e sono definiti comel’hairesis più precisa della religione giudaica (At 26,5). Analogamente laletteratura rabbinica riporta storie in cui «i farisei» o «gli anziani» o «isaggi» – termini tradizionalmente considerati come sinonimi – umilia-no sommi sacerdoti sadducei (t.Para 3,6ss) o li istruiscono nel loro uffi-cio sacerdotale (Joma 1,3-7), e in cui questi ultimi o le donne sadduceedichiarano di temere i farisei (t.Joma 1,8; b.Joma 19b; b.Nidd 33b).
Sulla base di dati come questi, nella tradizione storiografica moder-na i farisei sono stati costantemente presentati come il cuore religiosodella nazione ebraica e in qualche misura come la forma normativa delgiudaismo già nel periodo precedente il 70 d.C.1. Il fallimento della ri-volta giudaica, con la scomparsa del Tempio e degli altri gruppi religio-si, non avrebbe fatto altro che consolidare definitivamente la loro posi-zione di dominio: il movimento rabbinico, continuazione del farisei-smo, si poneva ora saldamente alla guida del giudaismo definendonel’agenda religiosa sulla base dell’osservanza della duplice Torah – orale escritta – di cui i farisei erano stati strenui difensori.
In questa cornice le controversie di Gesù con i farisei e le affermazio-ni critiche di Paolo sul suo passato farisaico e sulle opere della Leggevenivano per lo più lette nei termini di una contrapposizione tra duereligioni – cristianesimo e giudaismo – considerate distinte sostanzial-mente fin dall’inizio, l’una, il cristianesimo, basata sulla fede e sulla gra-zia, l’altra, il giudaismo, caratterizzata dall’osservanza minuziosa e for-male della legge rituale e delle tradizioni religiose; la prima aperta almondo e alla storia, la seconda chiusa nel proprio particolarismo.
Questo quadro interpretativo, che si era in gran parte sviluppato nel-la Germania protestante del XIX secolo e che risentiva da un lato degliinnegabili pregiudizi nei confronti dell’ebraismo e dall’altro della con-troversia teologica con il cattolicesimo, l’uno e l’altro polemicamenteassimilati al fariseismo, era destinato però ad essere messo radicalmen-te in discussione. A ciò concorsero una serie complessa di fattori, comela scoperta e la pubblicazione dei manoscritti del Mar Morto e dei codi-ci di Nag Hammadi, la rivalutazione di fonti prima di allora non ade-guatamente considerate (ad esempio la letteratura apocrifa e pseudepi-
1 Cf J. WELLHAUSEN, Die Pharisäer und die Sadducäer. Eine Untersuchung zur innerenjüdischen Geschichte, Neudruck, Greifswald 1874, 17; E. SCHÜRER, Geschichte des jüdi-schen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, II, Hinrichs, Leipzig 19074, 456; G. ALON, Jews, Ju-daism and the Classical World, Magness Press, Jerusalem 1977, 22; e anche il nuovo SCHÜRER,Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù, edizione riveduta e aggiornata da G. Vermes,F. Millar e M. Black, II, Paidea, Brescia 1987 (Edinburgh 1979), 479.
15
grafica dell’AT e del NT), la laicizzazione degli studi, l’affermazione nel-la seconda metà del XX secolo della ricerca statunitense, lo sviluppo diuna storiografia ebraica fortemente consapevole maturata nel contestodel neonato Stato di Israele e delle grandi comunità ebraiche america-ne, il dialogo interconfessionale in seno al cristianesimo e all’ebraismoe quello interreligioso tra ebraismo e cristianesimo, fiorito a partire dalsecondo dopoguerra2.
Si è passati così, per quanto riguarda il periodo del Secondo Tempio,dalla rappresentazione del giudaismo e del cristianesimo come religio-ni sostanzialmente monolitiche e contrapposte, l’una dominata dall’ele-mento farisaico e l’altra caratterizzata, nella sua essenza più autentica,dall’orientamento paolino inteso in senso fortemente antinomistico, allaraffigurazione del giudaismo e del cristianesimo come realtà marcata-mente pluralistiche, al punto che si parla sempre più spesso di cristiane-simi e giudaismi3, al plurale, dove in seno al variegato mondo giudaico ilruolo dei farisei tende ad essere sensibilmente ridimensionato, mentreall’interno della realtà cristiana il fenomeno “giudeocristiano”, l’ebrai-cità di Gesù e dello stesso Paolo vengono ampiamente rivalutati. Anzi, ilcristianesimo, in tutta la molteplicità delle sue espressioni, appare sem-pre più come una corrente giudaica tra le altre la cui costituzione comereligione autonoma dal giudaismo sarebbe da collocarsi dopo il 70 o il1354 quando non più tardi5. Così anche la denominazione di “cristiane-simo”, seppure al plurale (“cristianesimi”), è avvertita come inadeguataper il lungo periodo precedente la separazione tra le due religioni e sipreferisce definire il fenomeno come “giudaismo cristiano”6, fino alla
2 Su questi temi si veda D. GARRIBBA, «La presentazione del giudaismo nella storiogra-fia del XX secolo», in Rassegna di Teologia 45 (2004) 73-88.
3 Cf J. NEUSNER - W.S. GREEN - E.S. FRERICHS (edd.), Judaisms and Their Messiahs at theTurn of the Christian Era, Cambridge University Press, Cambridge 1987; G. BOCCACCINI, «Mid-dle Judaism and Its Contemporary Interpreters (1986-1992). Methodological Foundationsfor the Study of Judaisms, 300 BCE to 200 CE», in Henoch 15 (1993) 207-233.
4 Cf J.D.G. DUNN, The Partings of the Ways between Christianity and Judaism and TheirSignificance for the Character of Christianity, SCM Press - Trinity Press International, Lon-don - Philadelphia 1991, 238-240; S.C. MIMOUNI, Le Judéo-christianisme ancien. Essaishistoriques, Cerf, Paris 1998, 40.
5 Cf M. PESCE, «Sul concetto di giudeo-cristianesimo», in A. PITTA (ed.), Il giudeo-cri-stianesimo nel I e II sec. d.C. Atti del IX Convegno di Studi Neotestamentari, RicercheStorico Bibliche 2 (2003) 21-44.
6 Cf B.J. MALINA, «Jewish Christianity or Gentile Christian Judaism: towards an Hypothe-tical Definition», in Journal for the Study of Judaism 7 (1976) 46-57; M. Del VERME, «Dida-chè e origini cristiane. Una bibliografia per lo studio della Didachè nel contesto del giu-daismo cristiano», in Vetera Christianorum 38 (2001) 19.
16
proposta di abolire anche l’uso dell’aggettivo «cristiano» e di parlare digruppi di seguaci di Gesù7 o simili. In questo quadro è chiaro che l’osti-lità tra Gesù e i farisei – quando pure è considerata storica e non, comeoggi si tende, quale semplice retroproiezione dei successivi conflitti tracristiani e giudaismo rabbinico – e il ripudio di Paolo del suo passatofarisaico non sono più interpretati come scontro tra religioni differenti,ma come una dialettica fra tendenze diverse e parimenti rappresentati-ve del multiforme universo giudaico del periodo del Secondo Tempio.
In altre parole la riduzione del cristianesimo a mera corrente delgiudaismo e dunque l’interpretazione del rapporto tra i seguaci di Gesùe l’ambiente giudaico nei termini non già di un confronto tra “cristiane-simo” e “giudaismo” ma di una dialettica tra “giudaismi” è effetto diuna rilettura in chiave pluralistica del panorama religioso giudaico diepoca greco-romana, rilettura che a sua volta non può prescindere daun ridimensionamento del ruolo dei farisei.
1. Tendenze attuali della ricerca
Il primo studioso a mettere in questione l’opinio communis circa ilruolo dominante dei farisei nella Palestina del I secolo è stato M. Smithin uno studio del 19568. Il suo punto di partenza è stata l’opera di FlavioGiuseppe e più in particolare il confronto tra il Bellum Iudaicum e leAntiquitates Iudaicae. Egli infatti ha notato che è solo nelle Antiquitates,scritte negli anni novanta del I secolo d.C., che l’autore parla esplicita-mente dell’influenza dei farisei sulle masse, e che è solo nella successivaVita che Flavio Giuseppe dichiara di aver aderito al fariseismo. Nella suaprima opera, il Bellum Iudaicum, di poco successiva alla prima rivoltacontro Roma e dunque cronologicamente più vicina alla realtà storicaantecedente al 70 d.C., non c’è nulla di tutto questo. Inoltre, secondoSmith, le affermazioni delle Antiquitates circa l’influenza dei farisei sul-le masse sono contraddette dalla stessa storia che Flavio Giuseppe rac-conta. Nelle Antiquitates vi sarebbe dunque un’esagerazione intenziona-le del peso dei farisei nella Palestina del I secolo, che si spiegherebbetenendo conto del fatto che negli anni novanta il movimento rabbinico,erede di quello farisaico, stava affermando la propria leadership nel giu-
7 Cf M. PESCE, «Sul concetto di giudeo-cristianesimo», cit., 36-37; ID, «Il Vangelo di Gio-vanni e le fasi giudaiche del giovannismo. Alcuni aspetti», in G. FILORAMO - C. GIANOTTO (edd.),Verus Israel. Nuove prospettive sul giudeocristianesimo, Paideia, Brescia 2001, 48-49.
8 M. SMITH, «Palestinian Judaism in the First Century», in M. DAVIS (ed.), Israel, ItsRole in Civilization, The Jewish Theological Seminary of America, New York 1956, 67-81.
17
daismo palestinese e stava negoziando con i romani per ottenere il rico-noscimento ufficiale della propria posizione. Nelle Antiquitates FlavioGiuseppe promuoverebbe allora la causa dei farisei-rabbi indicando que-sti ultimi alle autorità di Roma come la forza su cui esse avrebbero potu-to fare affidamento per il controllo della Palestina. In altre parole i passirelativi alla popolarità dei farisei sarebbero parte di una strategia propa-gandistica e rifletterebbero la realtà dell’affermazione rabbinica neglianni 90. Prima del 70, secondo Smith, i farisei in nessun modo rappre-sentavano ciò che si suole definire come “giudaismo normativo” e laloro setta, composta approssimativamente di sole 6000 persone (Ant.17,42), «non aveva realmente presa né sul governo né sulle masse»9.
Una spiegazione per certi versi analoga è stata data del ruolo di pri-mo piano che ai farisei è assegnato nei vangeli. Ad avanzarla per primoè stato probabilmente P. Winter nel suo celebre On the Trial of Jesus10.Portando all’estremo alcuni risultati della Formgeschichtliche Schule, ein particolare degli studi di R. Bultmann, che aveva evidenziato la ten-denza della tradizione sinottica ad inserire via via i farisei nelle contro-versie di Gesù, Winter ha sostenuto che il ruolo dei farisei descritto neivangeli è essenzialmente il prodotto della successiva polemica cristianacontro il giudaismo farisaico-rabbinico. Il tenore dei rapporti tra Gesù ei farisei sarebbe stato in realtà ben diverso. A riprova di ciò vi sarebbesia il fatto che i farisei sono completamente assenti dalla “storia dellapassione”, che costituisce lo strato più antico dei vangeli, sia una certaprossimità dei farisei ai cristiani quale emerge da passi come At 15,5 oAntiquitates Iudaicae 20, 201-203. A dire il vero Winter da tutto ciò nontrasse la conclusione che i farisei al tempo di Gesù avessero scarsa in-fluenza. A lui interessava solo scagionare i farisei – generalmente consi-derati come i predecessori del movimento rabbinico e dunque, in qual-che misura, dello stesso ebraismo contemporaneo – da ogni coinvolgi-mento nella morte di Gesù, e si spinse in questo proposito fino al puntodi fare dello stesso Gesù un fariseo. Altri, tuttavia, non hanno esitato atrarre dagli argomenti utilizzati da Winter proprio quella conclusione.Così ad esempio M. Smith nella sua analisi dei farisei nei vangeli, pro-posta in appendice al suo Gesù mago11, ribadisce quanto già sostenutonello studio del ’56 affermando che «prima del 70 i farisei erano solo unpartito tra i molti e non controllavano né il sinedrio, né le masse, né la
9 Ib., 81.10 P. WINTER, On the Trial of Jesus, de Gruyter, Berlin - New York 1974 (Berlin 1961),
158-189.11 M. SMITH, Gesù mago, Gremese, Roma 1990 (New York - London 1978).
18
maggioranza delle sinagoghe»12; inoltre egli sottolinea la loro pressochécompleta assenza dalla Galilea e dunque la loro mancanza di influenzain questa regione, dove invece, secondo la tradizione sinottica, si sareb-bero concentrate le loro controversie con Gesù. La rilevanza dei fariseinei vangeli, come anche nel caso delle Antiquitates, rifletterebbe insom-ma la successiva realtà dell’affermazione rabbinica, anche se, diversa-mente da Flavio Giuseppe, gli evangelisti nel rappresentare i farisei avreb-bero perseguito un intento polemico.
Similmente, negli anni successivi l’applicazione del metodo storico-redazionale agli Atti degli Apostoli condusse diversi studiosi ad interpre-tare i farisei di quest’opera – ai quali pure Luca riconosce un posto digrande rilievo nella società palestinese – alla luce della situazione delgiudaismo posteriore al 70 o comunque in chiave puramente teologi-ca13, negando di fatto ogni consistenza storica alla rappresentazione lu-cana. E in generale si deve registrare una crescente diffidenza verso idati del NT, tanto che ad esempio P. Schäfer in un recente contributo suifarisei14 tralascia completamente di considerare il NT adducendo comemotivo, accanto all’assenza onestamente confessata di una personalecompetenza specifica, la scarsa attendibilità delle notizie neotestamen-tarie sull’argomento.
Probabilmente la posizione più radicale all’interno del filone interpre-tativo oggi prevalente è quella espressa da J. Neusner, che ha esaminatoin particolare le fonti rabbiniche. Nella sua opera in tre volumi, The Rab-binic Traditions about the Pharisees15, egli individua all’interno della lette-ratura rabbinica un corpus di tradizioni riferibili a suo giudizio ai fariseiin quanto relative ai maestri del periodo anteriore al 70 che o sono com-presi nelle catene di trasmissione della tradizione o sono associabili aquesti ultimi, maestri che possono essere identificati come farisei in quantoalmeno due personaggi presenti nelle catene, Gamaliele I e suo figlio Si-mone, in altre fonti figurano appunto come tali. Neusner calcola poi cheben il 67% delle tradizioni farisaiche da lui individuate riguarda la puritàdel cibo ordinario e la quasi totalità concerne comunque affari interni al
12 Ib., 25.13 Così ad esempio J.A. ZIESLER, «Luke and Pharisees», in New Testament Studies 25
(1978-79), 146-157; R.L. BRAWLEY, Luke-Acts and the Jews: Conflict, Apology and Concilia-tion, Scholars Press, Atlanta 1987, 94-106; J.T. SANDERS, The Jews in Luk-Acts, SCM Press,London 1987, 84-131.
14 P. SCHÄFER, «Der vorrabinische Pharisäismus», in M. HENGEL - U. HECKEL (edd.), Paulusund das antike Judentum, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1991, 125-175.
15 J. NEUSNER, The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70, 3 voll., Brill, Lei-den 1971.
19
partito, mentre temi di più ampio respiro attinenti ad esempio alla vitadel paese, alla politica, al culto del Tempio e simili sono assenti oppureoccupano un posto del tutto marginale. Inoltre la maggioranza delle tra-dizioni sui farisei e in particolare quelle di carattere settario riguardanopersonaggi del periodo erodiano e di quello romano. Preso nel suo insie-me questo materiale rappresenta i farisei come una sorta di conventicolapreoccupata essenzialmente della santificazione della vita quotidiana at-traverso l’osservanza scrupolosa delle norme rituali di purità e priva dipiù ampi interessi16. Ma come si concilia quest’immagine dei farisei conquella che ne offrono le altre fonti? In The Rabbinic Traditions about thePharisees Neusner già offre la soluzione a questo interrogativo, ma essaviene argomentata in maniera più ampia in una monografia di poco suc-cessiva, From Politics to Piety17, dove egli traccia un profilo storico deifarisei sulla base, oltre che della tradizione rabbinica, di Flavio Giuseppee del NT. Secondo Neusner l’immagine dei farisei presente nella tradizio-ne rabbinica corrisponde a quella del NT criticamente letto e solo in ap-parenza contrasta con quella di Flavio Giuseppe, che egli interpreta nellalinea di Smith. È vero infatti che lo storico giudeo descrive i farisei comeun gruppo politicamente influente, mentre i passi più attendibili del NT,non diversamente dal materiale rabbinico, presentano i farisei come unasetta di purità; ma la contraddizione svanisce se si considerano due cir-costanze: che le due diverse immagini dei farisei – quella di Flavio Giu-seppe e quella neotestamentaria e rabbinica – si riferiscono a due diversiperiodi storici, rispettivamente all’età asmonea e a quella erodiano-ro-mana; e che dalla stessa opera di Flavio Giuseppe si desumerebbe che ifarisei, entrati in una fase di declino all’indomani della morte di SalomèAlessandra, a partire dal tempo di Erode e fino al 70 d.C. non svolsero piùalcun ruolo significativo nella storia nazionale. Neusner immagina allorache durante quest’ultimo periodo essi, sotto la guida di Hillel, si fosseroritirati dalla vita politica trasformandosi in un gruppo pietistico, per poitornare da protagonisti sulla scena pubblica dopo il 70.
Circa quest’ultimo punto una posizione un po’ diversa è assunta dallostudioso inglese E.P. Sanders18, le cui tesi hanno avuto grande eco qui inItalia grazie anche alla traduzione delle sue opere principali. Egli nega
16 Ib., 304.17 ID., From Politics to Piety. The Emergence of Pharisaic Judaism, Prentice-Hall, En-
glewood Cliffs 1973.18 Per la sua posizione si veda soprattutto Il giudaismo: fede e prassi (63 a.C. - 66 d.C.),
Paideia, Brescia 1999; cf anche ID., Jewish Law from Jesus to the Mishnah: Five Studies,SCM Press-Trinity Press, London - Philadelphia 1990, e ID., Gesù e il giudaismo, Marietti,Genova 1992.
20
che i farisei si fossero mai ritirati intenzionalmente dalla scena politicadivenendo una setta di purità. Tuttavia anche per lui essi furono vera-mente influenti solo fino al 63 a.C., mentre nel periodo che va dal 6 al 66d.C. rimasero «completamente al di fuori delle cerchie dei capi giudei»19,perdendo qualsiasi capacità di incidere direttamente o indirettamentesulla vita pubblica sia sul piano politico che su quello religioso. A suogiudizio «posto che qualcuno lo facesse, era la categoria dei sacerdoti a“controllare” il giudaismo, e [...] il “giudaismo normativo” consisteva intutto ciò che i sacerdoti e le masse trovavano religiosamente adeguato»20.
Ancora più indicativa della “rivoluzione” storiografica degli ultimidecenni è la posizione di uno studioso come H. Stegemann, il qualeribaltando l’ottica tradizionale indica negli esseni piuttosto che nei fari-sei la più significativa componente religiosa del giudaismo del SecondoTempio21. I primi costituiscono infatti per lui «la più grande alleanza nelperiodo del Secondo Tempio»; una tesi che è condivisa anche da G. Boc-caccini, il quale per altro identifica essenismo ed enochismo22.
Accanto a questo filone interpretativo, oggi maggioritario, tendentea ridurre ai minimi termini il ruolo dei farisei nel giudaismo del periododel Secondo Tempio, va segnalata comunque la presenza di un’altra cor-rente di studi – rappresentata da autori come M. Hengel, R. Deines23, S.Mason24 e G. Jossa25 – che, pur respingendo l’idea tradizionale di unaequivalenza tra fariseismo e giudaismo normativo e pur riconoscendo ilcarattere pluralistico della realtà religiosa giudaica palestinese del tem-po, tuttavia continua a considerare i farisei come l’elemento maggior-mente rappresentativo del giudaismo di epoca neotestamentaria. Nelle
19 E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit., 518.20 ID., Gesù e il giudaismo, cit., 256.21 H. STEGEMANN, «The Qumran Essenes: Local Members of the Main Jewish Union in
the Second Temple Time», in J. TREBOLLE BARRERA - J. MONTANER (edd.), The Madrid Qu-mran Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Brill,Leiden 1992, 83-166.
22 G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico,Morcelliana, Brescia 2003.
23 Cf R. DEINES, «The Pharisees Between ‘Judaism’ and ‘Common Judaism’», in D.A.CARSON - P.O’ BRIEN - M.A. SEIFRID (edd.), Justification and Variegated Nomism, J.C.B. Mohr(Paul Siebeck), Tübingen 2001, 443-504; M. HENGEL - R. DEINES, «E.P. Sanders “CommonJudaism”, Jesus and the Pharisees», in Journal of Theological Studies 46 (1995) 1-70.
24 Cf S. MASON, Flavius Josephus on the Pharisees. A Composition-Critical Study, Brill,Leiden 1991; ID., «Revisiting Josephus Pharisees», in J. NEUSNER - A.J. AVERY-PECK (edd.),Judaism in Late Antiquity, II, Part Three: Where We Stand: Issues and Debates in AncientJudaism, Section Two, Brill, Boston - Leiden 2001.
25 Cf «I Farisei di Marco e Luca», in R. PENNA (ed.), Fariseismo e origini cristiane. Attidel VII Convegno di Studi Neotestamentari, Ricerche Storico Bibliche 2 (1999) 129-148.
21
pagine che seguiranno cercherò di dimostrare come questo secondoorientamento più del primo offra una ricostruzione credibile dell’am-biente giudaico del cristianesimo nascente.
2. Due presupposti problematici delle ricostruzioni“minimaliste” sui farisei
L’orientamento interpretativo inaugurato da M. Smith, come si rica-va facilmente da quanto sopra esposto, riposa in gran parte su una rico-struzione tradizionale della primitiva storia rabbinica. In particolareesso presuppone un rapporto di continuità lineare tra fariseismo e rab-binismo e, insieme, una rapida affermazione del movimento rabbinicoalla guida del giudaismo già nelle prime due decadi successive al 70d.C., quando cioè gli evangelisti e Flavio Giuseppe attendevano alle loroopere: ciò avrebbe fatto sì che in queste ultime i farisei, contrariamentealla verità storica, venissero rappresentati come un gruppo dotato diquelle caratteristiche di popolarità e influenza che in realtà sarebberostate proprie soltanto dei loro successori rabbinici.
Negli ultimi decenni, tuttavia, l’intero quadro delle origini del rabbi-nismo è andato soggetto a un profondo processo di revisione critica, edentrambe le convinzioni storiografiche sopra indicate si sono rivelatealtamente problematiche.
Circa il rapporto tra fariseismo e rabbinismo, gli studi recenti hannoinfatti messo in luce tutta una serie di dati che inducono a considerareil gruppo rabbinico non quale continuazione diretta di quello farisaico,uscito vincente dalla catastrofe del 70 d.C., sì invece come un «consape-vole movimento collettivo che, nell’interesse dell’unità nazionale, con-cedeva spazio alle correnti più diverse»26. Vale la pena di accennare al-meno ai principali fra questi dati27: i rabbi non si identificano mai chia-ramente con i farisei, almeno fino all’epoca amoraica; anzi, nella lette-ratura tannaitica il termine «farisei» (perushim) non sempre indica ilgruppo che conosciamo anche da Flavio Giuseppe e dal NT, e spessopresenta una connotazione negativa con riferimento a gruppi settari;nella Mišnah si parla molto più spesso di sadducei che di farisei e diquesti ultimi si fa menzione in una sola unità testuale (Jad. 4,6-8); laricerca recente ha messo in luce l’esistenza di una forte componente
26 G. STEMBERGER, Farisei, sadducei, esseni, Paideia, Brescia 1993, 178. Cf anche S.J.D.COHEN, «The Significance of Yavneh: Pharisees, Rabbis, and the End of Jewish Sectariani-sm», in Hebrew Union College Annual 55 (1984) 27-53.
27 Per quanto segue si vedano in particolare le opere citate alla nota precedente.
22
sacerdotale nel primitivo rabbinismo la quale non sembra facilmentespiegabile in base all’ipotesi di una matrice soltanto farisaica del grup-po di Javne, pur riconoscendo che i farisei non furono quel movimentoa carattere pressoché esclusivamente laicale dipinto dalla storiografiamoderna; che poi nella catena tradizionale di Abot vi fossero personali-tà sicuramente farisaiche, come Gamaliele e suo figlio Simone, non si-gnifica che tutte le altre personalità nominate nella catena fossero an-ch’esse di appartenenza farisaica (basti dire che nella catena sono pre-senti anche figure come Mosè, Giosuè e i profeti); allo stesso modo ilfatto che alcune storie che in fonti non rabbiniche sono relative ai fari-sei si ritrovino nella letteratura rabbinica in riferimento ai saggi, si spie-ga in modo sufficiente con la tendenza dei rabbi a «rabbinizzare» lastoria; è significativo inoltre che Johanan ben Zakkaj, considerato il fon-datore del movimento rabbinico, non presenti alcun tratto che induca aidentificarlo come fariseo, al punto che qualche studioso, sulla base diJad. 4,6, dove Johanan sembra prendere le parti dei sadducei contro ifarisei, ha anche proposto che egli fosse un sadduceo28.
Si devono registrare comunque alcuni recenti tentativi di recuperareuna più diretta continuità tra fariseismo e rabbinismo sulla base deidocumenti qumranici29. Poiché gli avversari dei qumraniti designati congli epiteti doreshei halaqot ed Efraim sembrano identificabili come fari-sei, e poiché in alcuni manoscritti gli autori sostengono delle posizionilegali che risultano contrarie a quelle affermate nella letteratura rabbi-nica, e in una disputa mishnica tra farisei e sadducei (Jad. 4,7) la posi-zione halakica sadducea sembra coincidere con quella sostenuta dagliautori di 4QMMT (58-61), se ne deduce che l’halakah rabbinica almenoin parte già esistesse nel periodo del Secondo Tempio e che a sostenerlafossero i farisei, i quali si rivelerebbero così come i predecessori direttidei rabbi. Questi tentativi sono però problematici30. Gli epiteti doresheihalaqot ed Efraim non sempre sono interpretabili con certezza in riferi-
28 Così B.D. EERDMANS (cit. in J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù, EDR, Roma1989, 393).
29 Uno dei principali esponenti di questo orientamento critico è L.H. Schiffman. Tra isuoi molteplici studi sull’argomento si vedano ad esempio «Pharisaic and Sadducean Ha-lakhah in Light of the Dead Sea Scrolls», in Dead Sea Discoveries 1,3 (1994) 285-299; «ThePharisees and Their Legal Traditions According to the Dead Sea Scrolls. The Case of TevulYom», in Dead Sea Discoveries 8,3 (2001) 262-277; «The Qumran Scrolls and RabbinicJudaism», in P.W. FLINT - J.C. VANDERKAM (edd.), The Dead Sea Scrolls after Fifty Years: AComprehensive Assessment, II, Brill, Leiden 1999, 552-571.
30 Per una puntuale e ben argomentata riflessione critica sui tentativi descritti si vedaG. STEMBERGER, «Qumran, die Pharisäer und das Rabbinat», in B. KOLLMANN - W. REINBOLD
23
mento ai farisei e comunque non ricorrono mai nel contesto di discus-sioni halakiche. Inoltre a ben vedere la continuità tra fariseismo e rab-binismo più che essere provata dagli argomenti sopra riportati ne è ilpresupposto. Non si può escludere infatti che le halakot difese dai qum-raniti e che risultano di fatto contrapposte a quelle rabbiniche fosseroaffermate in polemica con gruppi diversi dai farisei o ancora con quelloche E.P. Sanders chiama Common Judaism, e che le posizioni legali diquesti avversari dei qumraniti siano state poi ereditate, accanto a quelledi altri gruppi, tra i quali probabilmente i farisei, dal composito movi-mento rabbinico. La natura di coalizione del nascente movimento rab-binico naturalmente non è messa in crisi dalla possibilità che in alcunicasi, come quello menzionato di 4QMMT 58-61, si possa effettivamenteavere una presa di distanze da posizioni farisaiche o proto farisaiche. Etuttavia anche il caso di 4QMMT 58-61 non è esente da discussione, dalmomento che è stata contestata l’opinione secondo cui detto passo qu-mranico e Jad. 4,7 tratterebbero il medesimo tema halakico31.
Per quanto riguarda poi l’affermazione del movimento rabbinico allaguida del giudaismo del post-70, l’idea tradizionale che essa si fosse ve-rificata rapidamente nell’arco di un paio di decenni, ha cominciato adessere contestata già a partire dagli studi di E.R. Goodenough, il qualeosservando la difformità dell’arte sinagogale ebraica rispetto alle normecodificate nella letteratura rabbinica ne dedusse che l’autorità dei rabbifosse molto più circoscritta di quanto prima non si pensasse e che dun-que essi non costituissero il “giudaismo normativo”. Successivamenteproprio J. Neusner studiando la Mišnah nelle sue stratificazioni è giun-to alla conclusione che il movimento rabbinico nel periodo tra le dueguerre giudaiche fosse poco più che una setta cultuale e che la maggio-ranza del popolo stesse dalla parte dei gruppi apocalittici che avrebberocondotto alla catastrofe del 13532. La stessa esistenza di un Sinodo diJavne che avrebbe riorganizzato il giudaismo in modo unitario consoli-dando la leadership rabbinica sul popolo è stata messa seriamente inquestione da studiosi come P. Schäfer e G. Stemberger i quali hannoanche espresso scetticismo sulla possibilità di determinare nel tempo il
- A. STEUDEL (edd.), Antikes Judentum und Frühes Christentum, Festschrift für HartmutStegemann zum 65. Geburtstag, de Gruyter, Berlin - New York 1999, 210-224.
31 Su questo si veda in particolare Y. ELMAN, «4QMMT and the Rabbinic Tradition: or,When Is a Parallel not a Parallel», in J. KAMPEN - M.J. BERNSTEIN (edd.), Reading 4QMMT,Scholars Press, Atlanta 1996, 99-128.
32 J. NEUSNER, Il giudaismo nella testimonianza della Mishnah, EDB, Bologna 1995,90ss, 159-225.
24
riconoscimento romano dei rabbi33. Procedendo su questa strada recen-temente C. Hezser è giunta persino a negare l’esistenza, per tutto il peri-odo tannaitico e amoraico, di istituzioni come l’Accademia rabbinica, ilPatriarcato e il Sinedrio, sostenendo che lungo quest’arco di tempo irabbi non costituissero un movimento unificato, ma fossero una plura-lità di maestri con occasionali contatti reciproci, le cui opinioni, ampia-mente diversificate, non avevano alcun carattere normativo34.
Al di là di certe esagerazioni quello che sembra certo è che il proces-so di affermazione del movimento rabbinico fu piuttosto lento e fatico-so. Molti ritengono che in Palestina ciò sarebbe avvenuto non primadella fine del secondo secolo, e sicuramente non prima del 135, e moltopiù tardi nella diaspora35, dove pure il NT e le opere di Flavio Giuseppefurono scritti.
Alla luce di ciò risaltano due aspetti paradossali della critica “mini-malista” sui farisei. Il primo è che un’interpretazione così innovativadella storia farisaica dipende di fatto da una concezione delle origini delrabbinismo che appare ormai datata. Il secondo, molto più sorprenden-te, è che alcuni tra i principali esponenti di quel filone interpretativo (adesempio J. Neusner e S.J.D. Cohen) hanno anche promosso, in altre loroopere, il processo di revisione storiografica sulle origini del rabbinismosopra illustrato, che inevitabilmente mette in discussione la loro stessainterpretazione delle fonti sui farisei.
3. Le fonti sui farisei
L’ipotesi di Smith, tuttavia, risulta problematica non soltanto a moti-vo dei suoi presupposti. Discutibile appare un po’ tutta l’interpretazionedelle fonti che ne è alla base. Ma quali sono le fonti sui farisei sulle qualisi può fare affidamento per il periodo che qui più direttamente ci inte-ressa? Purtroppo non molte. Si tratta essenzialmente di pochi passi del-l’epistolario paolino, dei vangeli canonici (soprattutto Marco e il mate-riale della duplice tradizione), degli Atti degli Apostoli e delle opere di
33 P. SCHÄFER, «Die sogenannte Synode von Jabne. Zur Trennung von Juden und Chri-sten im ersten/zweiten Jh. N. Chr.», in Judaica 31 (1975) 54-64; G. STEMBERGER, «Die soge-nannte ‘Synode von Jabne’ und das frühe Christentum», in Kairos 19 (1977) 14-21.
34 C. HEZSER, «Social Fragmentation, Plurality of Opinion, and Nonobservance of Ha-lakhah: Rabbis and Community in Late Roman Palestine», in Jewish Studies Quarterly(1993) 234-251.
35 Di questo avviso sono anche A.J. SALDARINI, Farisei, scribi e sadducei nella societàpalestinese, Paideia, Brescia 2003, 200-202, J.D.G. DUNN, Jesus, Paul and the Law. Studies inMark and Galatians, SPCK, London 1990, 70.
25
Flavio Giuseppe. Altre fonti, che pure vengono non di rado prese in con-siderazione, appaiono poco utili.
La letteratura giudaica pseudepigrafica, ad esempio, non contienealcun riferimento esplicito ai farisei, e la paternità farisaica di alcuni diquesti scritti, che in passato veniva data per certa – si pensi in particola-re ai Salmi di Salomone –, oggi è sempre più spesso revocata in dubbio36.Di scarsa utilità è anche la letteratura qumranica: benché vi siano alme-no due testi, 4QMMT e 4QpNah, in cui pressoché unanimemente glistudiosi vedono riferimenti ai farisei e che sembrano tra l’altro testimo-niare a favore di un’ampia influenza del gruppo, tuttavia la loro datazio-ne, rispettivamente alla seconda metà del II secolo a.C. e intorno allametà del I secolo a.C., li colloca al di fuori dell’arco cronologico che anoi interessa. Troppo tarde e comunque di valore storico oltremodo dub-bio sono poi le fonti cristiane apocrife e patristiche e ancora la lettera-tura rabbinica.
Su quest’ultima è opportuno soffermarsi brevemente, dal momentoche molti studiosi, soprattutto ebrei, l’hanno considerata e la considera-no tutt’ora quale fonte nel complesso affidabile per la ricostruzione stori-ca del fariseismo, preferendola paradossalmente al NT, ritenuto troppotendenzioso. E la ragione di tale predilezione risiede fondamentalmentenell’idea, che si è visto essere fallace, di una continuità lineare tra farisei-smo e rabbinismo, in base alla quale si guarda agli scritti rabbinici comescritti essenzialmente farisaici. In realtà l’uso di queste fonti si rivela estre-mamente problematico per svariati motivi. Uno l’ho già anticipato: ladatazione tarda di questa letteratura, il cui primo prodotto, la Mišnah,comincia ad essere redatta agli inizi del III secolo d.C. Secondo motivo, ilcarattere prevalentemente orale del materiale raccolto dai redattori rab-binici, che implica un processo secolare di trasmissione orale e dunque laprobabilità consistente di una sensibile trasformazione nel tempo del datooriginario, come in molti casi risulta dal confronto sinottico delle tradi-zioni37. Terzo motivo, il genere letterario e la natura della letteratura rab-binica: quest’ultima consta per lo più di materiale legale e non manifestaalcun intento né prospettiva di natura storica; i rabbi non sono interessa-ti al passato né ai grandi accadimenti storici contemporanei, bensì all’or-dinato svolgimento della vita quotidiana secondo la volontà divina, e mi-
36 Cf J.H. CHARLESWORTH, Gli pseudepigrafi dell’Antico Testamento e il Nuovo Testamento,Paideia, Brescia 1990, 54s; S. MASON, Flavius Josephus on the Pharisees…, cit., 7ss.
37 Cf P.S. ALEXANDER, «Orality in Pharisaic-rabbinic Judaism at the Turn of the Eras»,in H. WANSBROUGH (ed.), Jesus and the Oral Gospel Tradition, Sheffield Academic Press,Sheffield 1991, 181-182.
26
rano fondamentalmente alla costruzione di una società ideale38. Quartomotivo, lo studio critico della letteratura rabbinica, a cominciare dallacritica testuale, è in un certo senso ancora agli inizi, e questo rende diffi-coltoso un approccio realmente scientifico ai testi. Infine vanno segnalatii problemi metodologici inerenti alla selezione e datazione delle tradizio-ni rabbiniche relative ai farisei. I due tentativi più noti di operare una taleselezione sono stati quelli di J. Neusner39 e E. Rivkin40. In entrambi i casila metodologia non sembra sufficientemente solida e le conclusioni che idue autori traggono a partire dal materiale selezionato appaiono ingiu-stificate. Neusner considera come tradizioni farisaiche quelle che riguar-dano: 1) i maestri pre-70 compresi nelle catene di trasmissione della tra-dizione (nelle quali almeno due rabbi sono certamente farisei anche se-condo altre fonti: Gamaliele e suo figlio Simone), 2) i rabbi che compaio-no nelle stesse pericopi in relazione ad essi, 3) le Case di Hillel e Sham-maj, in quanto esse fanno capo ai due noti maestri che sono presenti nellecatene di trasmissione della tradizione41. Per la datazione, Neusner si av-vale delle attestazioni, ovvero del nome dell’autorità che trasmette la tra-dizione – la quale fornisce il terminus ante quem – e anche dell’argomentodell’anteriorità logica di un principio halakico rispetto a un altro42. I limi-ti di questo metodo sono evidenti: a) l’utilizzazione delle catene tradizio-nali come criterio di identificazione dei farisei non tiene conto della ten-denza dei rabbi a «rabbinizzare» il passato (anche Mosè, Giosuè e i profe-ti rientrano nella catena!)43; in realtà neanche per Hillel e Shammaj sihanno prove certe di una loro appartenenza farisaica, tanto meno per leloro Case; lo stesso trattato Abot che contiene la principale catena di tra-dizione è un testo tardo e di dubbia attendibilità44; b) il ricorso alle catenedella tradizione rabbinica come criterio identificativo dei farisei di fattopresuppone quella continuità lineare tra farisei e rabbi che abbiamo vi-sto essere problematica e che lo stesso Neusner significativamente in al-cune sue opere ritiene tale45; c) la fiducia di Neusner nella veridicità delle
38 J. NEUSNER, Il giudaismo nella testimonianza della Mishnah, cit., 109, 115-116.39 ID., The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70, cit.40 E. RIVKIN, «Defining the Pharisees: The Tannaitic Sources», in Hebrew Union College
Annual 40-41 (1969-1970) 205-249.41 J. NEUSNER, The Rabbinic Traditions…, cit., Part 3, 301.42 ID., From Politics to Piety…, cit., 92ss.43 Cf S.J.D. COHEN, «The Significance of Yavneh…», cit., 36-37.44 G. STEMBERGER, «Rabbinic Sources for Historical Study», in J. NEUSNER - A.J. AVERY-
PECK (edd.), Judaism in Late Antiquity, II, Part Three: Where We Stand, cit., 184.45 G. Stemberger (Farisei, sadducei, esseni, cit., 54) segnala come lo stesso Neusner in
uno scritto dell’84 (Das pharisäische und talmudische Judentum, J.C.B. Mohr [Paul Siebeck],
27
attribuzioni non è giustificata46, soprattutto se si considera la presenza disvariati casi accertati di pseudepigrafia (questi sono particolarmente nu-merosi nel caso delle dispute tra le Case, che rappresentano il grosso delmateriale rabbinico sui farisei raccolto da Neusner), ed è sintomatico chelo stesso Neusner in alcuni suoi studi bolli come “fondamentalisti” quan-ti prestano fede alle attribuzioni47; d) come ha giustamente osservato A.J.Saldarini, richiamandosi agli studi di J. Smith, non si può provare consicurezza l’anteriorità storica di una legge rispetto a un’altra in base al-l’argomento della sua priorità logica, in quanto «l’evoluzione storica delleculture e delle religioni è troppo varia per questo»48.
Come ha ben mostrato E.P. Sanders, inoltre, problematica non è solola selezione che Neusner fa del materiale rabbinico sui farisei, ma an-che la sua classificazione e interpretazione49. Così ad esempio il calcolopercentuale in base al quale Neusner afferma che la maggioranza delmateriale rabbinico sui farisei riguarda questioni “settarie” è falsato dalfatto che esso è compiuto sulle singole pericopi piuttosto che sulle tra-dizioni, per cui si computano distintamente i casi paralleli. Inoltre egliconsidera come “settarie” questioni che difficilmente sono classificabilicome tali (ad esempio l’anno sabbatico) e imposta la sua interpretazio-ne sul presupposto discutibile secondo cui ciò che ricorre più di fre-quente nel materiale selezionato era anche più importante nell’agendareligiosa farisaica; mentre la maggiore ricorrenza può semplicementedipendere dal carattere controverso delle questioni e dagli interessi deimaestri rabbinici che hanno trasmesso e raccolto il materiale. Di fattoin base a questo criterio si potrebbe giungere ad affermare che per ifarisei i dieci comandamenti, la circoncisione o l’impurità derivante dallaconsumazione della carne suina fossero temi di nessuna o di scarsa rile-vanza. Infine l’interpretazione neusneriana risulta in se stessa poco per-suasiva in quanto ipotizza che la svolta epocale promossa da Hillel, del-la quale per altro nelle fonti non si parla esplicitamente, abbia determi-nato la cancellazione di vasta parte delle tradizioni del gruppo relative
Tübingen 1984, 106, n. 20) si dichiari «sempre meno sicuro» dell’appartenenza farisaica deimaestri compresi nelle catene sulla base della presenza in esse di Gamaliele e suo figlio.
46 D. KRAEMER, «Rabbinic Sources for Historical Study», in J. NEUSNER - A.J. AVERY-PECK
(edd.), Judaism in Late Antiquity, II, Part Three: Where We Stand…, cit., 208ss.47 Ad esempio in «Rabbinic Sources for Historical Study: A debate with Ze’ev Safrai»
in J. NEUSNER - A.J. AVERY-PECK (edd.), Judaism in Late Antiquity, II, Part Three: Where WeStand…, cit., 136ss.
48 Cit. in A.J. SALDARINI, Farisei, scribi e sadducei…, cit., 195, 202.49 Per le considerazioni che seguono cf E.P. SANDERS, Jewish Law from Jesus to the
Mishnah…, cit., 173ss.
28
alla vita pubblica, nonostante almeno alcuni singoli maestri farisei, comeGamaliele e suo figlio Simone – rispettivamente nonno e padre del NasìGamaliele II nonché antenati dell’autorità responsabile della redazionedella Mišnah –, furono ampiamente coinvolti nella vita politica e avreb-bero ben potuto preservarle.
Veniamo a Rivkin. Da un certo punto di vista il suo metodo è piùcontrollato di quello di Neusner. Egli infatti come passo iniziale scegliedi considerare solo quelle tradizioni in cui i farisei sono esplicitamentenominati come tali; e poiché nella letteratura rabbinica il termine peru-shim può designare oltre ai farisei anche gruppi ascetici ed ereticali,egli seleziona solo quei passi in cui i farisei sono contrapposti ai saddu-cei. Poi però Rivkin in modo alquanto acritico non solo conferisce valo-re storico a queste tradizioni senza offrire argomenti in tal senso, maanche identifica i perushim con i soferim e gli hakhamim, riproponendol’identificazione tra farisei e rabbi. Una correzione del metodo di Rivkinè stata data dal Lightstone50, il quale respinge quei testi in cui il riferi-mento ai farisei appare solo nel parallelo talmudico ed esclude un passoin cui la lezione più probabile non è “sadducei” ma “eretici” (minim); inquesto modo egli riduce il materiale rabbinico utilizzabile a sole cinquepericopi (Jad. 4,6; Jad. 4,7a; Jad. 4,7b; t.Hag. 3,35; t.Jad. 2,19-20). Inoltrea differenza di Rivkin egli evita opportunamente di trarre conclusionistoriche affrettate, e anzi indica il carattere stilizzato e storicamentesospetto di più d’una di tali pericopi. E in effetti anche queste cinquepericopi pongono problemi. Almeno in linea teorica non possiamo esclu-dere che la tendenza osservata in testi più tardi ad inserire i “farisei” inluogo dei “saggi” e i “sadducei” in luogo dei minim fosse già operante;né si può escludere a priori il carattere fittizio degli episodi. A ciò siaggiunga che è molto difficile capire a quale periodo tali tradizioni ri-salgano. Benché dunque alcune delle pericopi selezionate dal Lightsto-ne sembrino contraddire l’immagine neusneriana dei farisei come grupposettario (t.Hag 2,19; 3,35), non si può escludere che tali tradizioni, segenuine e se precedenti al 70 d.C., siano di epoca asmonea e rimandinoquindi a un periodo per il quale nessuno dubita che i farisei fosseroprofondamente coinvolti nella vita sociale.
Infine le fonti archeologiche. Si tratta di un materiale di difficile va-lutazione rispetto al nostro tema. Nessun reperto archeologico è ricon-ducibile con certezza ai farisei, per quanto relativamente ad alcune ti-
50 J. LIGHTSTONE, «Sadducees versus Pharisees: The Tannaitic Sources», in J. NEUSNER
(ed)., Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Part three: Judaism Before 70,Brill, Leiden 1975, 206-217.
29
pologie di manufatti, come gli ossari di pietra, i vasi di pietra e le vaschedi purificazione, non sia irragionevole ipotizzare un qualche collega-mento – comunque non esclusivo – col gruppo51. Un discorso analogopuò essere fatto per la sinagoga, sulla quale tornerò nell’ultimo paragra-fo di questo contributo.
Nel complesso, dunque, le fonti più affidabili per la nostra indaginesono costituite da Flavio Giuseppe e dal NT.
I farisei negli scritti di Flavio Giuseppe
Gli scritti flaviani rivestono un’importanza fondamentale per la no-stra ricerca. Sono le uniche fonti a riferirsi ai farisei nel più ampio con-testo della storia del popolo giudaico, consentendoci di delineare il lororuolo in essa e di abbozzare un profilo della loro storia. Lo storico ebreovanta poi contatti diretti col gruppo anche a livelli di vertice (cf Vita10.21.190.197) e in tutta probabilità egli stesso, almeno per un certoperiodo della sua vita, aderì al fariseismo (Vita 12)52. Inoltre per la storiadi età asmonea ed erodiana si serve, come fonte principale, dell’opera diNicolao di Damasco, il quale operando alla corte di Erode il Grandesicuramente ebbe modo di conoscere da vicino i farisei, per un certotempo anch’essi influenti negli ambienti di corte e poi avversari di Ero-de (cf Ant. 17,41ss).
L’interpretazione dell’opera di Flavio Giuseppe elaborata da M. Smithe divenuta l’asse portante della tesi “minimalista” sull’influenza dei fari-sei si rivela particolarmente discutibile. Innanzitutto essa presenta unterzo presupposto fallace oltre a quelli sopra discussi, l’idea cioè che leAntiquitates Iudaicae fossero dirette al governo romano e/o ai rabbi diJavne. In realtà tutti gli studi sui destinatari dell’opera portano ad esclu-dere questa ipotesi. Lo stesso Flavio Giuseppe del resto indica i “greci”come lettori delle Antiquitates (1,5; 16,174; 20,262) e un tale Epafrodito– verosimilmente il grammatico greco di cui parla il lessico di Suda –come dedicatario (1,8; Vita 430).
51 Cf R. DEINES, Jüdische Steingefässe und pharisäische Frömmigkeit, J.C.B. Mohr (PaulSiebeck), Tübingen 1993. Per quanto riguarda in particolare le vasche di purificazioneanche E.P. Sanders è disposto a riconoscere un legame con i farisei, ma solo relativamen-te alla tipologia di vasca archeologicamente meno attestata (E.P. SANDERS, Jewish Lawfrom Jesus to the Mishnah…, cit., 214-227).
52 Non mi sembrano valide le ragioni addotte per sostenere la mendacità dell’asserzio-ne di Vita 12 (ad esempio H. RASP, «Flavius Josephus und die Jüdischen Religionsparte-ien», in Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 23 [1924] 47) né quelle per inter-pretare il passo come significante l’ingresso dell’autore nella vita pubblica anziché la suaadesione al fariseismo (S. MASON, «Was Josephus a Pharisee? A Re-Examination of Life10-12», in Journal of Jewish Studies 40 [1989] 31-45).
30
Oltre che per i presupposti quell’interpretazione appare poi inade-guata anche per ciò che concerne la lettura stessa dei dati. Come hannoabbondantemente dimostrato gli studi di S. Mason, di D.R. Schwartz edi altri, non si può parlare di vera contraddizione né tra il Bellum Iudai-cum e le Antiquitates Iudaicae, né tra i sommari delle Antiquitates e lastoria che Flavio Giuseppe stesso racconta, né tra le Antiquitates e ilContra Apionem. Nel primo caso, infatti, è facile rilevare come i fariseifigurino come la “scuola” più importante già nell’opera più antica (Bel-lum Iudaicum 1,110ss.571; 2,119.162ss.411). Il fatto poi che più volte leAntiquitates rinviino esplicitamente alla presentazione del gruppo nelBellum (Antiquitates Iudaicae 13,173.298; 18,11) mostra quanto menoche l’autore non ha avvertito alcuna contraddizione a riguardo fra ledue opere. Inoltre, se è vero che nelle Antiquitates il tema dell’influenzadei farisei è maggiormente evidenziato, è anche vero che la presentazio-ne del gruppo non è univocamente positiva e che i tratti negativi nonsono sempre attribuibili alle fonti53, la qual cosa rende insostenibile l’ipo-tesi di un intento propagandistico dell’autore a favore dei farisei. Ladifferente enfasi delle due opere sui farisei si spiega dunque non già conla presunta adesione di Flavio Giuseppe alla causa dell’emergente movi-mento “farisaico-rabbinico” negli anni 90, sì piuttosto con la maggioreestensione dell’opera seriore e con l’ipotesi avanzata convincentementeda D.R. Schwartz, secondo cui nel Bellum, scritto solo pochi anni dopola rivolta contro Roma, vi sarebbe una maggior reticenza circa il coin-volgimento del giudaismo ufficiale, e quindi anche dei farisei, nelle vi-cende in qualche modo connesse a quella rivolta54.
Quanto al rapporto tra i sommari delle Antiquitates e gli episodi stori-ci raccontati da Flavio Giuseppe, una certa tensione va riconosciuta. Essatuttavia non è così significativa se si tiene conto di alcune circostanze: inprimo luogo Flavio Giuseppe scrive per un pubblico di cultura greco-romana, secondo una prospettiva prevalentemente politica e dal punto divista delle classi elevate, prestando così poca attenzione alla religiositàpopolare in ambito domestico e sinagogale, gli ambiti, cioè, in cui dovevafarsi maggiormente sentire l’influenza di un gruppo religioso (prima chepolitico) a vocazione popolare come i farisei; in secondo luogo lo storicogiudeo non intende scrivere una storia del gruppo farisaico né affermache i farisei ebbero il controllo diretto della vita pubblica, sicché non do-vremmo attenderci continui riferimenti ad essi né aspettarci di trovare
53 Cf S. MASON, Flavius Josephus on the Pharisees…, cit., passim.54 D.R. SCHWARTZ, «Josephus and Nicolaus on the Pharisees», in Journal for the Study of
Judaism 14 (1983) 157-171.
31
frequentemente membri del gruppo in posti di potere; in terzo luogo,come riconosce lo stesso Sanders55, la tendenza operante nel Bellum Iu-daicum a tacere del coinvolgimento dei farisei nelle vicende connesse allarivolta contro Roma non è del tutto abbandonata nelle Antiquitates; quar-to, Flavio Giuseppe non appare molto interessato a riferire l’orientamen-to religioso dei suoi personaggi56, il che lascia sospettare in molti casiriferimenti non espliciti ai farisei; quinto, per quanto riguarda il periodocompreso tra il 6 e il 66 d.C., occorre tenere conto che l’autore ebreodedica alla storia palestinese complessivamente uno spazio esiguo; sesto,non sempre le affermazioni sulla popolarità dei farisei si possono facil-mente isolare dal contesto narrativo57; settimo, alcuni dei passaggi conte-nenti quelle affermazioni derivano molto probabilmente da fonti. Accan-to a ciò è opportuno sottolineare che il ruolo e la presenza dei farisei nelcontesto degli episodi storici non sono affatto così irrilevanti, soprattuttose accanto ai riferimenti espliciti si tiene conto di quelli sufficientementetrasparenti. Presi nel loro insieme tali riferimenti coprono tutte le princi-pali fasi della storia giudaica del tardo Secondo Tempio, non escluso ilperiodo del presunto silenzio di Flavio Giuseppe, quello compreso cioètra il 6 e il 66 d.C. Per quanto riguarda quest’ultimo periodo, basti consi-derare che in esso è attiva la cosiddetta “quarta filosofia” – gruppo dotatodi un certo seguito (cf Ant. 18,9) – che appare come una sorta di estremi-smo farisaico (Ant.18,4ss; 18,23; 20,102)58; e che a quel periodo rimanda-no una serie di riferimenti a personaggi descritti al modo tipico dei fari-sei (ad esempio Ant. 19,332; 20,43; 20,201ss) e altri riferimenti espliciti alfariseismo (Vita 10-12). Si impongono poi alcune considerazioni di ordi-ne generale: 1) la presenza dei farisei all’interno del gruppo dirigente giu-daico all’inizio della rivolta (Bell. 2,411; Vita 21.191.197) si spiega moltomeglio se si ammette che essi anche precedentemente esercitarono unacerta influenza; 2) il racconto flaviano sembra implicare che la normati-va pubblica farisaica abrogata da Ircano I a prezzo di una lunga guerracivile e reintrodotta da Salomè Alessandra (Ant. 13,408-409) non sia statapiù messa in discussione; 3) la presentazione delle “scuole” giudaiche inAntiquitates 18,11ss, in cui si sottolinea fortemente l’influenza dei farisei,è inserita nel racconto relativo alla riduzione della Giudea a provincia
55 E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit., 552-553.56 M. HENGEL - R. DEINES, «E.P. Sanders “Common Judaism”, Jesus and the Pharisees»,
in Journal of Theological Studies 46 (1995) 35, n. 89.57 Cf S. MASON, «Revisiting Josephus Pharisees», cit., 42.58 Cf R. MEYER, «Farisa�oj», in Grande Lessico del Nuovo Testamento 14 (1984) 898s;
M. HENGEL, Gli zeloti, Paideia, Brescia 1996, 122.
32
romana, lasciando pensare che riflettesse in particolare la situazione delfariseismo a partire da quel momento storico; 4) al contempo però inquell’excursus Flavio Giuseppe mira a mettere in evidenza caratteristichegenerali e tipiche del gruppo – come mostra anche l’uso dei verbi al pre-sente – e poiché egli ebbe conoscenza diretta dei farisei, è probabile chequella presentazione, a prescindere dal problema della sua dipendenza omeno da fonti, corrisponda all’esperienza che lo stesso Flavio Giuseppefece del gruppo, esperienza che – è bene sottolinearlo – copre una partesignificativa del periodo del suo presunto silenzio sui farisei.
Ben difficilmente dunque questo “silenzio” può essere impiegato perdimostrare che i farisei furono scarsamente influenti nel periodo stori-co cruciale per la formazione del cristianesimo. Un più corretto usodell’argumentum e silentio offre semmai ulteriori elementi contro l’ipo-tesi di una propensione filofarisaica di Flavio Giuseppe nel corso deglianni 90. Tre dati sono particolarmente indicativi. Il primo: nei venti li-bri delle Antiquitates i riferimenti espliciti ai farisei sono tutti compresitra la metà circa del libro tredicesimo (§ 172) e le battute iniziali deldiciottesimo (§§ 4-23) e sono pertanto completamente assenti dalle par-ti dello scritto più significative dal punto di vista retorico, cioè l’inizio ela fine, dove si parla invece favorevolmente di sommi sacerdoti e dellastessa istituzione sommosacerdotale (cf 1,11-12; 20,224-251.261). Il se-condo: nella Vita, dove tra l’altro il problema delle fonti non si pone,l’influenza dei farisei, pur essendo presupposta in diversi passi, tuttavianon è mai affermata esplicitamente. Il terzo: il Contra Apionem, pubbli-cato non molti anni dopo le Antiquitates e la Vita e indirizzato ai mede-simi lettori, addirittura passa completamente sotto silenzio il farisei-smo, mentre pone al centro della sua rappresentazione idealizzata dellasocietà giudaica il Tempio e il sacerdozio (2,165.184-187.193ss).
Per quanto riguarda infine la differenza tra Antiquitates Iudaicae eContra Apionem, sulla quale insiste soprattutto E.P. Sanders, suggerendola maggiore attendibilità del quadro offerto nell’opera più tarda, essa sispiega essenzialmente con la strategia apologetica attuata nel II libro delContra Apionem: qui Flavio Giuseppe intende dimostrare come, in virtùdella “costituzione mosaica” – che egli vuole difendere dai detrattori –, sirealizzi l’armonica unità del popolo giudaico (2, 179-181.193ss); e questointento conduce l’autore da un lato ad esaltare il Tempio e il sacerdoziocome fattori di unità e dall’altro a tacere delle “scuole”, in quanto espres-sioni di divisione religiosa. A ben vedere, comunque, tra le due opere nonc’è vera contraddizione, perché nelle Antiquitates ai farisei si riconosceun’influenza indiretta sulla vita pubblica, mentre nel Contra Apionem siparla del ruolo di leadership che ufficialmente i sacerdoti hanno in base
33
alla “costituzione mosaica”. In ogni caso, come vedremo meglio più ol-tre, rispetto alla concreta realtà storica del I secolo, fra la rappresenta-zione del giudaismo delle Antiquitates e quella del Contra Apionem è cer-tamente quest’ultima a risultare più idealizzata e tendenziosa, essendodel resto pienamente conforme agli interessi filosacerdotali dell’autore.
In conclusione, non si intravedono ragioni per contestare la sostanzadelle affermazioni di Flavio Giuseppe circa il largo seguito popolare delgruppo farisaico, né per ipotizzare una crisi significativa di tale popola-rità nel periodo che va dal regno di Erode il Grande alla rivolta controRoma.
I farisei nel Nuovo Testamento
L’immagine complessiva dei farisei che emerge dagli scritti del NTsuona come una conferma del quadro offerto da Flavio Giuseppe e nelcontempo lo integra, dal momento che i riferimenti neotestamentari alfariseismo rimandano al periodo che si estende grosso modo dall’iniziodegli anni trenta alla fine degli anni cinquanta e coprono dunque granparte dell’arco cronologico interessato dal presunto silenzio dello storicoebreo sul gruppo.
L’epistolario paolino. Le lettere autentiche di Paolo di Tarso sono par-ticolarmente preziose per la ricerca sul fariseismo. Nonostante sianopiuttosto avare di notizie, esse costituiscono infatti le fonti più antichein nostro possesso. Risalgono agli anni cinquanta e sono pertanto sce-vre da qualsiasi sospetto di riflettere la più tarda realtà rabbinica. Inol-tre sono anch’esse, come gli scritti flaviani, opera di un ex fariseo. L’ade-sione del Paolo “pre-cristiano” al fariseismo è infatti un dato difficil-mente contestabile: a informarcene è lui stesso in Fil 3,5 e la notizia èconfermata dagli Atti degli Apostoli (22,3; 23,6; 26,4). I dubbi sollevati direcente a riguardo non sono da prendersi in seria considerazione59.
I testi rilevanti sono essenzialmente 1Cor 15,9; Gal 1,13-14.23; Fil3,5-6, nei quali l’Apostolo parla del suo passato precedente all’incontrocol Cristo. Un primo dato interessante si ricava dal passo di Filippesi.Qui Paolo menziona il suo essere stato fariseo quanto alla Legge comeuno dei motivi che egli ha di confidare “nella carne” più dei suoi avver-sari (probabilmente missionari giudeo-cristiani). Il passo presupponedunque che il fariseismo fosse una modalità di interpretare e vivere laLegge nota ed apprezzata. E poiché la lettera è indirizzata a una comu-
59 Cf M. VITELLI, «I farisei nel giudaismo palestinese al tempo di Gesù e dei primicristiani», in D. GARRIBBA - S. TANZARELLA (edd.), Giudei o cristiani? Quando nasce il cristia-nesimo?, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2005, 64, n. 33.
34
nità della Macedonia composta in prevalenza di gentili60, si deve conclu-dere che la fama del movimento farisaico negli anni cinquanta dovevaessere tale da superare i confini geografici della Palestina e quelli etnicie culturali della comunità giudaica61.
Indicazioni utili alla nostra ricerca vengono anche dal confronto traGal 1,13-2,21 e Fil 3,2-14, nel quale ultimo è compreso il passaggio so-pra considerato. È stato opportunamente rilevato come tra i due passivi sia una precisa corrispondenza strutturale e tematica. In particolaresi osserva uno stretto parallelismo fra Gal 1,13a (t¾n �m¾n ¢nastrof»npote �n tù 'Ioudaismù) e Fil 3,5b (kat¦ nÒmon farisa�oj), da cui risultauna sorta di assimilazione tra “giudaismo” e fariseismo. Certo, qui coltermine �oudaismÒj non si allude alla religione giudaica nel suo insiemema all’orientamento caratterizzato da un forte attaccamento alla Legge(cf 2Mac 2,21; 8,1; 14,38)62. Il dato è nondimeno significativo, perché,come correttamente osserva G. Jossa, a partire dalla rivolta maccabaica«il giudaismo si stava realmente trasformando in quella che [...] si usadefinire una “religione della legge”»63. Non è allora arbitrario asserireche «nei confronti della narrazione di Fil 3,5b, il retroterra di Gal 1,13apermette di riconoscere che, al di là di alcune esagerazioni, il fariseismorappresenta comunque la “scuola di pensiero” più rappresentativa delgiudaismo del I sec d.C.»64.
L’episodio della persecuzione compiuta dal Paolo “pre-cristiano” aidanni della giovane Chiesa, al quale alludono tutti e tre i testi paolini chequi consideriamo, offre ulteriori elementi di riflessione. In primo luogo èdegno di nota il fatto che in tali testi Paolo, e dunque un fariseo, figuricome protagonista attivo di una persecuzione e che quest’ultima appaiacome un’iniziativa di entità non trascurabile, come si evince dal fatto cheegli mette sempre la propria persona in primo piano senza minimamen-te accennare alla collaborazione di altri e che egli parla senza mezzi ter-mini di una persecuzione oltre misura (kaq' Øperbol»n) e di un tentativodi distruggere (Gal 1,13: �pÒrqoun; Gal 1,23: �pÒrqei) la Chiesa. Elementi,
60 Cf A. WIKENHAUSER - J. SCHMID, Introduzione al Nuovo Testamento, Paideia, Brescia1981, 546.
61 Cf G. JOSSA, «I farisei di Marco e Luca», in R. PENNA (ed.), Fariseismo e origini cristia-ne…, cit., 134.
62 Cf J.D.G. DUNN, «Who Did Paul Think He Was? A Study of Jewish-Christian Identi-ty», in New Testament Studies 45 (1999) 184.
63 G. JOSSA, Giudei o cristiani? I seguaci di Gesù in cerca di una propria identità, Bre-scia, Paideia 2004, 49.
64 A. PITTA, «Paolo e il giudaismo farisaico», in R. PENNA (ed.), Fariseismo e originicristiane…, cit., 92.
35
questi, che sono ampiamente confermati dal racconto degli Atti degliApostoli (9,1ss; 22,4ss; 26,9ss). E se quest’ultimo per certi versi può esse-re sospettato di esagerazione, non altrettanto può dirsi per la testimo-nianza di Paolo, il quale, come osserva M. Hengel, nella Lettera ai Galatiin particolare non aveva nessuna ragione per enfatizzare la persecuzionee la sua parte in essa, dal momento che questo rischiava di compromet-tere la sua posizione nel contesto della pericolosa situazione della Gala-zia65. A dire il vero non tutti concordano che l’episodio sia indicativodella popolarità dei farisei. A.J. Saldarini, fondandosi sui riferimenti lu-cani a un’autorizzazione sommosacerdotale ottenuta da Paolo per perse-guitare i cristiani (At 9,1.13-14; 22,5; 26, 10.12), ritiene che egli «traevaprobabilmente la propria autorità, e qualsiasi potere gestisse, dalla clas-se dominante giudaica di Gerusalemme o di comunità locali»66. Tuttaviale notizie degli Atti circa il carattere ufficiale della persecuzione e in par-ticolare circa l’autorizzazione richiesta da Paolo al sommo sacerdote sonosospette perché in linea con la duplice tendenza di Luca a drammatizza-re gli episodi di persecuzione della Chiesa e a metter in primo pianonell’opposizione ai cristiani le massime istituzioni giudaiche, soprattut-to il sommo sacerdote e l’aristocrazia sacerdotale-sadducea67. Tolta que-sta cornice ufficiale, di chiara origine redazionale, ciò che rimane è pro-babilmente un’ iniziativa di marca farisaica interna alla comunità sina-gogale grecofona di Gerusalemme, che fu in qualche modo tollerata dal-la leadership sacerdotale, a sua volta non certo favorevole ai cristiani.
Un’ultima riflessione riguarda la motivazione che Paolo adduce inGal 1,13-14 per la sua azione persecutoria. Essa appare come il fruttodella condotta di Paolo “nel giudaismo” e in particolare del suo zelo per“le tradizioni dei padri”68. Che quest’ultimo termine indichi specifica-mente le tradizioni proprie del gruppo farisaico – come ritengono i piùe come si evince dalla valenza dell’espressione in altre fonti69 – oppure
65 Cf M. HENGEL, Il Paolo precristiano, Paideia, Brescia 1992, 158.66 A.J. SALDARINI, Farisei, scribi e sadducei nella società palestinese…, cit., 147.67 Cf R.L. BRAWLEY, Luke-Acts and the Jews..., cit., 111ss; J.T. SANDERS, The Jews in
Luke-Acts, cit., 3ss, 18-20, 253, 287; S. LÉGASSE, «Paul’s Pre-Christian Career According toActs», in R.J. BAUCKHAM (ed.), The Book of Acts in Its Palestinian Setting (The Book of Actsin Its First Century Setting IV), Eerdmans, Grand Rapids (MI) 1995, 389.
68 Cf in particolare H.D. BETZ, Galatians: a Commentary on Paul’s Letter to the Chur-ches in Galatia, Fortress Press, Philadelphia 1988, 67-68, e A. VANHOYE, Lettera ai Galati,San Paolo, Milano 2000, 43-44.
69 Cf P. BONNARD, L’Épître de Saint Paul aux Galates, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel1972, 29; A. VANHOYE, Lettera ai Galati, cit., 44; H. SCHLIER, Lettera ai Galati, Paideia, Bre-scia 1966, 54-55; S. LÉGASSE, L’Épître de Paul aux Galates, Cerf, Paris 2000, 89; J.D.G.DUNN, The Epistle to the Galatians, Hendrickson, Peabody (Mass.) 1993, 60.
36
alluda in generale alle norme religiose, che per un fariseo non potevanonon comprendere le proprie tradizioni legali, è molto probabile che ladifesa di tali tradizioni dovette costituire almeno uno dei motivi dellapersecuzione. E ciò induce a domandarsi se la persecuzione paolinanon si spieghi meglio sullo sfondo di un’osservanza generalizzata delletradizioni farisaiche da parte della popolazione o quanto meno dellacomunità “ellenista” alla quale appartenne e nella quale operò comepersecutore il fariseo Saulo.
La fonte Q. Anche questa fonte come l’epistolario paolino vanta unadatazione antica: la stragrande maggioranza degli studiosi la pone tragli anni quaranta e l’inizio della rivolta contro Roma. In ogni caso essadeve necessariamente precedere di qualche tempo la redazione dei van-geli di Matteo e Luca, entrambi databili agli anni ottanta. Q inoltre provie-ne con ogni probabilità da un’area, quella siro-palestinese, nella quale ifarisei furono verosimilmente attivi. In altri termini esiste la concretapossibilità che la comunità di Q abbia avuto una qualche esperienza delfariseismo, come a detta di alcuni studiosi un passo quale Q 11,39ss,con le sue aspre invettive contro i farisei e i dottori della Legge o scribi,anche suggerirebbe70.
La pericope ora menzionata è ricca di informazioni utili per il nostrotema di ricerca71. L’invettiva contenuta nei vv. 39-41 riguarda la puritàrituale: Gesù critica i farisei perché purificano l’esterno della coppa edel piatto mentre l’interno è pieno di rapina e di intemperanza. L’invet-tiva evidentemente presuppone un forte interesse dei farisei per la leggerituale e in particolare per la purità. Neusner interpreta questo dato, chetrova conferma in altre fonti (cf Mc 7,3ss), come indicativo di interessisettari del gruppo72. Questo tuttavia non è necessariamente il caso. Comerecentemente ha messo in evidenza E. Regev, in una società di tipo teo-cratico come quella giudaica, dove l’accesso a Dio, fonte di autorità, èconsentito attraverso la purità rituale, la ricerca di un livello elevato dipurezza poteva corrispondere alla pretesa di esercitare una particolareautorità73. Interessante è anche l’accusa ai farisei di avere coppe e piatti
70 Cf C. TUCKETT, Q and the History of Early Christianity, Clark, Edinburgh 1997, 438ss.71 La ricostruzione della pericope è oggetto di discussione tra gli studiosi per molti aspetti.
Per quanto riguarda i destinatari delle invettive, tuttavia, si registra un amplissimo consen-so nel ritenere preferibile la versione lucana, che distingue i “guai” contro i farisei da quellicontro “i dottori della Legge” (cf J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, II, Paideia, Brescia 1991,416; T.W. MANSON, I detti di Gesù nei Vangeli di Matteo e Luca, Paideia, Brescia 1980, 151).
72 Cf J. NEUSNER, From Politics to Piety…, cit., 79-80.73 E. REGEV, «Pure Individualism: The Idea of Non-Priestly Purity in Ancient Judaism»,
in Journal for the Study of Judaism 32 (2000) 176-202.
37
pieni di “rapina” (¡rpagÁj). Probabilmente non ha torto R.A. Horsley acollegare questa critica con l’insistenza dei farisei sul pagamento delledecime74, che in certe aree agricole potevano effettivamente apparirecome una forma di vessazione. In altri termini l’accusa di “rapina” aifarisei si giustifica fino in fondo solo se si ammette che costoro non silimitavano ad osservare di persona una prassi particolarmente rigorosariguardo alle decime, ma in qualche misura cercavano di imporla anchead altri ed avevano una certa autorità ed influenza per farlo.
E questa influenza appare confermata dal v. 42b, che sembra impli-care il riconoscimento del valore normativo della prassi farisaica circala decimazione di certi tipi di erbaggi non soggetti a decima secondo laLegge biblica.
La terza invettiva (Q 11,43) è la più significativa per il nostro tema: ifarisei sono accusati di amare (file�te) i posti di onore nei banchetti, iprimi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Essi vengono dunquerappresentati come un gruppo che gode di grande prestigio sociale ed èpreminente nella sinagoga75.
L’ultimo dei “guai” contro i farisei assimila costoro a dei sepolcri chenon si vedono sui quali la gente cammina contraendo, senza accorgerse-
74 R.A. HORSLEY, «Jesus and Judaism: Christian Perspectives», in H.W. ATTRIDGE - G.HATA (edd.), Eusebius, Christianity, and Judaism, Brill, Leiden 1992, 69-70; ID., «Questionsabout Redactional Strata and Social Relations Reflected in Q», in SBL 1989 SeminarPapers, Atlanta 1989, 199. È chiaro che se l’interpretazione di Horsley è corretta bisognaipotizzare che Q 11,42b, che accetta la normatività delle decime farisaiche, appartenga senon a uno strato redazionale tardo, come ritiene J.S. Kloppenborg, almeno a uno stratodella tradizione successivo e comunque diverso rispetto a quello di Q 11, 39, oppure che sicollochi a livello della redazione (unica) di Q, come ritiene C. TUCKETT, Q and the History ofEarly Christianity, cit., 423.
75 In verità, dato che Mc 12,38-39 riporta un detto molto simile in cui compaiono noni farisei, come nella versione lucana del detto di Q, ma gli scribi, si discute se in origine illogion avesse di mira “gli scribi” (così ad esempio J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo diGesù, cit., 390, n. 56), o “i farisei” (cf H.T. FLEDDERMANN, Mark and Q. A Study of the Over-laps Texts, Leuven University Press: Peeters, Leuven 1995, 186-189; J. GNILKA, Marco, Cit-tadella, Assisi 1998, 675, e S. LÉGASSE, Marco, Borla, Roma 2000, 647). In ogni caso, èmolto probabile che Luca riporti il detto così come lo ha trovato nella fonte Q: data la suatendenza ad evitare i doppioni difficilmente avrebbe ripetuto due volte lo stesso logion in11,43 e 20,46, se non lo avesse trovato in due fonti diverse con qualche variazione diforma (cf T.W. MANSON, I detti di Gesù nei Vangeli di Matteo e Luca, Paideia, Brescia 1980,151s; H.T. FLEDDERMANN, Mark and Q..., cit., 188; o anche J.M. ROBINSON - P. HOFFMANN - J.S.KLOPPENBORG, The Critical Edition of Q, Peeters, Leuven 2000, 274). E se le cose stannocosì, non è poco significativo che un documento come Q, proveniente da un contesto incui era forse attuale un confronto con i farisei, descriva questi ultimi nei termini cheleggiamo in Lc 11,43. Anzi, se la sostituzione di “scribi” con “farisei” avviene a livello di Qsaremmo di fronte a un indizio significativo dello stretto legame tra scribi e farisei.
38
ne, l’impurità da cadavere. Ciò che rileva è che l’invettiva di fatto consi-ste in una denuncia della pericolosità dell’influenza farisaica e insiemein un’accusa di ipocrisia, accusa che è tipicamente rivolta a chi occupauna posizione di potere da parte di gruppi esclusi dal potere stesso76 eche non a caso i qumraniti rivolgono proprio ai farisei77 nel periodo incui questi ultimi sicuramente avevano grande influenza. La stessa quali-fica di Øpokrita�, che nella versione matteana dei “guai” è costantementepresente in riferimento ai farisei (e agli scribi), è possibile che figurassegià a livello di Q e che sia stata eliminata da Luca per adattare le invettiveal contesto simposiale in cui esse sono redazionalmente collocate78.
Un’ultima considerazione si impone. Nella pericope, secondo la suaricostruzione più probabile, alle invettive contro i farisei, dei quali sicritica soprattutto la prassi religiosa, seguono delle invettive contro i“dottori della Legge” o “scribi”, dei quali si prende di mira il modo in cuiesercitano l’autorità religiosa. La pericope, cioè, pur distinguendoli, as-socia farisei e scribi nello stesso contesto polemico. Ciò che va sottoline-ato è che si ha l’impressione che tale associazione sia indicativa di unostretto legame fra i gruppi: se i farisei osservano la Legge in modo minu-zioso e formale andando anche oltre il dettato biblico ma senza ottem-perarne le esigenze fondamentali, i dottori della Legge la interpretano inun modo che risulta oneroso e sviante; i primi sono accusati di rapina,probabilmente per via della propaganda che fanno a favore di un’osser-vanza rigorosa delle decime, i secondi sono criticati perché impongonogrossi pesi sulle spalle delle persone senza muovere un dito per aiutarle;i primi sono impuri e fonte di impurità, rendendo così inadatti all’incon-tro cultuale con Dio tanto se stessi che coloro con i quali entrano incontatto, i secondi chiudono il regno di Dio dinanzi agli uomini e non vi
76 Cf S. MASON, «Pharisaic Dominance before 70 CE and the Gospels’ Hypocrisy Char-ge (Mt 23,2-3)», in Harvard Theological Review 83 (1990) 263-381.
77 Cf G. STEMBERGER, Farisei, sadducei, esseni, cit., 40. Va detto tuttavia che nell’epitetodi doreshei halaqot (“cercatori di interpretazioni facili”) con cui i qumraniti designano ifarisei c’è più di un’accusa di ipocrisia. Probabilmente si tratta di un’interpretazione ma-levola di quell’akribeia nell’interpretazione della Legge per cui i farisei erano famosi: lungidall’essere “precisa” la loro interpretazione della Legge era troppo accomodante, “facile”appunto. Ma questa accusa di lassismo traduce verosimilmente in termini polemici iltentativo da parte dei farisei di rendere, attraverso l’halakah, meno gravosa l’osservanzadella Legge e dunque meno esclusiva e più “democratica” la pratica della religione (cf A.I.BAUMGARTEN, «Seekers After Smooth Things», in L.H. SCHIFFMAN - J.C. VANDERKAM [edd.],Encyclopedia of the Deads Sea Scrolls, II, New York 2000, 857-858), il che ben spiega lapopolarità che essi avevano secondo Flavio Giuseppe.
78 Cf M. DEL VERME, Giudaismo e Nuovo Testamento. Il caso delle decime, D’Auria,Napoli 1990, 48.
39
entrano loro stessi né consentono ad altri di entrarvi; gli uni e gli altriinoltre sono ipocriti, gli uni perché appaiono puri senza esserlo, gli altriperché da un lato costruiscono le tombe dei profeti manifestando conciò di prendere le distanze dai loro padri che quei profeti hanno ucciso edall’altro lato rifiutano il messaggio salvifico degli inviati di Dio. In fon-do, anche se da punti di vista diversi, quello della pratica e quello del-l’autorità, il tipo di religiosità dei due gruppi è lo stesso. In altre parolenon è peregrina l’ipotesi di un’identificazione dei dottori della Leggemenzionati nel passo in questione come maestri farisei79. E del restoquesto è evidentemente il modo in cui sia Luca che Matteo intendonoquesti dottori della Legge. Il primo infatti ambienta in casa di un fariseoil banchetto in cui Gesù pronuncia i “guai” contro “farisei” e “dottoridella Legge”, e subito dopo questo episodio inserisce il logion sul lievito“dei farisei” (Lc 12,1). Il secondo rivolge tutte le invettive in modo indi-stinto a «scribi e farisei», mostrando così di considerare entrambi comeun unico gruppo indifferenziato. Q dunque sembra offrire una preziosaconferma alla tesi tradizionale che afferma una stretta connessione trafarisei e scribi e un’ampia capacità di influenza religiosa del fariseismo.
I vangeli canonici. In tutti i vangeli i farisei figurano tra le principaliautorità giudaiche avverse a Gesù. La loro rilevanza come leaders religio-si e come avversari di Gesù comunque cresce lungo la linea diacronicache va da Marco a Giovanni unitamente a una progressiva riduzione del-la varietà del quadro religioso del giudaismo. Mc rappresenta quest’ulti-mo come una realtà alquanto articolata in cui i farisei svolgono un ruoloimportante; in questa rappresentazione tuttavia non sono “i farisei” ilprincipale gruppo di opposizione a Gesù ma gli scribi, e sono costoro (enon “i farisei”) che insieme agli “anziani” e ai “sommi sacerdoti” costitu-iscono il sinedrio e dunque il vero e proprio gruppo dirigente della nazio-ne. In Lc il giudaismo appare meno variegato (scompaiono gli erodiani);la connessione dei farisei con gli scribi, già presente in Mc, si fa più stret-ta, e rispetto a Mc si inverte anche il rapporto numerico tra le menzionidegli “scribi” e quelle dei “farisei” a vantaggio di queste ultime (21:12 inMc; 14:27 in Lc); i “farisei” appaiono inoltre preminenti in ambito sina-gogale (11,43) e sembrano occupare una posizione elevata anche sul pia-no socio-economico (16,14). In Mt non solo si osserva la stessa tendenza
79 È significativo a tale riguardo che l’International Q Project nella sessione di lavorodel 12-14 luglio del 1991 avesse proposto una ricostruzione critica del testo di Q 11,39-52ss in cui il bersaglio polemico di tutte le invettive, compreso quelle che Luca riferisce aidottori della Legge, era costituito da “i farisei” («Work Session 12-14 July, 22 November1991», in Journal of Biblical Literature 111 [1991] 504-505).
40
ad accrescere la presenza dei farisei rispetto a quella degli scribi (gli “scri-bi” sono menzionati 22 volte contro le 29 dei “farisei”) ma i due gruppitendono anche a fondersi; l’autorità dei farisei si accresce inoltre note-volmente: essi siedono con gli scribi sulla “cattedra di Mosè” (cf 23,2ss) einsieme ai capi dei sacerdoti figurano come destinatari della paraboladei vignaioli omicidi (21,45); i “farisei”, pertanto, sono considerati allapari degli scribi e dei sommi sacerdoti come i leaders spirituali della na-zione e come i responsabili del suo traviamento. In Gv i farisei si identi-ficano di fatto con i “giudei” (cf 1,19.24), e se nei Sinottici appaiono comeinviati delle autorità che costituiscono il sinedrio, in Gv essi sono parteintegrante del sinedrio (cf 7,32; 11,46ss) e sono loro ad inviare sacerdotie leviti (cf 1,19.24); hanno inoltre il potere di decretare l’esclusione dallasinagoga, e sono per questo temuti anche dai “capi” (cf 12,42); quantoall’immagine del giudaismo, essa risulta notevolmente impoverita, dalmomento che non si parla più né di “anziani” né di “sadducei” né di“erodiani” e neanche di “scribi”. Come spiegare questi dati? La soluzionedi M. Smith e di altri autori la si è vista: i vangeli, la cui redazione èsuccessiva al 70, riflettono l’ascesa del movimento rabbinico e la polemi-ca tra Chiesa e Sinagoga rabbinica; solo allora i farisei assurgono al ran-go di guide della nazione e il giudaismo perde quel carattere pluralisticoche aveva avuto in passato; prima del 70 i farisei erano un gruppo dimodeste dimensioni e comunque non erano tra i principali avversari diGesù. Ciò sarebbe provato anche da altri dati: l’assenza dei farisei dallastoria della passione (che costituisce uno degli strati più antichi dei van-geli); il carattere ideale di molte delle controversie tra Gesù e i farisei;l’inserzione secondaria dei “farisei” in molte delle scene di controversia;la circostanza, dedotta dalla letteratura rabbinica, dell’assenza dei fariseidalla Galilea, dove i vangeli ambientano la maggior parte delle contro-versie tra Gesù e i farisei; l’atteggiamento positivo dei farisei nei confron-ti dei primi cristiani e la sostanziale fedeltà alla Legge di questi ultimi.
La spiegazione offerta da Smith e dagli altri studiosi che ne condivi-dono le posizioni tuttavia non convince, e non solo per le ragioni espostesopra nel par. 2, ovvero il carattere tardivo dell’affermazione del movi-mento rabbinico – soprattutto nella diaspora dove si ritiene che i vangelisiano stati scritti – e la continuità problematica tra fariseismo e rabbini-smo. Alcuni fenomeni infatti non si accordano con l’idea di un confrontodiretto tra le comunità cristiane e il giudaismo rabbinico: in Mt rispettoa tutti gli altri vangeli si osserva un incremento della presenza dei saddu-cei, che non si giustifica in modo adeguato con la realtà del giudaismodel post-70; i rabbi si identificarono più che con i farisei con gli scribi, lacui presenza invece nei vangeli si riduce progressivamente fino a scom-
41
parire; i farisei dei vangeli assumono tratti sempre più tipizzati, il chelungi dall’indicare una contrapposizione attuale delle comunità degli evan-gelisti con essi, è indice di un distacco crescente dagli eventi narrati.
In realtà l’incremento della presenza dei farisei nei vangeli successivia Mc e gli altri fenomeni considerati si spiegano persuasivamente consi-derando due fattori. Il primo consiste nell’utilizzazione di nuovo mate-riale tradizionale da parte degli evangelisti. Questo è ad esempio il casodi due passi estremamente significativi per il nostro tema di studio: quellorelativo ai “guai” contro farisei e scribi, che Lc e Mt derivano dalla fonteQ, e il già menzionato Mt 23,2-3 («Sulla cattedra di Mosè si sono assisigli scribi e i farisei. Fate e osservate ciò che vi dicono, ma non quello chefanno. Poiché dicono e non fanno»). Del passo di Q si è già detto. Quan-to a Mt 23,2-3, è facile dimostrarne l’origine tradizionale80. L’atteggia-mento che esso suggerisce nei confronti dell’insegnamento farisaico con-trasta patentemente con la condanna di quell’insegnamento a livello re-dazionale (cf Mt 16,6.12, dove il “lievito” da cui i discepoli devono guar-darsi viene inteso redazionalmente come l’insegnamento dei farisei edei sadducei; o 23,16ss, dove scribi e farisei sono definiti “guide cieche”appunto per le loro interpretazioni). Inoltre la presenza di un riferimen-to originario ai farisei (esplicito o anche implicito, attraverso la men-zione di “scribi” di orientamento farisaico) mi sembra probabile anchein base ad altre considerazioni: se, come sembra, il logion proviene dacircoli giudeocristiani di stretta osservanza, è verosimile che i leadersgiudei il cui insegnamento essi erano disposti a seguire fossero maestrifarisei, dal momento che è documentata una certa prossimità tra fariseie gruppi giudeocristiani (cf At 5,34ss; 15,5), il che è tanto più probabilese il logion è ascrivibile, come alcuni ritengono, alla fonte Q (che comesi è visto conosce farisei e scribi di probabile orientamento farisaico,assegna loro grande autorità e lega i farisei alla sinagoga, a cui proba-bilmente rimanda la “cattedra di Mosè” di Mt 23,2)81 e se la comunità diQ è identificabile con la comunità di Gerusalemme guidata da Giaco-mo, che sappiamo essere stato in rapporti non ostili con i farisei (cf At15,5ss; Ant. 20,199ss)82; accanto a questo l’espressione «fate tutto ciòche possono dirvi (p£nta ... Ósa �¦n e�pwsi Øm�n) [scl. gli scribi e i fari-
80 Per molte delle osservazioni che seguono circa questo passo sono debitore a S. MASON,«Pharisaic Dominance before 70 CE and the Gospels’ Hypocrisy Charge (Mt 23,2-3)», cit.
81 Così ad esempio H. Schürmann cit. in J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Paideia, Bre-scia 1991, II, 400, n. 6.
82 Cf G. JOSSA, Giudei o cristiani?..., cit., 123, e M. VITELLI, «Quando nasce il cristiane-simo? Il contributo di una pubblicazione recente al dibattito sulle origini cristiane», inRassegna di Teologia 46 (2005) 776-777.
42
sei]» sembra alludere non soltanto al dettato della legge scritta, ma an-che alla produzione halakica propria dei farisei.
Il secondo fattore di spiegazione è rappresentato da un processo digeneralizzazione degli avversari di Gesù in virtù del quale si perde ladistinzione tra i farisei e il gruppo degli scribi – che storicamente erasenza dubbio costituito in larga parte da maestri farisei83 – e il frontedegli avversari di Gesù tende a ridursi a quella componente che sin dal-l’inizio aveva il ruolo principale, ovvero quella farisaica. Tuttavia, nonbisogna credere che l’inserzione secondaria di riferimenti ai farisei ne-gli episodi evangelici, conseguente a questo processo di generalizzazio-ne, sia un fenomeno così pervasivo da rendere i vangeli fonti inutilizza-bili. Ad esempio l’evangelista Luca, se in un paio di casi aggiunge reda-zionalmente dei riferimenti ai farisei nel materiale marciano (Lc 5,17.21;cf Mc 2,1-6), in un altro paio di casi li elimina (Lc 11,16; 20,20; cf rispet-tivamente Mc 8,11 e 12,13); e lo stesso Vangelo di Matteo, che pure pre-senta una tendenza accentuata ad inserire i farisei dove non figuravano,almeno in un caso manifesta il fenomeno inverso (9,14; cf Mc 2,18). Eda questo punto di vista l’assenza dei farisei dalla storia sinottica dellapassione e dalle pericopi relative alle predizioni della passione (dovepure sono citate le autorità giudaiche e tra queste gli scribi), e il fattoche solo nel corrispondente racconto giovanneo “i farisei” facciano unatimida comparsa (18,3), lungi dal dimostrare, come vedremo tra poco,che i farisei non furono coinvolti nella morte di Gesù, devono semmaiindurre gli studiosi a guardarsi da un approccio ai farisei dei vangelitroppo sbilanciato in senso storico-redazionale.
Tra i vangeli quello di Marco merita particolare attenzione. Esso èdatabile con tutta probabilità tra il 65 e il 70 d.C.: a quel tempo moltitestimoni dei fatti narrati erano ancora in vita, e la sua rappresentazionedel giudaismo difficilmente risente già della situazione successiva allacaduta del Secondo Tempio. Inoltre ancora oggi la maggioranza deglistudiosi è favorevole all’identificazione tradizionale dell’autore di questovangelo con Giovanni Marco84. Questi, giudeo di Gerusalemme – cittànella quale i farisei erano soprattutto radicati –, fu tra l’altro compagnodell’ex fariseo Paolo, cugino di Barnaba e collaboratore di Pietro; e la suacasa ospitò per qualche tempo la prima comunità cristiana, la quale ebbecontatti con i farisei. Si deve quindi presumere che egli disponesse diottime informazioni sulla vicenda di Gesù e sulla realtà del fariseismo.
83 Cf infra.84 Cf M. HENGEL, Studies in the Gospel of Mark, SCM, London 1985, 1-30; M. LACONI ET AL.,
Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, LDC, Leumann 1994, 139; S. LÉGASSE, Marco, cit., 38-39.
43
Di certo la rappresentazione che Marco offre dei farisei e dei lororapporti con Gesù risulta nel complesso credibile. In primo luogo vaosservato che, a giudizio pressoché unanime degli esegeti, buona partedel materiale marciano sui farisei ha un’origine tradizionale molto anti-ca. Questo è il caso soprattutto del gruppo di controversie galilaichesulla Legge (Mc 2,1-3,6). Qui i farisei appaiono come personaggi dotatidi autorità in tema di Legge, come legati alla sinagoga e come partico-larmente zelanti nel far rispettare la prassi legale al punto di arrivare adallearsi con gli erodiani per eliminare Gesù; inoltre questa alleanza, chetra l’altro si ripropone nella pericope sul tributo a Cesare (12,13ss), im-plica che i farisei avessero contatti con ambienti politici, così come ilriferimento agli «scribi dei farisei» (2,16) spinge a credere che i fariseiavessero una loro rappresentanza nel sinedrio, di cui gli scribi eranouna componente essenziale. Tutti elementi, questi, che risultano confor-mi a quanto sappiamo dei farisei dalle altre fonti. Né è così facile conte-stare la storicità del quadro marciano invocando il carattere ideale dellestorie di controversia85, la scarsa attendibilità di un’alleanza tra fariseied erodiani86 o l’assenza dei farisei dalla Galilea87. Tali argomenti a un’ana-lisi più attenta si rivelano poco convincenti. Circa il primo va detto che,anche ammettendo una certa stilizzazione nei racconti di controversia– che pure alcuni valenti esegeti contestano88 – essa può ben essere spie-gata col fatto che questi racconti riproducono situazioni tipiche del re-ale rapporto tra Gesù e i farisei89. Per quel che attiene poi all’associazio-ne di farisei ed erodiani, essa trova un riscontro più che una smentita inLc 13,31-32, che presuppone un qualche legame tra Erode Antipa e “al-cuni farisei”, nonostante questi ultimi sembrino agire favorevolmentenei confronti di Gesù e in modo contrario agli interessi di Erode; e co-munque quell’associazione non è così implausibile se la si consideracome un’alleanza temporanea contro un comune avversario, analogadel resto a quella che altre volte unisce gli stessi farisei e i sadducei (cfBell. 2,411; Vita 21). Infine, per quanto riguarda la presunta assenza deifarisei dalla Galilea, essa si basa soprattutto sull’idea, che oggi apparesuperata, di una Galilea fortemente ellenizzata e poco integrata nel giu-
85 Così ad esempio, sulla scia di Bultmann, E.P. SANDERS, Gesù..., cit., 341s.86 Cf M. SMITH, Gesù mago, cit., 223-224; J. GNILKA, Marco, cit., 167.87 Cf M. SMITH, Gesù mago, cit., 227.88 R. Pesch, ad esempio, insiste sulla concretezza e la vivacità delle narrazioni (R.
PESCH, Il Vangelo di Marco, I, Paideia, Brescia 1980, 273, 283, 301, 310).89 M. HENGEL - R. DEINES, «E.P. Sanders “Common Judaism”, Jesus and the Pharisees»,
cit., 6-7.
44
daismo e su una sottovalutazione ingiustificata della testimonianza deitre vangeli sinottici nonché di molti indizi offerti da Flavio Giuseppe90.
Ma che dire dell’assenza dei “farisei” dalla storia sinottica della pas-sione? Essa significa che al tempo di Gesù i farisei erano esclusi dalsinedrio e dai circoli di potere? E la vicinanza dei primi cristiani ai fari-sei (cf At 5,34; 15,5; Ant. 20,199ss) non smentisce la veridicità del qua-dro evangelico del rapporto tra Gesù e i farisei e dunque la stessa atten-dibilità dei vangeli come fonti sui farisei? Io non credo che a questiquesiti vada data una risposta affermativa. La ragione per cui nella sto-ria della passione non si fa menzione esplicita dei farisei è presto detta:in quel racconto le autorità giudaiche figurano nel loro ruolo istituzio-nale e non secondo l’orientamento religioso. Così si parla di sommi sa-cerdoti, anziani e scribi e di sinedrio, mentre non compaiono né fariseiné sadducei. La presenza dei farisei deve comunque leggersi in filigranadietro la menzione del sinedrio e più in particolare degli scribi91. Dispo-niamo infatti di numerose testimonianze di una larga sovrapposizionetra farisei e scribi e di una presenza di farisei nel sinedrio (cf Mc 2,16;Gv 11,47; At 5,34; 23,6.9; Ant. 14,172; 15,3-4). Particolarmente significa-tivo a tal proposito è il confronto tra Mc e Flavio Giuseppe riguardo aigruppi che compongono la leadership giudaica, dove a «i sommi sacer-doti, gli anziani e gli scribi» del racconto marciano del processo sine-driale a Gesù (cf 14,53; 15,1) corrispondono bene «i sommi sacerdoti, imaggiorenti e i notabili dei farisei» di Bellum Iudaicum 2,411 e Vita 21.
Per quanto riguarda poi la discontinuità tra Gesù e la primitiva co-munità cristiana relativamente al rapporto con i farisei, essa dipese cer-tamente dall’atteggiamento di maggiore aderenza alla Legge e alle tradi-
90 Tra questi indizi basterà ricordare i seguenti: la fondazione da parte di Giuda “ilGalileo” e del fariseo Sadoq di un partito che appare chiaramente come una filiazione diquello farisaico (Bell. 2,118; Ant. 18,4ss) e che anche in seguito sarà guidato da esponentidella famiglia galilaica di Giuda (es. Bell. 2,433.447; 7,253; Ant. 20,102); il galileo Eleazaroche induce Izate alla piena conversione al giudaismo (20,43); l’assegnazione del comandoin Galilea, da parte del governo provvisorio di Gerusalemme, a Giuseppe (Bell. 2,568; Vita29ss), che era legato al fariseismo; le amicizie e il profilo farisaici di Giovanni di Gischala(Bell. 2,591; Vita 74.193); l’invio in Galilea di una delegazione a maggioranza farisaica conil compito di sottrarre a Giuseppe il comando della regione (Vita 196ss). Favorevoli ariconoscere una presenza farisaica in Galilea sono tra gli altri S. FREYNE, Galilee fromAlexander the Great to Hadrian: 323 B.C.E. to 135 C.E., Glazier, Notre Dame, Indiana 1980,305s, e J.D.G. DUNN, «Pharisees, Sinners and Jesus», in ID., Jesus, Paul and the Law…, cit.,77ss; e G. JOSSA, «Il quadro storico, sociale, archeologico», in A. PITTA (ed.), Il Gesù storiconelle fonti del I-II sec. Atti del X Convegno di Studi Neotestamentari, Ricerche StoricoBibliche 2 (2005) 9-25.
91 Cf G. JOSSA, Il processo di Gesù, Paideia, Brescia 2002, 75.
45
zioni che i primi seguaci di Gesù ebbero rispetto a quest’ultimo, il che asua volta si spiega semplicemente col fatto che i primi cristiani non tras-sero dall’insegnamento del Maestro tutte le possibili conseguenze. Al dilà dei forti condizionamenti culturali e delle considerazioni di Realpoli-tik che verosimilmente giocarono un ruolo nell’orientare il comporta-mento della Chiesa delle origini, occorre tener presente sia che lo stessoinsegnamento del Maestro poteva non risultare del tutto chiaro, in quantoegli univa ad un’indubbia critica nei suoi confronti anche atteggiamentidi profondo rispetto92 (il motivo tipicamente marciano dell’incompren-sione dei discepoli può benissimo aver avuto anche a questo riguardoun fondamento storico)93 e sia che le dichiarazioni critiche di Gesù sualcuni aspetti della Legge come il sabato o la purità non erano formulaticome inviti positivi alla non osservanza. Non solo, ma la libertà mostra-ta dal Messia nei confronti della Torah e delle tradizioni era valida ancheper i suoi seguaci nel tempo in cui lo “sposo” non sarebbe stato più conloro (cf Mc 2,19-20)? Accanto a questo bisogna guardarsi dall’accentua-re troppo la discontinuità tra Gesù e la primitiva comunità cristianarispetto all’osservanza della Legge e al rapporto con i farisei. Intantotale comunità non è composta solo dagli “ebrei”, ma anche dagli “elleni-sti”, i quali, a motivo della loro critica al Tempio e alla Legge furonoperseguitati dal fariseo Saulo (At 6,8 - 8,3; 9,1ss). Inoltre gli stessi Apo-stoli – e primo fra tutti Pietro – non ebbero sulla Legge un atteggiamen-to così conservatore come una certa esegesi di matrice protestante inpassato ha sostenuto. Non per nulla Pietro, Giovanni e Giacomo rico-nobbero la legittimità della missione paolina (Gal 2,1-10) e Pietro fuaccusato di vivere «come i gentili e non alla maniera dei giudei» (Gal2,11ss); e non per nulla, secondo il racconto lucano, nelle persecuzionidegli Apostoli, benché fosse in primo piano l’aristocrazia sacerdotale, fucoinvolto anche il sinedrio con i suoi scribi: lo stesso Gamaliele in At5,34ss, se si oppone alla pena di morte per gli Apostoli non si opponealla loro fustigazione (la stessa pena, si noti, che l’Apostolo ai gentili in2Cor 11,24 dice di aver subito lui stesso cinque volte), e se prescindiamodal discorso di chiara origine redazionale che Luca gli fa pronunciare,non possiamo affatto essere così sicuri che il suo agire fosse dettato dareale favore verso i cristiani e non piuttosto da semplice calcolo politicoo ancora da quella maggior mitezza nelle punizioni che secondo FlavioGiuseppe caratterizzava i farisei rispetto ai sadducei (Ant.13,294).
92 Cf ID., «I farisei di Marco e Luca», cit., 145.93 In Mc 7,17 il detto sul puro e l’impuro del v. 15 viene definito parabol» ed è oggetto
dell’incomprensione dei discepoli.
46
In definitiva non ci sono ragioni stringenti per rifiutare nelle sue li-nee essenziali l’immagine che i vangeli, e principalmente il Vangelo diMarco, ci offrono dei farisei e dei loro rapporti con Gesù.
Atti degli Apostoli. In quest’opera i farisei sono raffigurati come ungruppo dotato di influenza e popolarità e in un certo senso come l’orien-tamento più rappresentativo del giudaismo: il fariseo Gamaliele è de-scritto come «un maestro della Legge onorato da tutto il popolo» (5,34);Paolo si vanta di essere stato istruito da lui «nella precisa interpretazio-ne della Legge dei padri» (22,3) e definisce i farisei come l’¢kribest£tha�resij del giudaismo (26,5); i farisei costituiscono inoltre uno dei duepartiti che compongono il sinedrio (23,6) – l’altro è quello dei sadducei– e all’interno di questa istituzione mostrano di essere una presenzamolto influente (5,34-40; 23,6-10); infine, diversamente dai sadducei,essi appaiono come i sostenitori dell’idea della resurrezione (23,8) che asua volta figura come un elemento fondamentale e caratterizzante delpatrimonio religioso nazionale (26,6-8).
Come valutare questo ritratto sul piano storico? La questione è com-plessa e richiede cautela. Come si accennava all’inizio, l’esegesi ha mes-so in rilievo la valenza teologica di tale ritratto. Non a torto la maggio-ranza degli studiosi94 ha individuato nella seconda opera dell’Auctor adTheophilum una tendenza a dipingere in chiave positiva il rapporto tracristiani e farisei, onde dimostrare la continuità della Chiesa – e in par-ticolare della missione paolina ai gentili – con Israele. E se questo èvero, occorre considerare la possibilità, da parte di Luca, di un’accen-tuazione dell’importanza dell’elemento farisaico in seno al giudaismo.
Ciò nondimeno non mancano ragioni per accogliere in sede storicaalmeno la sostanza di quanto gli Atti degli Apostoli dicono dei farisei.
In primo luogo, su un piano generale, va osservato che gran partedella ricerca attuale è orientata alla rivalutazione degli Atti degli Aposto-li come fonte storica95. Si fa sempre più strada la convinzione che il“Luca teologo” e il “Luca storico” non siano mutuamente esclusivi e chedunque non necessariamente ciò che nel libro degli Atti ha valore teolo-gico sia per ciò stesso privo di fondamento storico.
In secondo luogo si deve considerare la possibilità, oggi ammessa daun numero crescente di studiosi, che le “sezioni-noi” rinviino alla testi-
94 Cf J.A. ZIESLER, «Luke and the Pharisees», cit.; R.L. BRAWLEY, Luke-Acts and the Jews…,cit., 94-106; J.T. SANDERS, The Jews in Luke-Acts, cit., 84-131; J.T. CARROLL, «Luke’s Portrayalof Pharisees», in Catholic Biblical Quarterly 50 (1988) 604-621; D.B. GOWLER, Host, Guest,Enemy and Friend. Portraits of the Pharisees in Luke and Acts, Peter Lang, New York 1991.
95 Cf M. HENGEL, La storiografia protocristiana, Paideia, Brescia 1985, e C.J. HEMER, TheBook of Acts in the Setting of Hellenistic History, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1989.
47
monianza oculare del redattore finale dell’opera e che dunque questi siastato effettivamente un compagno di viaggi di Paolo96. E questo è undato di grande interesse, non solo perché vorrebbe dire che l’autore degliAtti è stato a contatto con uno dei protagonisti della storia protocristia-na, il quale, avendo avuto un passato da fariseo, potrebbe avergli fornitoinformazioni preziose circa il suo partito di un tempo, ma anche perchéle “sezioni-noi” presuppongono che l’autore sia stato accanto a Paolo nelsuo ultimo viaggio a Gerusalemme e per tutto il tempo della sua prigio-nia in Palestina. In altri termini si può ragionevolmente ipotizzare chel’Auctor ad Theophilum sia stato nella città santa e nella regione palesti-nese alla fine degli anni cinquanta e che in quell’occasione abbia avutomodo di raccogliere notizie sulla vicenda di Gesù e sulla primitiva storiadella Chiesa97 e ancora – ed è quello che più interessa ai fini della nostraindagine – di rendersi personalmente conto della situazione politica ereligiosa esistente nella città di Davide e nella terra di Israele.
In terzo luogo, è molto probabile che una parte significativa dellacomunità per la quale Luca scrive sia composta da fedeli provenientidal giudaismo98, alcuni dei quali non è inverosimile che avessero unaqualche conoscenza diretta della realtà palestinese e potessero esercita-re un certo controllo sulla veridicità del racconto lucano. Tale possibili-tà acquista concretezza se si tiene conto che Luca scrive gli Atti degliApostoli non più di 15/20 anni dopo il 70; che nell’età del Secondo Tem-pio esisteva un intenso interscambio tra diaspora e Gerusalemme99; eche le sinagoghe ellenistiche della città santa – punto di riferimento ob-bligato per i pellegrini provenienti dalla diaspora grecofona – probabil-mente non erano prive di contatti con ambienti farisaici, come dimo-stra il caso del fariseo Paolo100.
96 Cf M. HENGEL, La storiografia protocristiana, cit., 95-97; C.J. HEMER, The Book of Actsin the Setting…, cit., 308ss; J. FITZMYER, Luca Teologo, Queriniana, Brescia 1991, 9-28; ID.,The Gospel According to Luke, I, Doubleday, New York 1981, 35-53; V. FUSCO, Da Paolo aLuca, I, Paideia, Brescia 2000 (in particolare i seguenti saggi ivi raccolti: «Le sezioni-noidegli Atti nella discussione recente», 57-71; «Ancora sulle sezioni-noi degli Atti», 73-84;«Da Paolo a Luca: un problema ancora aperto», 85-137).
97 Cf C.J. HEMER, The Book of Acts in the Setting…, cit., 362-363.98 Cf PH.F. ESLER, Community and Gospel in Luke-Acts. The Social and Political Motiva-
tions of Lucan Theology, Cambridge University Press, Cambridge 1987, 30ss; su questa lineasi muovono tra gli altri anche G.E. STERLING, Historiography and Self Definition. Josephos,Luke-Acts and Apologetic Historiography, Brill, Leiden 1992, 374-378 e G. SEGALLA, Evangeloe Vangeli. Quattro evangelisti, quattro Vangeli, quattro destinatari, EDB, Bologna 1993, 249.
99 Cf S. SAFRAI, «Relations between the Diaspora and the Land of Israel» in ID. - M. STERN
(edd.), The Jewish People in the First Century, I, van Gorcum, Assen 1974, 184-215, 184-215.100 Cf M. HENGEL, Il Paolo precristiano, cit., 139s..
48
L’argomento principale a favore dell’attendibilità del ritratto lucanodei farisei, tuttavia, sta nel fatto che gli elementi fondamentali di quelritratto corrispondono a quanto sappiamo dei farisei da altre fonti, ilche è tanto più significativo se si conviene con la maggioranza degli stu-diosi che l’autore degli Atti non conosce né l’epistolario paolino né l’ope-ra di Flavio Giuseppe101. Che Gamaliele fosse un maestro della Leggefariseo particolarmente popolare (cf At 5,34), appare confermato sia daquanto dice Flavio Giuseppe in Vita 191102, sia dal materiale rabbinico sudi lui103. Passi come Antiquitates Iudaicae 14,172ss, 15,3-4 e soprattutto ilconfronto tra Mc 14,53ss e 15,1 da un lato e Bellum Iudaicum 2,411 eVita 21 dall’altro mostrano, poi, con sufficiente chiarezza che i leadersdei farisei costituivano una componente fondamentale e influente delsinedrio, rendendo credibile sia la presentazione di Gamaliele come si-nedrita autorevole104, sia quanto si dice in Atti 23,6 circa la composizionedel sinedrio. Un riscontro in altre fonti ha anche la descrizione dei fari-sei come l’¢kribest£th a�resij del giudaismo (cf Bell. 1,110 e Vita 191) ecome sostenitori della dottrina della risurrezione dei morti (cf Bell. 2,164;Ant. 18,14)105. La stessa rappresentazione lucana di uno stretto rapportotra cristiani e farisei, per quanto non esente da forzature, tuttavia ha unsicuro nucleo storico: alcuni episodi evangelici sembrano testimoniare afavore di un certo interesse dei farisei per Gesù (cf Lc 11, 37-38; 13,31;
101 Cf G.E. STERLING, Historiography and Self Definition…, cit., 366; G. SCHNEIDER, GliAtti degli Apostoli, I, Paideia, Brescia 1985, 123. Poco persuasivo – soprattutto a motivodelle implicazioni relative alla datazione degli Atti – risulta il recente tentativo di S. Ma-son di riaffermare la vecchia tesi dell’utilizzazione dell’opera flaviana, e in particolaredelle Antiquitates Iudaicae, da parte dell’autore degli Atti (S. MASON, Giuseppe Flavio e ilNuovo Testamento, Claudiana, Torino 2001, 207-251).
102 A proposito del figlio di Gamaliele, Simone, si legge: «Era della città di Gerusa-lemme, di famiglia molto illustre e della scuola dei farisei, che sono considerati superioria tutti gli altri per la precisa conoscenza delle leggi del paese».
103 Cf J. NEUSNER, The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70, cit., I, 341-376.104 Il caso del sinedrita di orientamento farisaico Samaias raccontato in Antiquitates
Iudaicae 14,172ss (cf Ant. 15,3) offre un parallelo interessante all’episodio di Gamalielenegli Atti. Samaias, in occasione del processo ad Erode, pronunciando un autorevole di-scorso nel sinedrio riesce a modificare l’orientamento dell’assemblea. Inoltre il racconto faemergere anche la popolarità di questo maestro fariseo: successivamente Samaias persua-se il popolo di Gerusalemme ad aprire le porte della città ad Erode che la cingeva d’assedio.
105 A dire il vero Flavio Giuseppe non parla specificamente di risurrezione dei mortima più genericamente di immortalità dell’anima e dell’acquisizione di un altro corpo daparte della anime buone. Probabilmente però ciò si spiega con l’intenzione dello storicogiudeo di adattare le credenze religiose giudaiche alle categorie di pensiero greche deisuoi lettori (cf G. STEMBERGER, Farisei, sadducei, esseni, cit., 91). Un’altra possibile testimo-nianza si ha in Mc 12,28 dove «uno degli scribi» consente con Gesù che ha difeso la dottri-na della risurrezione contro i sadducei.
49
Gv 3,1ss; 7,50; 19,39); circoli cristiani di matrice farisaica sono presup-posti da passi come Q 11,42; 16,17 e Mt 23,2-3; e di tipo farisaico appareil giudeocristianesimo della chiesa di Gerusalemme, almeno da quandola guida della comunità fu assunta da Giacomo il “Giusto”; il che sembracorroborato sia da Antiquitates Iudaicae 20,199ss, secondo cui alcunipersonaggi identificabili come farisei106 chiesero la destituzione del som-mo sacerdote Anano, colpevole, a loro giudizio, di aver condannato amorte Giacomo agendo illegalmente, e sia dall’atteggiamento non ostileverso i cristiani che emerge dall’opera di Flavio Giuseppe e che è possibi-le mettere in relazione, almeno in parte, al passato farisaico dell’autorenegli anni in cui Giacomo era alla guida della comunità cristiana di Ge-rusalemme107. Infine per quanto riguarda Paolo, come si è visto, è luistesso nella Lettera ai Filippesi (3,5) a confermare il dato sottolineato purtendenziosamente dagli Atti della sua formazione farisaica.
4. Farisei, sacerdoti, esseni
Dall’esame delle fonti svolto sin qui risulta dunque chiaro che ancherelativamente al periodo delle origini cristiane le affermazioni di FlavioGiuseppe circa la popolarità e l’influenza dei farisei non sono poi cosìinattendibili come un numero crescente di studiosi tende a credere. Permeglio valutare il peso del fariseismo nella società palestinese del tem-po è utile però discutere anche la tesi, che sembra andarsi oggi impo-nendo, secondo cui il ruolo principale nel panorama del giudaismo delSecondo Tempio fosse giocato non già dai farisei ma dai sacerdoti. Nonritengo invece occorra soffermarsi sull’ipotesi che individua negli esse-ni la principale formazione religiosa del periodo del Secondo Tempio.Benché essa abbia il merito di mettere in evidenza che gli esseni noncostituirono una realtà così isolazionista e settaria come spesso si tendea credere in base a una loro identificazione semplicistica con i qumra-niti, tuttavia gli elementi per affermare che essi costituissero effettiva-mente «la più grande alleanza del periodo del Secondo Tempio» sono discarsa consistenza. Basti dire che il NT passa gli esseni completamentesotto silenzio, come sembra fare anche la letteratura rabbinica, mentreFlavio Giuseppe, a parte pochi e scarni riferimenti a quattro singoli per-sonaggi di questo orientamento (tre profeti e un generale: Bell. 1,78;2,113.567; 3,11; Ant. 13,311-312; 15,373; 17,346), parla del gruppo come
106 Per questa identificazione cf S. MASON, Giuseppe Flavio e il Nuovo Testamento, cit.,198; E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit., 566.
107 Cf G. JOSSA, «I farisei di Marco e Luca», cit., 145-146.
50
tale solo negli excursus sulle “scuole” giudaiche – nei quali per altro nondice che essi fossero particolarmente influenti –, in Antiquitates Iudai-cae 15,371ss (gli esseni sono esentati da Erode dall’obbligo di prestargligiuramento di fedeltà) e in Vita 10 (qui gli esseni sono menzionati comeuna delle “scuole” comprese nell’itinerario formativo dell’autore dell’ope-ra), e questo – si badi bene – nonostante Flavio Giuseppe mostri unachiara simpatia per gli esseni108.
Ben altra attenzione merita la tesi di chi, come E.P. Sanders, propo-ne di vedere nel sacerdozio l’elemento dominante del giudaismo del Se-condo Tempio. L’autore inglese, in particolare, sostiene che i sacerdotiesercitarono un ruolo indiscusso di guida religiosa non solo in epocabiblica, come risulta dalle Scritture ebraiche, ma anche nel periodo suc-cessivo, e specialmente nel I secolo. Questo sarebbe dimostrato dallaletteratura qumranica, che assegna un chiaro primato ai sacerdoti, dalNT (ad esempio Mc 1,40-45) e soprattutto da Flavio Giuseppe, che intutte le sue opere pone in primo piano l’autorità dei sacerdoti sulla Leg-ge, in particolar modo nel Contra Apionem. Inoltre, a detta di Sanders,mentre i farisei contavano poco più di 6000 membri ed erano probabil-mente impegnati a tempo pieno nel lavoro agricolo, i sacerdoti eranonel numero di 18000/20000 e diversamente dai farisei erano liberi didedicarsi allo studio e all’insegnamento, dal momento che erano esclusiper legge dal possesso della terra ed erano mantenuti dagli emolumen-ti. Per questa ragione è anche probabile che fossero loro, insieme aileviti, piuttosto che i farisei, a svolgere una funzione di leadership nellesinagoghe e a ricoprire il ruolo di scriba. L’iscrizione di Teodoto delresto presenta la figura di un sacerdote, figlio e nipote di arcisinagoghi,il quale è egli stesso a capo della sinagoga che ha fatto edificare «per lalettura della Legge e l’insegnamento dei comandamenti» (CIJ II 1404);analogamente Filone dice che l’istruzione nella sinagoga era affidata aun sacerdote o a un anziano (Hyp. 7,12ss) e un’iscrizione della sinagogadi Sardi menziona un «sacerdote e maestro di sapienza»109. In definiti-va, secondo Sanders, «la gente comune non seguiva le opinioni dei fari-sei» e le sue opinioni erano «probabilmente quelle che insegnavano isacerdoti»110. Questo quadro è stato ulteriormente arricchito da altri stu-diosi: D.R. Schwartz, ad esempio, ha sostenuto che normalmente, quan-
108 In Antiquitates Iudaicae 18, 19ss Flavio Giuseppe arriva a dire degli esseni: «Sono imigliori degli uomini quanto al modo di vita [...]. Sono degni di essere ammirati a con-fronto di tutti coloro che si attribuiscono il possesso di virtù».
109 E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit., 245.110 Ib., 607-608.
51
do nel NT si parla di “scribi”, salvo il caso in cui si specifica che si trattadi scribi farisei, si deve ritenere che ci si riferisca a leviti111; e D. Binderin una recente monografia sulla sinagoga nel periodo del Secondo Tem-pio112 ha avanzato l’ipotesi che quest’ultima, lungi dall’essere un’istitu-zione contrapposta al Tempio, fosse intesa essenzialmente come unasua estensione, che consentiva a coloro che erano lontani da Gerusa-lemme una qualche forma di partecipazione ai rituali del Tempio113, sic-ché è del tutto naturale che i sacerdoti e i leviti fossero i principali can-didati alla leadership nelle sinagoghe, per quanto i laici ovviamente nonfossero affatto esclusi114.
Bisogna riconoscere a questi studi il merito di avere correttamenterichiamato l’attenzione sulla perdurante importanza dell’elemento sa-cerdotale nel giudaismo di età ellenistico-romana, che la storiografiadelle passate generazioni aveva eccessivamente minimizzato. Non c’èdubbio che il sacerdozio svolse un ruolo di primo piano durante tutto ilperiodo del Secondo Tempio. Basti ricordare che a capo della nazionec’era il sommo sacerdote, che controllava il Tempio e presiedeva l’altraistituzione centrale del giudaismo, il sinedrio, nel quale una delle trecomponenti fondamentali erano appunto i “sommi sacerdoti”. Del restole vicende della prima guerra giudaica quali sono raccontate da FlavioGiuseppe testimoniano con grande chiarezza come ancora alla vigiliadella catastrofe del 70 il Tempio e il sacerdozio costituissero un punto diriferimento fondamentale del giudaismo palestinese.
La realtà è tuttavia molto più complessa di quello che emerge dallericostruzioni degli autori citati, e la loro interpretazione dei dati risultadecisamente unilaterale.
La prima obiezione che si può muovere a Sanders, in particolare, ri-guarda l’interpretazione dell’opera di Flavio Giuseppe, che costituisce ilprincipale fondamento della sua ricostruzione. Egli mette tra parentesile affermazioni dello storico ebreo sui farisei ritenendo che esse rifletta-no una tendenza filofarisaica, mentre conferisce grande valore alla sua
111 D.R. SCHWARTZ, «“Scribes and Pharisees, Hypocrites”: Who are the “Scribes” in theNew Testament?», in ID., Studies in the Jewish Background of Christianity, J.C.B. Mohr(Paul Siebeck), Tübingen 1992, 89-101.
112 D. BINDER, Into the Temple Courts. The Place of the Synagogues in the Second TemplePeriod, Scholars Press, Atlanta 1999.
113 Ib., 32.114 L’importanza della leadership sacerdotale nella sinagoga del I secolo è sostenuta
anche da L.I. Levine, che pure contesta l’idea che la sinagoga avesse un carattere di istitu-zione prevalentemente religiosa (L.I. LEVINE, La sinagoga antica, I: Lo sviluppo storico,Paideia, Brescia 2005, 147ss).
52
testimonianza sul sacerdozio. In realtà, come si è già detto, l’orientamen-to delle fonti flaviane non è affatto filofarisaico ma filosacerdotale. Soloin Vita 10-12 lo storico giudeo, parlando della sua formazione giovanile,fa brevi riferimenti alla sua esperienza del fariseismo, mentre più volte –e in punti talora anche molto significativi dal punto di vista retorico – eglirichiama in modo enfatico il suo essere sacerdote (cf Bell. 1, 3; 3, 352;Ant. 16,187; Vita 1. 80. 198)115; e gli studi di H. Lindner, di S. Rappaport116
e S. Schwartz117 dimostrano a sufficienza come la visione del mondo diFlavio Giuseppe sia di tipo sacerdotale. È lecito dunque sospettare che lasua rappresentazione del sacerdozio più che rispecchiare la realtà delsuo tempo esprima le concezioni e le aspirazioni della classe sacerdotalea cui egli appartenne. Sospetto risulta soprattutto il quadro offerto nelContra Apionem. Qui Flavio Giuseppe intende presentare la “costituzionedi Mosè” per difenderla dai suoi detrattori e dimostrarne la superioritàrispetto ad altre legislazioni (2,145ss). Così egli raffigura il giudaismo neitermini di uno stato ideale caratterizzato da armonia e concordia (2,179ss),una “teocrazia”, in cui Dio stesso è a capo di tutto e i sacerdoti, guidatidal sommo sacerdote, amministrano saggiamente le cose più importantinell’interesse comune (2,185ss). Costoro infatti attendono al culto del Diounico nel Tempio comune a tutti, custodiscono la Legge divina, che tutticonoscono, e hanno l’incarico di sorvegliare tutti gli altri e di giudicare lecontese (2,193ss). È evidente che la centralità assegnata al sacerdozio,oltre a riprodurre il dato biblico (ciò di cui si parla nel testo è in effetti la“costituzione di Mosè”), riflette gli ideali sacerdotali dell’autore ed è pie-namente funzionale all’intento apologetico di presentare il giudaismocome una realtà unitaria e ordinata secondo principi superiori. Né è im-probabile che l’autore intenda far leva sull’ammirazione nei confronti delsacerdozio orientale piuttosto diffusa nell’ambiente culturale dei lettoridell’opera118. Il fatto poi che nel Contra Apionem non vi sia il minimo
115 T. Rajak sottolinea come la predilezione di Flavio Giuseppe per il sacerdozio abbiauna sicura motivazione nella sua discendenza sacerdotale (T. RAJAK, «The Against Apionand the Continuities in Josephus’s Political Thought», in S. MASON [ed.], UnderstandingJosephus. Seven Perspectives, Sheffield Academic Press, Sheffield 1998, 238).
116 Cf S. MASON, Flavius Josephus on the Pharisees…, cit., 332.117 S. SCHWARTZ, Josephus and Judaean Politics, Brill, Leiden 1990, 25ss, 60ss, 82-109.118 Di questo avviso sono anche M. Hengel e R. Deines, «E.P. Sanders “Common Judai-
sm”, Jesus and the Pharisees», cit., 67. Significativa a tale riguardo è la descrizione cheDiodoro Siculo fa dell’ utopistica isola di Pancaia in cui le attività di governo e l’ammini-strazione della giustizia sono demandate completamente ai sacerdoti (Bibl. Hist. 5,45).Inoltre, Flavio Giuseppe sembra consapevole dell’importanza riconosciuta al sacerdozionegli ambienti degli stessi detrattori della “costituzione mosaica” (C. Ap. 2,140).
53
accenno all’esistenza di haireseis e che del Tempio e dei suoi sacrifici siparli come di realtà attuali (2,193) non fa che confermare il caratterefortemente ideale del quadro del giudaismo ivi offerto.
Un secondo punto da sottolineare è che, contrariamente a quantosembra presupporre Sanders, i sacerdoti non costituirono un gruppounitario né sotto il profilo religioso, né sotto il profilo sociale, né dalpunto di vista politico. È importante soprattutto insistere sul fatto chec’erano sacerdoti di diverso orientamento religioso, compreso quellofarisaico, il che rende problematica una contrapposizione troppo netta,quale di fatto propone Sanders, tra sacerdoti e farisei. Abbiamo infattisicura notizia di sacerdoti (e anche sommi sacerdoti) farisei o comun-que di orientamento farisaico. Giuseppe fu uno di questi (Vita 12). Ac-canto a lui si possono ricordare Giozaro, uno dei membri della delega-zione inviata contro Giuseppe in Galilea (Vita 197) e Giovanni Ircano,descritto come discepolo dei farisei (Ant. 13, 289-290). È anche moltoprobabile che Ircano II sia stato almeno per un certo tempo vicino aifarisei, visto che fu nominato sommo sacerdote da Salomè Alessandra eche fu in contrasto col fratello Aristobulo, sostenuto a sua volta dall’ari-stocrazia filosadducea (Ant. 13,408ss)119. Inoltre 4Q169, 3-4 II 8-9 pone isacerdoti nella lista di coloro che furono sviati dai capi di «Efraim»120.Più ipotetico è il caso dei discepoli dei due maestri Giuda e Mattia chematerialmente abbatterono l’aquila d’oro posta sulla porta del Tempio(Bell. 1,650; Ant. 17,151). Se infatti la porta in questione è quella delvero e proprio santuario, i discepoli dei due dottori, i quali ultimi pro-babilmente furono farisei o vicini ai farisei, dovevano essere sacerdotiperché solo ai sacerdoti era possibile salire sul tetto del santuario121. Visono inoltre due argomenti di carattere generale da far valere: (1) sacer-doti e leviti erano circa 18000/20000122, e delle tre grandi correnti delgiudaismo – la farisea, la sadducea e l’essena – sappiamo che la secon-da, diversamente dalla prima, era propria “di pochi uomini” apparte-nenti agli strati socio-economici più elevati (Ant. 18, 17; cf anche 13,298),mentre la terza non partecipava in modo completo al culto del Tempio
119 Cf E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo, I, Paideia, Brescia1985, 308, o anche E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit., 515,525-526).
120 È un dato acquisito dell’esegesi qumranica che in 4Q169 col nome “Efraim” sialluda ai farisei (cf D. FLUSSER, «Pharisäer, Sadduzäer und Essener im Pescher Nahum»,in K.E. GRÖZINGER ET ALII [edd.], Qumran. Wissenschaftliche Buchgesellshaft, Darmstadt1981, 121-166).
121 Per questa osservazione si veda J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù, cit.,376, n. 93.
122 Cf ib., 311-320; E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit., 106, 251.
54
(18,19-20) e dunque non aveva tra i suoi membri dei sacerdoti offician-ti; anche calcolando che molti sacerdoti e leviti potevano fare riferimen-to a orientamenti religiosi minori o non avere una precisa collocazionepartitica, c’è spazio sufficiente per immaginare una consistente presen-za di sacerdoti e leviti di indirizzo farisaico; (2) se con la maggioranzadegli studiosi si ritiene che Antiquitates Iudaicae 18,15 faccia riferimen-to a un predominio dell’halakah farisaica sul culto del Tempio, ciò sipotrebbe spiegare meglio ipotizzando l’esistenza di un numero signifi-cativo di sacerdoti di orientamento farisaico. Se tutto questo è vero siapre la possibilità di conciliare almeno parzialmente i dati sull’influen-za sacerdotale con quelli sull’influenza farisaica.
Anche sotto il profilo sociale e politico, dicevo, il sacerdozio era inte-ressato da una forte conflittualità interna. Tale conflittualità è docu-mentata sia per i rapporti tra aristocrazia sacerdotale e clero semplice(cf Ant. 20,180-181; t.Men. 13, 18-19; cf t.Zeb. 11,16-7; b.Pes. 57a), siaper quelli interni all’aristocrazia sacerdotale (cf 2Mac 4,7ss; Bell. 2,409;Ant. 12,237ss; 14,4ss; 20, 180.213), sia per quelli tra sacerdoti e leviti(Ant. 20, 216), sia per quelli interni alla classe levitica (ib.), sia infine perquelli interni al clero semplice (Vita 73.195).
Un terzo rilievo critico alla ricostruzione proposta da Sanders è cheessa trascura l’ampia documentazione attestante un diffuso sentimentodi disaffezione nei confronti dei sacerdoti e in particolare dell’aristocra-zia sacerdotale. Non c’è dubbio che il sommo sacerdozio fosse gravatoda seri problemi di legittimità. C’era innanzitutto un problema di tipogenealogico. Almeno dal tempo di Ezechiele (44,15) il sommo sacerdo-zio era considerato prerogativa dei “figli di Sadoq”, ma a partire dalperiodo della riforma ellenistica la carica sommosacerdotale cominciòad essere rivestita da sacerdoti non sadociti. Secondo alcuni studiosi ilmalcontento per questa situazione, che aveva già spinto gli Oniadi afondare un tempio a Leontopoli (Bell. 1,33; Ant. 13,62ss), giocò un ruoloimportante anche nella fondazione della comunità di Qumran123. E chela questione della legittimità genealogica non sarà in seguito dimentica-ta lo dimostra l’elezione a sommo sacerdote, da parte degli zeloti nel 67d.C., di Fanni (Bell. 4,155), che fu molto probabilmente un sadocita124.
Sempre in epoca asmonea vi era poi il problema del cumulo del pote-re di governo con quello pontificale. A giudizio di non pochi autori que-
123 Cf E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù, cit., II, 700; J. MAIER,Storia del giudaismo nell’antichità, Paideia, Brescia 1992, 58.
124 Cf J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù, cit., 301ss e G. JOSSA, Gesù e i movi-menti di liberazione della Palestina, Paideia, Brescia 1980, 74-75.
55
sto potrebbe essere il principale motivo della rottura tra farisei e Asmo-nei125. E quanto questo problema fosse avvertito è probabilmente testi-moniato dalla delegazione popolare, forse di ispirazione farisaica, in-viata a Pompeo nel 63 a.C., la quale di fatto chiese l’abolizione dellamonarchia (Ant. 14,41-45).
Per il periodo che più direttamente ci interessa il problema del cu-mulo delle cariche non si pone più, ma il sommo sacerdozio non guada-gna certo in prestigio. A partire dal regno di Erode il Grande quello delsommo sacerdote diventa un ufficio quasi annuale126 (di ciò si lamentaanche t.Joma 1,7) di cui i governanti dispongono a piacimento. Erode,infatti, pone fine al sacerdozio asmoneo (Bell. 1,437; Ant. 15,53-56.260-266), ma senza ripristinare quello sadocita127. Anzi, elegge anche sommisacerdoti di provenienza non palestinese (Ant. 15,22.40.320-322). Nonsorprende che poco dopo la morte di Erode una folla insorga controArchelao chiedendo tra l’altro un sommo sacerdote «più pio e più puro»(Bell. 2,7; Ant. 17, 207).
Sotto i romani la carica appare gravemente compromessa col potereoccupante e continua a perdere credibilità. Per il periodo dal 6 al 41d.C.sono direttamente i romani a nominare e deporre i sommi sacerdoti: orail mediatore tra Dio e il popolo di Israele appare una creatura dell’odiatapotenza pagana occupante. Quanto questa situazione fosse insopporta-bile lo dimostra il fatto che dopo la morte di Erode Agrippa I, nel 44, igiudei ottennero che il diritto di nominare i sommi sacerdoti rimanessealmeno a un governatore giudeo, il che fu concesso a Erode di Calcide,prima, e ad Agrippa II poi128. Ma anche così doveva apparire evidente agliocchi di tutti che dietro gli Erodi, e dunque dietro i sommi sacerdoti,c’erano i romani. D’altra parte il partito zelota nasce proprio «da unaprotesta del clero semplice contro i compromessi con i pagani dei som-
125 Su questo si veda soprattutto il recente contributo di D.R. SCHWARTZ, «On PharisaicOpposition to the Hasmonean Monarchy», in ID., Studies in the Jewish Background ofChristianity, cit., 44-56. Cf anche E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit., 511-512; J. MAIER, Sto-ria del giudaismo nell’antichità, cit., 68.
126 Erode cambia otto sommi sacerdoti; Archelao, tre; i prefetti romani, sette; AgrippaI, tre; Erode di Calcide, due; e Agrippa II, sei (si veda l’elenco in E. SCHÜRER, Storia delpopolo giudaico al tempo di Gesù, cit., II, 285ss).
127 Che Ananel, insediato come sommo sacerdote da Erode nel 37 d.C. (Ant. 15,22.40),fosse un sadocita, come ritiene J. Jeremias (J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù,cit., 302), non ci sono sufficienti elementi per sostenerlo (cf E. SCHÜRER, Storia del popologiudaico al tempo di Gesù, cit., II, 285).
128 In Antiquitates Iudaicae 20, 6-16 i sommi sacerdoti e i capi del popolo fanno unapetizione all’imperatore perché gli abiti sommosacerdotali, e quindi la nomina del som-mo sacerdote, rimangano nelle loro mani.
56
mi sacerdoti»129. Non meno indicativo è il fatto che i sicari individuinonei “sommi sacerdoti” i loro nemici accanto ai romani e agli erodiani130.
Numerosissime sono poi le testimonianze relative alla corruzione delclero. Se ne trovano in abbondanza in tutti i grandi corpora letterari comel’AT (ad esempio 2Mac 3,4ss; 4,1ss; 4,7ss), il NT (ad esempio Mc11,18;14,1.43.53; 15,1.11.31; Lc 10,30; At 23,3), Flavio Giuseppe (ad esem-pio Bell. 1,70-71.89.91.97; Ant. 12, 158-159.240-241; 14,4ss; 20,179ss,201ss, 205ss, 213ss; 216ss; Vita 73.196.309), gli apocrifi dell’AT (ad esem-pio Testamento di Levi 14,5ss; PsSal. 8; Testamento di Mosè 1-10), la lette-ratura qumranica (cf 1QpHab 9,4-5; 12,8-10; Documento di Damasco4,15-5,11; 6,15-16; 4QpNah 2,8-9), la letteratura rabbinica (cf Ker. 1,7;Sheq. 4,3-4; Sifr.Deut. 105; 357; Pesiqta Rabbati 47,4; Wayyiqra Rabbah21,9; t.Men. 13,18-9; t.Zeb. 11,16-7; bPes. 57a). Insomma questa docu-mentazione testimonia probabilmente un sentimento diffuso di disaffe-zione per il sacerdozio, di cui occorre tenere conto.
E che questo si traducesse concretamente in una diminuzione dellacapacità di influenza dei “sommi sacerdoti” è ancora il racconto di Fla-vio Giuseppe a mostrarcelo. I sommi sacerdoti Mattia e Ioazar, infatti,vengono destituiti – il primo sul finire del regno di Erode, il secondo altempo della riduzione della Giudea a provincia romana – perché nonriescono a impedire sollevazioni popolari (cf Ant. 17,164; 18,26: nel casodi Ioazar si dice espressamente che «era stato gravemente contestatodal popolo»). Similmente nel 66 i sommi sacerdoti non riescono (per laverità al pari dei capi dei farisei) a far desistere il popolo dalla rivoltacontro Roma. I sicari, che pure avevano un significativo sostegno popo-lare (Ant. 18,6.9), non si fanno scrupoli di uccidere sommi sacerdoti eloro familiari e di rapire membri della loro casa (Bell. 2,256.426). Glizeloti, dal canto loro, cercano di riformare il sommo sacerdozio intro-ducendo il sorteggio e riportandolo all’interno della discendenza sado-cita (4,155). Gli idumei, alleati degli zeloti, si accaniscono particolar-mente contro “i sommi sacerdoti”, apparentemente uccidendone molti(4,315ss). E non diversamente si comporta Simone bar Giora (5,527ss).È sintomatico anche il fatto che nei vangeli e negli Atti degli Apostoli sidica spesso che l’azione dei sommi sacerdoti contro Gesù o gli Apostolifosse in qualche modo condizionata dalla «paura del popolo» (cf Mc11,32;14,2; At 4,21; 5,26).
Accanto a una diffusa opinione critica nei confronti dei sacerdoti, e inparticolare dell’aristocrazia sacerdotale, bisogna considerare l’esistenza,
129 G. JOSSA, Gesù e i movimenti di liberazione della Palestina, cit., 74.130 Ib., 85.
57
durante il periodo del Secondo Tempio, di atteggiamenti di riserva ri-spetto al Tempio stesso da parte di certi settori della popolazione, unatteggiamento che aveva probabilmente le sue radici nell’istanza profeti-ca di un culto spirituale. Secondo alcuni pseudepigrafi, come l’Ascensio-ne di Mosè (4,6-8) ed il libro di Enoch Etiopico (89, 73-74), il SecondoTempio era impuro dal principio. Il Libro dei Sogni sembra pensare a unfuturo escatologico senza Tempio131. Inoltre era diffusa l’attesa di un tem-pio celeste che rimpiazzasse quello attuale132. Sintomatica è anche l’am-biguità verso il Tempio dello Pseudo-Filone (alcuni datano quest’opera aprima del 70, altri dopo), che mentre appare interessato al Tempio, dal-l’altro presenta una soteriologia che risulta indipendente dal sistema sa-crificale133. Un chiaro rifiuto del culto del Tempio si ha nel IV OracoloSibillino134 (circa 80 d.C.). La comunità di Qumran riteneva l’attuale Tem-pio impuro, ed è possibile che la sua sostituzione del culto sacrificale conun culto spirituale non fosse intesa in senso puramente interinale135. An-che gli esseni sembra che non prendessero parte ai sacrifici praticati nelTempio, limitandosi ad inviare offerte (Ant. 18,19-20). Giovanni il Batti-sta, che aveva un non trascurabile seguito popolare, predicava un batte-simo di penitenza che non contemplava il culto sacrificale136. L’ascetaBanno viveva nel deserto, lontano da Gerusalemme e dal suo Tempio(Vita 11). Analogamente, Gesù, anche lui non privo di appoggio popolare,benché frequentasse il Tempio e pagasse la relativa tassa (Mt 17,25-26),concedeva il perdono indipendentemente dai sacrifici e dava una nettapriorità alla dimensione spirituale su quella rituale e in particolare allamisericordia rispetto agli olocausti e ai sacrifici (Mc 12,33); il suo gestonel Tempio inoltre implicava quanto meno una critica al modo in cui
131 Cf N. CASALINI, «Il tempio nella letteratura giudaica», in Rivista Biblica 43 (1995) 189.132 Cf S.J.D. COHEN, «The Temple and the Synagogue», in W. HORBURY - W.D. DAVIES - J.
STURDY (edd.), The Cambridge History of Judaism, III: The Early Roman Period, Cambrid-ge University Press, Cambridge 1999, 309.
133 Cf M. VOGEL, «Tempel und Tempelkult in Pseudo-Philos Liber Antiquitatum Biblica-rum», in B. EGO - A. LANGE - P. PILHOFER (edd.), Gemeinde ohne Tempel. Zur Substituierungund Transformation des Jerusalemer Tempels und seines Kults im Alten Testament, antikenJudentum und frühen Christentum, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1999, 251-263.
134 Specialmente ai vv. 24-25.135 Questo almeno è quello che ritiene O. Betz (O. BETZ, «Gesù e il Rotolo del Tempio»,
in J.H. CHARLESWORTH [ed.], Gesù e la comunità di Qumran. Il fondatore del cristianesimo eil Maestro di Giustizia, gli esseni e i primi cristiani, i pasti rituali e l’eucaristia, Piemme,Casale Monferrato 1997, 123).
136 E. LUPIERI, «Halakah qumranica e halakah battistica di Giovanni: due mondi a con-fronto», in R. PENNA (ed.), Qumran e le origini cristiane. Atti del VI Convegno di Studi Neo-testamentari, Ricerche Storico Bibliche 2 (1997) 84.
58
esso era gestito, e non mancano studiosi propensi a credere che quel ge-sto e il logion sul Tempio veicolassero «una critica al culto e quindi alleliturgie sacrificali come via da seguire per ottenere il perdono divino»137.Il gruppo di Stefano procede lungo questa strada mostrandosi anch’essocritico nei confronti del culto del Tempio (At 6,13ss)138, un atteggiamentoche poi sarà portato alle estreme conseguenze da Paolo e da quel tipo dicristianesimo che a lui si collega, e che conduce a un chiaro superamentodel culto sacrificale (cf Rm 3,25; Eb 9,11ss). Gli stessi “ebrei” della comu-nità cristiana primitiva, che certamente continuavano a frequentare ilTempio per la preghiera e l’insegnamento (cf At 2,46; 3,1-26), non è chia-ro se e in quale misura partecipassero ai sacrifici139. Di certo il giudeocri-stianesimo di derivazione giacobea del documento del II secolo incorpo-rato nelle Recognitiones pseudoclementine (Rec. 1,27-71) ritiene il cultosacrificale contrario alla volontà di Dio e causa delle sventure del popoloebraico; e lo stesso può dirsi per il Vangelo degli Ebioniti140.
Qualche elemento di ambivalenza nei confronti del Tempio si puòscorgere anche in un gruppo dal largo sostegno popolare come i farisei.Essi infatti – a prescindere dalla questione se intendessero imitare i sa-cerdoti nel Tempio o meno –, pur non mettendo in discussione il cultosacrificale, e anzi sostenendo il Tempio attraverso una rigorosa osser-vanza delle decime141, col loro programma di santificazione della Palesti-na incentrato sull’osservanza della Legge più che sul culto del Tempio difatto proponevano un’estensione dell’area del sacro e quindi, indiretta-mente, un certo decentramento della vita religiosa142. Del resto, se il giu-
137 Così R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologianeotestamentaria, I, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, 72.
138 Cf A. WEISER, «Critica della Legge e del Tempio da parte degli “ellenisti”», in K.KERTELGE (ed.), Saggi esegetici sulla Legge nel Nuovo Testamento, San Paolo, Cinisello Bal-samo 1990, 139-160.
139 Cf C. GIANOTTO, «Giacomo e il giudeocristianesimo antico», in G. FILORAMO - C. GIANOT-TO (edd.), Verus Israel. Nuove prospettive sul giudeocristianesimo, Paideia, Brescia 2001, 117.
140 Ib., 117-120.141 Cf E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit., 582.587.142 Tradizionalmente si è visto nei farisei un gruppo avente il programma di estendere
alla vita quotidiana le regole di purità valevoli per i sacerdoti nel Tempio. Si tratta di unaposizione che ancora oggi è probabilmente maggioritaria (cf G. ALON, Jews, Judaism andthe Classical World, cit., 219; M. HENGEL, Il Paolo precristiano, cit., 91ss; J. NEUSNER, «Mr.Sanders’ Pharisees and Mine», in Scottish Journal of Theology 44 (1991) 84ss; D.R. DE LA-CEY, «In Search of a Pharisee», in Tyndale Bulletin 43 (1992) 353-372; S.J.D. COHEN, «TheTemple and the Synagogue», cit., 309). Anche chi, come E.P. Sanders, si oppone a questatesi non può fare a meno di riconoscere l’interesse dei farisei per l’osservanza delle leggi dipurità nella vita ordinaria, definendo tale attitudine come «un piccolo gesto verso “il viverecome un sacerdote”» (E.P. SANDERS, Jewish Law from Jesus to the Mishnah…, cit., 192. Con
59
daismo riuscì a superare la crisi del 70, trovando nella Legge una pienacompensazione alla perdita del Tempio, ciò è plausibile che sia avvenutosulla base di premesse poste anche da un movimento come quello farisa-ico, oltre che da gruppi settari, nel periodo del Secondo Tempio143.
È anche stato osservato che negli strati più antichi della letteraturarabbinica non si avverte alcun particolare turbamento per la perdita delsistema sacrificale144. Il suo superamento sembra verificarsi senza gravitraumi, segno che nella religione del pre-70 la centralità del culto delTempio in certi settori era già oggetto di discussione.
Particolarmente discutibili sono poi le ricostruzioni di E.P. Sanderse D.R. Schwartz per quanto riguarda più direttamente il rapporto trasacerdoti e leviti, da un lato, e scribi dall’altro.
Diverse testimonianze ci dicono che non tutti i sacerdoti avevanoun’istruzione elevata o esercitavano la professione di scriba (cf Bell.4,155ss; Abot de-Rabbi Natan A 28). L’idea, poi, secondo cui i sacerdoti ei leviti in quanto interdetti dalla legge biblica dal lavorare la terra pote-vano dedicarsi allo studio e alla professione scribale, mentre i farisei,occupati per sei giorni alla settimana nelle campagne, non avevano lastessa possibilità, è una rappresentazione caricaturale che non ha ri-scontro nelle fonti145. Già nella stessa Bibbia, dove pure si enuncia laregola che i sacerdoti non potevano possedere terre (Num 18,20-21), sipresuppone da parte di sacerdoti e leviti il possesso di terre (1Re 2,26;Am 7,17; Ne 13,10), e si hanno chiare testimonianze che in età ellenisti-co-romana quella regola non era osservata (cf Diod., Bibliotheca Histo-rica 40, 3,7; Atti 4, 36-7; Vita 422,425). Non possiamo dunque escludere,in base all’ideale biblico, che i sacerdoti coltivassero la terra ed esserecerti che fossero tutti dediti al lavoro intellettuale. Per quanto riguarda
Sanders concorda fondamentalmente C. TUCKETT, «Les pharisiens avant 70 et le NouveauTestament», in D. MARGUERAT [ed.], Le Déchirement. Juifs et Chrétiens au premier siècle,Labor et Fides, Genève 1996, 81ss). Altri autori ritengono invece che l’attenzione dei fariseie di altri gruppi per la purità rituale al di fuori del Tempio prescindesse completamente dalmodello sacerdotale e avesse a che fare piuttosto con la preghiera e lo studio della Torah,considerati quali mezzi atti a consentire un personale contatto con Dio in un contesto incui si avvertiva sempre più l’insufficienza del culto templare come risposta alle aspirazionireligiose individuali (cf E. REGEV, «Pure Individualism…», cit., 176-202; J.C. POIRER, « WhyDid the Pharisees Wash their Hands?», in Journal of Jewish Studies 47 [1996] 217-223).
143 Cf A. VIVIAN, «I movimenti che si oppongono al Tempio: il problema del sacerdoziodi Melchisedeq», in Henoch 14 (1992) 97-112.
144 Su questo si veda in particolare S.J.D. COHEN, «The Temple and the Synagogue»,cit., 313ss.
145 Cf M. HENGEL - R. DEINES, «E.P. Sanders “Common Judaism”, Jesus and the Pharise-es», cit., 60ss.
60
poi i farisei, non risulta affatto che fossero legati al lavoro agricolo. Anzi,Flavio Giuseppe in Antiquitates Iudaicae 15,5 li collega chiaramente agliambienti cittadini (cf anche Ant. 20,201).
Di certo i vangeli non presentano mai i sacerdoti o i leviti come avver-sari di Gesù nel contesto di dispute legali, e in tali contesti gli scribi sonoinvece spesso associati ai farisei (cf Mc 7,1ss) o sono esplicitamente «scribidei farisei» (Mc 2,16). E in tutto il NT, quando si rivela l’orientamentoreligioso degli scribi, risulta che si tratta di scribi farisei (oltre a Mc 2,16e paralleli, cf At 5,34; 23,9). È vero poi che l’espressione “scribi dei fari-sei” implica che c’erano anche scribi di altri orientamenti. Tuttavia non èsostenibile che, quando gli scribi sono giustapposti ai farisei o quandonon se ne specifica l’orientamento religioso, si tratti di scribi non farisei.Talora farisei e scribi agiscono congiuntamente nel contesto di disputelegali dimostrando di condividere le medesime posizioni halakiche (adesempio Mc 7,1ss) o lo stesso tipo di religiosità (Q 11,39ss). In altri casi èchiaro che le posizioni dottrinali degli scribi corrispondono a quelle fari-saiche (cf Mc 12,28). La stessa tendenza della tradizione a perdere la di-stinzione tra scribi e farisei si spiega meglio se si ammette che già inorigine i due gruppi erano in stretta relazione, come si evince special-mente dal fatto che due documenti scritti probabilmente prima del 70 daautori forse giudeo-palestinesi, come Marco e Q, hanno un medesimologion gesuano in cui figurano in un caso gli scribi (Mc 12,38-40) e nell’al-tro i farisei (Q 11,43). Si è inoltre già visto come dal confronto tra Marco(14,1.53) e Flavio Giuseppe (Bell. 2,411; Vita 21) risulti una corrisponden-za tra “scribi” e “notabili dei farisei”. Un’ulteriore conferma dell’identifi-cazione degli scribi con i capi dei farisei viene dalla considerazione deiseguenti dati: dal NT il sinedrio risulta diviso dal punto di vista religiosoin farisei e sadducei (At 23,6), mentre sul piano istituzionale in sommisacerdoti, anziani e scribi (Mc 14,53); ora dagli Atti e da Flavio Giusepperisulta che i sadducei sono il partito dell’aristocrazia sacerdotale e in ge-nere delle classi elevate (cf At 5,17; Ant. 13,298), tra le quali ultime cisono senz’altro gli anziani. Ne consegue dunque che la parte farisaica delsinedrio dovrebbe approssimativamente corrispondere agli scribi.
Bisogna poi osservare che secondo la testimonianza concorde di Giu-seppe e del NT i farisei hanno la fama di possedere il requisito fonda-mentale degli scribi, ovvero la precisa conoscenza/interpretazione dellaLegge (cf At 22,3; 26,5; Bell. 1,110; 2,161; Ant. 17,41; Vita 191). Ed ècerto un dato degno di nota che anche prescindendo dalla letteraturarabbinica conosciamo diversi nomi di farisei o di personaggi di forma-zione farisaica altamente istruiti che presumibilmente non furono sa-cerdoti: Paolo (Fil 3,6; Gal 1, 13-14; At 22,3; 26,5), Gamaliele (At 5,34;
61
22,3), Simone, figlio di Gamaliele (Vita 190), Nicodemo (Gv 3,1.10),Pollione (Ant. 15,3), Samaia (Ant. 15,3.370), Gionata e Anania (Vita 196-197; cf § 274), Giuda il Galileo (Bell. 2,118; cf Ant. 18,4.23), Giuda eMattia (Bell. 1,650; Ant. 17,151)146.
Né l’argomento di Sanders basato sul numero dei farisei appare si-gnificativo. Innanzitutto non è chiaro se il numero di 6000 riportato daFlavio Giuseppe in Antiquitates Iudaicae 17,42 indichi la totalità dei fa-risei al tempo di Erode o solo il numero dei farisei che avevano rifiutatoil giuramento di fedeltà richiesto da Erode, o ancora se il numero inquestione sia puramente simbolico147. In ogni caso, come hanno oppor-tunamente osservato M. Hengel e R. Deines, quel numero non è affattopoco significativo se rapportato alla popolazione palestinese maschiledi età adulta dell’epoca e se si considera la possibilità che quel numeroindichi i membri di un gruppo che godeva del consenso di una quota dipopolazione molto più ampia.
Più complesso è il problema del rapporto tra farisei e sinagoga. Nonfurono certo i farisei ad inventare la sinagoga, che nasce molto probabil-mente nella diaspora148. Né si può credere che essa fosse un’istituzionepropriamente farisaica o che i farisei ne avessero il pieno controllo. Anzi,è anche credibile che alcuni gruppi settari, come molti ritengono certoper quanto riguarda Qumran, avessero le proprie sinagoghe149. Tuttaviac’è ancora qualche ragione per sostenere con T. Herford che in generale la
146 Riguardo a questi ultimi tre personaggi non dicono esplicitamente che si tratti difarisei, tuttavia Giuda e Mattia sono descritti al modo tipico dei farisei e tali sono in genereconsiderati dagli studiosi, mentre Giuda il Galileo è un maestro che insieme a un fariseofonda un gruppo religioso che a detta di Flavio Giuseppe professa idee in tutto uguali a quelledei farisei, salvo che per «l’invincibile amore per la libertà» che lo caratterizza (Ant. 18,23).
147 B. Schaller recentemente ha sostenuto che i numeri 6000 e 4000 che Flavio Giuseppeimpiega in rapporto rispettivamente a farisei ed esseni sono cifre stereotipe utilizzate soprat-tutto nella storiografia ellenistico-romana, alla quale Flavio Giuseppe si ispirerebbe; sicchéquei numeri sarebbero mere finzioni praticamente prive di valore storico (B. SCHALLER, «4000Essener - 6000 Pharisäer. Zum Hintergrund und Wert antiker Zahlenangaben», in B. KOLL-MANN - W. REINBOLD - A. STEUDEL [edd.], Antikes Judentum und frühes Christentum. Festschriftfür H. Stegemann zum 65. Geburtstag, BZNW 97, Berlin - New York 1999, 172-182).
148 Cf L. GRABBE, «Synagogue in pre-70 Palestine: A Reassessment», in Journal of Theo-logical Studies 39 (1988) 402ss; si vedano però, in proposito, le riserve di D. Binder, chepropende per uno sviluppo parallelo della sinagoga in Palestina e nella diaspora (D. BIN-DER, Into the Temple Courts…, cit., 204ss).
149 Cf D. BINDER, Into the Temple Courts…, cit., 451ss; per E.P. Sanders è possibile cheanche i farisei abbiano avuto delle proprie sinagoghe (E.P. SANDERS, Il giudaismo…, cit.,536); per il periodo rabbinico, l’idea secondo cui diversi gruppi (compresi i rabbi) avreb-bero avuto delle proprie sinagoghe è fortemente sostenuta da S.S. MILLER, «The Rabbisand the non-existent monolithic Synagogue», in S. FINE (ed.), Jews, Christians and Polythei-sts in the Ancient Synagogue, Routledge, London - New York 1999, 57-70.
62
sinagoga era il luogo dove i farisei si sentivano come “a casa”, e per rite-nere che essi in un certo senso erano i candidati naturali alla sua leader-ship150. Di fatto molte delle caratteristiche della sinagoga collimano con lecaratteristiche del movimento farisaico151. In primo luogo il carattere pre-valentemente laico, che non significa però chiusura all’elemento sacerdo-tale. Nella sinagoga, infatti, chiunque avesse una qualche istruzione po-teva leggere le Scritture e spiegarle (cf Mc 1,21: Gesù insegna nelle sina-goghe); e se i sacerdoti vi svolgevano occasionalmente un ruolo di presti-gio, come il passo di Filone, l’iscrizione di Teodoto e quella di Sardi sopracitati dimostrano, questo è probabile che avvenisse in considerazione delloro grado di istruzione e non per il fatto in sé di essere sacerdoti: lostesso passo di Filone fa capire che la presenza di un sacerdote non eraindispensabile («qualche sacerdote che sia presente o uno degli anzianilegge loro le sante leggi e le spiega...»). In secondo luogo farisei e sinago-ga condividevano lo stesso atteggiamento ambivalente verso il Tempio e isuoi funzionari. Per entrambi è attestata la presenza di sacerdoti; e senella sinagoga si raccoglievano le offerte da inviare al Tempio (cf Ant.16,163-173) e vari elementi decorativi e architettonici richiamavano ilTempio152, i farisei assicuravano il loro sostegno al Tempio e al sacerdozioattraverso il puntuale pagamento delle decime (anche al di là del coman-damento biblico: cf Q 11,42) e in qualche misura è possibile che si ispi-rassero a un modello di vita sacerdotale senza per altro avere la pretesa disostituirsi ai sacerdoti153. Al contempo però il fariseismo e il culto sinago-gale, incentrati come erano sullo studio della Legge – attività che comin-ciava ad essere avvertita come un vero e proprio atto di culto che consen-tiva un’esperienza di Dio anche fuori del Tempio – promuovevano un’esten-sione dell’area del sacro che in qualche misura andava a detrimento dellacentralità del Tempio; sicché è difficile credere che i sacerdoti fosserointeressati a promuovere la sinagoga. Del resto il fatto che in Palestina lesinagoghe compaiano relativamente tardi sembra esserne una prova154.Oltre al fatto che sia la sinagoga che i farisei privilegiavano una religiosi-
150 T. HERFORD, I farisei, Laterza, Bari 1925, 74, 83.151 Ib., 73-88.152 Cf D. BINDER, Into the Temple Courts…, cit., 168-9,200, 203-204.153 Sull’idea che i farisei si ispirassero in qualche misura al modello sacerdotale v.
supra, n. 142.154 Su questo punto e sul carattere competitivo del rapporto tra sinagoga e Tempio si
veda da ultimo P.V. MCCRACKEN FLESHER, «Palestinian Synagogues before 70 C.E. A Reviewof the Evidence», in D. URMAN - P.V. MCCRACKEN FLESHER (edd.), Ancient Synagogues. Histo-rical Analysis and Archaeological Discovery, Brill, Leiden 1998, 27-39; cf anche M. HENGEL
- R. DEINES, «E.P. Sanders “Common Judaism”, Jesus and the Pharisees», cit., 32.
63
tà imperniata sulla Legge, alcuni studiosi suggeriscono un legame piùdiretto fra l’insegnamento sinagogale della Legge e la concezione pro-priamente farisaica di essa, che poneva accanto alla Legge scritta unatradizione orale o comunque una serie di norme tradizionali non diret-tamente riconducibili alla legge mosaica155. Tale legame viene asseritosulla base di due testi: 1) Antiquitates Iudaicae 16,43-46, dove Nicolao diDamasco nel suo discorso ad Agrippa dice: «Ogni settimo giorno noi lodedichiamo allo studio delle nostre usanze (�qh) e della nostra legge (nÒ-moj)»; 2) CIJ II 1404 (iscrizione di Teodoto), secondo cui la sinagoga èstata eretta per la lettura della Legge (¢v£gnwsin nÒmou) e l’insegnamentodei comandamenti (didac¾n �ntolîn)156. Ed è anche significativo che inContra Apionem 2,175, parlando della pratica della lettura settimanaledella Legge, evidentemente nella sinagoga, si dica che «[Mosè] ordinòche ci si riunisse per ascoltare la legge e la si imparasse con precisione(¢kribîj)», con un richiamo a quell’acribia che sembra essere stata asso-ciata soprattutto all’esegesi farisaica.
Un quarto punto di contatto è nell’importanza riconosciuta alla pre-ghiera. La sinagoga, a differenza del Tempio, si caratterizzava infattianche per la preghiera157. E questo è un elemento che sembra tipicopure della pietà farisaica (Lc 5,33158; 18,10ss; Mt 23,5; Ber. 4,3159).
Infine, dagli scavi archeologici risulta che le sinagoghe palestinesidel periodo del Secondo Tempio normalmente disponessero di vasche dipurificazione (miqwaot)160, strutture che senza dubbio riflettono un tipo
155 Cf Antiquitates Iudaicae 13,297ss, 408; Mc 7,1ss.156 M. HENGEL - R. DEINES, «E.P. Sanders “Common Judaism”, Jesus and the Pharise-
es», cit., 32-33.157 Non che nel Tempio non si pregasse (cf Lc 1,10; At 3,1), ma la preghiera comunita-
ria non era parte integrante del culto pubblico nel Tempio (cf S.J.D. COHEN, «Temple andSynagogue», cit., 302ss; I. KNOHL, «Between Voice and Silence: the Relationship betweenPrayer and Temple Cult», in Journal of Biblical Literature 115 [1996] 17-30). Circa la pre-ghiera nella sinagoga cf D. BINDER, Into the Temple Courts…, cit., 404ss. Più scettico L.I.LEVINE, La sinagoga antica…, cit., I, 173ss.
158 In realtà proprio su questo punto il passo lucano diverge dai paralleli, che noncontengono un riferimento alla preghiera. Tuttavia, se, come abbiamo suggerito, Lucaebbe qualche esperienza del giudaismo palestinese prima del 70, l’aggiunta redazionalepotrebbe essere non meno significativa.
159 Il passo ci informa che fu il rabbi di famiglia farisaica Gamaliele II a fissare lapreghiera delle Diciotto Benedizioni nella forma a noi nota, e a decretarne la recita obbli-gatoria giornaliera.
160 Cf R. RONNY, «The Synagogue and the Miqweh in Eretz-Israel in the Second-Tem-ple, Mishnaic, and Talmudic Periods», in D. URMAN - P.V. MCCRACKEN FLESHER (edd.), An-cient Synagogues…, cit., 290ss.
64
di pietà, come quella farisaica, particolarmente attenta all’osservanzadella legge di purità anche indipendentemente dal culto del Tempio.
Accanto a queste considerazioni di ordine generale disponiamo dellatestimonianza del NT, spesso trascurata, che parla chiaramente a favoredi un’influenza dei farisei sulla sinagoga (ad esempio in Q 11,43; Mt23,2-3161; Mc 3,1-6 e At 9,1-2), mentre non lascia trasparire nessun colle-gamento diretto dei sacerdoti con questa istituzione162.
Nella stessa direzione sembra puntare un passo come AntiquitatesIudaicae 18,15: «Tutto il culto divino, per quanto attiene sia alle preghie-re (eÙcîn) sia ai sacrifici (�erîn) si svolge secondo la loro [dei farisei]interpretazione. Tanta stima viene loro testimoniata dalle città per illoro praticare sempre il meglio riguardo al modo di vita e alla dottrina».Non è improbabile infatti che il passo alluda a un’influenza farisaicanon solo sul Tempio ma anche sulla sinagoga, come lasciano intenderesia il riferimento alle preghiere – più tipiche del culto sinagogale chedella liturgia del Tempio – sia il riferimento “alle città” (al plurale)163.
Infine i dati archeologici. Com’è noto quello dell’identificazione dellesinagoghe costituisce un problema estremamente complesso, oggetto diun vivo dibattito tra gli studiosi. Per quanto riguarda l’area palestinesenel periodo del Secondo Tempio, si registra però un ampio consensosull’identificazione come sinagoghe di tre edifici rinvenuti a Gamala, a
161 Qui ricorre un riferimento alla “cattedra di Mosè”, che probabilmente è un elemen-to architettonico usato come seggio per il capo della sinagoga. Esempi di tale strutturasono stati rinvenuti in alcune sinagoghe sia palestinesi (es. a Corazin e a Hammath, vicinoTiberiade, a partire dal II secolo) che della diaspora (es. a Delo del II secolo a.C.), databilisia prima che dopo il 70 (cf K.G.C. NEWPORT, «A Note on the ‘Seat of Moses’ [Matthew23:2]», in Andrew University Seminary Studies 28 [1990] 53-58). A dire il vero, S.J.D. Cohene altri autori ritengono che l’espressione “cattedra di Mosè” non indichi un elemento ar-chitettonico della sinagoga, ma sia un’espressione metaforica con cui si allude all’autoritànell’insegnamento della legge mosaica (S.J.D. COHEN, «Were Pharisees and Rabbis theLeaders of Communal Prayer and Torah Study in Antiquity?», in H.C. KEE -L.H. COHICK [edd.], Evolution of the Synagogue. Problems and Progress, Trinity Press, Har-risburg 1999, 93-96; D.E. GARLAND, The Intention of Matthew 23, Brill, Leiden 1979, 42).Ma anche se fosse così, è evidente che è la sinagoga, dove si dà lettura della Legge e la siinsegna, il contesto più naturale per quel magistero a cui fa riferimento Mt 23,2-3.
162 La sola eccezione è rappresentata da At 9,1-2, dove si parla di una lettera per lesinagoghe di Damasco richiesta dal fariseo Saulo al sommo sacerdote per essere autoriz-zato a procedere contro i cristiani di quella città. Come si è detto, tuttavia, ci sono ragionivalide per dubitare dell’attendibilità di questo particolare.
163 M. HENGEL - R. DEINES, «E.P. Sanders “Common Judaism”, Jesus and the Pharise-es», cit., 33-34, n. 86. Su diverse posizioni sono E. Main, che ritiene che il passo si riferi-sca solo alla sinagoga (E. MAIN, «Les sadducéens vus par Flavius Josèphe», in Revue Bibli-que 97, 2 [1990] 187ss), e S.J.D. Cohen, che ritiene possibile che il riferimento sia solo alTempio (S.J.D. COHEN, «Were Pharisees and Rabbis …», cit., 97ss).
65
Masada e ad Herodium. Le sinagoghe di Masada ed Herodium datanoal periodo della prima guerra giudaica e sono state costruite dai sica-ri164. La sinagoga di Gamala è più antica. U.Z. Ma’oz propone ad esem-pio una data tra il 23 a.C. e il 41 d.C.165. Quello che è certo è che lasinagoga fu distrutta dai romani durante la prima guerra giudaica. Ilfatto che le sinagoghe di Masada e dell’Herodium abbiano un’originericonducibile ai sicari e che l’altro edificio sinagogale si trovi a Gamala,città di origine del sophistes Giuda il Galileo, cofondatore insieme alfariseo Sadoq della setta dei sicari (Ant. 18,4.9), è un dato certamentesignificativo ai fini del nostro discorso, se si considera che i sicari costi-tuirono in un certo senso l’ala radicale del movimento farisaico (cf Ant.18,23) e che furono in violento contrasto con l’aristocrazia sacerdotale(cf Bell. 2, 256. 426-428. 441). Sarebbe un errore tuttavia ritenere che ladiffusione delle sinagoghe in Palestina fosse dovuta propriamente al grup-po fondato da Giuda il Galileo (piuttosto che a quello farisaico), comeinvece sembra suggerire D. Urman166. L’iscrizione di Teodoto, che la mag-gior parte degli studiosi oggi riconosce far riferimento a una sinagogadel periodo del Secondo Tempio167, non presenta nessuno specifico nes-so con i sicari, mentre, come si è visto, c’è qualche ragione, benché te-nue, per ipotizzare una matrice farisaica, tanto più se, come molti riten-gono, questa sinagoga è da identificare con la sinagoga “dei liberti”168, lasinagoga cioè menzionata in Atti 6,9 dalla quale partì la prima persecu-zione dei cristiani, in cui un ruolo di primo piano fu svolto dal fariseoSaulo. Accanto a questo occorre segnalare la recentissima scoperta, adopera di E. Netzer, di una sinagoga nel “palazzo di inverno” degli Asmo-
164 Cf D. BINDER, Into the Temple Courts…, cit., 174,184; M.J.S. CHIAT, Handbook of theSynagogue Architecture, Scholars Press, Chico 1982, 204ss, 248ss.
165 Cf L. GRABBE, «Synagogue…», cit., 406.166 D. URMAN, «Public Structures and Jewish Communities in the Golan Heights», in D.
URMAN - P.V. MCCRACKEN FLESHER (edd.), Ancient Synagogues…, cit., 513-518.167 Cf J.S. KLOPPENBORG, «Dating Theodotos (CIJ II 1404)», in Journal of Jewish Studies
51 (2000) 243-277. M.J.S. CHIAT, Handbook of the Synagogue Architecture, cit, 202; R. RIE-SNER, «Synagogues in Jerusalem», in R.J. BAUCKHAM (ed.), The Book of Acts in Its PalestinianSetting, cit., 194ss. Più cauta su una datazione al periodo anteriore al 70 d.C. è L. BOFFO,Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, Paideia, Brescia 1994, 275-276.
168 Questa tesi, originariamente proposta da R. Weill, C. Clermont-Ganneau e L.H.Vincent, è stata in seguito ripresa da G. Dalman, E.R. Goodenough e J. Jeremias (cf J.JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù, cit., 112-113), ed è oggi sostenuta fermamente,tra gli altri, da R. Riesner (R. RIESNER, «Synagogues in Jerusalem», cit., 205-206) e M.HENGEL, L’“ellenizzazione” della Giudea, Paideia, Brescia 1993, 42-43. Comunque che ilpadre di Teodoto fosse un liberto non può essere desunto con sicurezza dal nome (Vette-no), né è chiaro se in Atti 6,9 si alluda a una o più sinagoghe (cf L. BOFFO, Iscrizioni grechee latine per lo studio della Bibbia, cit, 280-281).
66
169 E. NETZER, «A Synagogue from Hasmonean Period Recently Exposed in the WesternPlain of Jericho», in Israel Exploration Journal 49 (1999/2) 203-221. Cf anche L.I. LEVINE, Lasinagoga antica…, cit., I, 88. Scettico sull’identificazione dell’edificio scoperto da Netzer conuna sinagoga è invece U.Z. Ma’oz (cf G. STEMBERGER, «Was there a “Mainstream Judaism” inthe Late second Temple Period?», in Review of Rabbinic Judaism 4,2 [2001] n. 27).
nei a Gerico, datata al tempo di Salomè Alessandra o dei suoi figli169, checi porta a un’epoca troppo antica rispetto al sorgere della “quarta filoso-fia” e troppo bassa rispetto all’antichità del sacerdozio, ma che invececorrisponde al momento di massimo potere dei farisei.
5. Conclusioni
Negli ultimi decenni di ricerca si è passati da una rappresentazionedel giudaismo come realtà fondamentalmente monolitica, rispetto allaquale Gesù e il suo movimento apparivano come una sorta di corpoestraneo, a una ricostruzione del quadro religioso giudaico come costel-lazione variegata di “giudaismi” pienamente comprensiva del nuovogruppo fondato dal maestro di Nazareth. Questa svolta è avvenuta difatto attraverso una rilettura del ruolo del fariseismo, che da forma nor-mativa del giudaismo è passato ad essere inteso quale corrente religiosadi scarsa influenza. A tale rilettura va riconosciuto un indubbio valoreeuristico e in particolare il merito di aver messo in luce quanto di ecces-sivo e semplicistico c’era nelle ricostruzioni del passato. Essa, tuttavia,propone un’interpretazione del ruolo del fariseismo che non convince eche risulta riduttiva. Come ho cercato di dimostrare, correttamente in-tese le fonti restituiscono un’immagine dei farisei molto diversa da quelladelineata da studiosi come M. Smith e J. Neusner, un’immagine dellaquale la ricerca sul rapporto tra cristianesimo nascente e giudaismobisogna che tenga conto.