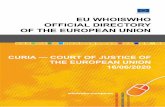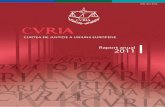Brevi introduzioni ai Libri Profetici, a Isaia, Ezechiele, Daniele e ai XII Profeti Minori
La curia romana nel secolo breve. Brevi appunti per una riflessione, in «Concilium», L (2014), 1,...
Transcript of La curia romana nel secolo breve. Brevi appunti per una riflessione, in «Concilium», L (2014), 1,...
Fondatori † Antoine van den Boogaard, Nijmegen Olanda Paul Brand, Ankeveen Olanda † Yves Congar, Paris Francia Hans Küng, Tübingen Germania Johann-Baptist Metz, Münster Germania † Karl Rahner, Innsbruck Austria † Edward Schillebeeckx, Nijmegen Olanda
PRESIDENZA
Presidente Felix WilfredVice-presidenti Thierry-Marie Courau – Diego Irarrázaval – Susan Ross
COMITATO INTERNAZIONALE DI DIREZIONE
Regina Ammicht-Quinn, Frankfurt a. M. GermaniaMile BabiĆ, Sarajevo Bosnia-ErzegovinaMaria Clara Bingemer, Rio de Janeiro/RJ BrasileErik Borgman, Nijmegen OlandaLisa Sowle Cahill, Boston/MA USAThierry-Marie Courau, Paris FranciaHille Haker, Chicago/IL USADiego Irarrázaval, Santiago CileSolange Lefebvre, Montreal/QC CanadaÉloi Messi Metogo, Yaoundé CamerunSarojini Nadar, Durban SudafricaDaniel Franklin Pilario, Quezon City FilippineSusan A. Ross, Chicago/IL USASilvia Scatena, Reggio Emilia ItaliaJon Sobrino, San Salvador El SalvadorLuiz Carlos Susin, Porto Alegre/RS BrasileAndrés Torres Queiruga, Santiago de Compostela SpagnaJoão J. Vila-Chã, Roma/Barcelos PortogalloMarie-Theres Wacker, Münster GermaniaFelix Wilfred, Madras India
SEGRETARIATO GENERALE
Asian Centre for Cross-Cultural Studies, Madras India
www.concilium.in www.queriniana.it
C O N C I L I U Mrivista internazionale di teologia
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEOLOGYINTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FüR THEOLOGIEREVUE INTERNATIONALE DE THéOLOGIEREVISTA INTERNACIONAL DE TEOLOGÍAREVISTA INTERNACIONAL DE TEOLOGIAMEĐUNARODNI TEOLOŠKI C ASOPIS
Anno L, fascicolo 1 (2014)
VIVERE NELLA DIVERSITÀ
Solange Lefebvre – Denise Couture K. Gandhar Chakravarty (edd.)
EDITRICE QUERINIANAvia Ferri, 75 - 25123 BRESCIA
ENRICO GALAVOTTIBologna (Italia)
La curia romana nel secolo breveBrevi appunti per una riflessione
Mi pare che una delle difficoltà maggiori che oggi si in-contrano nella riflessione sulla curia romana sia rappresentata dal fatto che la si conosce poco. Nel senso che si tratta davvero di un oggetto complesso e che, come tale, non ha ancora forse goduto, quantomeno a livello di ricerca storica, di quell’atten-zione che pure le si dovrebbe. Intendo dire che mentre ci è molto chiaro quando e in che modo la curia si è originata e il fondamentale passaggio organizzativo e strutturale che si ebbe nel XVI secolo con papa Sisto V, ci è decisamente meno facile mettere a fuoco il suo profilo nell’ultimo secolo in generale e negli ultimi decenni in particolare1: quelli in cui, cioè, sono
1 Rappresenta una felice eccezione il ponderoso lavoro di F. Jankowiak, La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Du gouvernement de l’Église et de ses États à celui de la seule Église universelle (1846-1914), École française de Rome, Roma 2007.
Enrico Galavotti
Insegna storia del cristianesimo presso l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ed è membro della Fondazione per le scienze religiose «Giovanni XXIII» dal 1998.
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Processo a Papa Giovanni. La causa di canonizzazione di A.G. Roncalli (1965-2000), il Mulino, Bologna 2005; Il professorino. Giuseppe Dossetti tra crisi del fascismo e costruzione della democrazia, 1940-1948, il Mulino, Bologna 2013.
Fondazione per le Scienze religiose «Giovanni XXIII», Istituto di Scienze religiose, via S. Vitale 114, I-40125 Bologna. E-mail: [email protected]
CONCILIUM 50 (2014/1) 141-147
142 enrico galavotti
emersi in modo più evidente quei nodi che hanno condizionato e condizionano pesantemente tanto l’esercizio del ministero petrino quanto l’attuazione della collegialità episcopale; nodi che rendono particolarmente attuale e urgente una riflessio-ne ponderata sulla curia, similmente a quella che è stata ben svolta nel fascicolo 5/2013 di Concilium. Si è pensato e si pensa ancora oggi che questa carenza conoscitiva sia colmabile at-traverso uno studio del papato: quasi che la curia sia appunto solo lo scenario che sta sullo sfondo degli atti e delle decisioni posti in essere dal vescovo di Roma. Ma sono proprio gli eventi intervenuti nell’eccezionale 2013 che ci dimostrano come que-sta prospettiva sia quella meno adeguata a cogliere la realtà. Sappiamo ancora poco delle ragioni che hanno mosso Benedet-to XVI alla decisione della rinuncia, ma già oggi è evidente il dato di come il “fattore curia” ‒ non fosse altro che come strut-tura che non è stata capace o non ha voluto supportare il papa in una determinata congiuntura ‒ abbia giocato un peso non indifferente. E che questo “fattore curia” non sia solo un’ipotesi lo dimostra anche il fatto che, ripetutamente, tanto il nuovo papa quanto alcuni cardinali che hanno preso parte al conclave del 2013 hanno dichiarato apertamente che uno dei temi dibat-tuti nelle congregazioni generali preconclavarie è stato quello di superare alcuni limiti dell’attuale organizzazione curiale2.
Un dato che infatti salta immediatamente all’occhio dello storico è l’enorme perdita di prestigio che la curia ha subito nel corso del pontificato di Benedetto XVI, al punto che la variabile “candidato di curia” – che pure era stata considerata con gran-de attenzione nei conclavi precedenti – non è stata minima-mente ventilata nei pourparler precedenti all’elezione pontificia del marzo 2013. Assumendo una prospettiva storica, tuttavia, la domanda più corretta da porsi sarebbe piuttosto se a questa perdita di prestigio abbia corrisposto anche una effettiva per-dita di potere. Ed è qui, appunto, che ogni storico deve iniziare la sua arrampicata, perché è sempre agevole dare risposte più
2 Cf. per esempio il chirografo del 28 settembre 2013 con cui papa Francesco ha ufficializzato la costituzione del «Consiglio di cardinali» e E. Segatti (ed.), Una nuova cattolicità. Intervista al card. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, in Il Regno-Attualità, 12/2013, 341.
La curia romana nel secolo breve 143
o meno brillanti sulla notizia del giorno, ma è decisamente più complesso darne ‒ e darne a proposito ‒ quando la riflessione investe dinamiche di lungo periodo.
Perché appunto trattare della curia romana significa an-zitutto prendere coscienza della necessità di mantenere uno sguardo lungo e largo. Occorre cioè considerare in primo luo-go che la cronologia della storia della curia non coincide neces-sariamente con quella dei pontificati e che essa è determinata, più ancora che da singole persone, da correnti, culture, scuole di pensiero, filiere che sovente hanno attraversato più stagioni nella vita della chiesa; in seconda battuta occorre anche tenere presente che ciò che noi chiamiamo “curia” ha in realtà un’e-stensione più vasta di ciò che è racchiuso tra le mura leonine. Parlare per esempio della curia romana senza considerare il peso che alcune facoltà teologiche o accademie hanno avuto e hanno nell’elaborazione di una determinata cultura teologica (che poi diventa anche una cultura pastorale) significa misco-noscerne un elemento fondamentale. Così come occorrerebbe anche vagliare con attenzione il peso della diplomazia ponti-ficia, che costituisce a suo modo una dilatazione della realtà curiale: lo si è visto bene all’indomani della nomina del cardi-nale Tarcisio Bertone al vertice della segreteria di Stato, quando appunto da più parti sono state avanzate obiezioni sull’oppor-tunità della designazione di un prelato il cui curriculum non contemplava esperienze di carattere diplomatico.
Proprio mantenendosi rigidamente nell’ambito di una ri-flessione preliminare sulla curia a cavallo tra XX e XXI secolo mi concentro allora su tre nodi che mi paiono meritevoli di ulteriori approfondimenti.
1) Un primo aspetto che ha caratterizzato la vicenda della curia nel cosiddetto secolo breve è stata anzitutto l’evidente consapevolezza dei papi di una certa sclerotizzazione della macchina curiale, a cui essi hanno tentato sì di rispondere me-diante atti di riforma costituzionale. Pensiamo in questo senso a quanto fatto da Pio X (Sapienti consilio, 1908), da Paolo VI (Regimini ecclesiae universae, 1967) e da Giovanni Paolo II (Pastor bonus, 1988). Ma i papi sono anche intervenuti per rimodulare i fulcri del funzionamento della curia affiancando, alle struttu-
144 enrico galavotti
re esistenti, altre strutture solo apparentemente più effimere, eppure capaci di essere la reale interfaccia tra il papa e gli altri organismi curiali. Cosa fu, in effetti, la celebre ‒ e famigerata ‒ “segretariola” impiantata da Pio X se non uno strumento per rendere ancora più rapida l’esecuzione del volere papale? E cosa fu poi lo stesso Sodalitium pianum, istituito da monsignor Benigni con il beneplacito di papa Sarto, per raccogliere infor-mazioni su coloro che erano sospettati di modernismo se non un organismo che bypassava funzioni normalmente spettanti ai nunzi e agli ordinari diocesani3? Più complessa ancora la strategia che seguì Pio XII, che pure conosceva molto bene la macchina curiale e che, per averne un controllo ancora più stretto, creò ad arte delle vere e proprie disfunzioni (la mancata sostituzione del cardinale segretario di Stato Maglione dopo la sua morte nel 1944; la nomina dei pro-segretari Montini e Tardini in conflitto tra loro; l’assegnazione di più dicasteri a un solo cardinale), in modo da poter essere l’unico regista della curia; una curia che poi, similmente a quanto avvenuto con Pio X, si vedeva spesso superata nelle sue specifiche competenze dall’attivismo di personaggi come mons. Ronca, padre Lom-bardi e Luigi Gedda, tutti personalmente legittimati da papa Pacelli. Papa Giovanni XXIII, per uno di quei paradossi che spesso si verificano, venne eletto nel 1958 da un cartello che de-siderava sanare queste disfunzioni, a cui prontamente rimediò (e in questo la similitudine con le circostanze in cui è avvenuta l’elezione di Bergoglio è impressionante)4; e sempre papa Gio-vanni si preoccupò che la curia non si sentisse minacciata dal concilio che aveva deciso di convocare, affidandole la prepara-
3 Su quest’ultimo resta d’obbligo il riferimento all’ancora insuperato É. Pou-lat, Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international, la «Sapinière» (1909-1921), Casterman, Paris 1969; rispetto alla “segretariola” si vedano le importanti informazioni offerte da S. Pagano, L’Archivio particolare di Pio X all’Archivio Segreto Vaticano, in G. La Bella (ed.), Pio X e il suo tempo, il Mulino, Bologna 2003, 153-182, nonché da G. Vian, La riforma della Chiesa per la restau-razione cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d’Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914), Herder, Roma 1998.
4 Cf. G. Alberigo, Dalla Laguna al Tevere. Angelo Giuseppe Roncalli da San Marco a San Pietro, il Mulino, Bologna 2000, 89-105.
La curia romana nel secolo breve 145
zione del Vaticano II5; ma anche papa Roncalli creò una nuova funzione: quella del segretario particolare del papa, che con papa Wojtyła prima e con papa Ratzinger poi è stata addirittu-ra dotata di dignità vescovile: quasi una sorta di reistituzione del cardinal nepote di antica memoria.
2) Un secondo fenomeno che certamente va considerato a livello storico e che credo contribuisca a spiegare l’attuale crisi in cui versa la curia è la perdita della percezione comune di una sua dimensione sacrale e di una sua eccezionalità rispet-to alle altre strutture in cui si articola la chiesa cattolica. Una dimensione, si badi bene, che era una parte fondamentale del potere curiale, al punto che davvero il motto Roma locuta causa finita descriveva effettivamente una modalità decisionale che non era immaginabile contestare. Se uno riguardasse oggi il film Pastor angelicus di Romolo Marcellini del 1942 rimarrebbe stupefatto: in piena Seconda guerra mondiale la santa Sede viene raffigurata ‒ perché così si autopercepiva ‒ come un regno incantato e fuori dal tempo, immune dalla tragedia in atto, quasi una riedizione cattolica della città proibita, popolata di mandarini al servizio dell’imperatore; la voce “conclave” dell’enciclopedia Ecclesia era, da questo punto di vista, esem-plare di tale autopercezione già nel suo incipit: «Il papa non è immortale. Subisce la sorte comune a tutti, e muore». È eviden-te allora che oggi, in un momento in cui anche le istituzioni sta-tuali o sovranazionali soffrono di un deficit di legittimazione, una struttura come la curia romana non possa fare eccezione. Ma nel caso specifico della curia romana mi pare che entrino in gioco soprattutto altri fattori:
a) il nodo della collegialità episcopale emerso al Vaticano II, che ha implicitamente posto la questione di un decentramento dei poli decisionali;
5 A padre Roberto Tucci, direttore di La Civiltà Cattolica, che gli riferiva del desiderio di molti che il papa esigesse una maggiore consonanza degli esponenti di curia alle linee direttive del suo pontificato, Giovanni XXIII replicherà pochi mesi prima di morire che aveva ben presente la questione, ma che era obbligato a non agire in modo troppo drastico per evitare che quello che si sarebbe riunito alla sua morte diventasse un conclave contro di lui e il suo concilio: cf. G. Sale, Giovanni XXIII e la preparazione del Concilio Vaticano II nei diari inediti del direttore della «Civiltà Cattolica», padre Roberto Tucci, Jaca book, Milano 2012.
146 enrico galavotti
b) questa esigenza di decentramento, tuttavia, ha anche fatto sì che, in una congiuntura vocazionale come quella che si vede da mezzo secolo in qua, gli episcopati nazionali siano decisamente più restii a mandare a Roma i loro elementi più “pregiati”, come invece era prassi decenni addietro (c’era, anzi, una sorta di gara tra nazioni per riuscire a garantirsi un posto in curia: e la cosa era importante non perché si entrava nella “stanza dei bottoni”, ma perché si era considerati degni di en-trarci);
c) un terzo fattore che mi pare vada considerato è dato dal-la contestuale desacralizzazione della figura del papa, che non poteva non determinare conseguenze anche sull’assetto delle strutture che da secoli lo assistono nel governo della chiesa. Pa-pa Francesco non mostra particolari imbarazzi nell’autodefinir-si come un «peccatore»: ma questa autorappresentazione, che spesso viene compresa solo a un livello superficiale, sortisce delle inevitabili implicazioni nel modo in cui viene percepito l’esercizio del ministero del vescovo di Roma. Quasi nessuno lo ricorda ora, ma, quando con Paolo VI i papi si misero a viaggiare, qualcuno obiettò appunto che questa scelta avrebbe deprivato il papa di quell’aura sacrale che lo aveva sempre avvolto. Non c’è alcun dubbio che oggi si guardi al vescovo di Roma in modo ben diverso da come avveniva prima del concilio Vaticano II ed è indubitabile che questo mutamento di prospettiva abbia riguardato anche la curia romana.
3) In terzo e ultimo luogo mi pare che l’esperienza stori-ca dimostri che le riforme della macchina curiale realizzate nell’ultimo secolo abbiano omesso un passaggio essenziale e preliminare. Hanno mancato cioè di procedere dal dato che quello della curia è anzitutto un problema teologico: in che modo, cioè, il papa può delegare ad altri enti porzioni del proprio primato senza che questo processo alteri o vulneri il delicato rapporto tra l’esercizio del primato stesso e il collegio dei vescovi6. Il luogo in cui questa riflessione avrebbe dovuto
6 Era un’idea che Giuseppe Dossetti ‒ ricorrendo a un approccio del proble-ma sostanzialmente eluso da tutti, più concentrati su questioni di meccanica curiale ‒ aveva già espresso all’indomani della conclusione del Vaticano II in un
La curia romana nel secolo breve 147
svolgersi era evidentemente il Vaticano II, ma la piega che pre-se rapidamente il dibattito, concentrandosi sugli abusi o sulla protervia di alcuni esponenti di curia indusse infine il papa a sottrarre dall’ordine del giorno la questione e ad avocarla a sé, lasciandola di fatto sinora aperta.
Il fascicolo che Concilium ha voluto dedicare a Per una rifor-ma della curia romana mi pare che possa quindi costituire un’uti-le base di ripartenza per un simile lavoro di riflessione. Perché la varietà delle prospettive con cui è stato considerato il tema della riforma mi sembra fondato su una valida premessa co-mune: e cioè procedere dall’assunto che una riforma degli as-setti di governo della chiesa cattolica può essere efficace se – e solo se – non viene pensata e attuata contro qualcuno, ma tiene ben fermo l’obiettivo ultimo del conseguimento di un’effettiva collegialità e di un’effettiva sinodalità: che a loro volta sono strumenti per ben più importanti obiettivi. Al fondo restano ancora oggi validissime quelle righe che Giovanni XXIII scrisse all’indomani di una vera e propria visita pastorale tra gli uffici della curia romana: «Tutti bravi e buoni questi addetti ai servizi del Vaticano, e tutti ben trattati: ma sempre desiderosi di como-dità, di vantaggi, come se qui dovesse continuare il Paradiso terrestre nella aspettazione del Paradiso eterno. Che il Signore ce lo conceda a tutti colla grazia sua, il Paradiso celeste»7.
ciclo di lezioni dedicate all’analisi dei documenti conciliari: G. Alberigo, Giu-seppe Dossetti al concilio Vaticano II, in G. Dossetti, Per una «chiesa eucaristica». Rilettura della portata dottrinale della Costituzione liturgica del Vaticano II. Lezioni del 1965, a cura di G. Alberigo e G. Ruggieri, il Mulino, Bologna 2002, 243s.
7 A.G. Roncalli - Giovanni XXIII, Pater amabilis. Agende del pontefice, 1958-1963, a cura di M. Velati, Istituto per le scienze religiose, Bologna 2007, 313.