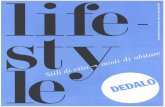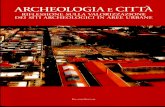Polveri urbane
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Polveri urbane
Città, città, città... città?
Massimo Bilò
L'argomento di questo saggio si iscrive nel proposito di fornire "strumenti di valutazione storico-critica" in
merito alla riqualificazione architettonica del paesaggio contemporaneo, proposito che mi interessa
particolarmente, perché credo che molti equivoci culturali, molti errori operativi, in breve, molti problemi
irrisolti della situazione italiana dipendano proprio dalla mancanza di strumenti valutativi.
A questa mancanza fa sempre riscontro un elevato grado di indeterminatezza dei termini, riscontrabile
anche in un fenomeno che ritengo molto preoccupante: il proliferare di recenti ridefinizioni tanto fantasiose
quanto fragili del fenomeno città. "Città diffusa", "città di latta", "città effimera", "città postmoderna", "città
del conflitto", "città senza luoghi", "non città", ecc. rappresentano esempi in questo senso; per gli anni
Sessanta, aggiungo "città territorio", "città regione", "città metropolitana", definizioni - queste ultime - più
adeguate alle necessità amministrative che non all'interpretazione dei cambiamenti fisici. Malgrado siano
tante, hanno dato pochi, o addirittura nessun contributo concreto agli studi urbani; ma il sostantivo non è
cambiato: sempre di città si parla.
Città, città, città, dunque. Possiamo utilizzare questo stesso sostantivo anche per la fenomenologia
insediativa succeduta alla città anticlassica, alla città del Moderno? A ben guardare, passano i secoli e non
riusciamo a liberarci della metafora più suggestiva mai inventata: la città-corpo dell'Alberti è tuttora il nostro
riferimento, seppure con il cuore aggredito, le arterie congeste, i polmoni di verde asfittici. L'Uomo realizza
e legge la città sulla base della sua fisiologia.
Città, sempre città. Ma dobbiamo chiederci: nella vicenda insediativa umana, non esiste altro dalla città?
Non è mai esistito altro? Sarebbe interessante esaminare le molteplici forme insediative succedutesi nei
millenni. La città nasce verso la fine del Neolitico, preceduta da altre forme: la cittadella, il santuario, la
necropoli, il villaggio e la rete di villaggi; più tardi si aggiungeranno gli insediamenti monastici. Ma la città
non è il risultato di una crescita dimensionale del villaggio: è un fenomeno del tutto originale che tuttavia
non cancella integralmente il preesistente: la forma villaggio, ad esempio, ha una straordinaria vitalità che
persiste tuttora, come è facile dimostrare. Per chiarezza: non sostengo affatto che la forma insediativa
migliore, che la forma auspicabile per il futuro sia il villaggio; cerco solo di verificare se, rispetto alle
modalità insediative contemporanee, esistano riferimenti interpretativi meno impressionistici di quelli che ci
vengono proposti; soprattutto, se siano possibili riferimenti liberati dalla dipendenza che tuttora induce
fortemente l'idea albertiana di città-corpo.
Per tale scopo mi propongo di usare un artifìcio retorico basato proprio su quell'idea. L'artifìcio consiste
nell'assumere come significative due tesi radicali sul rapporto tra città e territorio, due ipotesi riferite
entrambe alla città albertiana; con esso mi propongo di raggruppare tutte le differenti elaborazioni in
materia di occupazione del territorio in due sole e contrapposte concezioni. Concezioni assolutamente
artificiose e strumentali, ribadisco. La prima fonda su una visione antropocentrica del mondo che esalta il
dualismo artificio-natura; fonda sull'idea di città dimensionata, storicamente radicata nell'antitesi città-
campagna; fonda sulla percezione del territorio come sfondo dell'oggetto città. La città sarebbe la naturale
modalità insediativa dell'uomo come l'alveare lo è dell'ape.
Sulla base di questa concezione la dirompente urbanizzazione della nostra epoca è vista come "l'esito di
una crescita patologica", una spinta centrifuga, un'esplosione irrefrenabile, una metastasi che corrompe il
corpo albertiano. Alla luce di questa prima concezione si deve concludere che "la città-corpo è una forma
insediativa che si diffonde" sul territorio. La seconda concezione, invece, è basata sull'ipotesi che
l'occupazione a fini insediativi del territorio terrestre, la sua colonizzazione, sia un processo specifico, insito
nelle caratteristiche delle diverse specie che abitano il nostro pianeta, in particolare quella umana.
Secondo questa concezione la città classica e le sue derivazioni non sarebbero affatto la vera, l'unica,
l'elettiva, la naturale o la fatale forma dell'insediamento umano, come dimostrano da una parte le culture
nomadi o quelle primitive e dall'altra gli studi antropologici. Ogni forma insediativa, dalla casa rurale sparsa
alla città, sarebbe l'esito dell'equilibrio raggiunto tra fenomeni eterogenei -necessità, usanze, culture,
tensioni, ecc. - fenomeni che serpeggiano sul territorio e punto per punto lo investono assumendone e
formalizzandone la complessità, l'eterogeneità, la natura elettivamente ibrida. Questo articolato incontro tra
cultura e natura sarebbe l'origine di molteplici e differenti forme insediative che, a volte diacronicamente a
volte non, si manifestano e si confrontano, opponendosi, componendosi, sostituendosi. Alla luce della
seconda concezione si dovrebbe concludere che "la città-corpo è oggetto di inglobamento" nei fenomeni
trasformativi del territorio, come ogni altra componente del territorio stesso.
È chiaro che le due concezioni comportano giudizi di valore molto diversi e quindi originano comportamenti
altrettanto diversi; inducono criteri di progettazione e modi d'intervento anche antitetici.
La prima concezione è congruente con un'idea organica di sviluppo; è in sintonia con il pensiero della
conservazione e della tutela. Essa, infatti, viene assunta da chi pensa alla città classica -alla città
dimensionata - come al modello di riferimento per ogni epoca, anche per l'oggi; le qualità del centro antico
sono paradigmi per l'intera città: "antico è bello". Questa concezione porta a ridefinire ed esaltare l'unicità
dell'urbano, a confermare la sua sostanziale continuità e organicità, la ripetibilità dei codici formativi, il
rapporto di interdipendenza tra pieno e vuoto, tra edificio e strada; a rivalutare la capacità ordinatoria,
ricompositiva e risanatrice del progetto architettonico. Questa concezione è assunta, ad esempio, dai
propugnatori delle "cento piazze" per la riqualificazione delle periferie romane o napoletane. La ritroviamo
nelle proposte di Portoghesi per le nuove piazze barocche che, a suo dire, sarebbero in grado di
riaggregare nella dimensione del quartiere i tessuti più sconnessi.
Alla seconda concezione, che considera la città corpo come "oggetto di inglobamento", si ispira, invece, chi
assume un atteggiamento più problematico e considera lo sviluppo urbano contemporaneo come un
prodotto significante e legittimo di una società storicamente configurata. La seconda concezione, ha
importanti conseguenze sulla lettura della città consolidata. La intende come evento tra gli eventi, come
naturale molteplicità, come insieme di parti identificabili non solo per le differenti qualità fisiche o per la
datazione, ma anche per i diversi codici funzionali, i modi d'uso, gli stili di vita, le sollecitazioni percettive,
ecc. Su questa base le parti amplificano la loro relativa autonomia, la natura di campi conclusi, di interni in
contiguità, ma non per questo in continuità, sottraendo agli spazi esterni inedificati l'originario ruolo di
sfondo del nucleo urbano: anch'essi vanno letti come campi conclusi in contiguità con l'intorno. Non sono
ancora in grado di trarre profitto da queste considerazioni; il mio proposito è solo quello di indirizzare
l'analisi dei fenomeni insediativi verso riferimenti nuovi, riscattando il lavoro d'indagine dalle ipoteche della
città, classica in particolare.
C'è un crinale temporale al di là del quale la città come riferimento mi sembra perdere significatività;
certamente perde di operatività. La città prima compatta, poi continua e poi discontinua sembra dissolversi
nell'ambito di una fenomenologia territoriale dai caratteri ambigui, apprezzabili solo a costo di significative
rotazioni prospettiche. La discontinuità, dunque, non sembra essere il carattere conclusivo nell'evoluzione
della città; altre nozioni devono essere introdotte per interpretare in maniera più pregnante la
fenomenologia insediativa contemporanea. Ad esempio, considero particolarmente pertinente e suggestiva
la nozione di contiguità, specie se coniugata con quella di diffusione nell'espressione "diffusione della
contiguità"; espressione che contiene sia il senso dell'evento dilagante che della separatezza di entità
diverse per natura, ruolo, configurazione.
Ma come definire queste entità diverse in maniera sintetica? Non ho trovato termine più adatto di "luoghi".
È possibile comporre una tipologia di luoghi? Se lo è, essa è certamente costituita di pochi elementi; i
fondamentali mi sembrano cinque. "Luoghi dei flussi" o delle infrastrutture fisiche e immateriali; "luoghi del
privato", dove si coniugano in forme antiche, moderne o del tutto innovative - spesso tentative - la
residenza e il lavoro autonomo; "luoghi collettivi", per il commercio, lo sport, la cultura, gli eventi religiosi, gli
aeroporti, i porti, gli autogrill, i cimiteri, ecc; "luoghi della produzione intensiva" delle centrali energetiche,
delle grandi industrie anche agricole, delle distese di serre, ecc; "luoghi delle diverse nature" più o meno
antropizzate, comprese le aree della rinaturalizzazione.
Aggiungo qualche altra considerazione sulla forma insediativa risultante dalla diffusione della contiguità.
Essa è il risultato di continue "sconnessioni". Il fatto non ci può meravigliare se consideriamo la nostra
come una stagione di regionalismi, localismi, settorialismi, conflitti di competenze che cerchiamo di
contemperare con espedienti formali come la complementarietà, la sussidiarietà, le conferenze di servizi e
altre diavolerie simili, poco sensibili al dato fisico. Ogni potere vuole gestire il suo spazio o il suo strato
nella massima autonomia; questo provoca sconnessioni. Ancora: la nuova forma insediativa sembra
escludere caratteri che furono distintivi della città, primi tra tutti l'ordine e la gerarchia; ma anche la
dialettica tra pieni e vuoti, tra positivo e negativo. Anche l'esterno sembra escluso: si è sempre in un
interno, anche quando si è "nella" rete, dentro le cellule che percorrono la rete. Ma ci sono altri caratteri
storici che sembrano dileguarsi, come la durata degli oggetti architettonici e la durabilità dei materiali che li
compongono. Vince il provvisorio, l'effimero, l'allestimento; trionfa la singolarità sulla regola, l'atto percettivo
su quello riflessivo.
Immagini, dunque: leggiamo questa nuova forma insediativa come collaggio di immagini, così come
sempre abbiamo letto il paesaggio, la natura naturale; prodotto non-intenzionale e quindi privo di una
struttura significativa come quella che inverava la forma architettonica e la città.
Qui è opportuno ch'io mi fermi ponendo qualche quesito. Il Piano ha ancora un senso come prefigurazione
propositiva o il suo destino è quello trasformarsi nello strumento di gestione sincronica delle sconnessioni?
Dov'è, in questo stato, il luogo del progetto? Qual è la sua funzione? Quali i protagonisti? Soprattutto:
esiste già una declinazione del progetto che può essere utilizzata nell'ambito della nuova forma
insediativa? Ad esempio, possono essere assunte le tecniche del progetto di paesaggio?
Sono tecniche che non hanno ancora un livello di definizione convincente né una sufficiente esperienza
applicativa; tuttavia mi sembra di intravedere in esse alcuni caratteri distintivi che prefigurano altrettante
necessità d'innovazione; ma anche altrettante assolute incompatibilità.
Incompatibilità con i codici di natura funzionale, basati sulle selezioni, le distinzioni, le gerarchie, gli
standard quantitativi; con le ideologie della tutela ambientale d'ispirazione etico-igienistica; con gli assunti
radicali della tutela storico-estetica; con il piano e con l'articolazione del progetto per scale dimensionali;
con la polverizzazione decisionale; soprattutto, con le separatezze disciplinari (cioè reti all'ingegneria,
edifici all'architettura). Non è poco. Il progetto di paesaggio sembra revocare in dubbio tutti i nostri
orizzonti; ci avverte che premessa a ogni significativa innovazione è un salto culturale, una torsione nel
pensare che immagino pari, almeno, a quella riassunta dall'abate Laugier nella metafora della città-foresta.