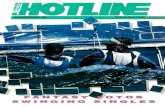1,20 2,12 by,11 in,11 a,10 for,8 to,8 talon,7 windwalker,7 i,7 ...
Pind. I. I 11 (ἐξοπάζειν)
-
Upload
mondodomani -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Pind. I. I 11 (ἐξοπάζειν)
MUSEUM CRITICUM Diretto da Benedetto M arzullo
XXIII-XXIV ( xg88-xg8g)
ESTRATTO
xg8g
GIARDINI EDITORI E STAMPATORI
IN PISA
PIND. l. I 11
( È;onat~w)
È:rtEl <nE<pavouç e; ò'maaEv KaO!!OU O"tQ<l"tcf> È; àÉ-frÀwv.
Lo schol. Pind. /. I llc (III 199, 4 Dr.) segnala che, poiché nelle 'Ia'fr!J.Laxal àvayQa<pa( non compare né che i Tebani abbiano vinto le Istmiche sei volte, né che ciò sia avvenuto a Erodoto, ot 'AQLO"tUQ)CELOL tjnÀ.oiiv"tEç xal È:rtl 1:oii VL"XTJ<p6Qou ÈxÀa!J.~avov"tEç 1:òv Myov, :rtEQLa<Ti)v d va( <pam "t'IÌV t; :rtQ6-frl]mv :rtOLTJLL"Xfl auvT]-frE(çt ( ... ) aÀ.Àwç "tE OÙ"X. ÙvayxaiOV ÙQL'fr!!ÒV "X.ELa'fr<lL" JtOÀ.À.cf'> yàQ !!ÒÀ.ÀOV xuoa(vEo-frm 1:òv VEVL"XT]X61:a. Ne consegue, che Hesych. E 4004 La. t;wnatev· t;É:rtE!!JtEV si pone come documentata alternativa testuale1.
Editori e commentatori hanno, per lo più, evitato di confrontarsi con l'obiezione degli aristarchei riguardo al numero delle vittorie, o hanno avanzato, a favore del testo tràdito, argomenti non risolutivi. Wilamowitz2 definisce «unbrauchbar» il verbo t!;o:rtatELV, e pessima la congettura degli aristarchei, poiché, con essa, il plurale <nE<pavouç «nicht mehr paBt». L. R. Farnell3 sostiene che KaO!!O'U <nQa"tcf>, non essendosi ancora il poeta riferito a Erodoto, deve indicare i Tebani che vinsero alle Istmiche, i quali dovettero, quindi, essere in sei4
. Aristodemo di Alessandria, nello scolio citato (Il. 15-23), spiega le sei vittorie in questione con quella istmica, più le cinque e non istmiche, elencate da Pindaro ai vv. 52ss., e donate da Apollo quale generico
l. La stessa variante (é!;cb:rtaoEv) ricorre in POxy. 2451, fr. l, col. l 28-30 (scoli alle Istmiche) é!;w:rtaoEv OlflEVI ]ç ÀEY'J[ .. JyovEVm frr]~mouç l ]o'Lva[ .] :t[ .]E!;.:rtaoEVa vc:p:rta. Si è trascritto il testo di Lobel, il quale, a p. 158, scioglie così la parte finale: t va TI 'tÒ é!;cb:rtaOEV àv'tl 'tOU oo:rtaOEV.
2. U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Pindaros, Berlin 1922, 334 n . l.
3. The works of Pindar, Vol. II, Critica/ commentary, London 1932, 336.
4. Inaccettabile è la convinzione di E. VON LEUTSCH, Pind. Isthm. I IO, <<Philol.>> XVIII (1862) 466, per cui le sei vittorie si spiegano col fatto che non sono solo istmiche, ma ottenute in vari altri giochi, di cui i Corinzi (ovvero l''lcrtttJ.6ç) avevano la :rtQOO'taola ('EUcb'tLa, EuxÀELa, etc.). Ma è chiaro, dai primi versi dell'ode, che Pindaro ha dovuto dedicarsi all'improvviso alla sua composizione, dal momento che uno o più Tebani avevano vinto in quei giochi istmici, e uno, Erodoto, gli aveva commissionato l'opera. Pindaro menziona, dunque, l'Istmo unicamente per le vittorie (o la vittoria) ottenute dai Tebani in quell'edizione dei giochi.
59
Jt{IO<Ttért'Y)ç 'tWV àycbvoov5. E. Thummer6 si oppose a tale soluzione, ritenendo impossibile: l) che le sei vittorie si riferiscano a diversi Tebani in varie gare, perché Pindaro non cita mai i successi dei compatrioti del dedicatario; 2) che le stesse siano di Erodoto, poiché sarebbe strano che nell'elenco ai vv. 52-9 non ne risulti neanche una, oltre a quella cantata nell'ode . Infine, esclude che si possa leggere Èçwn:aaEv: il verbo non è mai attestato, e, inoltre, eliminando éç, si eliderebbe «ein typisches Merkmal der Siegesnennung, wie sie Pindar in seiner Gedichten gibt». Infine, osserva che Pindaro amava impressionare gli ascoltatori con ostentazioni numeriche. Dunque, egli afferma, le sei corone sono le stesse dei vv. 52-9: la vittoria istmica fu la sesta per Erodoto7
.
La questione è stata ripresa, recentemente, da G. A. Privitera8, che
adotta la lezione Èçwn:aaEv degli aristarchei. Queste le sue ragioni: a) dallo scolio risulta che né nelle Istmiche attuali, né in quelle svoltesi fino ad allora, Tebe o Erodoto abbiano vinto sei volte9
; b) le sei vittorie non possono essere considerate quelle elencate ai vv. 52ss., perché la praeteritio di Pindaro fa intendere che esse erano più di sei (vv. 60ss .); inoltre, l'elargitore delle stesse è Hermes, e non l'Istmo- Posidone, soggetto di ùmaaEv del v. 11, tantomeno Apollo10; c) non si può dire che l'Istmo avrebbe concesso la sesta vittoria a Erodoto, do-
5. Negli scholl . a e ballo stesso luogo (Il . 1-3) si afferma semplicisticamente , che el; costituisce catacresi per un numero indefinito di vittorie.
6. Pindar. Die lsthmischen Gedichte etc., Il, Heidelberg 1969, 13.
7. <<Der Isthmos hat also fiir ihn die Zahl sechs voli gemacht, er hat es ermoglicht, daB Herodot jetzt von insgesamt sechs Siegen reden kann . In einer solchen Ausdrucksweise liegt freilich eine beabsichtigte Ungenauigkeit bzw. Verdrehung, doch solche Freiheiten gegeniiber dem wahren Tatbestand hat sich Pindar ofters genommen , um seinem Lob grossere Wirkung zu verleihen>>.
8. "Due note alla prima Istmica di Pindaro" , in Studi in onore di Anthos Ardizzoni, II, Roma 1978, 723-7 , 732s.
9. Anche contro Farne!!. PRIVITERA 724s. aggiunge l'osservazione di THUMMER ci t . , «Che Pindaro non ricorda in nessun epinicio le vittorie riportate dalla patria del vincitore». Tuttavia, lo fa Bacchilide: cf. II 9 e, forse , XII 35ss . (con l'osservazione di B. SNELL, Bacchylidis carmina cum fragmentis, post B. S. ed. H . MAEHLER, Lipsiae 197010
, XL V). Riguardo a quest'ultimo passo, bisogna, però, rilevare come il numero di trenta vittorie possa riferirsi al yÉvoç di Tisia e non ai suoi compatrioti : cf. PINo. O. XIII 96ss. (sessanta vittorie , tra istmiche e olimpiche, del yÉvoç degli 'OJ..tyadHom), e N. VI 58ss. (venticinque vittorie del yÉVoç di Alcimida). Cf., comunque, lo schol. ba quest'ultimo luogo (III 113 , 24ss. Dr.) t1;ijç q.>T]OLV wç EÌ.XOOLJtÉVtE <TtEq.>avouç ELÀT]q.><hwv t&v à:Jtò taUtT]ç tijç q.>atglaç iì xa{J-6J..ou t&v AtytVT]t&v.
10. Contro Aristodemo. Cosi già WrLAMowrrz cit.
6o
po quelle elencate ai vv . 55ss. , poiché Pindaro avrebbe usato il cardinale11 . Questo per quanto riguarda l'eventuale e;. Supporti formali sono: d) la iunctura atE<pavouç e; non corrisponde all'usus seribendi del poeta; e) anche Esiodo (Op. 324) usa il hapax xm:ona~n; f) t;oma.oEV non è isolato: del composto fornisce un'altra testimonianza Hesych. ci t.; g) comune è in Pindaro l'uso di m:É<pa.vm per una sola vittoria o corona; h) la ripetizione di preverbo e preposizione Èx l t; si ritrova in [Aesch.] Prom. 909s., Soph. OC 1292, Eur. lA 315.
Delle obiezioni di Privitera si possono condividere solo le sue osservazioni sulla necessità del cardinale contro l'ipotesi di Thummer, che va, quindi , rifiutata; sul fatto che le vittorie elencate nei vv. 52-9 siano solo parte di quelle ottenute da Erodoto; che l'elargitore delle stesse, Hermes, non abbia nulla a che fare con le eventuali sei del v. 11, donate dall'Istmo; infine, che il plurale OLE<pavouç è indifferente riguardo alla scelta della lezione, in quanto Pindaro usa anche altrove il plurale di m:É<pa.voç per indicare una sola vittoria o corona12
. I luoghi addotti da Privitera, per quest'ultima osservazione, necessitano, comunque, di analisi: se non altro per cercare di reperire eventuali referenti concreti di Pindaro. Per quattro luoghi (O. III 6, P. II 6, N. IV 17, I. III 11), non è detto che col plurale si intenda la sola corona della vittoria13
• L'atleta riceveva anche altre corone, perlomeno all'atto della <ptJÀÀ.oBoì..i.a.14
, che certo Pindaro avrà considerato non inferiore all'investitura ufficiale, costituendo il suddetto gesto, da parte del pubblico, il riconoscimento della gloria panellenica del vincitore15 .
11. Contro THuMMER cit.
12. Contro WrLAMowrrz cit. Specificamente , PRIVITERA 733 n. 7 porta O. III 6, P. Il 6, N. IV 17, I. VII 39. In Pindaro. Le Istmiche, s. l. 1982, 141, aggiunge l. III 11, e non menziona più N. IV 17. Cf. anche gli scoli elencati da Drachmann nell'Index X(i) della sua edizione (numeri: O. II 80a , 81b, VI 115a, IX 82a; P. IV 4, 100a, 266, VIII 10a, 94; N. VII 47, 53).
13. Gli scoli ad l. (I 108, 12-28 Dr.) riferiscono xa[tmç alle chiome dei cavalli o a quelle dei xw~-ta~ovteç . La prima ipotesi non appare del tutto peregrina: quanto al rituale della qmÀ.À.o~oÀ.[a, cf. schol. O. VI 44b (I 164, 1s. Dr.) btetù~ xat aùtal at TJI-tlOVOL CTCE<pavmç È~aÀ.À.OvtO (<àv>e~aÀ.À.OVtO Marzullo) xat avitemv.
14. Cf. M . BLECH, Studien zum Kranz bei den Griechen, Berlin-New York 1982, 112 et n. 107. Un vincitore con più corone è in una rappresentazione vascolare , cf. G . Q . GrGLIOLI, Phylli:Jbolia, «ArchCI» II (1950) tav . XII 2 (potrebbe , comunque , trattarsi di un plurivincitore) .
15. Si rilevi, inoltre, che nei tre luoghi appena citati le più corone, se non direttamente al vincitore (J. III 11), sono attribuite alla patria d'origine per suo tramite (P. II 6, N. IV 17), come del resto conviene , se si tratta delle corone della <puÀ.Ào~oÀ.[a . Il
61
Difficile è l'ultima occorrenza, l. VII 39, dove non è chiaro se si parla della chioma del poeta o di quella dell'atleta. Nel secondo caso, l'interpretazione più probabile mi sembra quella degli scoli, che intendono, metaforicamente, crtc<pavOLç f.LO'UOLXo'iç: l'esempio non sarebbe, quindi, pertinente alla tesi di Privitera, almeno per quanto riguarda le corone=vittorie. Egualmente si deve giudicare, nella ipotesi che la
. xal:tav sia quella del poeta: allora non si individua un referente per il plurale crtE<pavOLow, ma comunque non si parla di corone di vittoria, come nel supposto parallelo /. I 10. In ogni caso, l'ipoteticità delle considerazioni precedenti costringe a riconoscere efficacia all'osservazione di Privitera16.
Per quanto riguarda le restanti obiezioni, l'eventuale e; non potrebbe avere altra posizione, per ragioni metriche. Inoltre, è assente qualsiasi epiteto per crtc<pavouç (specificato da t; àt'frJ..oov), che possa giustificare gli assunti di Privitera17
. In definitiva, sulla Wortstellung non si può speculare. Nei luoghi tragici menzionati da Privitera, l'azione marcata dai due ablativi è violenta, abrupta, come non avviene nel passo pindarico: si attribuirebbe al poeta tebano una ridondante anafora18
.
Anche l'apparentemente solida testimonianza delle 'IO'frJ.ttaxaì. àvayQa<pal., è traballante. L. Dissen, in margine al nostro luogo19
,
rimanda, dopo aver diffidato dell'accuratezza delle liste dei vincitori, o di quella dei grammatici nel consultarle, alla sua discussione di N. VIII 16 (II 2, 443), nel cui testo si legge ~EI.vwç ùwowv crtaùtoov xaì. Jta-tQÒç Méya Ncf.LEaLOV ~aÀ.J.ta . Che si tratti di due vittorie di Dinia nello stadio, Dissen non ha dubbi: «Vix alium sensum admittunt verba ut nunc collocata sunt». L'inscriptio alla N. VIII (III 140, 9-13 Dr.) ci
dono, da parte dell'Istmo, della pluralità di corone per la sola vittoria di Erodoto, alla città di Tebe, risulterebbe, da questo punto di vista, isolato.
16. Sul plurale (pro singulari), cf. W. J. VERDENIUS, Commentaries on Pindar, l, Leiden 1987, 14 (ad O. III 6), e i suoi riferimenti bibliografici. Egli menziona anche, come esempio, P. X 26 ( crwp6.vwv Ilu{Hwv), per la vittoria di Ippocleas nel diaulo dei fanciulli. Ma si veda l'inscriptio alla Pitica (II 242, 3ss. Dr.) f:v 6è 'tfl aù'tfl TJJ.tÉQ<;l f:vbtT]OE xat mabwv, où oùx EJ.tvftoftrt, 'Lowç 'toii OLauì..ou ~-t6vov J.tL<J"!}òv ì..af3wv. Da questa si può ragionevolmente ricavare che gli mÉ<pavm Ilu{hm siano un accenno alle due vittorie di Ippocleas, per quanto una non venga estesamente celebrata . Il plurale ha, quindi, oggettivo referente.
17. Per obbedire a questi, Pindaro avrebbe dovuto scrivere me<p6.vouç E~ È~ Mttì..wv, con evidente cacofonia.
18. Sulla glossa esichiana, e sul composto esiodeo, vd. infra pp. 91, 93 e nn. 106, 108.
19. In Pindari opera quae supersunt etc. , ed. A. BoECKHIUS, II 2, Lipsiae 1821, 485 .
62
informa che alcuni ritennero che i due stadi significassero una vittoria di Dinia e una del padre Megas, ma che JtaQÉXEL Oé, cpr]oÌ.v ò ~(OUJ.toç, ri)v àJtoQ(av 'tÒ J.tl]OÉ'tEQOV ail'twv Èv wi:ç NEJ.tEov(x.mç àvayEyQér.cp-frm. Dunque, sia con l'interpretazione di Dissen, che ritengo la più probabile, sia con quella di alcuni scoliasti, si giustifica il sospetto di Dissen sull'accuratezza delle liste dei vincitori, o della loro consultazione da parte dei filologi. Lo schol. ad l. (III 142, 19s. Dr.) recita ùtoowv o è maù(oov, O'tL owuÀ.oOQOJ.tOç. Ora, anche ammettendo che tale spiegazione sia giusta, e non costituisca (come credo) un espediente, non milita, comunque, a favore dell'acribia di Didimo, che avrebbe potuto risolvere l'aporia reperendo nelle liste la vittoria di Dinia nel diaulo, sempre che fosse ivi riportata20
• Le argomentazioni di Privitera risultano, quindi, nel complesso, discutibili. Quanto da lui argomentato non sembra cogente, ma, soprattutto, alla soluzione sua e degli aristarchei si oppone il carattere di <'mér.~ELV . Ciò risulterà chiaro dalla rassegna sull'uso del verbo, che ci sembra opportuno compiere. Seguiremo sue persistenze e mutamenti da Omero alla fine dell'Ellenismo, tenteremo di interpretarne le occorrenze più singolari.
Il verbo è, notoriamente, epico: in Omero ne risulta la polisemia, cui il basilare significato di «seguire con insistenza», «far seguire» dà adito21
• Converrà separare Iliade e Odissea, poiché diversamente il verbo viene impiegato nei due poemi. Facilmente enucleabile è il significato di «inseguire», «urgere», raro, ma chiaramente testimoniato: soggetti ne sono travolgenti eroi (E 334, e 341, P 462), e l'ineluttabile vecchiaia (~ 321, e 103). Nel singolare A 493, si tratta di un corso d'acqua ÒJta~Of..tEVoç da un torrenziale acquazzone. È l'unico esempio di passivo, in questo significato, e di soggetto non animato («animato», infatti, va considerato yi]Qaç). Non sarà azzardato considerare recenziore il verso22 . Su queste poche occorrenze del verbo con valore
20. Occasione di imbarazzo è data anche dalle aristoteliche liste dei vincitori pitici: cf. schol. PIND. O. II 87e (= ARISTOT. fr. 617 R.) . 21. Su òn:a~Etv, cf. F. BECHTEL, Lexilogu.s zu Homer, Halle/Saale 1914, 249s. Sul valore intensivo-iterativo da una parte, fattitivo dall'altra, cf., in particolare, Bechtel e FRISK, GEW II 401. Sulle sue differenze con ùtù6vm e JtOQEiv, cf. F. MAWET, Recherches sur les oppositions fonctionnelles dans le vocabulaire homérique de la douleur (autour de nijf.La-aì.yoç), Bruxelles 1979, 168. 22. Diverso è, altrove, il senso del medio di Òlta~ELv (cf. pp. 64, 66). Su questa forma particolare, e sul suo significato , cf. H. JANKUHN , Die passive Bedeutung medialer Formen untersucht an der Sprache Homers, Gottingen 1969, 88s., e G. P. SHIPP, Studies in the Language of Homer , Cambridge 19722
, 275. Sulla massiccia presenza di
iterativo-intensivo, prevalgono nettamente quelle dove l'uso è fattitivo. Dal senso di «far seguire», òn:a~ELV appare presto specializzato nel significato di «dare come compagno»: JtOf!JtOV (Q 153, 461 , e il sarcastico N 416?3, e À.aov (I 483, II 38, ~ 452) . Il predetto senso sembra pacifico con JtOf!JtOV come oggetto, più problematico con À.aov, dove òn:a~ELV si potrebbe rendere anche con il semplice «dare». Tuttavia, in II 38 e~ 452 si tratta di Patroclo, mandato in campo da Achille, col séguito dei Mirmidoni, un À.aov visto singolarmente come un «compagno>> del condottiero Patroclo e concesso da Achille.
A questa serie appartiene anche l'isolato W 151 IIa'tQOXÀ.<p ... XOf.llJV òn:aoaLf!L (se. Achille) qJÉQED'frm: il Pelide offre la chioma all'amico «come compagno, buon viatico» al momento della partenza di questi per il viaggio all 'Ade. Da una parte, questa occorrenza, travisata, darà spunto, come vedremo, a un uso particolare del verbo in periodo ellenistico, dall'altra sembra allinearsi, pur nella sua particolarità , con l'uso di òn:a~ELV per ~ELvijLa24 , che troveremo nell'Odissea. Si può supporre, che il nostro caso costituisca elaborazione o anticipazione dell'uso suddetto. Un terzo «aggancio» per il nostro verso è con il valore semantico di òn:a~ELV in N 416, e , indirettamente, in Q 153 e 461 : ovvero l'ambito escatologico (cf. n. 23) . Di «confine» , tendente al semplice «dare», «concedere» , è l'occorrenza di ùmaoe À.aov in I 483, dove manca il contesto bellico a giustificare il senso di «dare come compagno»25 : verosimilmente, si tratterà di una mera ripresa formale del sintagma, in un contesto che ne distorce il senso originario26
• In serie con questi versi sono K 238 e T 238, con due forme del medio di òn:a~ELV , nel senso di «prendersi come compagno». Nelle rimanenti occorrenze del verbo, la metà di quelle presenti nell'Iliade, òn:a~nv è definitivamente traducibile con «dare, donare, assegnare, concedere» (anche se in particolari termini) . In esse è op-
forme seriori nelle similitudini americhe , cf. in SHIPP cit. , tutta la PartA: sulla similitudine ove è inserito ÒJta~6~evoç , cf. p. 216. 23. Nonostante la recenziorità di Q, la presenza di Hermes Jto~6ç nei vv . 153 e 461 di questo canto, sembra preludere al verso di N (discesa agli Inferi) . Probabilmente, versi come Q 153 e 461 erano <<formulari >> da tempo in contesti di xma~amç. Su ciò (molto parzialmente , e solo per N 416) , cf. H . L. LEVY , Echoes of early eschatology in the Iliad, <<AJPh>> LXIX (1948) 420s. 24 . Cf. come rendono il verso K. F. AMEIS-C. HENTZE, Homers Ilias , etc. , II 4, Leipzig-Berlin 1922, 48: <<mitgehen, auf dem Wege in den Hades>>. 25 . Cf. , inoltre, infra, le occorrenze odissiache di ÒJta~ELV con questo significato . 26. Tutto ciò, ovviamente, è favorito dalle valenze acquisite dal verbo nelle occorrenze che esamineremo in seguito.
portuno distinguere i soggetti (divino e mortale) e le caratteristiche di quanto dato o donato. Su tredici (o quattordici) casi27
, dieci (o undici) hanno come soggetto una divinità, e ben in otto (o nove) a essere donato è il x:u&oç28
• Solo in tre occasioni viene attribuita alla divinità una donazione differente: ~LYJV (cf. n . 28), x1:ijmv 2 491 (da parte di Hermes a Forbante), e xaÀ.À.oç "tE xaì, "IÌVOQÉYJV ÈQU"tEtvftv z 156 (da parte dei -ttcot a Bellerofonte).
Se si considerano le occorrenze del sintagma xii&oç òna~ELV, si nota che la concessione di questo particolare mana29 avviene esclusivamente in contesti guerreschi, è prerogativa di pochi eroi (Aiace, Ettore, Achille) e degli eserciti in battaglia (Troiani e Danai), ed è un possesso transitorio, legato ali' hic et n une d eli' occasione di gloria concessa dalla divinità, occasione sempre caduca. Diverse sono, infatti, le divinità concedenti, a seconda del loro impegno in quel momento della guerra: Zeus (prevalente: H 205, e 141, M 255, P 566, 630?, <I> 570), Apollo (O 327, II 730), Posidone (2 358). La provvisorietà del dono è esplicita in e 141 vuv j.tÈV yàQ "tOUL<J) (se. Hectori) KQOVL&Y}ç ZEùç xii&oç òna~EL30 • Ritengo che proprio in questo dinamico «far seguire>>, «dare come compagno», all'esercito e al singolo eroe, la «magica forza», stia l'originario e corretto uso di òna~ELV, quale atto del donare da parte degli dei31
: il verbo, più che genericamente epico, appare, in questo senso, caratteristico della Heldendichtung. Negli altri due casi, xaÀ.À.oç "tE xaì, -YtvoQÉYJV ÈQa"tnvftv e x•f)mv, si tratta di doni che rappresentano acquisizioni definitive per i beneficiari, in contesti che costituiscono excursus rispetto alla linea principale del racconto, e non sono bellici. Qui il verbo pare aver assunto, senza sfumature, il generi-
27. In P 630 gran parte dei codici reca l'adonio xùùoç <ÌQrJYEl (gen~ralmente accettato) , altri hanno xùùoç òrta~n (uno aù,;òç <Ìf.tUVEt) .
28. Oltre all'incerto P 630 (cf. nota prec.) , cf. H 205, E> 141, M 255 , :::358, O 327, II 730, P 566, <I> 570. In H 205 la concessione del xùùoç viene invocata insieme a quella di 13bv 29. Sulle valenze di xùùoç basti rimandare a H . FRA.NKEL, Dichtung und Philosophie desfruhen Griechentums, Miinchen 19623,88 n . 14, e É. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes , II , Paris 1969, trad . it. Torino 1976, 327ss.
30. Cf. anche::: 357. Su tale peculiarità dei doni divini in Omero, cf. W. MARG, Der Charakter in der Sprache der fruhgriechischen Dichtung, Wi.irzburg 1938, 61ss.
31. Del dinamismo del xùùoç sono ancora testimoni II 241 ,;<ji (se. Patroclo) xùùoç &~-ta rtQÒEç, EÙQUorta ZEù, e, con xùùoç come soggetto,~ 415 "tOU"t<Jl (se. Agamennone) ... xùùoç &~-t' E'i'E"tat, e P 251 Èx ÙÈ ~tòç n~-tiJ xal xùùoç ÒrtT]ÙEi:, evidenti variazioni sull'originale xùùoç òrta~Etv , che ne rispettano, però, le valenze semantiche. Sulle particolarità linguistiche di II 241 e P 251, cf. SHIPP ci t., 291 e 295.
65
co significato di «dare, concedere», evidentemente secondario: in effetti, gli ultimi due casi hanno affinità con il citato I 483 xat fA.' (se. Phoenicem) à<pvEtòv efh}xE, JtoÀ:ùv ÒÉ fA.Ot <i'maoE À.a6v (se. Peleus), di cui abbiamo rilevato la distorsione semantica. Mutano anche gli agenti dell'òJt<i~EtV: in Z 156 sono generici {}wl,, in 3 491 Hermes32
. Tuttavia, queste due occorrenze hanno una marcata specificità, su cui torneremo in seguito. Si è detto che si tratta di excursus (o, comunque, di «espansione» genealogica): in essi, com'è frequente, troviamo frammenti di narrazione mitologica, in cui si racconta di mortali in privilegiato rapporto con la divinità. Così è per l'eroe Bellerofonte, come pure per il JtOÀ.UfA.rJÀ.oç Forbante, il cui «nome parlante>> motiva emblematicamente il favore di cui godeva presso Hermes, dio dei pastori. Vedremo altrove, come il verbo ÒJt<l~ELV marchi situazioni di tal genere. Due sono, invece, i casi in cui ÒJt<l~Etv denota un dono da parte di un mortale, sempre di oggetti concreti, ma di eccezionale valore o rilevanza: P 196 (Peleo a Achille: afA.f3Qom "tEUXta), X 51 (Alte alla figlia: JtoÀ.À.a, come dote). Anche questi due luoghi dimostrano il persistere del più banale significato di «dare, regalare»33
•
Nell'Odissea non troviamo il senso di «inseguire, urgere», evidentemente sentito ancora come proprio dell'ambito bellico. Non poche sono, invece, le attestazioni del significato di «dare come compagno», nei contesti più svariati: t 90 = x 102 (xi)Quxa), x 204 (àQx6v) , v 68 (OfA.c.piJv), o 310 (TJYEfA.OVa), u 364 (:n:ofA.Jtijaç). A questi è da aggiungere x 59, ove ritroviamo il verbo in diatesi media, col significato di «prendersi come compagno» (xi)Quxa xal haiQov). Come si vede, si tratta quasi sempre dell'attribuzione di una figura «istituzionale» (sfugge solo v 68), creata o meno che sia sul momento: anche in u 364, con la
32. È chiaro che PLTJv, quale oggetto di Òlta!;,Etv in H 205 (insieme a xiiùoç) , è, invece, perfettamente congruo. 33. Va rifiutato, nell'Iliade e in tutte le occorrenze seguenti, il significato di «seguire, accompagnare», con cui talvolta il verbo viene reso. In ciò si distingue Mazon, nella sua, peraltro ottima, traduzione america (cf. ad e 103, 341 e A 493). I suddetti significati sono degli apparentati rno~-tm e ÒltTJÙÉOO, la cui differenza morfologica da Òlta!;,oo ne riflette anche le differenti valenze semantiche. Per la MAWET cit., 167, il significato di 'dare' per Òlta!;,EtV è dovuto a <<Une extension de caractère poétique , par rapport à la valeur étymologique, et propre essentiellement à la langue épique ou artificielle>> (corsivi dell'autrice). Se l'estensione semantica sia peculiare della lingua epica (almeno questo tipo), non sapremmo dire, comunque la Mawet avrebbe potuto rintracciare nell'epicissimo xiiùoç Òlta!;,Etv la probabile origine della suddetta estensione . La costellazione divinità- privilegiato beneficiario- concessione di uno straordinario «compagno>> (appunto il xiiùoç) si prestava facilmente ;al passaggio di Òlta!;,nv dallo specifico 'far seguire' al divino, eccezionale , ma generico 'dare'.
66
sarcastica evocazione di rco~J.rcfiaç da parte di Teoclimeno. Tale valenza, riconoscibile nel JTO!LJ'COV e J....aòv òrca~ELV dell'Iliade, non trova, invece, rispondenza nell'uso con diatesi media del verbo nello stesso poema (K 238, T 238), dove si tratta di generica scelta di un compagno. Tuttavia, una profonda concordanza tra le occorrenze iliadiche e quelle odissiach~ si trova nel trattarsi quasi sempre di una «missione» di qualche tipo, normalmente ambascerie o sopralluoghi. Se un uso nasca dall'altro; è impossibile dire: piuttosto, si può ipotizzare che il verbo nel senso di «dare, prendersi come compagno» marcasse atti formali di designazione da parte di un capo (di cui non ci è possibile delineare in dettaglio lo status )34
.
Restando alle occorrenze del verbo con soggetto mortale, si rileva come nell'urbana atmosfera dell'Odissea si sviluppi un uso sconosciuto all'Iliade: l'òrca~ELV di doni ospitali. Così è in ò 131s. (Alcandre a Elena), 619. (Menelao a Telemaco), {} 430 (Alcinoo a Odisseo), v 120s., 304s. (i Feaci a Odisseo), o 119 (Menelao a Telemaco), w 283. Tale serie, rappresentata nella Telemachia (e propaggini), nonché nei notoriamente tardi {} (con propaggini) e w, non sembra scaturire dall'elaborazione di passi, già riconosciuti secondari, quali quelli iliadici di I 483, 8 491 e X 51, dove, pur non trattandosi di doni ospitali, abbiamo analoghi esempi di gesti di liberalità. Piuttosto, la suddetta serie sembra avvicinarsi al significato originario del verbo, «far seguire». Infatti, com'è spesso esplicitato, i doni si offrivano al momento del congedo, si «facevano seguire», si «davano come compagni» da parte dell'ospite, al momento dell'intrapresa del ritorno, come buon «Viatico». Apparenta bili più direttamente alle occorrenze di I 483 etc., sono, nell'Odissea, s 62 x:tfjmv (Odisseo a Eumeo), e cp 214 à.Mxouç x.aì, X.'tlJ!J.U'ta (Odisseo a Eumeo e Filezio)35
: il significato generico di
34. Cf. K. F. AMEis-C H ENTZE, Homers Odyssee, I 2, 190811 , 108 (ad x 102) : «Wo zwei Miinner mit oder ohne Herold gesendet werden, da ist eine fOrmliche Gesandtschaft verstanden» . G. A . PRIVITERA, Omero. Odissea, II, s.I. 1982,57, con la sua traduzione (<<e per compagna la felice concordia>>), allinea implicitamente !; 181 in questa serie di occorrenze. Tuttavia, il significato di <<dare come compagnO>> è utilizzato, abbiamo visto, in contesti ben determinati, per cui qui avremo il più comune (in seguito) significato di <<dare>>, <<donare» .
35. Del resto, non si tratta che di riprese formulari di E 491, di cui abbiamo visto, sopra, la maggior pregnanza, con una variazione ad hoc in cp 214, cf. A. HoEKSTRA, Omero. Odissea, IV, s. l. 1984, 198 (ad s 62). Tuttavia, non è forse solo in seguito a irriflessa formularità, che la rimarcata (da ònaf;etv) benevolenza di un dio verso un mortale in E 491 venga riusata nella più << umana» Odissea per il rapporto tra Odisseo e i suoi fedelissimi servitori.
«dare», «regalare» è qui del tutto consolidato. Particolare e inaudita è l'ultima occorrenza con soggetto umano nell'Odissea: in w 201s. si dice che çlitemnestra xaA.eJti]v M... q.rfi~-tLV ÒJt<lOOELI -thjAU'tÉQTIOL yuvm~(v . E la prima volta che si attribuisce a un mortale la capacità di òmil;ew un «oggetto» di tale portata: non si tratta più di ~ELvi}La o di 'X'ttll-ta'ta, bensì della potente ed estesa q:l'fi!-1-Lç, allo stesso tempo impalpabile e concreta, come sono, normalmente, solo le «forze» dispensate dalla divinità. Tale occorrenza, forse motivata dall'enorme impatto del comportamento di Clitemnestra, è resa possibile, evidentemente, dalla recenziorità di w. La sua problematicità, inoltre, appare dall'improprio uso di ÒJtét.l;ew, che, seppure sopporta qui il generico senso di «dare}}' non è, come in tutti gli altri casi similari, traducibile con «regalare», «concedere» 36 .
Otto sono le occorrenze di òJtét.l;ew, in cui il soggetto è divino: esse propongono, confrontate con quelle dell'Iliade, interessanti risultanze. Il dono del xiiùoç è sempre prevalente (tre volte), ma, nel complesso, gli oggetti si diversificano. Già le occorrenze con xiiùoç sono significative: nessuna è in contesto bellico, e, in particolare, in y 57 Posidone viene richiesto di xiiùoç òJtét.l;nv a Nestore e ai suoi figli: si tratterebbe, per questi, di un'acquisizione definitiva. Così come lo è il xiiùoç (insieme alla xét.QLç) offerto da Hermes Jtét.V'twv l àvl'tQroJtwv EQYOWL (o 319s.), e quello da Zeus a Telemaco, secondo quanto auspicato da Penelope ('t 161). Rilevante è il processo day 57 a o 319s., che costituisce affermazione generica, se non gnomica. Siamo in piena sfera etica, dove ci aveva forse già condotto il <pfi~-tLV ÒJtét.l;Hv di w 201. Qui la valenza iliadica di xiiùoç ÒJtét.l;Hv non è più riconoscibile, e lo stesso sostantivo è ridotto all'irrigidito significato di «gloria». Si delinea, invece, il nuovo utilizzo del verbo in ambito etico, a marcare altre donazioni divine, com'è attestato da ulteriori occorrenze: v 45s. ÙQE'tTJV ... l JtOV'tOL'YJV (gli dei ai Feaci), a 19 oA.Bov (gli dei: ulteriore affermazione di carattere gnomico )37
, l; 180s. 6~-to<pQOaUV'YJV (gli dei a
36. È più che probabile, anche in base alle considerazioni precedenti, una forzatura del divino xùboç òn:a~ELV (di cui si rintracciano alcuni elementi), con intenti , come si è detto, amplificatori.
37. L'è\À.j3oç, com'è noto, non ha esclusiva valenza di concreto possesso, ma implicazioni più estese, anche in ambito etico: basti vedere, ad es ., P . LÉvt.QUE, ""Oì..j3wç et la félicité des initiés" , in Rayonnement grec, Hommage à Ch. Delvoye , Bruxelles 1982, 114s., C. DE HEER, MAKAP·EYLJAIMQN-OABIO"l:·EYTYXHJ:, Amsterdam 1969, 12ss.
68
Nausicaa)38• Infine, tra i doni degli dei sono ò'(~uv (a Penelope e Odis
seo: 'ljJ 210), e, più materialmente, avÙQa 'tE xaì, olxov (a Nausicaa: ~ 181), e {}éamv àmùftv (Apollo a Demodoco: {} 498)39
'. L'ambito dell'òn:a~ELV da parte delle divinità si è, quindi, allargato, trasferito in contesti più generici, e, talvolta, leggermente spersonalizzato, come dimostra anche la sostituzione di {}EO(, come soggetto, alla divinità individuale(~ 179, v 45, a 19, 'ljJ 210: nell'Iliade solo Z 156s.).
Negli Inni omerici avviene una radicale semplificazione: delle otto occorrenze del verbo, nessuna ha soggetto umano. Del significato «far seguire», nelle sue varie accezioni, rimane solo un «relitto», decentrato rispetto alle affini occorrenze esaminate: esso è semanticamente plausibile, ma appare o artificiosa rielaborazione delle suddette occorrenze, o discendente da un utilizzo di òn:a~ELV altrimenti sconosciuto. Infatti, in HHerm. 120 si dice che il dio EQycp ù'EQyov on:a~E («faceva seguire opera ali' opera»). Per il resto, non si descrive o non si invoca (secondo l'uso innico) altro che doni dagli dei. In linea con l'Odissea, in HDem. 261 si parla della 'tL!lTJ che la dea concede a Demofonte, in HHerm. 477 del xiiùoç che il dio chiede ad Apollo di concedergli40
, e in HDem. 219s., in una nuova iunctura, dell'ò'ljJ(yovov xaì, aEÀmov figlio che gli à{}avamt diedero a Metianira41
• Le altre quattro occorrenze sono dirette richieste di favori da parte dell'autore dell'Inno alla divinità cui lo stesso è dedicato, e risultano, evidentemente, organiche al genere. Una volta viene richiesta XUQLV (cf. o 320) al canto (H. XXIV 5), tre volte {h)!lftQw (3(omv o (3(ov (HDem. 494, XXX 18,
38. L'ultimo luogo è, comunque, di certo espressione di una sensibilità tarda, cf. B. MARZULLO, Il problema america, Milano-Napoli 19702
, 341ss. Forte è la tentazione di stabilire la recenziorità anche di v 45 e a 19: di quest'ultimo si rilevino, oltre al menzionato carattere gnomico (inusitato, quindi), la sostituzione di ÒÀ.~ov al più concreto xtijmv (xtin.tm:a).
39. Per la prima volta il privilegiato rapporto che, mediante ò:n:a~ELV, si instaura tra la divinità e il mortale, riguarda un TEXVLTY]ç, pur particolare, qual' è l'aedo. Un segno, tra gli altri, dell'emergere nell'Odisseo dell'orgogliosa riflessione del poeta sul suo status, rispetto all'Iliade, cf. H . MAEHLER, Die Auffassung des Dichterberufs im fruhen Griechentum bis zur Zeit Pindars, Gottingen 1963, 21ss.
40. L'occorrenza è particolare, sia per essere l'unica <<concessione>> di xiiboç (sebbene, ormai, semplice <<gloria>>) da un dio a un altro, sia per il modo con cui essa avviene (esprimendosi Apollo con l'invenzione di Hermes: che ne riceverebbe gloria , dobbiamo supporre), sia per il significato , del tutto slegato dalle altre occorrenze epiche.
41. L'uso del verbo indica che Metianira si è sentita oggetto di un particolare beneficio divino. Il caso rientra tra quelli in cui ò:n:a~ELv designa il rapporto tra divinità e mortale, in narrazioni a carattere mitologico: ove si realizza integralmente il basico 'octroyer', cf. HESYCH. O 976 Ò:n:aaaç· XaQLOUJ.LEVOç.
XXXI 17): questi ultimi casi abbassano l'utilizzo del verbo a contesti, appunto, biotici, quali mai riscontrati in precedenza, segnalandosi anche per essere i primi riguardanti direttamente l'io poetante. Si osservi che negli Inni a Demetra, XXX e XXXI, le divinità dedicatarie sono preposte alla fecondità della terra, per cui ben s'intende tale richiesta. L'ò:rcaf;etv marca le particolari prerogative del dio. In definitiva, nella poesia omerica il verbo ha conosciuto un processo di netto distacco (annunciato già da alcuni passi dell'Iliade) da quelli che sembrano i suoi usi e contesti originali42
, con una finale affermazione del significato di «dare», «regalare», «concedere», quasi un'eliminazione degli altri sensi possibili, e, allo stesso tempo, un'apertura del verbo a utilizzi in nuovi ambiti. In Esiodo, quanto risulta dallo sviluppo colto nella poesia omerica è confermato: una sola occorrenza di ò:rcaf;eLV con soggetto umano, e sette con soggetto divino43
. Interessante è il primo caso, Th. 437s. vtxi]aaç ... xaÀ.Òv ae-frÀ.ov l QE'La <pÉQEL xa(Qwv 'tE, ,;oxeiim òè xiiòoç ò:rcaf;et: in effetti, qui ò:rcaf;av è traslato in un ambito, quello atletico, in cui, vedremo in seguito, avrà peculiare fortuna, seppure usato in maniera diversa. Così come xiiòoç che qui riconosciamo nuovamente, come nell'Odissea e nell'Inno a Hermes, nella sua irrigidita valenza semantica di «gloria»44
• Più rilevante è che l'ormai laicizzato xiiòoç possa essere oggetto dell'ò:rcaf;etv da parte di un mortale: arriva qui a compimento il processo arditamente iniziato con l'ò:rcaf;av <pil!J.LV da parte di Clitemnestra in w 201.
Delle altre sei occorrenze del verbo con soggetto divino, ben tre si concentrano nella descrizione delle prerogative di Ecate45
, e si applicano ai diversi contesti etico-economico (&~ov, Th. 420), bellico (vtXl]V, Th. 433), e, più pedestremente, venatorio (ayQl]V, Th. 442).
42. Parlo di contesti originari, in quanto la coerenza di molte delle occorrenze omeriche, particolarmente iliadiche, non mi pare dovuta solo a rigida formularità, o strettamente alla materia del poema (quella bellica, nel caso dell'Iliade). Tanto più che il prosciugamento semantico che constateremo nella produzione letteraria seguente all'epica, segnala che in questa il verbo dispiega le più ampie alternative espressive. 43. Tra queste ultime anche il fr . 58, l M.-W. w:naoav èn't~y[m:m, per il resto indecifrabile. 44. Cf. lBYC. SLG fr. 176,11 Page. Non sarà un caso che né il poeta di '1', né quello di {t, esprimano mai la gloria derivante dall'eccezionale prestazione atletica per mezzo di XiJboç Ò3tCl~ELV. 45. Tali accumuli, cui bisogna aggiungere il verso appena discusso, sono sempre sospetti: fanno supporre l'intervento di mediocri versificatori. Sulla discussa sezione, cf. M. L. WEsT, Hesiod. Theogony. Ed. with proli. and comm. by M. L. W., Oxford 1966, 276-80.
70
A questo punto è evidente la utilizzazione massiccia del verbo per caratterizzare la concessione divina: è il soggetto che lo marca, gli ambiti di utilizzo diventano sempre più svariati, in relazione all'intervento e alle prerogative stesse delle divinità. Così anche nello spurio Th. 974, dove è Pluto a concedere l'oJ..~oç (addirittura -c<j) ÙÈ -cux.6vn), in Op. 167s., dove si menzionano ~(o-cov e i}'frw separati dagli uomini, dati da Zeus agli eroi, e in Op. 474, ove oggetto di òm1~ELV è il sostantivo -cÉÀoç, il più onnicomprensivo tra quelli fin qui riscontrati46 . Si delinea, in Esiodo, una leggera forzatura: la divina «concessione» viene sciolta anche dalla relazione con un privilegiato mortale, molto più sistematicamente che nell'Odissea diviene una possibilità eventuale per tutti: si potrebbe dire che il verbo assume valenza pienamente «religiosa».
Pur in questa specializzazione semantica del verbo, riaffiora, in Op. 324, un senso direttamente ricollegabile a usi iliadici, ormai traslato in ambito etico: il pregnante xa-corca~n, infatti, resuscita il senso di «urgere», «serrare», «perseguire da dietro», applicato, in questo caso, a un'ineluttabile istanza negativa ( avmÙELrJ): sostanzialmente in accordo, da una parte, con analoghe immagini che vedono protagoniste le terribili Hybris e Ate47
, formalmente riecheggiando l'impeto bellico inarrestabile di eroi (E 334, e 341, P 462), ma, soprattutto, l'urgenza insopprirnibile di yijQa; (~ 321, e 103). Efficace la connotazione fornita dal preverbo xa-ca: òrca~ELv risulta, per la prima volta, composto, in ragione della felicissima soluzione di un'esigenza espressiva. Solo l'aggiunta del perfettivo xa-ca poteva dare al verbo il senso di «perseguire fino in fondo», e, quindi, «vincere» (come interpreta Proclo, ad L). Ciò dimostra la raffinata sensibilità linguistica di Esiodo, contraddicendo quanto afferma Wilamowitz48 a proposito del composto: egli ne rileva giustamente la motivata unicità, ma la giustifica con l'accantonamento, da parte del poeta, dell'etimologia del verbo. Esiodo ha, invece, se non altro obbligandosi a Omero, ben chiara la sfumatura intensiva e iterativa originaria di òrca~ELV, che corrobora espressivamente con xa-ca49
.
46. Esiodo correda, qui, il verbo con omcrfrev: forse non aveva perso l'originario senso di <<far seguire>>. 47. Cf. W. J. VERDENIUS , Commentary on Hesiod Works and Days 1-382, Leiden 1985, 93 (ad v . 142), su Ò1t7JOÉw.
48. Hesiods Erga, Berlin 1928, 80.
49. Cf. VERDENIUS cit. , 162. Altre occorrenze esiodee di Ò1ta~Etv sono state conget-
71
La forza centrifuga che abbiamo visto operante già nella poesia esametrica arcaica, continua e porta a compimento il suo cammino nella produzione letteraria successiva e prealessandrina. Questa ci offre quarantanove attestazioni certe del verbo50
, di cui ben diciassette nel solo Pindaro, e quattro (o tre: vd. n. 67) in Bacchilide: uno sbilanciamento a favore della lirica corale, che vedremo significativo. Inoltre , in soli tre casi, che abbisognano di particolare interpretazione, il soggetto di òm1~ELV non è divino. Infine, si stabilisce, senza eccezioni, il senso di «dare», «regalare>>, «concedere»: l'unica testimonianza in senso contrario (Soph. fr . 373, 5 R.) è, come si vedrà, inesistente51
•
La giambografia e la elegia arcaica e classica non recano traccia del verbo, se non nei «moralizzanti» Solone, Semonide e Teognide (o chi per lui) . Conviene, prima di tutto, considerare Sol. fr. 13, 74 W. xteùe6. ·roL t}vlJ"toi:ç wnaoav à:ttO.vamL. Tale occorrenza soloniana richiama direttamente, per genericità del soggetto, significato e carattere gnomico, a 19. Senonché, XÉQÙOç differisce da oA.{3oç, in quanto da una parte rispecchia una concezione etico-sociale della ricchezza diversa e nuova, rispetto a ciò cui s'applicava l'oA.{3ov òna~eLv omerico. In secondo luogo, l'intervento divino espresso con òna~eLV viene attribuito a tutte le piccole o grandi occasioni di xteùoç. Ciò, evidentemente, ulteriormente spersonalizzando e «svilendo» i contesti rispetto a Esiodo, trascina sistematicamente il verbo nella sfera etica, a diversi livelli, dandogli spesso, di conseguenza, la cifra gnomica. Non gnomiche, ma indicative di come òna~ELV possa marcare l'avvolgente tutela divina su una svariata serie di fenomeni, sono le invocazioni soloniane , in cui sono contenute le altre due sue occorrenze di òna~ELV . In una (fr. 19, 5 W.) , ci si augura xaQLV xal xiiùoç, da parte di Afrodite, per un ecismo cipriota, in un'altra (fr. dub. 31, 2 W.) "t'IJXl]V àym'}i)v xal xiiùoç, da parte di Zeus, per i itw!lOL da Solone stesso fondati . La particolare sensibilità soloniana per le istituzioni politiche è, evidentemente, alla base della scelta di òna~eLv: significativo ci sembra l'irrompere della mediazione attraverso un umano istituto, in quello che è sempre stato un ambito di rapporto privilegiato tra divinità e mortale, quello, appunto dell'òna~ELv: si tratta di un'ulteriore conseguenza
turate da Grenfell e Hunt in fr. 43a , 79 M.-W. , e da Vitelli in fr . 75 ,1 M.-W., ma esse risultano tutt'altro che sicure: cf. gli apparati ad l. 50. Le restituzioni congetturali del verbo in frammenti papiraceidi SAFFO (fr. 88a, 6 V.), BACCHILIDE (I 148 Sn.-M.) ed EscHILO (fr. 168, 12 R.) verranno lasciate da parte .
51. Il verbo è, contrariamente a altri poetismi, del tutto bandito dalla prosa, per quanto si è potuto verificare.
72
della g·~neralizzazione del suddetto rapporto 52. Altre «antropologie»
urgono, e, sia pure una sola volta, la richiesta «politica» di ò:ru11;ELV si ripeterà (cf. Pind. N. IX 29s.) . Si noti come la richiesta del nomoteta sia, anc:he, di x. ii o o ç òm11;ELV: la iunctura verrà invariabilmente evitata da tutti i poeti arcaici e classici, presumibilmente in quanto troppo obbligante relitto epico. Solone sembra, invece, coscientemente usarla, quale più immediatamente individuabile, elevata etichetta formale della d tvina benevolenza. Infine, la richiesta a Afrodite di ò:ru11;ELV Èo-frA.òv voatov è ulteriore ampliamento degli ambiti di applicazione del verbo, con un richiamo alla tutela che la divinità esercitava su Cipro.
Sulla falsariga gnomica, cui Solone ha dato definitiva legittimità, sono Theogn. 151 u~QLV (Zeus all'uomo malvagio), e v. 321 ~(ov x.al :n:A.oirwv (il dio all'uomo malvagio: protasi di un'ipotetica). È contemplato, tra gli oggetti dell'ò:n:a!;ELv, un fenomeno negativo (u~QLV): ulteriore dimostrazione della vasta sfera che il verbo può coprire, in ambito etico53 . Apparentemente simile era Sem. fr. 7, 71s. W., tuttavia piuttosto prodotto dell'enfasi sarcastica: l'ro:n:aoev con cui viene connotato il dono agli uomini, da parte di Zeus, della donna Èx. m{hlx.o1J , I.I.ÉYLatov x.ax.ov, appare sopra il rigo, per il contesto54
• Incontreremo ulteriori esempi di questa enfasi.
Gli altri frammenti lirici dell'età arcaica e classica sono ancora più poveri: oltre all'indecifrabile attestazione nell'adespoto SLG fr. 473 I 6 Page, ne troviamo un esempio ciascuno nei due grandi poeti lesbici. L'ò:n:aoòm saffico (fr. 58, 24 V.) non è, purtroppo, specificamente interpretabile (il testo è lacunoso) , anche se il contesto suggerisce il trasferir1ento del verbo in ambito erotico, ambito dove il dono, la concessione divina, in quanto espressi da ò:n:a~ELV, riceverebbero nuova pregnanza. Limpida è la nuova iunctura alcaica (fr. 206, 2 V.),
52. Diversa, applicata a :n:av"tc.ov/àvftgtbmov EQYOLOL è la xagLç (con il xiiboç) che viene <<istituzionalmente>> concessa da Hermes in o 320. Del resto, pare che il referente di Odi!:seo sia, per EQYOLOL, una ribalda destrezza. Non è escluso che il xiiboç iliadico, concesso agli eroi per eclatanti imprese belliche , sia qui maliziosamente <<riusato» (mu.:atis mutandis) per la picaresca impresa di Odisseo . Non per niente soggetto è Hermes
53. È un precedente 1'6'L~uv di 'ljJ 210 , che , tuttavia, non appartiene allo stesso ambito. Questf occorrenze smentiscono la pur prudente MAwET ci t., 168: <<ces verbes (se. 6:n:a~ELv e :n:ogEiv), au contraire de ò(òw~-tL, ne semblent pas qualifiés pour l'expression de dons dcifavorables ou nuisibles» (corsivo dell'autrice) .
54. Si nc·ti anche, come osserva MARG cit ., 25, come qui, nel giambo, sia per la prima volta citato Zeus, e quale elargitore di tal tipo di donne.
73
dov'è Atena che ro:ltetOOE tl-ÉQOOç: viene qui probabilmente rivitalizzata la funzione in ambito bellico del verbo, in maniera che si avvicina ad analoghe occorrenze iliadiche molto più rispetto a Hes. Th. 433 (vf:x.T)v ... òmxam)55 • Per quel poco che si può ricavare dai frammenti, i due poeti eolici non hanno prescelto il verbo per stantio epicizzare, ma lo hanno accuratamente selezionato per connotare determinati contesti, dar loro una aulica pregnanza, che solo il recupero mirato del verbo epico avrebbe consentito56.
Abbiamo detto che la lirica corale, con Pindaro soprattutto e Bacchilide, attesta quasi la metà delle ·occorrenze di Ò:lta~ELV riscontrabili tra Esiodo e la poesia alessandrina. Nel poeta tebano il verbo si trova esclusivamente negli Epinici, e non è ristretto ai contesti mitici all'intemo di questi: anzi, dodici casi sono reperibili nelle sezioni di «attualità», e solo cinque nel mito. In effetti, nell'ambito dell'ideologica celebrazione dei giochi panellenici, nella costruzione di un lessico che ad essa, e a quanto le era sostanzialmente complementare, fornisse la necessaria caratura aristocratica, quasi «mitica», l'epico Ò:lta~ELV non può che ottimalmente riattivarsi. Tanto più che l'ambito dei suoi oggetti si è, dalla Iliade, notevolmente ampliato, coincidendo con le esigenze di Pindaro, sempre esplicito e variato nell'affermare il glorificante rapporto verticale tra divinità e mortale57 •
Alle sezioni mitiche appartengono le occorrenze (con soggetto divino) di O. VI 65s. tl-T)oauQòv ()f.()u!J.Ov l JLCtvtoO"Uvaç (Apollo a Iamo), VII 50s. "tÉX,vav l :1taoav Èmxtl-ovf.rov ... aQtO"to:7t6vOLç XEQOÌ. 'KQet"tEiv (Atena ai Telchini), P. IV 107s. "tLJLclV (Zeus a Eolo e ai figli), I. VIII 38s. yÉQaç tl-E6JLOQOV 1 ... ya!J.Ou (gli dei a Peleo). Significativo è l'emergere del verbo in ambito tecnico (cf. i primi due luoghi citati): anch'essa, con molte altre, risultante formale, sia pur mediata, della meditazione sulla, e ideologizzazione della propria "tÉXVTJ da parte del poeta58• L'opera tecnica, compresa, ovviamente, la JLCtvtL'KTt, allivello
55. Quello alcaico (ttéQooç;) è oggetto che si apparenta piuttosto strettamente, sul piano dei contenuti e non, a xiiooç;. Talché sarebbero preferibili come loci similes omerici le occorrenze di xiiboç; ò:rta~ELV, piuttosto che Z 156s., addotto dalla Voigt. 56. Sull'occorrenza alcaica, cf. W. BARNER, Neuere Alkaios-Papyri aus Oxyrhynchos, Hildesheim 1%7, 97-102. 51. Fatto che, forse, provoca la netta persistenza del prevalere di casi con soggetto divino. 58. Per il cantore si può invocare, in quest'ambito, un esempio omerico, ovviamente dell'Od!Ssea: i} 498 chç; iiQa tO.L (se. a Demodoco) :rtQ61pQC.OV itroç; oo:rtaOE itÉa:rtLV
74
piil alto, è frutto del divino o:n:a~ELV. Questo costituisce organico componente linguistico del paradigma mitico esposto da Pindaro, appunto per le -réxvm. In linea più generale, l'o:n:a~ELV di questi quattro luoghi è quello già riscontrato in Omero, in casi di digressioni mitologiche, quando si narra di privilegiati rapporti tra divinità e mortali.
Alle gesta atletiche tocca il privilegio di sei luoghi: O. VIII 82s. À.LnaQÒV l XOOJ.tOV (Zeus al yÉvoç di Callimaco ), O. XIII 14 vLxa<p6gov ày~atav (le Ore ai Corinzi), P. VIII 64s. TÒ ... JA.ÉYLOTOV ... xaQJ.tUTrov (la vittoria nel pentatlo: Apollo), il nostro l. I 11 OTE<pavouç ... È!; àé1t).rov (l'Istmo ai Tebani), II 13s. 'L:n::n:OLOL vtxav (Posidone a Senocrate), l. III/IV 45 TOLU6E t'WV t'OT'ÈOVTOOV <p'ÙÀÀ'àmbciv ("Aoo<pOQOç). A queste occorrenze si aggiunga N. I 17s. '0ÀUJ.t:7tLa6rov <pullmç ÈÀ.mciv XQUOÉOLç l JA.LX-6-Évm (se. il À.a6v di Siracusa), con doppio oggetto, che verrà più opportumimente discussa infra. Si noti come, a patte un caso (vtxav l. II 13), nell'ambito atletico il divino ò:n:a~ELV si concentri su elementi conseguenti al gesto vittorioso vero e proprio, si · applichi alle sostanziali e palpabili ricadute a livello di «immagine» pubblica (l'ornamento, lo splendore, la gioia, le corone, i canti). In realtà, proprio quegli elementi sono ciò che rendono una vittoria atletica. acquisizione sublime nel curriculum di un aristocratico, ciò che viene «concesso» dagli dei è ben più di un eclatante exploit sportivo. Ricordiamo che tra i suddetti elementi c'è anche l'ode composta dal poeta: risulta evidente, che Pindaro, facendo di quelli l'oggetto dell'ò:n:a~ELV all'atleta, vi inserisca anche il suo contributo (cf./. III/IV 44).
Degli altri cinque luoghi dove si tratta di dono divino, uno è di ambito «politico»: in N. IX 29s. si invoca J.tOLQav ... rl!voJ.tov per gli Etnei, che con Solon. frr. 19, 5 e 31, 2 W. costituisce la sola richiesta di tutela politica espressa con ò:n:a~ELV. In Solone essa viene invocata per determinate istituzioni, in Pindaro si richiede più generica EUVOJ.t(a, che la relazione con la minaccia di guerra (cf. vv. 28ss.) rende direttamente «esistenziale», piuttosto che politica (cf. P. V 66s. à:n:ÒÀ.EJ.tOV ... EUVOJ.t(av). Comune pare la richiesta di ò:n:a~ELV stabilità, garantita dagli dei, più che dalle istituzioni stesse. In N. I 16s. si afferma che Zeus w:n:aoE ... l :n:OÀ.ÉJ.tOU J.tVU<JTiiQa ot (se. a Persefone) xaÀ.x.EVTÉoç l À.aòv 'L:n::n:mxJ.tov. Tale frase sembra porsi all'incrocio tra
lxmò~v. Ma esso è più isolato, rispetto all'inserimento delle due occorrenze pindariche nell'ambito di una valutazione della 'tÉX'VTJ· In o 319s. X6.QLç; e xiiboç; concessi da Hermes agli fQYa degli uomini si riferiscono a «opere» che non hanno niente a che fare o;on le 'tÉXVaL (cf. n. 52).
75
II 38 (- ~ 462) alla ò'O.Uov ì..aòv onaaaov, per l'ambito bellico, e I 483 x a( Il' a<pvELÒv e-&rjxE, noì.. ùv M jlOl ùmaaE ì..a6v, come segno di oì..j3oç. Un diretto richiamo al primo luogo omerico presupporrebbe una rivitalizzazione del significato di «dare come compagno>>. Tale significato, però, l'abbiamo visto perdersi dopo l'Odissea, e risulterebbe unico in tutta la produzione letteraria da quel punto fino all'Ellenismo. È probabile, invece, un'affinità diretta con I 48359
, per cui il bellicoso esercito sarà uno dei doni con cui Zeus ha onorato la figlia60
.
Ulteriori concessioni della divinità sono -cà "tEQnva (O. IX 28: le Cariti, in riferimento anche al canto del poeta), EÙÒ(av ... l Èx XEljl&voç (/. VII 38s., Posidone a Pindaro, quale voce dei Tebani), e -caç (se. àOLòaç) a<p{}ov(av .. ·1-llJ"tWç ajlaç ano (N. III 9: la M usa a Pindaro).
Anche il caso dell'Olimpica è classificabile, sia pur indirettamente, con quelli in cui òna~ELV è applicato all'ambito atletico. Solo che qui -cà "tEQ11:Va ha estensione molto ampia, e la mediazione, attraverso il canto del poeta, risulta più marcata. Interessante il caso dell'Istmica. In primo luogo, l'immagine in cui è usato òna~ElV è del tutto inedita, per il verbo: si giustifica in quanto si tratta dell'intervento di un dio nel suo regno, un segno di benevolenza che è anche di straordinario potere. Tuttavia, la singolarità dell'occorrenza non si ferma qui: l'immagine è interpretata come superamento vittorioso di uno stato di guerra61
, cui segue questa gloriosa vittoria atletica. Ma quanto immediatamente precede (v. 37 E-cì..av ÒÈ ntv{}oç où <pa-c6v) applica la metafora anche, e soprattutto, a un processo di pacificazione interiore62 .
59. In cui il sintagma wJ"taoE À.aov, come abbiamo visto, si era già corrotto nel senso di <<dare>>, <<donare>>. Altro evidente omerismo, nello stesso luogo, è J"tOÀ.Éf.lOU f.lVUatijQa, come già notato dallo schol. BDPU ad l. (III 14, 16 Dr.) . Tutta la frase è un compatto esempio di variazione della fissa dizione epica.
60. Significativa, in questa occorrenza, l'unione dell'ambito bellico, cui prima di tutto sembra appartenere òml.~ELV, con l'ambito atletico, ad esso eguagliato. È questo uno dei rari casi di òml.~ELV da un dio a un altro (cf. HHerm. 477): del tutto affine è, come vedremo, CALL. H. III 33. Per quanto inserito nella celebrazione della Sicilia, questo atto di divino ÒJ"ta~ELV rientra tra quelli che sanciscono mitologiche donazioni in contesti narrativi. 61. Cf. G. A. PRIVITERA, Pindaro cit. , 222s., e i paralleli da lui forniti per E'ÙÙLa e XEq.u:i>v con valenza politica o militare. 62. Non sembra che i termini in questione costituiscano metafore frequenti, in ambito arcaico e classico, per moti dell'animo: tuttavia, per XELf.lWV, cf. SoPH. Ai. 206. , per E'ÙÙLa PROTAG. fr. 9 D .-K., e, forse, PrNo. O. I 98 (pausa nei confronti di ulteriori ambizioni di vittoria?). Privitera e il suo riferimento, J. PERON, Les images maritimes de Pindare, Paris 1974, 299s., insistono troppo su quello che è solo uno dei livelli connotati dall'immagine: lo stato di guerra e, inversamente, di pace e vittoria atletica.
Ciò non significa che, in questo caso, si debba supporre un sorprendent(: ÒJta!;nv divino con effetti in interiore homine: è l'immagine marittima che ha preso il sopravvento sul denotato63
. Altra occorrenza rilevante, questa volta per le dichiarazioni di poetica pindarica, è quella della Nemea: con l'intervento della Musa, campo di applicazione dell'òJta!;ELV divino diventa, come in {t 498, l'attività del cantore. Risulta problematico a quale elemento della frase vada collegato aJto: se a omx.!;E, il senso sarebbe che la Musa dovrebbe, anamnesticamente, far emergere la «ricchezza di canto» accumulata nella f..t:i'j"tLç del poeta; se ad à~:p'l'tovi.av, si dovrebbe «costruire» oJta!;E à~:p'l'tovi.av àJtò f.Ltl"tLOç a~J.aç. Ovvero la Musa è invitata a fornire «ricchezza di canto» alla !J.finç; di Pindaro, da cui, poi, tale ricchezza dovrebbe sgorgare: un procedimento simile all'Èv ~:pgwlv OL!J.<lç l Jtavwtaç ÈvÉ~:puoEv del 'l'tcoç per Femio in Horn. x 347s. , dove, del resto, una varia lectio in Max. Tyr. XVI 5, XXXVIII l et Isidor. Pelus. IV 30 recita 'l'twl ÙÉ f.LOL WJtaoav Òf.LqJUç.
Nel poeta tebano, dove ÒJta!;nv ha trovato terreno fertile per un suo riuso, risultano anche due delle tre occorrenze di ÒJta!;ELV con soggetto umano, reperibili nella letteratura postesiodea e preellenistica. La prima, in ambito mitico, richiama , per l'oggetto, N. I 16s., e, di conseguenza, I 483, e quest'ultimo ancora più precisamente del luogo della Nemea: in O. IX 66, infatti, si dice che JtOÀLV ù'wJtaoEv (se. Aox.poç) À.aov "tE ÙLm"tav (se. a 'OJtùç) , un patente omerismo, per marcare , anche formalmente , le nobili origini della città64
. Estremamente interessante la seconda occorrenza, /. VI 66s .. .. Aa!LJtWV ÙÈ f.LEÀ.Éwv l tgymç ÒJta!;wv: la sentenza esiodea (Op. 412), pur applicata a un caso specifico, viene contemporaneamente elevata a paradigma (€Jto<;), traslata in un'aura, per così dire, metastorica, con la sostituziont: di òJta!;n v a ò~:pÉÀ.Àtt v65
.
63 . Forse ha ragione PERON ci·:. , a legare i due piani con la figura di Posidone, che è anche n:Qo<Tta'tl]ç delle gare is,miche . In questo caso, avremo un'ulteriore caso di òn:a~ELV applicato, seppur non direttamente, all'ambito atletico .
64. Per il passaggio dei beni, in regalo , dal padre al figlio, sono paragonabili P 196 et x 51. 65. A meno che, intendendo, come alcuni , i vv. 72s . quale riferimento all'eccellenza di Lampone come allenatore (già lo schol. ad 1.), non si interpreti f.tEÀ.É'tav òn:a~wv come un'esaltazione della sua abilità. Ma poiché tale amplificazione dell'abilità artigianale non avrebbe le stesse giustificazioni di quella presente in Eschilo (di cui tratteremo in seguito, p. 80s.), tenderei a rifiutare tale interpretazione. L'occorrenza sarebbe anomala rispetto al «sistema>> pindarico . Comunque , quanto afferma PRIVITERA, Pindaro cit. , 214, secondo cui l'immagine della pietra nassia non può indicare un Lampo-
77
A fronte dell'estrema diffusione e varietà nell'uso del verbo da parte di Pindaro, nel collega Bacchilide le occorrenze dello stesso sono poche (anche considerando la differente estension.e del corpus dei due poeti), sostanzialmente prolisse, e non molto originali. Nell'ambito atletico è VIII 28ss .... JtEQL x[Qa-tL t' ò]mi[oom]ç l yf..auxòv ... l av&T]!.I.'EÀ.ULUç66
, in quello etico xv 59s. UY(3QLç, a Jt~ov-ç[o]y MVU!.i.LV tE ... l à.À.À.6tQLOV wnaoEv, mentre generico augurio è in XVII 132 ona~E (se. ~aALE) tl-E6Jto!.l.nov Eotl-f..oov tuxav. Il t_utto suona alquanto elaborato e convenzionale: in particolare, la seconda occorrenza imita il pesante gnomizzare dei lirici arcaici, specificarp.ente Theogn. 321, mentre nella terza, la iunctura OJtaçE . .. tU XUV ripete quella altrettanto poco pregnante di Solon. fr. 31, 2 W. Si noti, sempre in XVII 130s. , l'affinità con le invocazioni inniche di òna~ELV (cf. pp. 000)67
• Infine, tra i pochi lacerti dell'epica arcaica e classica, solo in uno compare il verbo. In Panyas. fr. 17, 8 Bernabé, è l'aloa di Hybris e di Ate a dare xaxa agli uomini: siamo in un ambito che, fin qui , si è dimostrato piuttosto continuo, fra quelli cui òna~ELV è applicato: quello etico. In più, come in Theogn. 151 ne sono oggetto fenomcrni negativi: la «moralizzazione» del verbo, anche con questo esempio epico, appare estesa68 •
ne allenatore , poiché la cote affila solo metalli, è falso. La cote nassia serviva anche per levigare pietre nobili (cf. PuN. NH XXXVI 54, XXXVII 109). 66. Unica occorrenza negli epinici . 67. Del resto, HHom. XXIV 5, questa occorrenza bacchilidea, e ARI:sTOPH. Thesm. 972 (vd. infra, p. 82) sono state accomunate da N. J. R.iCHARDSON, The Homeric Hymn to Demeter, Oxford 1974, 323s. L'aggettivo l'tE6:rtoJ.Utov, che accompagna "tuxav, sembrò a Kenyon (F. G . K. , The Poems of Bacchylides etc. , London 1897, 174) <<appropriate in connexion with the literal meaning of o:rta~E, 'send usa companion'». Si potrebbe confrontare il :rtOJ.UtÒV 6:rta~ELV di N 416, Q 153 et 461 , ma un recupero bacchilideo di tale senso del verbo sarebbe isolato: è del tutto verosimile che il poeta intendesse l'ormai unico significato di <<dare, concedere>>. Insieme a questi tre luoghi, è da considerare il dubbio fr . 65, 2 Sn.-M. x]U6oç 6m'tooa"t[. Due sono le singolarità, una è l'unione con xii6oç, che, a parte Solone, è stata evitata generalmente (in ambito arcaico e classico) dopo Omero, in quanto, probabilmente, eccessivamente marcata: anche da Pindaro, nonostante xii6oç sia suo Lieblingswort (cf. W. J . SLATER, Lexicon to Pindar , Berlin 1969, 294: il termine compare solo negli epinici . In Bacchilide si trova in I 160, VI 3, X 17, sempre in epinici). In secondo luogo , se 6:rtaooa"t[ non cela un'inedita seconda plurale, si deve trattare di un medio, bandito dall'uso anch'esso dopo Omero e prima dell'Ellenismo. Ritengo che questi siano indizi per una datazione bassa del frammento , rispetto a Bacchilide. 68. Significativo, a indicare l'uniformità semantica raggiunta dal verbo, è Io svanire, anche nell'epico Paniassi , del senso di <<urgere da dietro>> , <<premere da dietro>>, che
Del periodo classico rimangono le occorrenze sceniche. In tragedia, alcun·~ di esse marcano situazioni di forte contenuto religioso e mitico: così in Aesch. Eum. 622s. Zeuç, .. .'tOVÙE X.QllO!J.ÒV w:n:aoE l <pgal;ELV 'Ogtcn:n , in Eur. Hipp. 44 e 890 per le àga( che Posidone concesse (quak ytgaç, v. 44) al figlio Teseo, come anche, qualunque soluzione testm.le si voglia adottare, in Eur. El. 119269
• Su questa linea è il peculiare Phoen. 157 4ss .. .. a'L~-ta'toç lijù11 '\jlllX,Qàv ì..mj3àv <pov(av, l &.v Èì..ax.' "Atùaç, w:n:aoe ù'"Ag11ç, particolarmente nella traduzione di L. Mc!ridier70
: «une sanglante libation de meurtre, qu'Hadès avait reçue, qu'Arès avait offerte». Un anello, forse, tra Horn. W 151 e le occorrenze ellenistiche del verbo nel senso di «offrire». Tra dio e eroe tragico c'è un rapporto esclusivo, marcato in questi casi da ò:n:al;Etv, nel b·~ne e nel male. Il contesto etico non sembra sussistere, o perlomenc risulta ancora più mediato, anche rispetto alle occorrenze pindariche. Oggetto è il fatto , di carattere «religioso», e di portata globale , che impregna il destino dell'eroe tragico: l'alta caratura del verbo viene utilizzata per elementi decisivi dell'avvenimento tragico, qualificando anche il suddetto rapporto, basilare nella costruzione del suo nucleo. Sostanzialmente, il privilegiato rapporto fra divinità e mortale, che avevamo visto espresso con ò:n:al;Etv, in brani di narrazione mitologica, divenuto centrale nel dramma, conserva uno dei suoi contrassegni.
Più generico, gnomico, ma sulla linea delle precedenti occorrenze è Aesca. Eum. 530 . .. :n:av'tt !J.Éoq.> 'tÒ xgamç 'ltEòç w:n:aoev . Più consuete le iuncturae di Aesch. Pers. 762 'tt!J.i}V (quella di regnare su tutta l'A-
Esiodo, in un contesto affine, aveva brillantemente sfruttato con xa'tona~n (vd. supra , p . 71) . Quando Paniassi vorrà esprimere l'incombere di irresistibili agenti etici, ricorro:rà a Òn'I]ÒÉw (fr. 18 Bernabé). Ancora <<moralizzazione» del verbo pare presentarsi i:1 un indatabile «epigramma», contenuto nella Vita Homeri Herodotea (1. 185 Allen 1, dove oggetto è xijea (all 'autore da parte di un'indefinita divinità) . Altra occorrenza epica di incerta cronologia è nel Certamen Homeri et Hesiodi, l. 274 Allen, dove Omero invoca eterno xÀÉoç da Apollo , come si addice al poeta. È immediatamente ' riconoscibile la sfumatura innica.
69. !)icuramente, comunque , non si può intendere wnaoaç con le valenze epiche (cf. ~ 321, E 334, E> 103, 341 , A 493 , P 462) di «urgere», «perseguire>>, «inseguire>> (da eLi la resa «cacciasti i sanguinosi letti dalla terra greca>>), poiché con àn6 il verbo non çotrebbe avere che il senso di «scacciare>> , del tutto assente dalle sue presunte matrid . Personalmente, preferiamo intendere, con ÀUXE' (Weil), <<Concedesti destini da as:;assino (a me e ad Elettra) , lontano dalla terra ellenica>> (cf. i vv. seguenti). ContiO òna~w = òtwxw si esprime anche J . D . DENNISTON, Euripides. Electra. Ed. with intr. and comm. by J . D . D ., Oxford 1939, 198. 70. H. GRÉGOIRE-L. MÉRIDIER, Euripide, Tome V, Paris 1950, 218.
79
sia), di Eur. Med. 424ss. 1'tÉomv àm&av (ciò che Apollo non concesse alle donne)71
. Ciò vale meno per Med. 516s., dove si tratta del dono, da parte di Zeus, di 'tE'XIJ.TJQLa per riconoscere l'oro falso. La singolarità di questa occorrenza è affine a quella di Sem. fr. 7, 71s. W. (cf. p. 73), applicandosi l'òn:a~Hv, in quest'ultimo caso, all'ambito antropogonico, in quello della Medea, potremmo dire al «creazionistico». Non si riesce tuttavia, diversamente che nel giambografo, a intendere compiutamente il significato dello scarto72
• L'Auctor del Prometeo utilizza, significativamente, òn:a~etv per i doni dell'archetipico benefattore dell'umanità: il fuoco (vv. 7s. e 252), e più generiche 'tLIJ.a( (v. 30).
Rimangono due particolari occorrenze eschilee del verbo, che ne dimostrano l'uso sapiente da parte del tragico, che opera con conscia e espressiva distorsione. In Sept. 256 Eteocle esclama: <h Zeli, yuvmx&v olov ron:aoaç yÉvoç: un'affermazione, che sembra sviluppare, in senso più generale, quella di Semon. fr. 7, 71 W., con cui condivide la forzatura dell'applicazione di òn:a~ELV all'ambito antropogonico . Anche qui si tratterà di un espressione sarcastica, con òn:a~Hv utilizzato per il suo usuale e solenne senso di benigno dono divino: come dire «bel dono ci hai fatto, Zeus, dandoci tal yÉvoç delle donne!}}. In conclusione, esaminiamo la terza e ultima occorrenza del verbo con soggetto umano reperibile nel torno di tempo qui esaminato. A proposito dell'artefice dello scudo di Ippomedonte , l'ayyeÀ.oç afferma, in Aesch . Sept. 491s.: 6 O'Y)IJ.a'tOuQyòç &'ounç eù'teÀ.i)ç aQ'~v ,/omtç 'to&'eQyov ron:aoev n:Qòç àon:t&t. Un tratto sarcastico è stato rilevato anche per questo passo73
, tuttavia la suggestione del resoconto dell'ayyeÀ.oç (vv. 486-500), barocco e terroristico, è che egli sia sotto l'impressione di un fenomeno quasi sovrannaturale: a questo livello innalza, con òn:a~etv, l'opera dell'artigiano autore dello scudo di Ippomedonte . Gli scudi, del resto, marcano emblematicamente (anche in senso letterale) gli assalitori di Tebe, fanno parte della sostanza mitica del rac-
71. Da tempo si è riconosciuta l'affinità con,'} 498. La ricezione pressoché integrale dell'omerismo non appare operazione più che formale. 72. Il verso si può , forse, spiegare facendo riferimento alla valenza etica che Pindaro dà all'oro, particolarmente nel fr . 222 Sn.-M. ~Lòç nalç 6 xgucr6ç. Inoltre, il verso potrebbe essere considerato come inserito in un'espressione dell' «umanesimo>> euripideo. Con il contrasto tra una divina, quasi «religiosa>> concessione relativa all'oggetto che i Greci consideravano più prezioso, e una lacuna qualitativamente di ben più ampia portata, decisiva sul piano esistenziale, riguardante il rapporto tra gli uomini. 73 . Almeno cosi sembra da intendere la menzione da parte di E . FRAENKEL, Due seminari romani di Eduard Fraenkel , Roma 1977, 59. La cursorietà di gran parte di queste note non consente, comunque, sicurezza assoluta.
8o
conto, talismani dotati di un senso molto superiore al loro status di manufattC4
•
Sofocle, pur 'O~-t'Y]QtXO.nm:oç75 , non conosce il verbo, se non nel problematico 01Jvona~Etm del fr. 373, 5 R. Dagli apparati non si capisce, se la forma sia o meno testimoniata dalla tradizione76
: in ogni caso, benché generalmente accettata, diverse ragioni militano contro la sua accettazione. Tra queste non è il trattarsi di un anas, né la mancanza del verbo semplice nel resto della produzione sofoclea, ma il confronto con i precedenti. La diatesi, infatti, rimanda ai luoghi omerid di K 238, T 238 e x 59, ove òna~Ecrfrm significa «prendersi come ':ompagno», e all'isolato A 493, dove il senso è quello di «essere pressato, spinto»: nessuno dei due sensi è applicabile al contesto sofocleo, non essendoci un oggetto che il nJ..:ijftoç si «prenda come compagno», né un agente che «incalzi>> lo stesso nÀijftoç (cf., del resto, v. 6 ot... tqrom). Dunque, si tratterebbe di un epicismo, isolato nell'ambito della letteratura postesiodea, di ordine sommariamente formale, frutto di un abuso o di un pesante fraintendimento dei modelli: sembra troppo per poteme fare carico a Sofocle 77
. È preferibile tornare al non d:scutibile 01Jf.UtÀa~Etm78 , che ha, tra l'altro, un séguito in Nic. Chon. Hist. p. 36, 28 v. Dieten.
74. L':lntÀLoev di D . L. Page, proposto in apparato , è meno singolare, ma anche molto riù banale.
75 . Cl. W . SCHMID, GGL I 2, 311 n. 6.
76. Nei deteriores, secondo quanto affermano Genthe (F. ELLENDT-H. GENTHE, Lexicor. Sophocleum, Berolini 1872, 704) e Nauck (ad fr. 344). Da parte sua, l'editore del test:.mone, K. JACOBY, Dionysii Halicarnasei Antiquitatum Romanarum quae supersunt. I, Lipsiae 1885, ad l., ha 01J~À.ét~e,;m, e nessuna indicazione in apparato, mentre Radt attribuisce 01JVo:n:étt,nm alla editio princeps, e aggiunge <<01Jf.L:rtÀ.ét~e,;m codd . , ut vid.>>.
77. Non si può dire troppo, ir mancanza dei contesti, di HESYCH. o 971 La. ò:n:a~Of.IEVm · bt6f.Levm. {}eqa:n:euo· Jom, et 980 La. ò:n:aooof.Levoç- àxoÀ.ou{)T]oaç. Non potendosi attribuire i glossemi a fnintendimento da parte dei grammatici (come sembra in x 1836 La., cf. n. 106), alla luce delle attestazioni fin qui esaminate, dovremmo supporre una rilevante abusio da rarte degli autori di questi residui lemmi: un'abusio che diff:cilmente si può immaginare per Sofocle, mentre, in altro modo, si verifica in Nrc. Ther. 813. Si veda, del resto, come Paniassi, in due variazioni sullo stesso tema, distingua ò:n:ét~nv <<dare>> (fr. 17, 9 Bernabé, cit.) da Ò:rtTJbeì.v <<seguire>> (fr. 18 Bernabé tx Y<lQ o t ·A l:TJç l:E xaì. 'Yj3qw; alo' <af.L'> ò:n:TJliEi). 78 . Come già afferma l'inascoltaLO GENTHE cit., 704 (s. v. 01J~À.a~Of.Lm) et 708 (s. v. 01Jvo:n:6~of.Lm) . Forse anche Jebb <!ra per 01J~Àét~nm, cf. A .C. PEARSON, The Fragments of Sophocles, II, Cambridge 1917, 45 . Bene fanno gli editori a relegare in apparato l'ò:tét~EL recato da un testimone (THEOPHIL. ad Autolyc. II 37) del fr. trag. adesp .
81
Delle due occorrenze aristofanee (uniche nella produzione comica), una (Eq. 200) è platealmente parodica della dizione epica (si tratta di un buffonesco oracolo): in particolare nella iunctura xiiùoç òn:a~EL, la più riconoscibile come omerica, se non iliadica. Nesso che, abbiamo visto, per lo più viene accuratamente evitato dagli autori fin qui considerati. La seconda attestazione è in contesto lirico (Thesm. 972), e si tratta di formale richiesta d'aiuto a Artemide (on:a~e ÙÈ VLXYJV), da parte del Coro delle Donne: la struttura innica avrà favorito tale sintagma, da considerarsi singolare per Aristofane.
Le occorrenze in ambito alessandrino, per quante si è riusciti a recensime, sono sessantanove, di cui due terzi (quarantasei) distribuite tra Apollonio Rodio (ben trentadue), il corpus teocriteo e Nicandro79
•
Sotto la spinta dello ~ijÀ.oç '0!-LlJQLXoç, e dell' abusio e fraintendimento del verbo, riaffiorano vecchi significati di quest'ultimo. In quella che è, probabilmente, una delle attestazioni ellenistiche più antiche, Moero, fr. l, 9 Pow., il sintagma è convenzionale (wn:aoe "tL!J.~v), come il soggetto (Zeus), ma che l'onore si applichi alle pur epiche (E 778) "tQ~QWOL n:eÀ.eLamv, è inaudito. Tuttavia, non si tratta che di uno sviluppo dell'òn:a~eLv, che caratterizza mitologiche concessioni: senonché, dal rapporto divinità-mortale si estende a quello eziologico, prettamente alessandrino. Questa di Moero è una delle poche occorrenze, in cui il dono divino non costituisce fatto o oggetto di particolare concretezza.
Le altre sono in Rhian. fr. l, 9s. Pow. oç ÙÉ XEV eùox{}fim, i}eòç ù'É3tL oÀ.{3ov on:a~e/ xal 3tOÀ.UXOLQUVLlJV, Hernìonax (?) 2 Pow. (p. 252) VLXlJV xal imÉQ"tEQOV ei'ixoç òn:a~eL (se. Zeus); AP IX 521, l oùx liQa OOL ye (se. Saffo) OÀ.L~OV Én:l XÀ.Éoç wn:aoe Moì:Qa80
• Sono stanche
493, 3 K.-Sn. Esso sarebbe, al contrario del presunto ouvoJta~Etm, semanticamente corretto e congruo con i precedenti (~tXTJ ÒJta~EL: cf. ~ 321 = E> 103 yi'jQaç ÒJta~EL, HEs. Op. 324 atb& M t' àvmbEtTJ xatol'ta~n), tuttavia, pare preferibile, per come si è sviluppato l'uso del verbo dopo Esiodo, ÒJtabEl, anche se si tratterebbe, forse, dell'unica occorrenza tragica di ÒJtabÉw, cf. E. FRAENKEL, Aeschylus. Agamemnon, Ed. with a comm. by E . F . , II, Oxford 1950, 222s. Per il vocalismo a, sospetto in trimetro giambico, cf. ÒJtaMç- ÒJtdwv, et G . BJòRCK, Das Alpha impurum und die tragische Kunstsprache, Uppsala-Wiesbaden-Leipzig 1950, 109s.
79. Di queste, non risultano interpretabili i lacunosi CALL. fr. 114, 22 Pf.; CERe. fr. 6, 13 Pow.; ep. adesp. fr. 3, 6 Pow.; hex. adesp. SHfr. 935,9 Ll.-J./P. Non si considereranno, inoltre, le restituzioni congetturali in CALL. SH257, 23 Ll.-J./P.; hex. adesp. SH 955, 7 Ll.-J./P.
80. Su APOLL. RH. IV 1026ss. etBION fr. 8, 1s. Gow, cf. pp:·85 et89. Per l'attribuzione dell'epigramma dell'Antologia, cf. H. STADTMULLER, Anthologia Graeca epigramma-
82
riprese, in ambito et-ico (Riano), o poetico (AP), anche di sintagmi precedenti81
. Si noti, in Riano e nell'Antologia, l'apparire in tmesi di un pmverbo (èn:l), a determinare il verbo. Dopo l'esiodeo xm;on:a~n (Op. 324), sono le prime attestazioni di composizione, e le prime in assoh:.to per òn:a~etv.nel senso di «dare», «concedere». Senza che, per questo, ci sia un apprezzabile arricchimento semantico: probabilmente, si voleva semplicemente rimarcare il rapporto verticale.
I poeti ellenistici, dunque, prediligono l'òrta~eLv di oggetti visibili e palpabili, a cominciare da Alex. Aet. fr. l, 3 Pow., dove è 'Héì.wç a rifornire i suoi cavalli di -thJ!-.1-iJQea MQrtov: l'apparente livello biotico è contwddetto dall'eccezionalità del mitologico mangime, che merita l'aulico òn:a~eL82 . Callimaco, coerentemente, sembra evitare il verbo, epicamente compromesso, e relativamente trito nell'uso: oltre all'indecifnbile occorrenza del fr. 114, 22 Pf., lo troviamo in H. III 33 et fr. 260, 59 Pf. Nel primo caso si tratta del dono a Artemide, da parte di Zeus, di tredici città: H. Herter ha individuato «riecheggiamenti delle promesse fatte da Agamennone ad Achille per placare la sua ira I 149ss.»83
, e se, come afferma Bommann, da ciò si doveva rilevare «come sul piano divino tutto si svolge con maggiore grandiosità»,
tum cur'l Planudea, III l, Lipsiae 1906, 519 (ad IX 521): lo dà ad Alceo di Messene, sulla base di XII 64,5 e XVI 8,8, ma aggiunge <<at res incerta, nec obloquor, si quis Dioscolidae indicare malit>>.
81. Non è, forse, senza significato che un'applicazione alessandrina, sia pur generica, del "erbo in ambito politico (la concessione di Jtoì..uxmgav(Tj in Riano), non investa istituzioni o città, come in Solone e Pindaro, bensì il destino di un uomo: presumibilmente, il dinasta. Su ciò, cf. M. M. KoKOLAKIS, PIANOJ: O KPHJ:. EIIIKOJ: TOY 3°Y n . X. AIQNOJ:, A8HNAI 1968, 23-38. Il contesto di Ermonatte (se di lui si tratta) JOn è dettagliatamente evincibile: precede xal otav xatà òe!;Là XELQÒç l ò.m:gémtn, si parla, con tutta probabilità, di OTJ!-LEia divini (cf. il testimone). L'oggetto eùxoç netricamente equivale a xiiùoç, di cui pare qui essere un sostituto, nel suo ormai e<)mune senso di <<gloria>>. Su Eilxoç equivalente a x.iiòoç in Omero dal punto di vista fmmulare, cf. L. C. MuELLNER, The meaning of Homeric EYXOMAI through its formula5, Innsbruck 1976, 108ss. \1uellner insiste unilateralmente sull'equivalenza semantica di eùxoç e xiiòoç in Omero. In realtà, la iunctura del secondo termine con ÒJt<l~ELY, mai attestata per eiJxoç, e le altre testimonianze del dinamismo di xiiòoç (cf. n. 31), lo distinguono qualitativamente e non <<secondariamente>> da xiiòoç. Solo nell'ellenismo sarà possibiie' la completa sovrapposizione, e, quindi, la novità di eùxoç ÒJt<l~En.
82. 0,) vale anche per il (3totov concesso da Zeus agli eroi nell'Isola dei Beati (HEs. Op. 167). Cf. la richiesta di ihl~-Ll]Qea (3totov e j3(ov ÒJt<l~ELV negli Inni omerici XXX u: et XXXI 17 (in quest'ultimo caso, soggetto è ancora Helios).
83. F . BORNMANN, Callimachi H 1mnus in Dianam. Introduzione, testo e commento a cura ci F. B., Firenze 1968, 21.
ÒJtU~ELv marcherà, anche formalmente, questa differenza di piani. Si noti l'affinità con Pind. N. I 16s.: la donazione sancisce la solenne attribuzione in ambito olimpico di una sfera territoriale alla singola divinità, che ne diventa tutrice esclusiva. Nel frammento, oggetto della «donazione» di Apollo sono gli ÈJtLXELQa. àyyeÀ.i.'l']ç, ovvero la nera pece che colora le ali del corvo, in seguito alla cattiva notizia da lui recata a Febo: null'altro che l'ambito mitico e l'origine divina del fenomeno sembrano giustificare l'utilizzo del verbo , in questo caso. Si noti anche che si tratta di una profezia, e il contesto eziologico, per cui con ÒJtU~ELV si determina e si sanziona la divina origine di un fenomeno e la sua immutabilità.
La solenne caratura del verbo si stempera nel recupero, da parte dell'amabile Teocrito, dell'urbana atmosfera della Telemachia e del soggiorno odissiaco presso i Feaci. Varrà la pena di rilevare, innanzitutto, che l'unico caso di ÒJtU~ELV divino nel corpus teocriteo si trova nello spurio Id. XXV 118s. 84 , dove Helios dà al figlio Augia il dono di essere à<pveLÒV f.LTJÀ.OLç JtEQÌ. Jtavn.ov ... àvùQffiv (cf. I 483 , S 491, X 51, e , inoltre, il carattere di narrazione mitologica del passo). Del poeta dell'Id. XXV, del resto, è stato riconosciuto come il suo ~ijì-..oç <Of..l'I']QUt6ç non sia quello di Teocrito85
. Le altre cinque occorrenze del corpus hanno come soggetto un mortale, come solo quattro volte (e in tre autori) si era verificato dopo Omero, e sono inserite in contesto «mondano». Di esse, quattro riguardano doni da un uomo a un altro, e, per la precisione, in tre si tratta di doni d'amicizia: in VII 128s. Licida ùma.ae il suo bastone a Simichida, quale ;ewf]wv Èx MOLaav86
;
in XXVIII 9 et 15s. è l'autore a regalare una conocchia d'avorio alla moglie dell'amico Nicia. Tali occorrenze richiamano diversi luoghi odissiaci (ù 131s., 619, lt 430, v 120s., 304s., o 119, w 283s.), non sfruttati dalla letteratura anteriore a Teocrito. In diversa situazione, ma ancora dono di un mortale , è quello che Tolemeo II Filadelfo dà come premio, per l'abilità nel canto, negli agoni sacri a Dioniso. L'utilizzo del verbo, per il regnante egizio , all 'interno dell'encomio teocri-
84. Sul componimento, cf. G . PERROTIA, Studi di poesia ellenistica (<<SIFC>> N. S. IV (1926]), in Poesia ellenistica. Scritti minori II , Roma 1978, 325ss. , e G . SERRAO, Il carme XXV del corpus teocriteo, Roma 1962. 85. Cf. PERROTIA cit. , 342. 86. Si rilevi, in quanto rilevante per il passo da cui siamo partiti (PINO. / . l 11), che la preposizione Ex. dipende da !;ELvr]tov, e non da wJtaoE (con cui , peraltro, non darebbe senso) : cf. A . S. F. Gow, Theocritus . Ed. with a transl. and comm. by A.S. F . G ., Il, Cambridge 19522, 163.
teo, dove Tolemeo è equiparato a uno Zeus terreno, ha divini ascendenti, ed è semidio, riacqdsta, rispetto ai casi erecedenti, perlomeno parte della sua valenza di divina concessione. E la prima volta che il verbo viene utilizzato con un mortale come soggetto, e nell'ambito della attualità, sebbene per marcare una sorta di aura divina: tale incastro non è possibile, eviden.temente, che nell'Ellenismo. L'ultima occorrenza, estremamente singolare, è, non a caso, in un carme non teocriteo del corpus: in Xi~VII 56 Dafni vuole òna~ELV un OWQOV (se. la mitra della fanciulla) ad Afrodite. Le parti qui sono rovesciate: è un mort:ùe a donare alla div inità, dimostrando che il verbo, da quello gene:~ico di 'dare', ha svi luppato anche il senso, ormai lontano da quelli originari, di 'offrire alla divinità', 'consacrare' . Gow (ci t. 485) data, ipoteticamente, il ce>mponimento alla prima età cristiana. In ogni caso, una testimoniar za ellenistica di questo sviluppo è in Simias fr. 2:>, l Pow. (il nÉÀ.Ex.u•;) , dove Epeo offrì (ò'maoE) la sua scure, com~:: OWQOV a Atena87
.
Il divino òna~ELV, che a·revamo visto nettamente maggioritario fino all'EJenismo, ma già in ~ 'eocrito praticamente assente, compare in Apollonia Rodio, ma, CO{.rentemente con il suo omerismo «spinto))' bilanciato da tutti gli altri 1si del verbo reperibili in Omero. Tuttavia, tra le tredici occorrenze di quel tipo, una sola è direttamente accostabile a luoghi omerici, ovvc ro quello in cui Medea, in un infelice accumulo, augura ad Arete che gli dei le concedano ~i.otov tEÀW<pOQOV, à.yì..ot'Y)v, na'ioaç e x.iiooç •t1toQ-th'Jtow n6À.YJoç (IV 1026ss ~ ). con cui si confrontano abitualmente~ 180ss. e YJ 148ss.88
. Delle altre occorrenze, s•:::i si commisurano alh materia dell'epos argonautico: in I 248s. , 885, II 690, III 75, e IV l 500 si richiede, a diverse divinità, il vootoç per i protagonisti dell'impresa, mentre in II 616 è Atena a concedere agli Argonauti di passare ildenni le Simplegadi. Il verbo marca, periodicamente, la tutela o la ·ichiesta di tutela alle divinità sull'impresa: non :;olo sul viaggio in sé, poiché il vootoç presuppone anche la felice riuscita.
In tre casi, l'ambito di utilizzo del verbo è quello dell'episodio mitologico: in esso, come si è 5pesso osservato, l'òna~Etv marca l'aspetto
87. È probabile che questo ser.so si sviluppi da 'P 151 I1atg6xÀ.cp ... x6~-t1']V ò;n;étom~-tt (se. Achille) q>ÉQEcrltm. Cf. anche EuR. Phoen. 1574ss.
88 . ::::f. H. FRA.NKEL, Noten zu den Argonautika des Apollonios, Miinchen 1968, 556, e E. LIVREA, Apollonii Rhodii A rgonauticon liber quartus, etc., Firenze 1973, 297. Per Fran~:el, sulla base di SoLON. fr. 19 W. , sembra profilarsi <<eine traditionelle Form»: in effett i, ritorna in Apollonio l'c rmai stantio xuùo; , appesantito dalla specificazione à;n;ogfh1toLO ;n;6À.T]oç.
ss
paradigmatico e «speciale» dell'avvenimento, l'eccezionalità dell'origine del dono, e, inoltre, il particolare rapporto rilevabile tra divinità e beneficiario. In Apollonia Radio, in tre digressioni mitologiche89
, il verbo ribadisce appunto questi momenti di particolare contatto tra divinità e mortale: in II 947s. si tratta di Zeus, che concesse a Sinope di preservare la verginità, in III 1181s. della giovenca che Apollo donò a Cadmo, perché questi ne venisse guidato, in IV 220s. dei prodigiosi cavalli donati da Helios a Eeta90
• A questi casi, reperibili in digressioni, Apollonia ne ha voluto aggiungere uno nel corso della narrazione principale: in I 721s. Giasone indossa un mantello purpureo, opera e dono di Atena91
• Il particolare rapporto della divinità con l'eroe trova conferma anche in questo, altrimenti poco motivato, òmi~ELV divino: a Giasone viene conferita la stessa statura mitologica dei personaggi digressivamente evocati dal poeta durante il racconto.
Le ultime due occorrenze di Ò3ta~ew con soggetto divino meritano particolare attenzione: in III 132 e 142 Afrodite promette a Eros di regalargli, come giocattolo, la palla con cui si trastullò Zeus bambino. Come in nessun poeta ellenistico fin qui esaminato, il verbo viene utilizzato in un quadretto, che coinvolge l'Olimpo nella più leziosa quotidianità. Lo scarto, che va oltre !'«urbano» uso del verbo attuato da Teocrito, svela ancora una volta l'alessandrino. L'atmosfera distanzia i luoghi apolloniani anche dal più solenne Cali. H. III 33, dove pure si tratta del dono da una divinità adulta a una bambina. Dileguatasi la Stimmung divina, e assente la nobile <ptÀ.i.a che caratterizza l'ò3ta~Etv tra i mortali, non sembra esserci nulla che giustifichi il verbo, in questo caso. A meno di ipotizzare l'abusio, dovremmo far intervenire una volontà quasi parodica del poeta, che avrebbe contrapposto alla levità della scena il solenne Ò3ta~ELV: dopotutto, si tratta sem-
89. Anche IV 220s., nonostante la brevità, può essere considerato tale. 90. Fuori delle Argonautiche, Apollonia si ripete in questo senso nella Naux.Qét"tEwç X."ttOLç (fr. 7, 3 Pow.), dove n (se. 'Qx.ueon) x.étÀ.À.oç à:rtELQL"tOV WltU<JUV 'Qem (cf. z 156s.). Tuttavia, il rapporto non è tra divinità e mortale, ma tra due esseri soprannaturali ('Qx.uQ6TJ è una ninfa), come, finora, solo nel singolare HHerm. 477, in PINO. N. I 16s., e in CALL. H. III 33. Ma le 'QQm appaiono, qui , figure stilizzate: nel frammento apolloniano non c'è il rapporto personale individuabile negli altri passi.
91. Per il significato, intimo, di questo dono, cf. H. FRANKEL cit., 99, 102. Può essere, come affermato da A. ARDIZZONI, Apollonio Rodio. Le Argonautiche. Libro l. Testo, traduzione e commento etc., Roma 1967, 190, che o:rtacrcrEV <<riecheggia, come puro suono, la clausola di X 441 (e:rtacrcrE), di cui è stato utilizzato .. . lo hemiepes (l>t:rtÀ.ax.a :rtOQ<pUQÉTJV)>>. Tuttavia, l'uso del verbo è più sostanzialmente motivato, come vedremo.
86
pre di Afrodite, di Eros, ~di un soprannaturale giocattolo! L'uso odissiaco del verbo per gli ì;Etvi}w, che abbiamo visto ripristinato in Teocrito, viene, ovviamente , assunto nell'omerismo di Apollonia: così in II 31s., 814s. e IV 1220, ~~ome in I 837s. oggetto dell'òml~Etv è l'ospitalità stessa. Tuttavia, la perdita delle valenze esatte del verbo provoca a busi, in casi di altre o I erte di doni: in I 325s. Pelopia dà una xaÀ.~v ùt:rt\axa al fratello Acasto, semplicemente perché si vesta, in I 675s. Ipsipila propone che le lemniadi offrano doni agli Argonauti, perché restino fuori dalle mura, e in III 909s. Giasone ne vuole dare a Medea per ottenere il suo aiuto . In questi due ultimi casi, ò:rta~ELV è utilizzato per doni volti a ottenere qualcosa in cambio (come, del resto, nei già considerati III 132 e 142) un uso che pare lontano dagli originari sensi di è:rta~nv92 . Ma l'abusù1 del verbo, nel senso del semplice 'dare', si estende ancora: in II 122~, III 180, 349 si tratta dell'eventuale concessione, da parte di Eeta, del vello d'oro, senza fare resistenza; in I 1351 dei Misi,che offrono QUO,.a a Eracle, per la perdita di Ila (precisamente, gli danno i figli migliori); in III 657 della VUf.t<:PlJ, che fratelli o padre danno allo sposo; e, inf ne, in IV 1108s., Alcinoo afferma che mai dariì ai Calchi il rampollc• (yEvÉ'frAl]V), che Medea porta in seno. Sono usi ~;variati, inauditi e stu )efacenti, che banalizzano il verbo, utilizzato semplicemente per il sue color epicus.
Le due ultime occornnze apolloniane, con ò:rta~EtV nel senso di 'dare', hanno come oggelto xiiùoç. Inutile dire che dell'iliadico xiiùoç non c'è traccia, come ormai da tempo: nel primo caso (I 345) è Eracle a intimare ai compagni che nessuno gli dia il xiiùoç di essere il capo della spedizione. Questa concessione di xiiùoç (ormai banale 'gloria') da un mortale all'altro, 1a un precedente solo in Hes. Th. 437s. , e corrpleta, nonostante il nitico contesto apolloniano, la «laicizzazione» del sintagma. Ancma più inaspettato è I 511 'tà (se. XEQauvoç, ~goni), O'tEQO:rti}) yàg ~Ll xiiùoç ò:rta~Et. Il soggetto di ò:rta~EtV non è, qui, né divino, né umano: la capacità di procurare xiiùoç è passata a «forze» strumentali. Quella che era, essenzialmente, una marca della liberalità e del favore divino o umano, viene disinvoltamente trasferita agli strumenti del poterE 93
. L' «integralismo» o m eri co di Apollonia,
92. Solo gli autori di HDe1~1. 494 e HHom. XXX 18 chiedono alle divinità di àrca1;ELv ~(m:ov -&u!J.i)Qw àvr'ù ùijc:;, ma il rapporto che si instaura è ben diverso (cf. pp. 69s.). Si veda , inoltre, come differenti sono l; 62 e cp 214, ove l'òrca~ELV da parte di Odisseo ai fedeli servitori itact si è in cambio del loro lungo e incorruttibile servizio: tutt'altro che strumentale, durque, ma espressione di liberalità. 93. La particolarità dell'occc.rrenza si riflette nella traduzione di E . DELAGE, in
benché, come abbiamo visto più volte, «personale», non tralascia anche le più rare valenze del verbo: in I 614s. è Cipride (anzi il suo x6J..oç atv6ç) a perseguitare, «urgere» Lemmo, e in IV 920s. malanni x:uvtEQa ... (}aurt~Qta V'YJWV attendono di perseguitare gli Argonauti (cf. L\ 321 , E> 103, 341): quest'uso non aveva riscontro dopo il xm:o:~ta~n esiodeo (Op. 324). Pienamente nella tradizione, che persiste, dunque, piuttosto salda, è l'uso, per òm!~ELV in questo senso, di soggetti rappresentati da forze (anche relativamente) impersonali, minacciose e irresistibili. Infine, il significato di 'dare come compagno' si trova in I 167: :1tai:6a 6'Èòv acpEtÉQOLOL xamyv~towt o:~taaaEv.
Si prosegue ancora con un poeta epico94, Euforione, il cui breve fr.
42 Pow., sembra indicare come egli abbia impeccabilmente ripreso l'uso omerico del verbo nel caso di doni ospitalj95
, uso che abbiamo visto gradito a Teocrito e a Apollonio Rodio. Riconosciamo l'alessandrino anche nel fr. SH 418, 25s . Ll.-J./P., dove si narra che Dioniso Melanaegis ò'maaE KEXQ0:7tt6mç la regione di MEÀ.mva[, contesa tra Beoti e Ateniesi. A tale episodio veniva riportata l'origine della festa delle Apaturie, per cui Euforione offre un ulteriore esempio di Ò:7ta~ELV utilizzato in ambito eziologico. Sempre in linea con usi ellenistici, ma questa volta concordando nell'abusio, è Euphor. fr. 140, 1s. Pow. (=AP VI 279, 1s.), dove Eudosso ct>o[~<p :7tatÒEL'YJV ò'maaEv àyÀaL'YJV: ancora un caso di umano òm!~ELV a favore di un dio, ancora una conferma, quindi, della presenza del senso di 'offrire', per cui cf. i già citati [Theocr.] XXVII 56 e Simias fr. 25, 1 Pow. L'epigramma di Euforione richiama particolarmente da vicino Horn. lJI151 , probabile origine di questo uso del verbo (cf. pp. ). Con altri autori, scendiamo alla fine del III e al II secolo, se non oltre96
•
F. VIAN , Apollonios de Rhodes. Argonautiques, Tome l, Paris 1974, 73: <<Ces armes qui confèren t à Zeus sa su prém a ti e». Il verso ha sapore esiodeo: cf. Th . vv . 71s. , 504-6, 707s., 853s. In realtà , l'occorrenza sembra anche riflettere l'uso emblematico che di tali segni del potere facevano i dinasti ellenistici. Per il simbolo regale del fulmine in età ellenistica, cf. KoKOLAKIS cit. , 29. -94. Tutte le occorrenze ellenistiche sono in poesia esametrica, eccetto THEOCR. XXVIII 9 e 16, e SJMIAS fr . 25, 2 Pow., ove sono coriambi , e [LYCOPHR.] Alex. 887 (trim. giam.). 95 . Tanto più se è vera l'ipotesi che egli si rifaccia a SOPH. Ai. 815ss., cf. l'apparato di Powell . 96. Incerta è l'età di Filone il Vecchio, la cui identificazione non è stabilita: cf. B. ScHALLER, Philon (9), in Der kleine Pauly , IV, Miinchen 1975 , 775 , col. I 42ss. Comunque è anteriore a Alessandro Poliistore (ca. 100 a. C.) : cf. il testimone dei frr. 681-6 in SH (pp. 328-31) .
88
Continuano a rimanere sporadiche, dopo la relativa e motivata impennata in Apollonio Ro:lio, le occorrenze di ÒJt<l~ELV con soggetto divino; la più pregnante pare quella di Philo Senior, SH fr. 682, 3 Ll.-J ./P., che nella sua (parziale) versificazione dell'Antico Testamento, ha colto, almeno formalmente, la connotazione divina del verbo: infatti, leggiamo à.'A./-..'6 (se. E>E6ç) !lÈV EV XELQEOOL XEQUO<pOQOV om:aoE XQt6v (se. ad Abramo). Si potrebbe supporre che il poeta giudeoellenistico abbia avuto come modello narrazioni mitologiche come quele di cui abbiamo visto molteplici esempi, dove l'esclusivo rapporto tra divinità e mortale, sancito da un dono, era marcato anche dall'uso dd nostro verbo. Delle altre tre occorrenze, due sono di Bione, frr. VIII ls. et XIV 6 Gow: la prima rientra, banalmente, nell'ambito del canto come dono divino, in cui òrta~ELV è poco sfruttato, ma con continuità97
, nella second1 si domanda a Afrodite perché abbia concesse• ad Eros di essere alato e arciere, e, quindi, ineludibile. Si potrebbe considerare l'occorrenza come una delle rare incursioni del verbo in ambito erotico98
, tuttavia i luoghi a cui essa può più strettamente apparentarsi sono Semon. fr. 7, 71s. W. 1:i)v ù' (se. yuvai:xa) EX rttt}.Ypwu· 'tOÙ'tO ÙÈ ùtax,?tùòv l ZEùç à.vùQaOLv !lÉytmov c:lmaoEv xaxé·v, e Aesch. Sept. 256 d) ZEù, yuvmxwv oiov oortaoaç yÉvoç. Essa si applica in ambito teogc•nico, senza però le connotazioni dei passi citati: l'uso del verbo sembra inteso a una frigida amplificatio.
L'ultimo caso è nel Pap Chic. II 14 Pow., un componimento dedicato a Arsinoe-Afrodite, .1on completamente intelligibile. Esso reca ;r:tQ6Jlaoa XQU'toùoa aù rtév1:ov òrta~ELç: un uso del verbo giustificato dall'::,poteosi della regina, applicato a un ambito del tutto inusuale, quell;:> del potere sulla natura. Si diceva, verosimilmente, che Arsinoe-Afrodite è in grado di 'concedere' un mare calmo. È confrontabile solo Pind. l. VII 38s. (cf. pp. 76s. ), al cui senso si rimanda per chiarire le :;annotazioni che può avere, per l'apoteosi di Arsinoe, attribuirle il gesto di òrta~ELV.
Le restanti occorrenze :;ono congrue con l'abusio apolloniana del verbo, in contesti di donazione umana: in hex. adesp. SHfr. 937, 34s. Ll.-J./P. è un ignoto che promette ad altrettali ignoti ErtUQXLa ÙW'tL''lJ[ l EX !lEYUQWV che un re òrtaod t], se lo seguiranno in
97. HoM. i} 498, PIND. N. III 9, EuR. Med. 425. Si noti come in questi tre casi si tratti di dicl:iarazioni di poetica, quasi <<biologica>> nel caso della Medea, mentre il passo di Bione è privo di qualsiasi pregn mza.
98. Anzi l'unica certa, anche s< è probabile che SAPPH. fr. 58, 24 V. trovasse in quel campo la sua applicazione . Cf. anche [THEOCR.] XXVII 56.
battaglia99. In questo caso torna l'òn:a~ELV del dono per avere in cam
bio qualcosa, come, appunto, in Apollonio Rodio: un uso, come si è già considerato, alieno da quelli originali del verbo. In Mosch. Eur. 41s., è Telefassa a donare un cesto d'oro alla figlia Europa: un atto di donazione tra mortali che non corrisponde a quello canonico di òn:a~ELV, riservato, come abbiamo più volte visto , ai doni ospitali o di amicizia. Esso non è, comunque, isolato, ma assimilabile, per la preziosità del dono, a Apoll . Rh . I 325s., altrimenti bisogna ritornare a Omero (P 196, X 51)100
. Un'ulteriore attestazione di uso anomalo del verbo è in [Lycophr.] Alex. 886ss., dove Medea 'offre' un cratere a Tritone, come ringraziamento per l'aiuto concesso agli Argonauti nel ritorno. In contesto decisamente biotico, goffamente ornato con rari epiteti e sostantivi, è Maiistas 32s. Pow. xaì. oon:aoEv (se. lo stesso Maiistas) àeyuea!-LOL~òv l 'tL!-LtlV, oii X'tÉUQ EOXE: per comprare un libretto. E ciò, nonostante l'atto sia funzionale al gesto profondamente religioso della costruzione di un tempio per Serapide 101
.
Concludiamo con l'«orgia» epicistica di Nicandro: eliminato, si direbbe per ragioni contingenti, dalle sue composizioni l'uso di òn:a~nv con soggetto divino, quello dei contesti di donazione ospitale o di amicizia, e vari altri, non riducibili al contenuto di Theriaka e Alexipharmaka, al poeta didattico non rimane altro che assumere in maniera disorganica questo elemento della dizione epica, le cui occorrenze in lui costituiscono un vero e proprio tripudio dell'abusio. L'unico caso che si inserisca correttamente nella tradizione del verbo, è in Ther. 356 .. . trvr]•oùç ùf. xaxòv JtEQÌ. yijeaç òn:a~EL, ripreso da ~ 321 e e 103, con la variazione, che abbiamo visto ellenistica102 , del preverbo in tmesi.
Sulla stessa linea della «preziosa» ripresa di sensi del verbo da tempo obliterati, sono Ther. 59s. •fi~-Loç ÙÈ n:o'ta!-Loì:o n:oì.ueeayÉoç xmà ÙLvaç l 'ÙÙQrJÀ.TJV XUÀ.U!-LLV'frov Òn:a~EO X<lL'ttlEOOUV, V. 520 XUL 'tQLO(jllJÀ.À.OV Òn:a~EO XVW'\jJÌ.V <ÌQWyi)V, e Al. 402s. O'taÙLrJV E'Ùav'frEU vaeùou l QL'frl.ùa {}uì.ax6woav òn:a~EO. Inquieta il medio, che rimanda al significato di 'prendersi come compagno' (K 238, T 238, x 59): non meraviglierebbero, nell 'involuto Nicandro, esortazioni a «pren-
99. Sulla datazione dell'adespoto, cf. l'apparato in SH. 100. In Mosco potrebbe trattarsi di opportuna variatio, dopo il :n:6QE .. ./ .•. :rt6QEV dei vv. 39s. 101. Sulla velleitaria dizione di Maiistas, cf. l'apparato di Powell. 102. Cf. RHIAN. fr . l, 9 Pow., AP IX 521 , l.
90
de n i come compagno» il xaÀ.a!.u vitoç e il 'tQ(mpuÀ.À.oç103. Tuttavia ,
anche altrove (Ther. 813) , il poeta usa incongruamente il medio, cosicché si può intendere ò:rtasw come «procùrati», dal generico senso di 'dare' (lett. 'datti'), sEnza più legame con i peculiari contesti che abbiamo sottolineato in Omero. Eguale processo si incontra nei casi imrrediatamente raggruppabili sotto il senso di 'dare': in Ther. 775 e 813 (qui con l'inaudito, in questo senso, medio òn:ase'tm) e Al. 398, il verbo denota l'atto di procurare agaùov xaxov' xfjga, e j3ag'Ùv !J.OX:~ov agli uomini da parte di animali tossici (scorpione, scolopendra), o veleni ( <pagLxoç) 104
• Singolare è l'ultima occorrenza nicandre<J ' Al. 270 vdmgav 'tÒitL oagxa (se. della castagna) JtE(IL oxuÀ.oç ailo·,. òn:asEL. Qui, come in Ther. 356, troviamo il determinante prevert:o n:eg( (in tmesi), ma , culmine dell'artificiosità, viene ripetuto anche il senso: la buccia interna della castagna 'pressa d'intorno' la polpa del frutto. Se per una volta Nicandro , in Ther. 356, pur sovradeterrr.inandolo con JtEQL, si era limitato a recuperare integralmente un sint<.gma america quale yfjgaç òn:a~EL, non ha perso altrove l'occasione per riciclarne, abusivamente, il senso. In una frase, tra l'altro, in cui h sfumatura essenziale del verbo di «urgere da dietro>>, già pregiudica :a da JtEQL, viene completamente persa. Abbiamo voluto esaminare tale verso nicandreo, ci1e sarebbe classificabile con Ther. 356, alla fine della trattazione, poiché dichiara quanto nel Colofonia, oltre ogni poss ibile esperimento metaforico, il verbo è stato definitivamente snaturato, e utilizzato come pura forma.
A questo punto, appare sufficientemente definito il carattere di òn:a:;ELv, soprattutto in relazione a una corretta lettura del passo pindarko. Che il vocabolo non tolleri normalmente supporti preverbali , è chia:~o: lo troviamo solo in alcuni abusi ellenistici (ma sempre in tme~i) 105 , e nella solitaria ricorrenza esiodea di xa'ton:asn (Op. 324) , che abbiamo visto giustificata, tuttavia, da particolari esigenze espres-
103. Ciò soprattutto nell 'indamento a prendere il 'tQLcrqmÀÀov come xvw'ljllv agwy~v .
104. In Al. ritorna il preverbo in tmesi : in questo caso , btl. A questi singolari sintagmi è 1ffine quello della seconda redazione , versificata, del giuramento di Ippocrate (Hip[. ·Ocr. I l = CMG I l, ed. I. L. HEIBERG, Berolini 1927' 5, 15s.-6, l) o'ÌhE nç av OOOQO ~ç IJ.E .. ./ ... n:ELOELE ... Ò.VÉQl <pUQIJ.UXU oouvm/ .. ' 't<l3tEQ xax6'tT]'tU {}u!J.ocp·Mgov oLOEv òmil;Etv (<<aetatis Christianae>> , LLOYo-JoNEs/PARSONS, in app. ad HELIOD. fr . 471 , : -7, SH p. 240) . 105. Cf. RHIAN. fr . l, 9 Pow., AP IX 521 , l , Nrc. Al. 398 (~n:t) ; Al. 270, Ther. 356 (n:EQLI .
91
sive (cf. pp. )106. Altrettanto rare risultano le preposizioni connesse
col verbo: riguardo all 'ablativo E;, in questione nel presunto E;wnaOEV del nostro Pind. l. I 11, esso dipende da ò:n:a~ELV, forse, solo in hex. adesp. SH fr. 937, 34s. Ll.-J./P. E:rtUQXta ùonLVTJ[ /Ex !J.EYUQWV ò:n:acr~[t], mentre à:n:6 potrebbe essere legato direttamente al verbo in Pind. N. III 9 àcp{}ov(av ò:n:a~E !J.tl'tteç c:lj.Laç a:n:o (cf., tuttavia, p. 77) . Invece in Pind. l. VII 38s. e Eur. El. 1192, EX XH!J.Wvoç e à:n:ò yaç 'Eì-.ì-.av(ùoç costituiscono sintagmi in sé conchiusi, in cui la preposizione risulta indipendente dal verbo, come, del resto, in EX Mowav di Theocr. VII 129 (cf. n. 86) e E; àéttì-.wv di Pind. l. I 11. Il sintagma conclusivo del nostro passo, mEcpavouç E; àéttì-.wv costituisce, pertanto, schietta perifrasi per 'vittorie': lo si può confrontare con O. VIII 59ss. xaQtv ex :n:ayxQa'ttou (EQém), v. 64 Es LEQ<Ì>V àéttì-.wv M;av (cpéQEtv), e XII 17s. mEcpavwcra!J.Evoç l xal ùlç Ex Iluftwvoç107
• Tale caratteristica, ovvero la mancata segnalazione della provenienza, oltre al soggetto, dell 'oggetto di òna~Hv, sembra scaturire dai sensi originari del verbo: sia 'urgere, pressare (da dietro), inseguire (con insistenza)', che 'far seguire, dare come compagno' non tollerano specificazione ablativa. Quando il soggetto è divino, il dono in effetti non ha luogo d'origine, non scaturisce se non dalle risorse astratte, immaginarie, costitutive del dio stesso: soprattutto quando il dono , come spesso avviene, non ha carattere oggettuale. Qualsiasi indicazione ablativa,
106. Non è, quindi , automaticamente utilizzabile per giustificare l'eventuale hapax pindarico: quest'ultimo non sarebbe altrettanto motivato. Anzi, non lo sarebbe per niente. A onor del vero, di xm:om:11;Etv fornisce due ulteriori testimonianze Esichio: x 1836 La. xm:om1t;EL · àxoì..ou-ltEi, che viene, tuttavia, ricondotto al passo psiodeo (sarebbe meglio, quindi, correggere, come Schmidt, in -n lemma e interpretamentum), nonostante l'evidente fraintendimento nel glossema (errore dell'interprete di Esiodo, o lemma di uno scorretto imitatore?), e x 1837 La. xm:o:rtétt;wv· bL<i>xwv, di origine ignota. In ogni caso, questi lemmi, sia o meno il primo attinto da HEs. Op. 324, non mutano la situazione riguardo al presunto È~omacrEv , poiché rimandano direttamente al modello esiodeo. Il sofocleo auvo:rtétt;E'taL (peraltro non utilizzato da Privitera) è risultato altamente improbabile, come anche il cruvo[:rta1;6f1EVOç--], congetturato in un'iscrizione da G. SEURE, /nscriptions grecques du pays des Astins, <<REA>> XXXI (1929) 311.
107. Cf. W. J. SLATER, Lexicon to Pindar, Berlin 1969, 158, sect. C(~) . Non intende il carattere del verbo THUMMER cit., 12, quando afferma che il significato di <<far seguire>> era ancora sentito da Pindaro, come dimostrerebbe la preposizione È~ . Quanto ciò sia errato, si vedrà subito. Morfologicamente, si ha una coalescenza dei due elementi del sintagma in É~a-ltì..oç : un atleta <<in pensione>> in LuciAN. Lex. 11, un atleta squalificato in schol. HoM. u 76. Su ÈV Cxf!E'tÉQ~ yvÙ>f!~ .. .l oo:rtacrE di Eu R. M ed. 424s., cf. KOHNER-GERTH, I 406.
92
per l'azione di òrta~nv, 1 :mtraria all'esclusiva indicazione del soggetto divino, non apparirebt ~congrua con la meravigliosa forza e «autarchia» della divinità. Cosi< ché, per interrelate ragioni sostanziali e formali, un composto come !;oonaoev risulta molto più che improbabile. Il supposto analogo seg talato da Privitera in Hesych. e 4004 La. è!;oorta~ev, rispecchierà, • 'ertanto, la lezione degli aristarchei nel luogo pindarico: cui s'attag ia perfettamente anche l'interpretamentum È!;Értell3teV108
.
EMANUELE DEITORI
108. A proposito della glossa, fH. BERGK, Pindari carmina, Lipsiae 18784, ad/. I 11
affermava: «spectat piane dive1 .um vocabulum, quod in Cyprio titulo indagavi>>. Di questa iscrizione cipria non re! a traccia. Sui termini ciprioti è!;wmoc:; e xm:omàv, O. ScHROEDER, Pindari carminr. Lipsiae 1900, 346, rimanda a H . L. AHRENS, Zu den kyprischen Inschriften, «Philol. XXV {1876) 58{= KS I, Hannover 1891, 226), che non ha alcuna relazione con la ostra glossa. Essa è riferita a Pindaro dal solo Snell, tra gli editori del poeta. Alberti ! Schmidt tra gli editori di Esichio, e Turyn tra quelli di Pindaro, la segnalano a conf1 mto. Che il lemma sia all'imperfetto, si può spiegare con la somiglianza di zeta e sig1 .a maiuscole. L'interpretamentum si sarà adeguato al lemma corrotto.
93