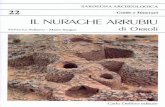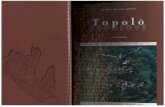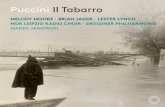Paola Italia, Savinio, Soffici e la politica culturale del fascismo nei primi anni Venti: «Il...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Paola Italia, Savinio, Soffici e la politica culturale del fascismo nei primi anni Venti: «Il...
1. Piccola guida alla mia opera prima [1947], Hermaphrodito e altri romanzi, a c. diA. TINTERRI, Milano, Adelphi 1995, p. 925. Sui medesimi eventi Savinio tornerà nel1951 in Città del mio destino, «Corriere d’Informazione», 16-7 luglio 1951 (A.
PAOLA ITALIA
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALEDEL FASCISMO NEI PRIMI ANNI VENTI:
«IL NUOVO PAESE» E IL «CORRIERE ITALIANO»
Il primo fascismo e l’organizzazione della cultura
Ad Alberto Savinio è capitato, come a pochi altri letterati italianisuoi contemporanei, di vivere ‘in presa diretta’ i primi anni delfascismo, trovandosi coinvolto, suo malgrado, in vicende politi-che di portata nazionale. Lui che, assorbito esclusivamente dallapropria vocazione artistica, aveva attraversato il primo dopo-guerra, dal radiosomaggismo al biennio rosso, come «Fabriziodel Dongo a Waterloo»:
La guerra era finita ma la mia classe era ancora sotto le armi, onde l’am-ministrazione dell’esercito, non sapendo che farsi di me, mi aveva manda-to in forza alla censura militare, che aveva sede a Milano, nell’ultimo pia-no del palazzo con tanta gentilezza disegnato da Piermarini. Da quell’ec-celso osservatorio, tra il 1918 e il 1919, io vidi i tumulti onde uscì il fasci-smo, come dal sommo di un colle si vede l’agitarsi degli uomini nella val-le. Talvolta, a fine di cogliere un particolare, scendevo in piazza. Ma lemani in pasta non le misi mai. Che posso farci? Non sono uomo d’azione.Se qualche uomo d’azione ha qualcosa da ridire, io gli rispondo: «Si provilei a fare quel che faccio io». Gli uomini d’azione non hanno i «diritti»che ho io, uomo non d’azione, meglio uomo di là dall’azione, meglio an-cora uomo dall’azione superiore. Perché dividere ancora gli uomini in uo-mini d’azione e uomini... come chiamarli: di meditazione? [...] Quindicianni dopo, un pomeriggio, nella villa di un amico, a Blevio, un uomo pic-colissimo di statura ma fornito di una barba molto folta e molto lunga,narrava tra sandwiches e cocktails certi atti di grande ardimento da luicompiuti a Milano, non so se nel 1918 o nel 1919, nella «battaglia di viaMercanti». Io ascoltavo. E mentre il barbuto omino parlava, si apriva da-vanti a me come un quadro. Rivedevo i luoghi, rivedevo gli uomini, rive-devo i fatti. Anch’io dunque mi ero trovato alla «battaglia di via Mercan-ti». Ma non me n’ero accorto. Come Fabrizio del Dongo a Waterloo1.
SAVINIO, Opere. Scritti dispersi tra guerra e dopoguerra (1943-1952), introduzione di L.SCIASCIA, a c. di L. SCIASCIA e F. DE MARIA, Milano, Bompiani 1989, p. 1381): «Dal’ultima finestra del braccio destro di palazzo Reale, un po’ pigiando su lettere del tut-to prive d’interesse il timbro “Verificato per censura”, un po’ buttando un occhio nel-la sottostante piazza del Duomo, seguivo gli scontri sociali di quel tempo disordinato etristissimo. Un giorno, a uno scontro più grosso scesi a vedere. Venni a sapere anni do-po che quello scontro aveva un nome: battaglia di via Mercanti. Era capitato a me co-me a Fabrizio del Dongo, che si trovò alla battaglia di Waterloo e non se ne accorse».2. Sorte dell’Europa [1945], Milano, Adelphi 19912, p. 73.3. Cinquantanove lettere ad A. Soffici, a c. di M.C. PAPINI, «Paradigma», 4 (1982),p. 362.
Nel 1918, infatti, mentre il futuro capo del governo muoveva isuoi primi passi come direttore del «Popolo d’Italia» a Milano,Savinio era ancora in forza all’Ufficio Censura di Palazzo Reale,dove timbrava controvoglia la corrispondenza destinata all’este-ro. E nel 1919 aveva avuto occasione, insieme a Ungaretti, Bon-tempelli e Carrà, di incontrare direttamente lo stesso Mussolini,
il quale, prospettando in nostra presenza il futuro, delineava un program-ma nel quale anche noi avremmo dovuto partecipare al rinnovamentononché politico, ma culturale dell’Italia. Inutile dire che, carpito il potere,Mussolini non si ricordò più di noi (come noi, a onor del vero, non ci ri-cordammo più di lui) e ai fini del “rinnovamento culturale” dell’Italiapreferì rivolgersi a scrittori d’altro stampo. Cominciò da allora quella sor-da avversione al fascismo degli uomini di mente poetica e artistica, chesvuotò il fascismo di ogni contenuto spirituale e diventò così una dellecause meno appariscenti, ma più profonde della sua morte2.
Una posizione privilegiata, un «eccelso osservatorio», quello diPalazzo Reale, che diventa anche il titolo della rubrica («Osser-vatorio») da lui tenuta in questo periodo sul «Primato ArtisticoItaliano», e che sarà poi il romanzo a puntate su Innocenzo Palea-ri: reduce sradicato dalla società, scrittore solitario, intellettualemisogino imbevuto di letture weiningeriane e costretto a venire apatti con la storia, Paleari è l’unico personaggio ‘politico’ di Savi-nio. E anche l’autore, in questo periodo, sembra venire a patticon la storia, convinto, come scrive il 18 dicembre 1918 a Soffici«che l’artista non dev’essere ormai l’uomo appartato ed indiffe-rente a tutto ciò che non sia arte. L’uomo artista deve trovare lasua posizione vitale in mezzo al suo tempo ed abbracciare tutto,da cui possa ricevere influenze ma specialmente darne»3.
390 PAOLA ITALIA
4. Nel 1929, da alcune dichiarazioni su «Comoedia», si sviluppa una violentissimacampagna di stampa contro de Chirico e Savinio e Oppo, sulle pagine della «Tribu-na», invoca per loro il ritiro della cittadinanza italiana (Lettere a Pavolini, a c. di F.BERNARDINI NAPOLETANO e M. MASCIA GALATERIA, Carte e carteggi del 900, Roma,Bulzoni 1989, pp. 172-5). Per i fatti conseguenti all’articolo Il sorbetto di Leopardi,che provocò la chiusura di «Omnibus» nel 1939, cfr. A. TINTERRI, Savinio e l’«Altro»,Genova, Il Melangolo 1999, p. 114.5. Nella definizione di Sciascia che si legge nella Nota a Torre di guardia, introduzio-ne di S. BATTAGLIA, a c. di L. SCIASCIA, Palermo, Sellerio 1977: «L’intelligenza di Savi-nio, la sua formazione, il suo modo di vivere, il suo comportamento erano quanto dipiù lontano, di più refrattario, si può immaginare rispetto al fascismo. E può anchedarsi che a un certo punto della sua vita, dopo un lungo soggiorno in Francia e al ri-torno in Italia, si sia in qualche modo sentito fascista per afflato patriottico più cheper ideologia: ma non ci ha messo molto tempo per ricredersi e per ritrovarsi» (p. 11).Controproducente, tuttavia, anche se in buona fede, la decisione di censurare e diescludere dal volume alcuni articoli considerati «innaturalmente» fascisti, che ha im-pedito fino ad ora un dibattito storicamente documentato sull’argomento.6. «Il fascismo era soprattutto una forma di retorica e di estetismo, e come tale unafiliazione del dannunzianesimo. [...] Si vuol sapere perché l’esteta cambia apparenzaalle cose? Per vergogna. Sotto ogni estetismo si nasconde la vergogna di mostrarsi co-me si è. Dannunzianesimo e fascismo sono due fenomeni di vergogna», Il montone,«Corriere d’informazione», 29-30 marzo 1948 (Opere. Scritti dispersi, pp. 676-7). Inun altro articolo del 1948 invece Savinio riconosce un rapporto causale tra la fine delfascismo e lo sviluppo della psicanalisi in Italia: «Se un esplicito divieto alla psicanalisiil fascismo non lo pronunciò mai è perché non aveva bisogno di pronunciarlo, inquanto il divieto alla psicanalisi era implicito nell’essenza stessa del fascismo come èimplicito nell’essenza stessa di ogni organizzazione totalitaria. Lo Stato totalitario nonregola soltanto e amministra le attività pratiche del cittadino, ma regola ancora e am-ministra le sue attività psichiche, meglio le chiude e le ferma, come il pneumotoracechiude e ferma il polmone. [...] Il regime totalitario dimostra di non riconoscere al cit-tadino una vita psichica personale e autonoma, e avversa perciò la psicanalisi, la quale,per parte sua, dimostra invece che l’uomo possiede egli stesso gli elementi necessariper governarsi da sé in tutto e per tutto, e può fare a meno dunque a un’autorità cen-trale, e ha diritto dunque, soprattutto nell’esercizio della sua vita psichica, a una pienaautonomia», Uomo nuovo, «Corriere d’informazione», 27-8 febbraio 1948 (Opere.Scritti dispersi, p. 656).
Non può essere questa la sede per tentare un bilancio com-plessivo del suo complesso e contraddittorio rapporto con il fa-scismo, che da una prudente simpatia iniziale si evolve in condi-scendenza e partecipazione, ma infine si incrina e procura addi-rittura a Savinio un’imprevedibile e violenta persecuzione perso-nale (sul versante politico e razziale)4, fino a sfociare in una posi-zione di «naturale» antifascismo5, testimoniata dalla sua produ-zione saggistica in cui trova luogo una delle più acute e originalianalisi politiche6, che aggiorna con gli strumenti della psicoana-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 391
7. In particolare le considerazioni sviluppate nel saggio Intorno al socialismo (rubri-ca «Osservatorio»), «Il Primato artistico italiano», II, 5 (luglio 1920), pp. 34-6, a pro-posito della mancanza di identità della folla costretta a proiettare il proprio princi-pium individuationis (di derivazione schopenhaueriana) in un essere superiore.8. Ai cinque interventi sul «Corriere Italiano» registrati finora dalle bibliografie sidevono aggiungere cinque articoli sul «Nuovo Paese» e ben 61 sul «Corriere Italia-no», di carattere letterario e politico, oltre a un cospicuo numero di recensioni cine-matografiche del tutto inedite. Un primo contributo alla conoscenza delle collabora-zioni di Savinio al «Corriere Italiano» è stato dato da Elisabetta Piccioli nella tesi dilaurea La terza pagina del «Corriere Italiano» discussa a Firenze nell’a.a. 1996-7 (rela-tore Prof. Giuseppe Nicoletti). La presente bibliografia (cfr. sotto l’Appendice) è rica-vata da uno spoglio diretto della copia integrale del quotidiano depositata presso l’Ar-chivio Storico Capitolino di Roma; alcuni ritagli delle recensioni cinematografiche de-positate al Fondo [Sc. 55 – Ritagli di giornale I], invece, sono stati segnalati in Il sognomeccanico, a c. di V. SCHEIWILLER, introduzione di M. VERDONE, Milano, Quadernidella Fondazione Primo Conti, Scheiwiller, 1981 (privi tuttavia di indicazioni cronolo-giche, che qui abbiamo cercato di ricostruire), ma non in A. BERNARDI, Al cinema conSavinio, Lanciano, Metis 1992.
lisi le riflessioni sul rapporto fra massa e potere sviluppate pro-prio in questi anni7.È però possibile ricostruire il quadro storico-culturale dei
primi anni Venti attraverso la documentazione offerta dalle suecollaborazioni a due importanti quotidiani del tempo, a tutt’og-gi poco studiati: il «Nuovo Paese» e «Il Corriere Italiano», sullacui terza pagina – diretta da Ardengo Soffici – egli scrive assi-duamente. Si tratta di una produzione quasi sconosciuta, checonta contributi di notevole interesse, di carattere letterario,storico e politico, nonché la prima regolare rubrica di recensio-ni cinematografiche mai apparsa su un quotidiano in Italia8 eoffre quindi la possibilità (come sempre, quando si tratti di Sa-vinio, che attraversa tutti i principali movimenti artistici dellaprima metà del XX secolo, dalle avanguardie alle restaurazioni)di aggiungere un tassello al capitolo, ancora in gran parte dascrivere, sulla politica culturale del fascismo prima delle leggisulla stampa (votate nel 1923, ma rese operative solo dopo il de-litto Matteotti).In particolare, la storia di Savinio di questi primi anni Venti si
intreccia strettamente a quella di Ardengo Soffici, l’amico fio-rentino degli anni di Ferrara, patrono personale e letterario emodello di intellettuale, da quando soprattutto la stella di Papi-ni, l’altro astro che aveva tenuto a battesimo la ‘metafisica’ dei
392 PAOLA ITALIA
9. Il presente articolo costituisce uno dei capitoli di uno studio, di prossima pubbli-cazione, dedicato alla produzione letteraria di Alberto Savinio nel decennio 1915-25attraverso i materiali del suo Archivio. La ricostruzione che proponiamo è basata suimateriali presenti nel Fondo Savinio custodito presso l’Archivio Contemporaneo«Alessandro Bonsanti» del Gabinetto Vieusseux di Firenze e nel Fondo Papini delCentro di documentazione sulle avanguardie storiche «Primo Conti» di Fiesole, non-ché sullo spoglio integrale dei due quotidiani sopradetti, la cui raccolta completa è de-positata alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II (il «Nuovo Paese») e pressol’Archivio Storico Capitolino (il «Corriere Italiano») di Roma. Ringrazio Anna CasiniPaszkowski, Angelica e Ruggero Savinio e Laura Soffici per avere agevolato le mie ri-cerche e avermi consentito la pubblicazione delle lettere e dei testi dei relativi Fondi.10. «Non sono dunque un avversario politico del socialismo in quanto principio dilotta economica e sociale. Ma dell’altro aspetto del socialismo, di quello ideale che hodetto! Ah, lasciatemene parlare. […] Il materialismo, questa dottrina non dico d’ani-mali, ma da puri cretini, d’essenza giudaica e tedesca, contraddetta da tutto nel mon-do, ripugnante a ogni intelletto un po’ chiaro; la quale per cominciare, nega ogni virtùallo stesso strumento che la crea. […] La mancanza del senso reale, superiore dellastoria, nella concezione del passato, del presente e dell’avvenire delle società, che glistessi credono dominati o diretti da certe forze d’ordine inferiore, ma a loro parerepreponderanti; mentre ignorano o disprezzano quelle più potenti, ancorché occulte;le forze spirituali, motrici del mondo» (A. SOFFICI, Opere, Firenze, Vallecchi 1965,vol. VI [Battaglia tra due vittorie, 1923], pp. 335-6).11. Dopo una serie di contatti epistolari, Soffici incontra personalmente Mussolini«in una sera d’inverno tra il 1917 e il 1918», nell’ufficio di direttore del «Popolo d’I-talia» dove si è recato con Carrà per chiedere un pubblico intervento a favore del ge-nerale Capello, accusato della disfatta di Caporetto (A. SOFFICI, Miei rapporti conMussolini, a c. di G. PARLATO, «Storia contemporanea», XXV, 5 ottobre 1994, pp.762-5; l’incontro con Mussolini è anche in A. SOFFICI, I diari della grande guerra. «Ko-bilek» e «La ritirata del Friuli» con i taccuini inediti, a c. di M. BARTOLETTI POGGI eM. BIONDI, Firenze, Vallecchi, 1986, p. 22). Cfr. però le due cartoline postali inediteinviate da Soffici a Papini e conservate nel Fondo Papini (il carteggio Soffici-Papini,1915-1918, è di prossima pubblicazione, a c. di M. Richter, nelle «Edizioni di Storia eLetteratura»). La prima, dell’11 agosto 1918, riferisce di uno dei primi incontri: «Ca-rissimo, | andai l’altro giorno a Milano dove vidi Mussolini, uomo molto simpatico.Parlammo molto bene di te. Mi pregò di dirti che se gli manderai qualcosa per il Po-polo sarà felicissimo e ti pagherà (scusandosi) 100 lire l’articolo. Ha pregato anche me
fratelli de Chirico, brilla meno luminosamente nell’isolamento diBulciano9.All’indomani della marcia su Roma si delinea la necessità per
il nuovo governo di organizzare il consenso degli intellettuali. Lapersona a cui Mussolini si rivolge per operare questa difficile le-gittimazione culturale è Soffici, che aveva conosciuto sin daglianni della «Voce» (nonostante la personale avversione del tosca-no per ogni forma di socialismo rivoluzionario o riformista)10 edurante la guerra11, e che nel 1919 era stato attivo collaboratore
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 393
ed io farò forse qualcosa per lui. Tu dovresti scrivere qualcosa di vibratam.te italiano emandarglielo» (cartolina postale a t.p. «Arezzo Pieve S. Stefano 15-8-1918» e «Postamilitare 12.8.18»). In una successiva, del 27 agosto 1918, Soffici appare conquistatodalla linea politica del quotidiano mussoliniano: «Credo sempre il Tempo un giornalelosco mentre il Popolo d’Italia ha per lo meno il merito di avvicinarsi di più per l’ardo-re e la violenza del suo atteggiamento al nostro modo di sentire in questo speciale mo-mento. Anch’io sono avverso ai suoi atteggiamenti demagogici di cui sento il pericolo,ma almeno son sicuro che non tende segretamente ad arrangiamenti con la Bocherie econ Giolitti e questo è molto» (due bifogli su otto facciate, datata «27 agosto 1918»).12. Il 16 agosto 1919, in particolare, il «Popolo» pubblica in prima pagina un inter-vento di Soffici dal titolo: In guardia!, «preceduto da un cappello dello stesso Mussoli-ni nel quale era detto in sostanza che con quella lettera si aprivano le ostilità contro inemici della guerra e della nuova Italia da essa uscita. […] Il fatto è per me di grandevalore costituendo una fra le prime manifestazioni ideali del fascismo» (SOFFICI, Mieirapporti..., p. 766). La collaborazione al «Popolo» cementa la fiducia di Mussolini inSoffici, tanto da spingere il fratello del Duce Arnaldo, direttore nel 1921 del supple-mento «Ardita», ad offrirne a Soffici la direzione per salvare la rivista dalla chiusura,già decisa da Mussolini (SOFFICI,Miei rapporti..., pp. 767-8).13. SOFFICI, Opere, vol. VI, pp. 95-99.14. La rivista che nel marzo 1920 Soffici fonda, dirige e scrive interamente da solo,esce trimestralmente per soli quattro numeri fino al dicembre 1920. Nei vari articoliSoffici propugna un ritorno alla classicità (inteso come recupero dei valori tradiziona-li della cultura e dell’arte italiana) e alla realtà della natura (che emergeva già dallelettere a Carrà quando lo esortava a copiare il «portinaio» prima di cimentarsi a fareGiove): «Ho scelto il titolo di Rete Mediterranea per significare la mia intenzione dicreare un centro di collegamento fra i punti sensibili della civiltà, appunto, mediter-ranea, che credo superiore a tutte. Come sono un fervente dell’italianità, così il mioamore e la mia fede si estendono come una rete a tutto quanto di solare è nel pensie-ro e nell’arte delle nazioni affini, intorno al glorioso bacino, e che all’Italia si ricon-nette per ascendenza o discendenza. E in quanto al programma, esso può riassumersiin questo. Difesa e illustrazione della stessa cultura mediterranea, con l’affermazione
del «Popolo d’Italia» con articoli di aperto sostegno al neonatomovimento fascista12. Ricorda lo stesso Soffici:
Di persona Mussolini lo conobbi solo nel 1917, pochi giorni dopo la rottadi Caporetto. [...] Non rividi più Mussolini che a Roma, pochi giorni do-po la sua ascesa al potere. Andai a salutarlo alla Consulta, poi ebbi un pri-mo colloquio con lui al Grand Hôtel dov’egli allora alloggiava. [...] Lanostra conversazione fu lunga e affettuosa. Ragionammo dei compiti cheaspettavano l’Italia rinnovata, della profonda magnificenza del nostro po-polo, dei suoi futuri destini. Ebbi la felicità di sentire in quei discorsi co-me Mussolini fosse davvero l’uomo inviato dalla Provvidenza, colui cheriassume in sé le giuste idee e le aspirazioni occulte della stirpe, i suoi di-versi ideali inespressi o male espressi13.
Terminata l’esperienza di «Rete Mediterranea»14 e ritornato nel-
394 PAOLA ITALIA
insieme, di un’energia personale nella sua fase di pieno sviluppo» (Dichiarazione pre-liminare, «Rete Mediterranea», I, 1 (marzo 1920), pp. 19-20). Alcuni degli articolipubblicati su «Rete Mediterranea» sono stati raccolti da Simonetta Bartolini in A.SOFFICI, Estetica e politica. Scritti critici 1920-1940, Firenze, Solfanelli 1994 e cfr. an-che E. NISTRI, Le riviste del ’900, da «Rete Mediterranea» a «Italia e Civiltà», inAA.VV., L’uomo del Poggio, a c. di S. BARTOLINI, Roma, Volpe 1979.15. «Gerarchia», 9 (25 settembre 1922), poi in SOFFICI, Opere, vol. vi, pp. 353-60 eI diari della grande guerra, p. xxix.16. Cfr. Massime per i fascisti, «Il Popolo d’Italia», 16 novembre 1922 e cfr. anche Y.DE BEGNAC, Taccuini mussoliniani, prefazione di R. DE FELICE, Bologna, Il Mulino1990, p. 217, sull’atteggiamento di Soffici nei giorni di ottobre, attraverso le parole diMussolini: «Soltanto Soffici ci confortava del suo consenso. Egli vedeva, nella rivolu-zione, l’ultima impresa dell’Italia toscana di Giovanni de’ Medici e riscontrava nellanostra azione il medesimo senso guerriero del Ferrucci. Guardava a noi con spiritomilitare. Lo stesso che lo aveva spinto a difendere Cadorna e Capello, quando tuttierano contro i due migliori generali espressi dalla guerra mondiale».17. Lettera di Carrà a Soffici del 20 novembre 1922 (Carlo Carrà-Ardengo Soffici.Lettere 1919-1929, a c. di M. CARRÀ e V. FAGONE, Milano, Feltrinelli 1983, p. 157).18. Soffici stesso ricorda che dopo la chiamata di Mussolini a Roma la sua collabora-zione al governo era finita in nulla, «tanto che in capo a un anno me n’ero tornato acasa ai miei lavori» (A. SOFFICI, Diari 1939-1945, Prefazione di P. BUSCAROLI, Roma,Le edizioni del Borghese 1962, p. 40).
la casa del Poggio, già dal settembre del 1922 Soffici aveva chia-rito il suo pensiero nel saggio Il fascismo e l’arte15, in cui avevasostenuto che il nuovo movimento doveva coniugare «i fatti pra-tici con quelli spirituali», anche se la politica non doveva eserci-tare il controllo «sulla libera manifestazione del genio creatoredella bellezza». Una posizione piuttosto ambigua, che non gli sa-rebbe stato difficile mutare in seguito.La sua diretta partecipazione alla politica culturale del fasci-
smo si chiarisce all’indomani della marcia su Roma16. Durante lacostituzione del governo Mussolini, a Milano, circola addiritturala voce di una sua partecipazione al Gabinetto come Sottosegre-tario alle belle arti17, divenuta poi più realisticamente la direzio-ne della terza pagina dei due quotidiani filogovernativi: il «Nuo-vo Paese» e il «Corriere Italiano», cui egli porterà a collaborareil fior fiore della letteratura italiana del tempo, da Baldini a Cec-chi a Cardarelli a Ungaretti allo stesso Savinio.A differenza dell’immagine che si è tramandata – con la com-
plicità dei diari sofficiani18 e prima del rinvenimento del memo-riale Miei rapporti con Mussolini – di un uomo sempre più ripie-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 395
19. Come sostiene ad esempio Accame, secondo cui all’inizio del fascismo «Soffici[…] immaginò per sé ed i suoi amici […] una funzione di guida culturale, che gli fuprospettata ma non affidata» (G. ACCAME, Soffici fascista, in AA.VV., L’uomo delPoggio, p. 213).20. Come si vede chiaramente nelle considerazioni sul concetto di ‘popolo’ in A.SOFFICI, Speranza, «Rete Mediterranea», 2 (1920).21. «Se c’è qualcosa che valga la pena di essere amata nella vita è quella specie di co-munità aristocratica che si forma quando tre, quattro, cinque uomini veramente crea-tivi, puri, realmente artisti, s’incontrano, vivono e lavorano insieme. C’è qualcosa dialto, di solenne di sovrumano in quella chiesa. Appena si vede che ogni ciarlatano, lepeggiori mediocrità, i cretini e i farabutti possono accostarsi, liberamente entrare e co-municare – tutto lo charme se ne va, nasce il puttanaio, l’incanagliamento e un uomoche si rispetti finisce con lo sdegnarsi, lo scoraggiarsi ed il ritirarsi da parte senza piùnessun entusiasmo né speranza» (lettera inedita, su carta non intestata, due bifogli suotto facciate, datata «27 agosto 1917», conservata presso il Fondo Papini).22. Si veda l’acuta analisi di Prezzolini, pubblicata in tempi ancora non sospetti, nelluglio del 1920 sul «Convegno». Soffici – sostiene Prezzolini – non è stato cambiatodalla guerra, il suo atteggiamento è sempre rimasto lo stesso, anche se in «Rete Medi-terranea» egli ha sostenuto il contrario: «Detesta i piccoli letterati, pieni di gonfiezzarivoluzionariamente vuota, e sente maggiore simpatia per gli uomini medi della bor-ghesia italiana e si fa grande difensore, delle autorità d’ogni genere e persino dei gene-rali, per il semplice fatto di essere generali». Anche da avanguardista Soffici era uomod’ordine in quanto «non vi è mai stato più assoluto conservatore e più convinto rea-zionario dell’anarchico» che tende naturalmente al principio di autorità, cieco e con-servatore perché manca di un’autodisciplina naturale dello spirito (G. PREZZOLINI,Ardengo Soffici, «Il Convegno», I, 6 luglio 1920, 46-51; la citazione a p. 49).
gato su se stesso e completamente estraneo alla politica culturalefascista19, Soffici diventa in questi anni un importante organizza-tore culturale che, forte del suo passato avanguardistico, lacer-biano e vociano e dei buoni rapporti con l’ambiente letterarioromano (segnatamente rondesco) riesce a fornire al governoquel sostegno culturale che ancora gli mancava.Tra le varie spinte che rendono Soffici organico al programma
fascista, piuttosto che il riconoscimento di valori popolari e rura-li20, vi è l’aspirazione a un rinnovamento della nazione da realizza-re in termini aristocratici ed elitari, secondo un progetto ch’egliaveva già affacciato a Papini nel 191721 e che non era stato ignora-to dai suoi lettori più attenti22. Non si tratta quindi solo di unanaturale filiazione del nazionalismo e del reducismo, ma di unprogramma culturale di impostazione antidemocratica, a cui perun biennio Soffici tenta di trovare una dimensione anche politica,senza riuscire forse a percepire che sulla commistione tra l’una el’altra dimensione il fascismo avrebbe posto le basi del suo totali-
396 PAOLA ITALIA
23. Nel dicembre 1924 viene fondato a Colle Val d’Elsa «Il Selvaggio» di Mino Mac-cari, inaugurato con l’articolo fascismo toscano in cui Giovanni Tramontano riconoscein Ardengo Soffici un «toscano e fascista, che dovrebbe di tutti noi essere il maestro eal quale dovremmo affidare la guida del nostro movimento intellettuale» («Il Selvag-gio», luglio 1924). Il programma del «Selvaggio» è assolutamente in linea con l’esteti-ca di Soffici, ma il suo isolamento ormai è decretato. Nel 1926 egli comincia a colla-borare anche con «L’Italiano» (che inizia le pubblicazioni dal 14 gennaio) e tesse conAlessandro Casati le fila di una ricucitura del rapporto tra Croce e Gentile, ma in po-sizione completamente defilata, nonostante sul «Mattino» di Napoli del 22-3 agosto1926 (Gli artisti chiedono un capo: Soffici) Ungaretti lo proponga a Mussolini quale re-sponsabile di tutte le attività artistiche italiane.24. Si veda in SOFFICI, Miei rapporti..., p. 733 la definizione di Parlato di Soffici co-me «impolitico», sulla scorta del memoriale, ma anche del carteggio ivi riprodotto:«non di rado i colloqui (o le lettere) tra Soffici e Mussolini sembrano i dialoghi tra unparvenu della politica e un consumato politico» e il capitolo «L’impolitico», pp. 758-9in cui si rileva il disegno metapolitico sofficiano nell’«ordine, la classicità, il mito dellaToscana quieta e creatrice, il senso di una storia d’Italia che prescinda dagli accadi-menti politici per costituire un filo conduttore più spirituale che storico, il senso, infi-ne, di una moralità atta a rigenerare un’Italia corrotta che neppure il fascismo riuscìad incarnare» (p. 759).25. Un fascismo che è «classicità e tradizione» e la realizzazione di quanto di positivovi è stato nella storia italiana, con un «rovesciamento speculare della tesi di Gobetti»,secondo cui il fascismo non avrebbe rappresentato che la stratificazione di tutti gli ele-menti negativi della società politica italiana (SOFFICI, Miei rapporti..., pp. 745-6). Politi-camente, inoltre, va considerato il fallimento delle trattative con Giovanni Amendola,avviate per istituire un ponte con il governo, in seguito all’aggressione subìta dal depu-tato il 26 dicembre 1926, trattative ora documentate attraverso la Memoria e le letteredell’Archivio Soffici in SOFFICI,Miei rapporti..., pp. 747-54 (cap. 4. Amendola).
tarismo. E che dopo essere sceso nell’agone, di fronte alle primeprove generali del regime, non gli sarebbe restato che «ritirarsi daparte», nello splendido isolamento della casa del Poggio23.Ci sembra inoltre che la spinta maggiore a un suo impegno
concreto a favore di un riconoscimento culturale del fascismovada rintracciata nel personale rapporto con Mussolini, nel for-tissimo carisma esercitato dal politico sul letterato, dal capo delgoverno sull’artista. Se è vero che Soffici entra in politica con lostesso spirito patriottico e di sacrificio con cui era andato inguerra, e che nonostante le pubbliche e inequivocabili prese diposizione politica, resta sostanzialmente un «impolitico»24.Quanto più si diffonde in lui la sensazione che Mussolini segui-va altre linee da quelle ch’egli aveva indicato per portare al «ri-sanamento spirituale del paese ed alla sua elevazione dal latodelle discipline artistiche, letterarie e della morale civile»25, e se-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 397
26. Si veda il saggio di M. BIONDI, Per una autobiografia intellettuale. Ricordi del Du-ce, in AA.VV., Cultura e fascismo. Letteratura arti e spettacolo di un ventennio, a c. diM. BIONDI e A. BORSOTTI, con prefazione di E. GHIDETTI, Firenze, Ponte alle Grazie1996 (soprattutto la n. 53 sul rapporto di Soffici con il fascismo, pp. 101-6) e quello diS. BARTOLINI, Estetica e fascismo in Soffici alle pp. 143-69. Secondo Parlato il fascismo«più metastorico che storico» di Soffici conterrebbe «già in sé gli elementi intorno aiquali si svilupperanno la delusione e il rancoroso distacco dell’artista toscano», cui sa-rebbe toccata una delusione ben maggiore che il passaggio all’antifascismo (cosa chenon fece mai): «restare fascista senza potere riconoscere nel fascismo l’inveramentodella classicità» (SOFFICI,Miei rapporti..., pp. 746-7).27. Di quanto il progetto di Soffici fosse debitore a un’immagine idealizzata e irrealedella politica – tra il salotto letterario e l’amabile conversazione da caffè – lo si ricavada questo passo di SOFFICI,Miei rapporti..., : «Mi ero figurato perciò che, riuniti intor-no a me, nella comunione di alcune idee fondamentali, tutti i nuovi uomini d’ingegnoritenuti capaci di servire la più vasta idea fascista e italiana con la loro opera di pensa-tori, di critici, di letterati e d’artisti, avrei ottenuto da Mussolini di presentarglieli, difarglieli conoscere nella loro vera luce, di farli affiatare con lui, in modo che potesseroconcorrere ad un’azione armonica d’insieme, concertata d’accordo con lui e per il be-ne massimo dell’Italia messa ormai nelle sue mani. Pensavo che Mussolini dopo il suogrande lavoro giornaliero di uomo di Stato, avrebbe trovato qualche ora per accoglie-re in casa sua, cioè in una propizia intimità, tutti noi, il gruppo di quei primi elementi– il quale sarebbe poi andato via via ingrossando, fino ad attirar tutte le vere vive for-ze intellettuali italiane – e per discutere insieme a quelle (come altra volta si faceva incerti salotti famosi) quel che di meglio ci fosse da fare. Si vedrà tra poco come questamia non fosse che un’illusione» (pp. 786-7). Si veda, a questo proposito, anche il capi-tolo 5. La delusione e l’intransigenza, pp. 754-9.28. SOFFICI,Miei rapporti..., p. 835.
gnatamente quelle di Marinetti e dei futuristi26, tanto più la suabattaglia culturale alza i toni dello scontro. Ma è un dialogo pri-vato, anche se svolto in forma pubblica, che finisce per prenderele forme di un tragico monologo: all’entusiasmo iniziale e all’il-lusione di poter influenzare direttamente le decisioni dell’amicodivenuto capo del governo e di «attirare verso di esso le forze ar-tistiche e letterarie che gli parevano più propizie»27 segue la de-lusione: «Debbo confessare che il mio sforzo rivelatosi vano sindal principio, mi resultò alfine fallito totalmente»28 e l’abbando-no di un ruolo culturale e intellettuale pubblico.
Un «grande giornale fascista»: «Il Nuovo Paese»
Le prime manovre culturali del neonato governo si svolgono lasettimana successiva alla marcia su Roma. L’8 novembre 1922
398 PAOLA ITALIA
29. Su Michele Bianchi (1883-1930), quadrumviro della marcia su Roma vicino aMussolini, cfr. di F. PAOLONI, Michele Bianchi nella storia del fascismo, Milano, 1940,pp. 35 e 69-70.30. G.UNGARETTI-A. SOFFICI, Lettere a Soffici 1917-1930, a c. di P. MONTEFOSCHI eL. PICCIONI, Firenze, Sansoni 1981, pp. 101-2.31. Nel volume Lettere a Soffici 1917-1930, è erroneamente identificato con il «Cor-riere Italiano», che uscirà invece dalla metà del 1923.32. Carlo Bazzi (1885-1937), direttore del «Nuovo Paese» dal 1922 al 1924, coinvol-to nel delitto Matteotti fu costretto a fuggire in Francia dove morì; Cesare Rossi(1887-1967), giornalista e politico, collaboratore del «Popolo d’Italia» dal 1923 al1924 era Capo dell’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio; accusò Mussolinidel delitto Matteotti, fuggì in Francia, ma fu arrestato nel 1928 e incarcerato fino allaliberazione.33. UNGARETTI-SOFFICI, Lettere a Soffici 1917-1930, p. 108.34. SOFFICI,Miei rapporti..., p. 771.
infatti Ungaretti scrive a Soffici:
forse si fonda a Roma un grande giornale fascista. Ho subito chiesto di ve-dere Michele Bianchi29 ed ho chiesto, se la cosa si facesse, che tu fossi chia-mato a dirigere la terza pagina. Bianchi ha preso subito nota della cosa conentusiasmo. Credo di avere fatto il mio dovere di amicizia verso di te30.
Il «grande giornale fascista» è il «Nuovo Paese», che inizia lepubblicazioni di lì a poco, il 2 dicembre 192231. Il 9 dicembre èancora Ungaretti a chiamare a gran voce Soffici a Roma:
Qui sei aspettato da tutti come la Provvidenza [...] Vuoi darmi retta? Vie-ni subito a Roma, qui ci sono pensioni – tutto compreso – alloggio e vitto– a 35-40 lire al giorno – pensioni di prim’ordine.
Starai per qualche giorno in una di quelle pensioni, farai intanto pressionisul Commissariato – dal quale ti recherai con lettere di Bazzi e di Rossi32 –per avere la casa, e organizzerai la 3a pagina33.
Soffici incontra il futuro direttore, Carlo Bazzi (cugino del genera-le De Bono), ma poi chiede di vedere direttamente Mussolini. L’e-pisodio, narrato neiMiei rapporti con Mussolini, permette di chia-rire le circostanze del suo trasferimento nella capitale. Mussolini,infatti, sostenendo che per «compir bene l’opera appena incomin-ciata in pro dell’Italia […] intendeva adoperare a questo fine tuttiquelli che secondo lui avevano qualità proprie alla bisogna: utiliz-zare insomma tutte le capacità e forze delle nuove generazionich’egli rappresentava ed era lì per guidare verso grandi mete»34;
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 399
35. Cfr. la lettera a Prezzolini del novembre 1922 citata in SOFFICI, Miei rapporti...,p. 741 in cui Soffici dichiara che avrebbe fatto volentieri a meno di assumersi l’incari-co «se la considerazione del po’ di bene che si può fare da quel posto, e di qualchepiccolo vantaggio economico non mi avessero persuaso a non rifiutarlo nettamente. Eormai che sono in ballo, ballerò».
36. «Casi nuovi occorsimi nella mia vita familiare non mi permettevano più di appar-tarmi come per l’innanzi» (SOFFICI,Miei rapporti..., pp. 768-9).
37. Da una lettera di Esodo Pratelli pubblicata da Luigi Cavallo in Soffici. Immaginie documenti (1879-1964), con la collaborazione di V. SOFFICI, redazione e indici di O.NICOLINI, Firenze, Vallecchi 1986, p. 317.
38. Il quotidiano è schedato in O. MAJOLO-MOLINARI, La stampa periodica romanadal 1900 al 1926. Scienze morali, storiche e filologiche, Roma, Istituto di Studi Romani1977, vol. II (N-Z), pp. 512-6 e cfr. anche SOFFICI, Miei rapporti..., pp. 742-3. L’edito-riale del primo numero recita esplicitamente: «L’avvento del governo Mussolini con-chiude quella rivoluzione che, iniziata sulle Argonne sulla tradizione di GiuseppeMazzini, consacrata di fronte al nemico dal martirio di Cesare Battisti – trionfa attra-verso un travaglio di otto anni, nei giorni sacri alla estrema vittoria del Piave a alla me-moria del Caduto Ignoto».
non gli dichiara apertamente, ma lascia intendere di essere dietrol’operazione del «Nuovo Paese» e di volere affidare a lui l’orga-nizzazione culturale del nuovo governo. Ricorda ancora Soffici:«Nell’avviarci insieme, gli parlai dell’eventuale opportunità per luidi giovarsi nella sua nuova impresa di alcuni altri amici nostri divalore secondo le speciali capacità di ciascuno: idea ch’egli condi-videva perfettamente. E facemmo alcuni nomi». La candidaturadi Savinio all’impresa culturale nasce probabilmente in questocolloquio.Dopo alcune incertezze35, mosso da ragioni anche di ordine
economico36, alla fine del mese Soffici si trasferisce a Roma contutta la famiglia (lo comunica Rosai a Prezzolini il 28 dicembre1922). Il suo inquadramento negli organi del fascismo è imme-diato. Aderisce prima al Direttorio poi all’Ente Autonomo dellaCorporazione Nazionale delle Arti Plastiche, suggerendo agli al-tri membri (Esodo Pratelli, Leto Livi, Carlo Carrà, Vicenzo Co-stantini) di «portare fino al Presidente del Consiglio, On. Mus-solini, la notizia di quanto agitiamo e organizziamo. La nostravoce significherà finalmente l’operosità, le necessità, i sentimentidi una collettività artistica nazionale nettamente inquadrata emoventesi su di un vasto piano d’azione»37.Il «grande giornale fascista»38 nasce sulle ceneri del «Paese»
400 PAOLA ITALIA
39. Cfr. Soffici. Immagini e documenti, p. 318 per l’elenco delle collaborazioni di Sof-fici al «Nuovo Paese», a cui sono tuttavia da aggiungere altri sette articoli: Piccola po-sta, 17 gennaio, p. 3 [firmato Ariel] (si tratta di una risposta all’articolo di Ungarettidel 16 gennaio 1923, p. 3, cui Ungaretti risponde nuovamente il 18 gennaio sul «Nuo-vo Paese» rivolgendosi direttamente a Soffici); Piccola posta, 21 gennaio 1923 [firmatoAriel]; Piccola posta, 28 gennaio 1923 [firmato Ariel]; L’arte di Ruskaja, 31 gennaio1923; Piccola posta, 3 febbraio 1923 [firmato Ariel]; Piccola posta, 5 febbraio 1923[firmato Agnello Pecori]; Piccola posta, 7 marzo 1923 [firmato Agnello Pecori].40. La sua assoluta solidarietà con Mussolini è bene espressa da una lettera inviata il17 febbraio 1923, su carta intestata del «Nuovo Paese», in cui chiede di parlare con ilcapo del governo senza incorrere «nel bufalo burocratico» e aggiunge: «Se desideri ve-dermi, fammi dunque avere questo mezzo amichevole. Io sono come sai, al Nuovo Pae-se, dove attendo un tuo cenno ed i tuoi ordini» (SOFFICI,Miei rapporti..., p. 850).
che era invece nittiano e socialista e aveva pubblicato vignettesatiriche contro Mussolini e il fascismo. La terza pagina del«Paese» era praticamente inesistente. Per tutto il 1922 il settoreculturale era stato occupato dal romanzo d’appendice: Tormen-to! di Flavia Steno. Dal gennaio 1923 l’entrata in redazione diSoffici dà i primi risultati, il quotidiano passa da 6 a 8 pagine ela terza pagina viene regolarmente dedicata alle notizie artistichee letterarie, accreditandosi gradualmente le firme più prestigio-se. Gli articoli pubblicati da Soffici sono numerosi e meritanoun approfondimento39. Alcuni vengono firmati con lo pseudoni-mo Ariel o Agnello Pecori, nella rubrica «Piccola posta». Si trat-ta di interventi strategici, volti a costruire una testa di ponte ver-so gli intellettuali che, come scrive Pancrazi, erano ancora rima-sti «sulla opposta riva», a farsi portavoce delle istanze del mon-do culturale verso il capo del governo, e viceversa a presentarein forma di ‘ingenui’ dialoghetti letterari – una sorta di rubricafissa – le sue prime illiberali decisioni: testi di estrema importan-za in quanto certificano l’operazione culturale svolta da Soffici,la cui ricostruzione aggiunge un tassello, circoscritto ma centra-le, alla storia della politica culturale del primo fascismo.Pur con toni squisitamente letterari (il modello dialogico tea-
trale, ma anche operettistico) e movenze popolaresche pre-stra-paesane, Soffici introduce i temi chiave della gestione politicadella cultura40, che avrà modo di perfezionare sulle colonne del«Corriere Italiano». Il suo primo articolo, I discorsi che corrono,è del 2 gennaio 1923, il giorno successivo alla sua entrata al gior-nale. Soffici propone un emblematico dialogo ambientato in tre-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 401
no sui mali che affliggono l’Italia e sui rimedi che il governo do-vrebbe porvi. Il testo è dedicato «A Sua Eccellenza Benito Mus-solini» e si conclude con un accorato appello: «Che Mussolini simettesse in contatto diretto col popolo lavoratore, che ha fedein lui ed aspetta da lui il risanamento di tutte le piaghe: di quelleferroviarie come delle altre». Altrettanto significativo il raccontodel 7 gennaio: Sciamanna, incentrato su un barrocciaio di Pog-gio a Caiano, chiamato così perché «fra quanti sono individuidella sua specie e del suo mestiere a parecchi chilometri all’ingi-ro, nessuno è appunto più sciamannato di lui, più sbracato e cia-no», un povero diavolo, ignorante ma forte lavoratore, con «ilvizio di bestemmiare e di ubriacarsi» ma sostanzialmente pacifi-co. Sciamanna però è comunista e ha cominciato ad avere deiguai con il partito. Soffici spiega che egli è troppo ignorante pergiustificare questa sua passione politica, del tutto istintiva e in-giustificata, ma che a causa delle invettive lanciate contro i fasci-sti si è da poco buscato «un carico di legnate». A nulla sono val-si i tentativi per ricondurlo alla ragione, Sciamanna è irremovibi-le, se anche dovesse riconoscere la bontà dei discorsi dell’amicodopo un’ora non si ricorderebbe più nulla: «Mi garba divertirmiin compagnia, bere insieme a quegli che conosco; e non vo maialla messa. Più comunista che così!...». La battuta diverte ancheun capo fascista che lo lascia andare, ma Soffici commenta che,se continuerà così, Sciamanna dovrà affrontare seri guai con lagiustizia. La storiella si conclude con un’ambigua morale, inte-ressante per l’evidente tentativo di attribuire alla violenza fasci-sta un ruolo pedagogico e necessario: «Sciamanna è, secondome, il paragone, del novanta per cento almeno, di quei disgrazia-ti italiani, che pagano il fio della loro ignoranza, scambiata percattiveria, solo a cagione ch’essa riflette alcun poco della realissi-ma perfidia dei nostri dannabili demagoghi».Ancora più significativo è I discorsi che corrono, del 24 gen-
naio, un dialogo nuovamente ambientato in treno tra un «Intel-lettuale idealista liberale», un «Filofascista, suo amico»; un «Pri-mo Intellettuale democratico», un «Secondo Intellettuale demo-cratico» e un «Terzo Intellettuale democratico». La posizione diSoffici qui è particolarmente ambigua perché passa da un’inizia-le condanna all’aperto sostegno di alcuni metodi violenti e ille-
402 PAOLA ITALIA
41. Non si può perciò consentire con Parlato (SOFFICI,Miei rapporti..., pp. 742-3 chetende a ridurre la portata degli articoli pubblicati da Soffici sul quotidiano, parlandodi «concetti di carattere politico non particolarmente significativi» in riferimento a Di-scorsi che corrono (2 gennaio 1923) e definendo Sciamanna (7 gennaio 1923) il raccon-to di un socialista del Poggio «costantemente ubriaco». Né con la riduttiva definizio-ne dei Discorsi che corrono (24 gennaio) di «lettura “aperta” del fascismo, che seppurein sintonia con la normalizzazione mussoliniana, è perfettamente coerente con la pro-pria immagine del fascismo».42. SOFFICI,Miei rapporti..., p. 776.43. Non risulta, invece, una collaborazione di de Chirico anche se il 10 marzo 1923 afirma «Il venditore d’anelli di gomma per gli ombrelli», nella rubrica «Usi e costumi»esce un divertente profilo di De Chirico, pittor metafisico, con una caricatura di A.Bartoli, in cui il pittore viene descritto a passeggio per Trastevere.
gali utilizzati dai fascisti (l’uso dell’olio di ricino, l’annullamentodelle opposizioni, ecc.). Se gli oppositori avessero possibilità diparlare – sostiene il Filofascista – non farebbero altro che espri-mere «malignità e pettegolezzo da caffé». La libertà di parolanon è un diritto ma un bene da sapersi meritare41.A stare alle sue affermazioni in Miei rapporti con Mussolini,
dopo i primi tempi, il «Nuovo Paese» gli pare «il più volgare emalfatto giornale che mai avesse visto», tanto da non credereche Mussolini contasse su di esso per far nascere una nuova cul-tura fascista:
Cominciai perciò col raccogliere intorno a me alcuni amici scrittori ed ar-tisti di valore, dei quali intendevo valermi nella bisogna; ma subito dovet-ti accorgermi della vanità del tentativo, giacché Bazzi mi fece immediata-mente capire che per le lettere e le arti non intendeva spendere un soldo;senza contare che il redattore Torsiello non vedeva nella terza pagina cheun puro capriccio del direttore, ed aveva sempre pronta zavorra venutaglidai ministeri o «ufficialmente» raccomandata come indispensabile, e dellaquale me la riempiva ordinariamente a mia insaputa42.
Soffici porta invece al quotidiano le firme più illustri dell’intel-lettualità del tempo, non solo fiorentina, da Prezzolini a Torre-franca; Lucio d’Ambra, Pavolini, Flora, Ciano (dal 1 febbraiorecensore ufficiale per il teatro), Ungaretti, Corradi, Franchi,Bragaglia, Evola, Spaini, Baldini, Folgore, Raimondi, CurzioSuckert e lo stesso Savinio43. Gli effetti della nuova direzione so-no visibili sin dai primi mesi. Ottone Rosai, il 3 marzo 1923, daFirenze si congratula con lui: «si è avuto subito la speranza di un
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 403
44. O. ROSAI, Lettere 1914-1947, Firenze, Vallecchi 1974, p. 226.45. ROSAI, Lettere..., p. 706. Anche nella lettera inedita a Papini del 4 gennaio 1923,conservata presso il Fondo Papini, traspaiono già i sintomi di un’insoddisfazione:«Giro dalla mattina alla sera per cercare alloggi introvabili; vo al giornale, sono cir-condato da gente di ogni risma, sono stanco» [lettera su carta non intestata, bifogliosu quattro facciate, datata «Roma 4 gen. 23»].46. «Chi è d’un partito è perduto per la ragione. Io non sono perciò un uomo politi-co. E se in questa mia rivista si trova questa rubrica è soltanto perché nel momento at-tuale, più che in qualunque altro, i fatti di ordine politico sono spesso così strettamen-te aderenti, o minacciano di divenirlo, a quelli spirituali ed estetici da dover per forzaprenderli in considerazione per metterne in chiaro i rapporti, e, a un bisogno, far delnostro meglio per modificarli a vantaggio, o a minor minaccia, almeno dell’intelligen-za e della bellezza. | È dunque unicamente con questo fine speciale e ben limitato chemi sobbarcherò ad avanzare il piede sopra un terreno non mio e che so pieno d’esserie cose per cui ho sempre sentito un gagliardo disgusto. È un sacrificio che faccio sul-l’altare dello Spirito e della Patria» (Politica, «Rete Mediterranea», 1, 1920).47. Aldo Finzi (1891-1944), sottosegretario all’Interno a partire dalla marcia su Roma
giornale che fra tanti sarà unico e si potrà leggere e impararciqualche cosa»44. Ma l’amico, rispondendo, sembra minimizzareil proprio ruolo: «La mia vita qui è idiota: non fo nulla e guada-gno appena quel che ci vuole per vivere e raggranellare in un an-no il necessario per poter lavorare un altr’anno senza scribac-chiare per i giornali»45. La confessione ci permette di considera-re l’ambivalenza della sua posizione, da un lato corifeo del no-vello governo fascista pronto a sfoderare i toni più accesi e la re-torica più violenta, dall’altro artista deluso dalla routine giornali-stica, che non aspetta altro che potersi ritirare al Poggio per ri-prendere in mano tele e pennelli, e dedicarsi alla sua vera arte.Sembra paradossale, ma più i suoi articoli sono radicali e violen-ti, sorretti da un’incrollabile fede in Mussolini, più nella corri-spondenza personale egli mostra una profonda insoddisfazioneper un ruolo che dichiara di non avere scelto e di non amare, inciò ambiguamente in linea con le dichiarazioni «impolitiche» delprimo numero di «Rete Mediterranea»46.Intanto, le sorti del «Nuovo Paese» sono pericolanti; Musso-
lini pensa ormai a un nuovo quotidiano, che sin dal titolo si pon-ga in antagonismo al «Corriere della Sera», da sempre rappre-sentante della borghesia imprenditoriale e affaristica di area li-berale: «Il Corriere Italiano». Soffici riceve la proposta di colla-borazione da Aldo Finzi47, vero ispiratore del giornale che sarà
404 PAOLA ITALIA
fino al giugno del 1924. Coinvolto nel delitto Matteotti, fu allontanato dal governo.Dopo essere passato nelle file della resistenza, fu fucilato alle Fosse Ardeatine.48. MAJOLO-MOLINARI, La stampa periodica romana..., p. 513.49. Il quotidiano continua le pubblicazioni fino al 1924, con la medesima imposta-zione della terza pagina, ma senza gli articoli che gli avevano dato un rilevante pesoculturale nei primi mesi dell’anno. Restano alcuni collaboratori eccellenti come Unga-retti, Franchi, Suckert e le cronache teatrali di Galeazzo Ciano. Il 10 maggio 1923Achille Lega dà notizia della mostra personale di Giorgio de Chirico sul fiorentinoLungarno Serristori, nella casa del collezionista e letterato Giorgio Castelfranco («ilde Chirico si mostrò un temperamento di vero pittore fine dalla sua prima pittura me-tafisica che, non dobbiamo negarlo, ha lasciato tracce in molti dei nostri migliori arti-sti e li ha condotti a una disciplina e a studiare il valore essenziale di ogni oggetto nel-la forma e nello spazio»), il 24 maggio è la volta di Corrado Pavolini che recensisce lamostra collettiva della Galleria d’Arte Bragaglia in cui esponevano, tra gli altri, Sofficie de Chirico. Il solo Evola continua a scrivere regolarmente. Il 14 novembre, quandoormai non troviamo più collaboratori di rilievo, compare un articolo di Gobetti: Il di-rettore di scena, sul teatro di Bragaglia, segno dell’allontanamento definitivo delle sortidel giornale dagli interessi del regime.
diretto ufficialmente da Filippelli, e dalla metà di aprile del 1923ne assume la direzione della terza pagina. Nella lettera del 28maggio 1923 a Cesare Rossi, capo dell’Ufficio Stampa della Pre-sidenza del Consiglio, Mussolini dichiara il «Nuovo Paese» or-mai «pleonastico» e propone di sopprimerlo48, ma grazie agliappoggi di Carlo Bazzi, il quotidiano sopravvive per un altro an-no e mezzo (chiuderà il 24 gennaio 1925), adottando una lineasempre più polemica, in particolare contro i popolari e DonSturzo (costantemente caricaturizzato sulla prima pagina delgiornale), quanto mai inopportuna in quel momento, poiché ilfascismo si proponeva di conquistare la classe moderata e conessa, naturalmente, l’area cattolica49.
Prove generali di giornalismo: le collaborazioni di Savinioal «Nuovo Paese»
Il fatto che Savinio si trasferisca a Roma nel 1923 e inizi subi-to a collaborare al «Nuovo Paese» è indicativo di come continuiad agire su di lui l’influenza di Soffici. Tuttavia, per quanto coin-volto con il gruppo letterario romano della «Ronda» nella colla-borazione con le terze pagine sofficiane, e a volte non estraneo auna certa retorica filogovernativa, egli è da questo punto di vista
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 405
50. Europa, «Ulisse», gennaio 1948 (SAVINIO, Opere. Scritti dispersi, pp. 620-1).51. UNGARETTI-SOFFICI, Lettere a Soffici 1917-1930, p. 107.
antitetico a Soffici. Innanzitutto ogni sua partecipazione ad atti-vità culturali e politiche è subordinata al proprio progetto arti-stico. Un progetto di cui egli sente l’originalità, l’urgenza e l’im-portanza, e che persegue con straordinaria coerenza nel tentati-vo di tradurre in forme concrete i principi di «filosofia delle ar-ti» dichiarati su «Valori plastici» nelle collaborazioni dal 1918 al1921. Ogni sua partecipazione, perciò, va inserita nel quadro or-ganico e coerente della sua vocazione artistica, all’interno delquale trova un senso e un valore. Inoltre, sin dal primo dopo-guerra, Savinio trova nella propria riflessione culturale e artisticaquegli anticorpi contro ogni forma di idolatria personale – sonoparole sue – che invece mancano a Soffici e che mancherannoagli intellettuali italiani, come ricorda egli stesso nel 1948:
Mussolini io lo conobbi a Milano, nel 1918, in condizione di uomo qua-lunque. Per fortuna io sono negato a ogni forma di idolatria. La mia ripu-gnanza anche al minimo accenno di idolatria – il padre Dante, il divinoPlatone – mi costringe a sottovalutare le stesse qualità di Dante e di Pla-tone. Ma anche se così fossi, la conoscenza che avevo di Mussolini comeuomo qualunque, mi salvava dal riconoscere il Mussolini indiato. Non èDio il Dio che abbiamo visto nascere50.
È probabile che il suo coinvolgimento nell’impresa si debba an-che ai suggerimenti di Ungaretti (occulto e insospettabile registadi molte operazioni culturali di questi anni, grazie ai suoi perso-nali rapporti con Mussolini), che alla fine del 1922 (timbro po-stale del 6 dicembre), forse al corrente delle sue precarie condi-zioni economiche, scrive a Soffici per chiedergli di aiutare Baldi-ni e Savinio51.Gli articoli scritti da Savinio per il quotidiano non sono molti
e proseguono i filoni sperimentati nelle collaborazioni del primodopoguerra alla «Ronda» e al «Primato Artistico Italiano»: lospunto narrativo, le recensioni e il commento di costume. La suaposizione verrà giustificata, più tardi, come una sorta di «reti-cenza», di costante isolamento rispetto agli individui di «speciediversa»:
406 PAOLA ITALIA
52. Conquista e amore, «Il Tempo», 12 giugno 1945 (SAVINIO, Opere. Scritti dispersi,pp. 139-40).53. Si veda la Nota al testo a questo racconto in A. SAVINIO, Casa «la Vita» e altri rac-conti, a c. di A. TINTERRI e P. ITALIA, Milano, Adelphi 1999, p. 889.54. Con lo stesso titolo Savinio terrà una rubrica sul «Popolo di Roma» nel 1925-6(quattro interventi) e nel 1942 (tre interventi).55. Le Stagioni, «La Ronda», IV, 8-9 (luglio-agosto 1922), p. 508.56. Già uscito su «Il Primato Artistico Italiano», II, 6 (agosto-settembre 1920), p. 20.
Gli italiani di sentimenti e costumi non fascisti riuscivano a vivere nell’I-talia fascista praticando un ben combinato modus vivendi, il quale se nonaltro era la riprova di quanto giusta è la teoria di Darwin dell’adattamen-to animale all’ambiente, vivendo esclusivamente fra di loro, eliminandodalla propria cerchia gl’individui di specie diversa, ossia i fascisti; e se de-terminate ragioni rendevano necessari i rapporti con individui di speciediversa, corazzandosi di una reticenza tale, da diventare simili ad altret-tante tartarughe chiuse dentro il loro carapace52.
In questo caso, il «carapace» sembra essere una misura stilisticaimprontata a una compostezza classica, già sperimentata sulla«Ronda» con l’aggiunta di una scelta di temi apparentementesvagati e poco perspicui a chi non abbia presente il contesto dacui vengono derivati.Il primo articolo esce il 6 marzo 1923. Si tratta di un capitolo
della Casa ispirata caduto durante la revisione del manoscritto,dedicato all’ultimo incontro con Apollinaire: Addio al poeta, cheSavinio ristamperà nel 1933 sulla «Nazione del popolo» e nel1938 in Achille innamorato53. Altri tre pezzi escono nella rubricaIl vaso di Pandora54, inaugurata il 30 marzo con Le Sirene, pro-seguita il 25 aprile con un articolo costituito da brani di tonorondista, uno dei quali – Le stagioni – recupera un altro capitolodella Casa ispirata, pubblicato proprio sulla «Ronda»55. Il 29-30aprile il Vaso prosegue con il trittico Le statue sui tetti; Carmenparaclausitiron, Encomio (una recensione dello spettacolo teatra-le di Ercole Patti «Carosello»). Il quinto e ultimo articolo vienepubblicato il 13 maggio, quando Soffici ha già abbandonato il«Nuovo Paese» per assumere la direzione della terza pagina del«Corriere Italiano», e ha un titolo generico: Miscellanea (com-prende: Ordine del passato56, Quando la pioggia cessa, Il calciodell’asino, Chiosa necessaria).
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 407
57. Cinquantanove lettere ad A. Soffici, p. 373 (la lettera è datata genericamente «Lu-nedì», la ricostruzione dell’anno è congetturale).58. Nuova enciclopedia, Milano, Adelphi 19853, alla voce «Questi».59. Per cui cfr. MAJOLO-MOLINARI, La stampa periodica romana..., vol. I, pp. 182-9.
Una lettera inviata a Soffici nel 1923 fa pensare che la colla-borazione di Savinio fosse più attiva, se pure sotto pseudonimoo anonimato: «eccoti una colonnina di quella rubrica di varietàdi cui s’era parlato. Credo che andrà bene per i lettori del Nuo-vo paese. Fra poco ti porterò dell’altro materiale, poiché possie-do delle fonti inesauribili di simili storielle»57. Potrebbe trattarsidella rubrichetta Malaria, apparsa per la prima volta il 1 marzo1923 (cinque giorni prima del suo primo articolo) firmata «Ano-fele», di cui escono nove puntate fino al 12 dicembre 1923 (1,15, 22, 30 marzo 1923; 8-9, 14 aprile 1923; 4, 8, 12 dicembre1923). Oppure di alcuni articoli miscellanei usciti anonimi sottoi titoli: Notizie di varia cultura (31 marzo 1923); Fiori di carta (21aprile 1923); Notizie di varia cultura (31 marzo 1923).Il genere composito ed eterogeneo dei contributi, se da un la-
to rimanda alla prosa rondesca e al pezzo conchiuso e stilistica-mente perfetto, dall’altro rappresenta le prove generali della sag-gistica saviniana, che sembra poi trovare nelle collaborazionicon il «Corriere Italiano», sia per il carattere continuativo (unpezzo ogni due giorni circa), sia per il tono leggero e fintamentedisimpegnato, una prima realizzazione di quella «lingua chiara eleggera, monda tanto di enfasi tribunizia, quanto di oscuritàpseudo filosofica o ermetica»58, che sarà la cifra stilistica dell’au-tore negli anni a venire.
Soffici e la terza pagina del «Corriere Italiano»
La storia del «Corriere Italiano»59 è strettamente legata aquella della progressiva infiltrazione del governo Mussolini nelmondo affaristico e imprenditoriale e della sua graduale occupa-zione di tutti i principali centri di potere dei mass-media. Il quo-tidiano romano, nato nell’agosto del 1923 per diretta iniziativadel governo, dopo poco meno di un anno viene travolto dal de-
408 PAOLA ITALIA
60. G. RAVEGNANI, Uomini visti. Figure e libri del 900 (vol. I: 1914-1954), Milano,Mondadori 1955, pp. 94-5.
litto Matteotti, organizzato proprio all’interno della sua redazio-ne. Direttore è Filippo Filippelli, vice direttore Tom Antongini,redattore capo Armando Odenigo, la politica estera è di Gubel-lo Memmoli (pseudonimo del conte Giovanni Capasso Torre),quella interna di Nello Quilici, che chiama a Roma anche Rave-gnani. È proprio dai vivaci ricordi di Ravegnani che traiamopreziose informazioni sulla redazione del giornale.
Proprio nel mese in cui la Ronda tirava le cuoia, fui chiamato a Roma daNello Quilici, il quale era stato mio direttore al Resto del Carlino, e mi vo-leva colà per affidarmi la terza pagina di un nuovo giornale (il CorriereItaliano), che in fatti nacque, visse un paio di anni, e morì di morte inglo-riosa. Tuttavia, o come redattori o come collaboratori ebbe nomi di gala: irondisti in testa (Cardarelli, Baldini, Barilli, Bacchelli), e poi Soffici, Savi-nio, Civinini, Chiarelli, Campanile, Tieri e persino il «bel tenebroso», ov-verossia Guido da Verona. Fu Quilici […] a dare al Corriere Italianoquell’indirizzo sensibile e aperto ai vari fatti dello spirito, che, nel quoti-diano, erano trattati almeno alla pari dei fatti politici e della cronaca. Perquesto Soffici era critico d’arte (e poi direttore di Galleria, che fu il men-sile, tipo Lettura, del Corriere Italiano), Barilli critico musicale, Chiarellicritico teatrale, Baldini estensore dei quotidiani «pezzulli» in corpo 6 diterza pagina, Civinini inviato speciale, e Cardarelli, Savinio, Bacchelli,Campanile, Montano, Saffi e dieci altri ottimi nomi, quali scrittori di «el-zeviri», note e corsivi. Senza dubbio, il Corriere Italiano significò un inse-rimento in massa della letteratura nel giornalismo; e, si badi, di una lette-ratura per lo più rondesca, vale a dire risentita e non di gusto corrente60.
Nell’editoriale del primo numero dell’11 agosto 1923 Filippellipresenta il nuovo foglio come successore del «Giornale di Ro-ma»: «il cui nome resta legato attraverso magnifiche pagine dilealtà e di ardore alla marcia d’ottobre». La sua adesione al fa-scismo è assoluta:
La rivoluzione fascista è in marcia e si arresterà per trasformarsi e supe-rarsi solo quando tutti gli italiani in alto e in basso sentiranno vivere in lo-ro un’anima nuova fatta di giovinezza, di adesione alla realtà, di orgogliodella razza, di disciplina, di volontà chiara ed ostinata di conquistare nelmondo senza iattanza e senza colpi di testa, giorno per giorno, i propriidiritti, tutti i diritti di un popolo grande, serio, forte, laborioso e pacifi-co…. Per quanto le nostre forze lo permetteranno noi spianeremo il cam-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 409
61. Cfr. la lettera del 13 dicembre 1961 inviata a Prezzolini, in G. PREZZOLINI-A.SOFFICI, Carteggio II (1920-1964), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 1982.62. Cfr. il volume di E. ORLANDO, Il dossier Matteotti, Milano, Mursia 1994 e soprat-tutto la requisitoria della parte civile al processo di Chieti contro Dumini in Matteotti.Il mito, a c. di S. CARETTI, Pisa, Nistri 1994.63. SOFFICI,Miei rapporti..., p. 805.
mino e fiancheggeremo l’opera dell’uomo che sta guidando il nostro po-polo con superba tenacia, contro tutti i nemici aperti ed occulti.
Le vicende economiche del giornale sono legate a doppio filo almondo affaristico che ruota intorno al movimento fascista, ungiro malamente diretto da Filippelli, la cui automobile sarà uti-lizzata per il sequestro Matteotti. Così, in una lettera a Prezzoli-ni, ricorda laconicamente la vicenda lo stesso Soffici:
Il giornale [«Nuovo Paese»] cessò dopo alcuni mesi, per dar luogo alCorriere Italiano, dove pure io fui chiamato a dirigere la terza pagina.Nell’aprile del ’24, io, stufo, tornai a casa mia, qui [Poggio a Caiano].Mesi dopo il Corriere [Italiano] fu travolto dal delitto Matteotti, Bazzi,grande amico e compare di Cesarino Rossi esulò con questi a Parigi61.
Nel memoriale su Mussolini, però, racconta anche che a un cer-to punto intorno a Filippelli incominciarono a riunirsi «le perso-ne più disparate che andavano dal Rossi, al gigantesco fascistabolognese Arconovaldo Bonaccorsi, dal generale De Bono, capoallora della polizia, a Chiavolini, dal deputato Carnazza a Puta-to, Volpi, Viola, Dumini…. Questi ultimi quattro – che doveva-no essere pochi mesi dopo implicati nel delitto Matteotti62 – fa-cevano piuttosto che visite delle apparizioni saltuarie […], maper questo appunto la loro presenza al giornale era meno spiega-bile, e anco era compromettente, tanto più che in taluni caffè elocali pubblici del centro di Roma, già cominciava a circolare lavoce di certa ceka, imprudentemente progettata non si sapeva dachi, e di cui essi, si diceva, avrebbero dovuto far parte»63.Dopo aver pubblicato la notizia del sequestro Matteotti il 13
giugno, il 14 Filippelli cerca di chiarire la sua posizione scagio-nando il suo autista Amerigo Dumini; il 15 il presidente delConsiglio di Amministrazione del giornale presenta le dimissionidi Filippelli e la nomina di Memmoli alla direzione. I fatti preci-pitano in poco tempo. Il 17 giugno Filippelli è arrestato su un
410 PAOLA ITALIA
64. R. DE FELICE, Soffici, gli intellettuali e il fascismo, in Ardengo Soffici. L’artista e loscrittore nella cultura del 900, Atti del Convegno di studi, Villa Medicea, Poggio a Caia-no, 7-8 giugno 1975, a c. di G. PAMPALONI, Firenze, edizioni Centro Di 1976, p. 70.
65. MAJOLO-MOLINARI, La stampa periodica romana..., vol. I, p. 188.
motoscafo al largo di Genova mentre tenta la fuga, vengono rin-venuti dei documenti nella sua valigia, resi pubblici il 18 giugno,che provano la colpevolezza di Dumini e provocano il mandatodi cattura di Cesare Rossi. L’ultimo numero del giornale è del 19giugno 1924; tre giorni prima Savinio aveva pubblicato una re-censioncina di un volume di racconti di Ercole Patti: Novellieriin boccio.È forse improbabile che nella redazione culturale del giornale
si avesse avuta alcuna notizia di quanto Filippelli, Rossi e Dumi-ni stavano progettando a livello politico, ma se si ripercorre labreve vita del quotidiano si vede chiaramente come sin dall’ini-zio l’impostazione culturale fosse funzionale a quella politica.Intento dichiarato era fare un giornale nuovo che, da posizionifasciste, avesse «quella autorità politica e quella fattura tecnicache possedeva a Milano, nel campo liberale, il “Corriere dellaSera”»64. E analogamente al quotidiano milanese, infatti, a que-sto «Corriere» romano viene allegato un mensile di carattereesclusivamente letterario: «Galleria».Chiamato alla redazione della terza pagina, Soffici vi convo-
glia gli artisti e gli intellettuali che avevano già lavorato al «Tem-po», alla «Ronda», al «Convegno», al «Primato Artistico Italia-no» e più recentemente al «Nuovo Paese», ma vi assume un at-teggiamento politicamente più impegnato. La cultura non è piùdefilata e autonoma, ma assolutamente solidale alla politica. Alcentro della terza pagina, infatti, campeggiano sempre uno odue articoli di cronaca, che trattano temi vari come aperture diospedali (25 agosto) o inaugurazioni di monumenti (come gli ar-ticoli scritti dallo stesso Savinio il 31 ottobre e 1 novembre1923). Non si può dire, quindi, che «più che una pagina lettera-ria come era venuta di moda all’inizio del ’900, è una pagina diarticoli di varietà non strettamente culturale»65. Si tratta, invece,di un’importante operazione culturale, promossa e voluta daSoffici e solidalmente portata avanti dal gruppo redazionale di
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 411
66. Il 25 agosto 1923 vengono ad esempio recensite due pubblicazioni di Marga: Uo-mini rappresentativi fascisti (Fascio milanese) e Piccolo mondo fascista, che viene diffu-so nelle scuole come libro di lettura (Casa Editrice Fascista Imperia).67. Per Baldini, come per gli altri collaboratori, si dà qui soltanto una campionatura,molto significativa, degli articoli pubblicati sul quotidiano: Barba cèca, 12 agosto 1923;Pastello parigino, 2 settembre 1923, Frate Silvio e Frate Lupo, 18 settembre 1923; I sui-cidi nell’anticamera, 13 ottobre 1923; Il bruco e la rosa, 18 novembre 1923; Fontana diTrevi, 20 gennaio 1924; Grilli zuarini, 23 febbraio 1924; Il mementomo al Margherita,13 marzo 1924; Cannoniere di mezzogiorno, 15 marzo 1924; La primavera e le ragazze;La morte del ragno, 25 marzo 1924.68. Parole povere, 1 dicembre 1923; Parole povere, 27 dicembre 1923; Fine del Dilu-vio 1 gennaio 1924; Elegia etrusca 13 gennaio; Studi sul mio paese, 20 gennaio 1924;
provenienza vociana e rondesca, che si intreccia con la nascentepubblicistica fascista66, connubio che valorizza la prima per le-gittimare la seconda innestandola nel solco della cultura italiana.Emblematica a questo proposito un’intervista con il generaleGrazioli su I nuovi criteri tattici, apparsa il 6 settembre 1923 interza pagina, in cui si prospetta l’utilizzo della milizia nazionalein operazioni di pertinenza dell’esercito, soprattutto nel campopiù idoneo a milizie volontarie come quello delle «truppa diavanscoperta e di copertura; come presidio di città attaccate oassediate». Il 16 settembre 1923, in una pagina dove Soffici par-la di Rimbaud in Africa, nel Corriere teatrale e in Archi e fiati(cronaca musicale), il lettore viene informato con dovizia di par-ticolari della Giornata di Mussolini. Nel mese di ottobre del1923, in preparazione dell’anniversario della marcia su Roma, lospazio è tutto dedicato alle varie commemorazioni (a partire dalvademecum del 2 ottobre: Le cerimonie commemorative dellaMarcia su Roma) e di interventi letterari non se ne trova traccia.Il 25 ottobre è proprio Amerigo Dumini a scrivere un ricordodell’ottobre 1922: Dalla mobilitazione alle barricate all’assaltodell’«Avanti!», e la celebrazione continua con un intervista a DeBono il 27 ottobre 1923.Tuttavia, nonostante l’elevato coinvolgimento nella linea edito-
riale e politica del giornale, se analizziamo la terza pagina dalpunto di vista strettamente letterario non possiamo non ricono-scere il livello buono e spesso di notevole qualità dei contributidei collaboratori, che vanno da rondisti di lungo corso come Bal-dini (circa un articolo al mese)67, Cardarelli68, Barilli (titolare del-
412 PAOLA ITALIA
Parole povere, 7 febbraio 1924; Il trionfale successo di Emilar al Costanzi. Bruno Barillivince superbamente la sua prima battaglia, 13 marzo 1924; Il pastore, 25 marzo 1924.69. L’Opera di Parigi, 18 agosto 1923, il 27 e il 29 settembre esce due volte l’articolosu Alfredo Casella.70. La morte di Maurice Barrès, 6 dicembre 1923; Le cose viste da Ojetti, 21 dicembre1923; Passato e presente, 30 dicembre 1923; Il paese del silenzio, 4 gennaio 1924, Cal-zini e Savarese, 30 gennaio 1924, Il volto di Roma, 19 marzo 1924; Constatazioni, 21marzo 1921; Scontentezze, 23 marzo 1924; Jerome Kapla Jerome, 28 marzo 1924.71. Argomenti, 6 ottobre 1923; 14 ottobre 1923; 21 ottobre 1923; 23 novembre 1923;9 dicembre 1923; 15 dicembre 1923; 29 dicembre 1923; 3 gennaio 1924; 12 gennaio1924, 23 gennaio 1924.72. Un giorno di riposo a Rocca di Papa, 18 agosto 1923; Ho vinto il milione!, 24 ago-sto 1923; Il Presidente in famiglia, sulla spiaggia di Levanto, 26 agosto 1923; La dome-nica del Presidente tra i bagnanti di Levanto, 28 agosto 1923; L’uovo di Colombo, 2 set-tembre 1923; Spoleto, Monteluco, Norcia, 12 settembre 1923; Norcia-Preci-Visso, 15settembre 1923; Montefalco, Foligno, Trevi, 22 settembre 1923; La città dei bevitori:Fiuggi, 4 ottobre 1923; Teste di turco, 19 dicembre 1923; Storia d’una lupa e dei suoicinque lupacchiotti, che fecero la cena di Natale mangiandosi un vecchio mendicante, 25gennaio 1924; Come s’avvelenano i lupi nella montagna di Castel Sant’Angelo, 26 gen-naio 1924, Serenata a due lupi, al chiaro di luna, 20 gennaio 1924; Verso il paese dellaguerra fra uomini e donne, 24 febbraio 1924.73. Addio pagliaio!, 4 novembre 1923.74. Primizie, 19 settembre 1923; Monumento alla mia serva, 15 dicembre 1923; Con-tro le cavallette, 10 febbraio 1924.75. Venezia, 3 ottobre 1923.76. Giovan Battista Marino, 3 agosto 1923; Anticlassicismo, 8 settembre 1923; Divinopiù divino, 25 dicembre 1923; Del parlare oscuro, 8 gennaio 1924; Variazioni sullo stile,5 febbraio 1924.77. Un precursore: Francesco Crispi, 1 settembre 1923; Il cane e le mosche, 3 novem-bre 1923; Il signor Emilio (un grande editore), 12 dicembre 1923.78. Il 4 settembre 1923 in Cocomereide, risponde all’articolo di Savinio Giostra. Il co-comero («Corriere Italiano», 28 agosto 1923), con una difesa del frutto; Savinio repli-ca nuovamente con Siciomachia («Corriere Italiano», 15 settembre 1923).
le cronache teatrali)69 e Montano (che firma la recensione al Por-to sepolto di Ungaretti con prefazione di Mussolini), a luogote-nenti come Savinio e Ravegnani70, a letterati di area milanese co-me Bontempelli (che fino al gennaio 1924 tiene la rubrica Argo-menti)71, a un eccentrico e prolifico umorista come Campanile72.Ma anche ex vociani come Prezzolini73 ed ex futuristi come Go-voni74 e Palazzeschi75, letterati come Flora76 e, come ricorda Ra-vegnani, anche Guido da Verona, che il 2 marzo 1924 firma unaLettera d’amore alle sartine d’Italia, e Panzini (tre contributi)77,mentre Giovannetti continua l’inossidabile rubrichetta «Satyri-con», che già teneva sul «Tempo» e sul «Nuovo Paese»78 e Braga-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 413
79. Biglietto da visita conservato presso il Fondo Papini.80. Nelle «Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodi-che», emanate dal Regio decreto-legge del 15 luglio 1923, n. 3288, pubblicato sullaG.U. 8 luglio 1924, art. 2 si legge: «Il prefetto della provincia ha facoltà, salvo l’azionepenale, ove sia il caso, di diffidare il gerente di un giornale o di una pubblicazione pe-riodica: a) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false e tendenziose re-chi intralcio all’azione diplomatica del governo nei rapporti con l’estero o danneggi ilcredito nazionale all’interno od all’estero o desti ingiustificato allarme nella popolazio-ne ovvero dia motivi di turbamento dell’ordine pubblico; b) se il giornale o la pubbli-cazione periodica con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni o vignette istighi acommettere reati o ecciti all’odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordinidelle autorità o comprometta la disciplina degli addetti ai pubblici servizi o favoriscagli interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vili-penda la Patria, il Re, la real famiglia, il sommo pontefice, la religione dello Stato, leistituzioni e i poteri dello Stato o le potenze amiche (cito da G. LANGELLA, Le riviste dimetà novecento, Brescia, Editrice La Scuola 1981, pp. 11-2). Il decreto sulla stampa su-scita la reazione di Gobetti su «Rivoluzione liberale», III, 30 (22 luglio 1924).
glia tratta I problemi dell’allestimento scenico (2 novembre 1923).La stagione d’oro della terza pagina del «Corriere» non varca
l’anno. Un primo segnale d’involuzione è dato dalla comparsa, il26 marzo 1924, delle Memorie di Tex Rickard, «romanzo bio-grafico del grande organizzatore americano». Pochi giorni dopoSoffici torna a Poggio a Caiano, lasciando a Baldini l’incarico as-sunto esattamente un anno prima. Già dal 19 marzo, tuttavia,aveva meditato un ritorno in Toscana, comunicato prontamentea Papini, con cui sembra voler riallacciare i rapporti interrotticon la vicenda fiumana: «Ai primi di Aprile tornerò in patria perrestarvi – Ci vedremo, e riprenderemo l’antica intimità, piùprofondamente amici»79.Gli articoli di Soffici sono forse il documento più importante
e meno conosciuto della politica culturale del fascismo nel suoprimo anno di vita. Il 15 agosto 1923, con un pezzo intitolatoChiose, Soffici pubblica un durissimo intervento sulla necessitàdi applicare le leggi sulla restrizione della libertà di stampa, che,approvate nel luglio precedente, sarebbero state messe in attosolo nel 1924, dopo il delitto Matteotti80:
Da tutti coloro, spregiatori della Patria, abbrutitori di popoli, disfattisti inguerra ed in pace, che per anni ed anni si sono sfogati a predicare e sbrai-tar oscenamente da periodici e quotidiani mantenuti e sgrammaticati, èstato fatto un gran parlare di libertà di stampa, dacché il governo di Mus-solini ha dato ad intendere di voler che la baldoria finisse o diventasse al-
414 PAOLA ITALIA
81. Chiose, «Il Corriere Italiano», 15 agosto 1923. Soffici continua dichiarando cheper un paese come l’Italia «diseducato, al tutto guasto da un malgoverno di più decen-ni, sboccato come un cavallo giovane retto da un guidatore imbecille, un richiamobrusco alla dignità, alla serietà, all’onestà, alla coscienza della disciplina e dell’ordine,in una parola, non è atto che possa garbare e trovare unanimità di consenso. [...] Biso-gna avere la coscienza affatto pulita, per non temere che un governo come l’attualepossa privare un popolo, nobile nel suo insieme, del magnifico privilegio della reale li-bertà di opinione e di parole. [...] Sapevo benissimo, quanto a me, per esempio, anchesenza le tranquillizzazioni posteriori, che il capo del fascismo, cioè della vera Italia,non avrebbe mai commesso l’errore di imbavagliare la nazione, di umiliarla davanti ase stessa ed al mondo. Egli sa meglio di chicchessia che una giusta critica, l’espressionesincera di un parere diverso, l’enunciazione franca di idee, anche audaci, non si po-trebbero impedire senza danno proprio, della Patria, e senza offesa atroce allo spirito,che come si sa soffia dove e come vuole; e sempre in favore di una più larga ed intensavita. […] Così approviamo la restrizione giusta, come sapremmo ad ogni modo libe-rarci da un capestro che ingiustamente ci fosse stato messo al collo». Il tentativo di sal-vare la propria fede nella libertà di stampa naufraga in un contorto ragionamento – so-stenuto da una capziosa citazione dell’abate Galiani («Che Dio vi scampi e liberi dallalibertà di stampa stabilita per legge. Non v’è nulla che più contribuisca a rendere unanazione grossolana») – che offre di fatto al governo l’avallo del mondo culturale allapropria autocensura («Questo per dire che anch’io sono per la libertà di stampa, comeprincipio, e contentissimo che nessuno pensi a toglierla se non quando lo imponganole leggi del vivere civile, e la necessità di difendere l’interesse vero della Nazione»).82. Cfr. anche la lettera del 17 aprile 1924, citata in SOFFICI, Miei rapporti..., p. 853,in cui Soffici, già trasferitosi a Poggio a Caiano, riferisce a Mussolini di una concilia-zione tra il «Corriere della Sera» e il governo fascista, propostagli da Prezzolini all’ini-zio di aprile, ma non approdata a nulla per l’assenza di Mussolini da Roma. Secca la
meno un po’ meno sconcia. Le più alte querele, i più comunali argomen-ti, le frasi di maggior effetto, sono stati tirati fuori per la circostanza; enon s’è visto ritornare un po’ di tranquillità se non quando una mezzapromessa è venuta che, ove la canaglia suddetta desse segno di una saluta-re resipiscenza, qualche temperamento si porterebbe forse nell’applica-zione dei provvedimenti escogitati81.
Di estrema importanza anche un successivo intervento del 5 set-tembre 1923 (Chiose. Legalità), in cui il concetto di legalità è de-finito in relazione all’esercizio della violenza, con preciso riferi-mento alla soppressione del «Corriere della Sera», antagonista,come si è detto, del «Corriere Italiano» sin dalla sua fondazione:
Per questo oggi [il «Corriere della Sera»] potrebbe sparire senza lasciarealcun rimpianto; ma a patto, ripeto, che chi vuol distruggerlo si senta ingrado di creare un organo altrettanto buono dal punto di vista stretta-mente giornalistico, come potrebbe crearlo molto migliore e più intonatocol momento storico, dal punto di vista politico, culturale e spirituale82.
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 415
risposta di Mussolini (t.p. del 24 aprile): «Mi farai il piacere di dire al tuo amico che èun piramidale imbecille. Il governo fascista non tratta col Corriere. Se ne frega!» (SOF-FICI, Miei rapporti..., p. 854). Soffici risponde il 28 aprile dissociandosi dalla propostaprezzoliniana e reiterando la sua dichiarata fiducia nel Duce, ma aggiunge: «Può darsiche, non essendo io uomo politico-pratico, ti venga fuori con discorsi o proposte inge-nue. Ma l’intenzione è sempre quella. […] Leggi le mie noterelle sul Corriere Italiano?Anche quelle le scrivo per te».83. Anche un appassionato intervento in difesa della scultura di Medardo Rosso(Caccia al rosso, il 26 agosto 1923), di cui Soffici aveva sempre riconosciuto il valoreartistico, è occasione per una dichiarazione che testimonia il diffuso clima di violenzae intimidazione. Di fronte all’oblio in cui è tenuto Rosso, Soffici si scaglia contro «me-stieranti guastatori di marmo e di bronzi» di cui fa nomi e cognomi (Ferrari, Ximenes,Calandra, Bistolfi, Dazzi, Zanella, Trubeskoi), per concludere con una domanda nontroppo retorica: «Oppure dovremo, all’ultimo, mentre tanto felicemente vanno spa-rendo da quelle politiche, trasportare in queste lotte dello spirito, del gusto e dell’in-telligenza artistica gli argomenti persuasivi del manganello, dell’olio di ricino, e, a unbisogno, della revolverata, per essere intesi a fare un po’ di luce intorno a noi?». Nesegue una polemica con Ojetti (accusato di aver sottovalutato l’opera di Medardo)che il 30 agosto (Prime fucilate) replica accettando provocatoriamente la proposta diSoffici di fare una lista di proscrizione degli artisti (che semplificherebbe anche il la-voro dei critici e dei politici costretti a inaugurare ogni giorno mostre e monumenti diartisti indegni di entrare nella lista). Seguono il 1 settembre Fucilate di risposta (A pro-posito della «Caccia al Rosso»), che, dopo alcune schermaglie, svela le intenzioni soffi-ciane: «Dopo di che a me non resta ormai che dir due ultime parole ormai relative allaminaccia di ricorrere ai metodi del fascismo nelle questioni artistiche. Anche qui Ojet-ti pecca d’immodestia quando vuol sentirsi preso di mira personalmente, o nella suaqualità di critico. La minaccia (tutta carta, infatti, e purtroppo!) era invece espressa-mente rivolta ai manomettitori ufficiali delle opere rossiane; e, sebbene in fondo nean-che io pensi che il manganello, ecc. debbano entrare in ballo dove sono in giuoco lecose dello spirito, non riesco a convincermi che il metterla in effetto ogni tanto nonfosse atto santissimo. Del resto vedremo!». Il 2 ottobre la polemica è già rientrata esul «Corriere Italiano» viene pubblicato Il monumento alla Vittoria e il colle del castel-lo di Gorizia, un’anticipazione dalla rivista d’arte «Dedalo» diretta dallo stesso Ojetti.
Il progetto di risanamento culturale, secondo una linea classici-stica che proponeva a modello dell’arte fascista la ‘sana’ tradizio-ne italiana contro la candidatura futurista83, emerge molto chia-ramente nella polemica con Marinetti, sollecitata da un articoloin cui Soffici propone una rilettura personale in chiave antiger-manica dei movimenti artistici d’inizio secolo (Italia, «CorriereItaliano», 8 dicembre 1923). Postulato che il romanticismo è diorigine protestante, Soffici fa derivare da esso il naturalismo, ildecadentismo e il futurismo. Il futurismo – che riassumerebbe insé le tre correnti precedenti – ateo e anticattolico, è perciò antila-tino e antiitaliano e di conseguenza antifascista, perché il fasci-
416 PAOLA ITALIA
84. Cfr. sulla polemica anche SOFFICI,Miei rapporti..., pp. 744-5.85. Carta manoscritta conservata nel Fondo Savinio fuori schedatura in una cartellet-ta intitolata: «Corrispondenza e Block notes non schedati»; sta] prima lett. ill. come]prima, pure, diversissime] ms. diversissimi su] prima dissente dall’opinione tua.] dadalla opinione anche] prima perché sembrare accettabile] 1venir accettata da cui 2pa-rer accettabile come buona giusta da cui T alla genesi... all’ultimo] 1io spero 2che a< >da cui T.
smo predica un «ritorno al passato», la «restaurazione dei valoritradizionali», «fa appello alla gloriosa storia della nostra razza» e«rivendica la grandezza millenaria della nazione». Nel futurismoSoffici riconosce però alcuni elementi «genuinamente italiani»(mentre quelli degeneri sono di origine «forestiera»): «l’amoredel rischio che tanto giovò in guerra, l’arditismo divenuto poisquadrismo fascistico, il gusto del pittoresco passato nella Mili-zia, l’esaltazione della gioventù espressa poi con inni nazionali, etante altre virtù sono di pura essenza futurista». L’obiettivo pole-mico, naturalmente, è Marinetti, che si affretta a replicare –sull’«Impero» del 9 novembre – che «naturalismo, romantici-smo, verismo, decadentismo» non sono stati movimenti germani-ci, ma di derivazione francese, cosa che Soffici, attivo a Parigi dal1904 al 1907, doveva sapere bene84. La polemica continua il 9novembre con un evasivo trafiletto sul «Corriere Italiano» (Di-sfattismo?) in cui Soffici rimanda la discussione del problema al-la seconda puntata di Italia, pubblicata però solo l’8 dicembre1923 (la terza puntata esce più tardi, il 22 febbraio 1924).Nel Fondo Savinio si conserva un breve testo manoscritto,
purtroppo incompiuto (forse una prima stesura di un articoloper il «Corriere Italiano» mai pubblicato), in cui Savinio replica aSoffici, mostrando il suo personale dissenso dalle idee dell’amico:
La responsabilità, caro Soffici, di questa mia nota è da imputare ad tuoarticolo “Italia” pubblicato l’8 corr. su queste medesime colonne. La rina-scita culturale dell’Italia, dopo la sua rinascita politica, è un problema chesta sommamente a cuore a te, come a me, come a ogni italiano che non siao un bruto o un inguaribile cretino. Ma le opinioni intorno alle possibilitàdi questa rinascita, sono molte e diversissime. La mia, ad esempio, dissen-te su molti punti dall’opinione tua. Lascia dunque che l’esponga: anche senon dovesse sembrare accettabile potrà aiutare alla genesi di quella ideagiusta e salutare che, speriamolo, all’ultimo ci salverà [ ]85.
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 417
86. DE FELICE, Soffici..., p. 69.87. Lo si percepisce dalle parole di critica di Ottone Rosai, il 14 settembre 1923:«Vedo ogni tanto il Corriere Italiano e mi sembra soffra del male di tutti i giornali ecioè non sia quello che anche tu vorresti fare» (ROSAI, Lettere..., p. 197).88. Cfr. SOFFICI, Miei rapporti..., p. 741 (l’osservazione è già in DE FELICE, Soffici...,p. 70); dal canto suo Soffici interviene direttamente presso il Duce per proteggereGobetti dagli attacchi squadristi che ne provocheranno la morte (SOFFICI, Miei rap-porti..., pp. 787-8).
Alla fine del 1923, nella collana «I problemi del fascismo» diret-ta da Curzio Suckert, Soffici pubblica presso la «libreria dellaVoce», con dedica a Mussolini, Battaglie tra due vittorie, prece-duto da un Ragguaglio sullo stato degli intellettuali rispetto al fa-scismo dello stesso Suckert. Già il titolo, mettendo sullo stessopiano la marcia su Roma e la vittoria «tradita e mutilata», lasciaintravedere – secondo de Felice – molte perplessità ed è «l’indi-ce o di un fascismo limitatamente inteso, o dell’inizio di un ri-pensamento, di una insoddisfazione»86. Se è eccessivo e fuor-viante parlare per Soffici di un fascismo «moderno, critico, “re-visionista”, veramente “nazionale”», che si attuerebbe attraversola politica del «Nuovo Paese» e del «Corriere Italiano» (dove in-vece, come si è visto, la posizione è molto meno sfumata e orto-dossamente fedele al governo e al suo capo) è anche vero che, aldi là dei toni violentemente polemici dei suoi scritti, egli nonpartecipa in modo alcuno alla vita politica della capitale, né ac-cetta quegli incarichi di governo che pure gli erano state offerti.La sua posizione, perciò, si rivela tanto più contraddittoria ecomplessa87 quanto più i suoi articoli mostrano la sicumera diuno ‘squadrismo culturale’ di certo arrogante e pericoloso. Daun lato, infatti, il suo passato e la sua riconosciuta intelligenzaletteraria potevano far sì che Gobetti si rivolgesse a lui nel mag-gio del 1923, per commissionare una biografia di Mussolini dafare uscire per la sua casa editrice e proponendo uno scambiotra «Energie nove» e il «Nuovo Paese»88, dall’altro le sue dichia-razioni di incondizionata fede fascista proseguono ben oltre ilsuo attivo coinvolgimento nella politica culturale del governo,come mostra la prima lettera inviata a Mussolini dopo il delittoMatteotti: «Sono felice di vedere come la tua azione proceda vi-gorosamente. La fatalità storica è per te, mio caro e grande e
418 PAOLA ITALIA
89. SOFFICI,Miei rapporti..., p. 855.
90. La rivista è stata ristampata anastaticamente nel 1983, cfr. «Galleria», XXVIII,3-6 (dicembre 1983), a c. di R. TORDI, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Edito-re, pp. 183-7 e nel 1992, «Galleria». Una rivista di Soffici e Baldini sotto il fascismo.Gennaio-Maggio 1924, con due testimonianze di G. SPADOLINI, a c. di A. PAOLETTI,Firenze, 1992.
91. Cfr. la lettera a Padre Rosa del 24 giugno 1924 riprodotta da R. RIDOLFI, Vita diGiovanni Papini, Milano, Mondadori 1957, p. 224: «Ai primi di maggio vennero dame due amici a propormi, a nome di Filippelli, di andare in Terrasanta con l’Emm.moGiorgi per mandare corrispondenze a quel giornale. Ma io rifiutai subito. Tornaronopiù volte ad insistere e giunsero ad offrirmi 150.000 lire per un solo mese di viaggio!Io seguitai a rifiutare e venni quassù nel mio romitorio a lavorare. Ora la morte delgiornale, dopo pochi giorni dalla condanna del S. Padre, mi ha fatto doppio piacere:come cattolico e come italiano».
92. Un quadro della situazione del «Corriere» negli ultimi mesi ci è offerto dal primoeditoriale dello «Spettatore italiano», dove Vincenzo Fani Ciotti (che firma i suoi in-terventi con lo pseudonimo di Volt) cita l’ultima politica del «Corriere Italiano» comeun esempio da non imitare: «Pur concedendo una ragionevole libertà ai singoli redat-tori, il giornale dovrà avere un indirizzo rigorosamente omogeneo ed unitario. La man-canza di questa omogeneità fu precipuo difetto del defunto «Corriere Italiano»; percui questo foglio disgraziato, volendo contentar tutti, si rese spiacente a Dio e ai nemi-ci sui. Dal bazar di quella redazione, gli articoli anche troppo aggressivamente intran-sigenti dei colleghi Soffici e Suckert uscivano cozzando con la scettica prosa degli ex-redattori del “Tempo”, fra cui quel Giovannetti che pochi anni prima sberteggiavaMussolini, quale spaventapasseri e spauracchio della borghesia italiana. […] Non è le-cito mandare Papini in Terra Santa a braccetto con Mata Hari!».
provvidenziale amico»89.All’inizio del 1924 al quotidiano viene affiancato un mensile
culturale interamente diretto da Soffici: «Galleria»90, il fiore al-l’occhiello dell’impresa del «Corriere». Vengono reclutati tutti iprincipali collaboratori della terza pagina del «Corriere», daCardarelli a Baldini, da Linati a Savinio (che vi pubblica però,come vedremo, solo tre contributi cinematografici), ma ne esco-no solo cinque fascicoli, fino a maggio. Il progressivo coinvolgi-mento del giornale nell’organizzazione dell’omicidio di Matteottiha evidenti ripercussioni anche sulla terza pagina e su «Galle-ria». Negli ultimi mesi prima del tracollo viene pubblicato apuntate il romanzo di Guido da Verona: Mata Hari e nel maggiodel 1924 Filippelli, mirando a conquistare l’importante fetta dipubblico ed elettorato cattolico, propone a Papini di diventarecorrispondente del «Corriere» in Terrasanta per una cifra al tem-po esorbitante91; incarico che viene rifiutato92. Ma dall’aprile
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 419
93. SOFFICI,Miei rapporti..., p. 853.94. Il 20 giugno 1924, quando il quotidiano ha ormai sospeso le pubblicazioni, sul«Popolo d’Italia» viene pubblicata una ricostruzione dei finanziamenti occulti al«Corriere Italiano». Vengono citati gruppi affaristici genovesi a cui nel 1923 si sareb-be rivolto come intermediario l’affarista Gigetto Parodi, convincendo (previa letteradi Mussolini) Odero (per gli armatori), Bruzzone (per gli zuccherieri) e GiovanniAgnelli a sostenere finanziariamente l’impresa. Una parte di tali fondi, tuttavia, erastata stornata a favore del «Nuovo Paese», anche mediante l’intervento di Cesare Ros-si. Dopo quattro mesi di disinvolta gestione finanziaria, era stato lo stesso Finzi – cheaveva sostenuto il giornale sin dalla sua fondazione – a declinare ogni responsabilità,scontrandosi con Filippelli, senza riuscire a portare dalla sua parte i finanziatori, fede-li più che al giornale al solo Mussolini, il quale sosteneva Filippelli attraverso CesareRossi (MAJOLO MOLINARI, La stampa periodica romana..., vol. I, pp. 182-9).
precedente Soffici ha già lasciato Roma ed è tornato al Poggio93,continuando solo sporadicamente le collaborazioni al «Corriere»e mantenendo ufficialmente la direzione di «Galleria». Così scri-ve a Mussolini il 17 aprile 1924:
Mio caro Amico,non so se tu sappia ch’io ho lasciato Roma da una quindicina di giorni
per venir qui a lavorare in pace. Resto direttore di Galleria e redattore delCorriere Italiano e per questo ogni mese verrò per alcuni giorni a Roma,dove tornerò stabilmente in autunno. […] Questa vittoria elettorale tra-scende di molto il significato che avrebbe potuto avere in altri momenti –e sono sicuro che tu saprai trarne tutto il partito possibile. Di più in più sidelinea la tua missione provvidenziale. Di più in più tutti coloro che ten-tano bestialmente di contrastare il passo alla tua, o nostra, Italia si chiari-scono essere oscuri come cadaveri ambulanti.
Il 10 giugno 1924 viene assassinato Matteotti e il 19 giugno ilgiornale chiude94.
Savinio e il «Corriere Italiano»: letteratura, politica e cinema
Dal 1923 al 1924 Savinio scrive sul «Corriere Italiano» 66 ar-ticoli, per lo più firmati, molti dei quali conservati in ritaglio nelFondo Savinio (la maggior parte senza data), altri siglati «A.S.»,«Al.S.» o semplicemente «S.». Tuttavia, la sigla più usata,«A.S.», non garantisce la paternità dell’articolo in quanto sulquotidiano collaborano anche Alberto Spaini e, naturalmente,Ardengo Soffici. L’articolo Arte. La «Saletta» d’Aragno («Corrie-
420 PAOLA ITALIA
95. Si veda anche SOFFICI,Miei rapporti..., p. 789.96. Questi gli interventi dubbi: Libreria. Endimione di Sibilla Aleramo, agosto 1923[siglato A.S.]; Libreria. «Opera poetica» di Mario Ittar e «Segreti di Cagliostro»; «Lecommedie» di P. Terenzio Afro, 7 settembre 1923 [siglato «a.s.»]; Libreria. «Un palazzoveneziano del Quattrocento» di Angiolo Torsi, 10 novembre 1923 [non firmato]; Libre-ria. «Pietro Fetro» di Luigi Capuana, 9 dicembre 1923 [non firmato]. Al gruppo è pos-sibile aggiunge alcune recensioni di spettacoli di operetta recanti la sigla «s.a.l.», utiliz-zata da Savinio per tre pezzi sul cinema conservati al Fondo: Giuda di F. Mari al Voltur-no, 2 novembre 1923; La fidanzata di Lucullo al «Costanzi», 4 novembre 1923; La bam-bola della prateria al Quirino, 7 novembre 1923; Vergognatevi Barone! di W. Kollo alCostanzi, 13 novembre 1923; La «Sirena» di O. Strauss al Costanzi, 25 novembre 1923.
re Italiano», 4 ottobre 1923), ad esempio, siglato «A.S.», do-vrebbe essere di Soffici in quanto rientra nella polemica svoltadallo scrittore in altri articoli del quotidiano, contro le decora-zioni della «presunta arte fascista»95. Tra i vari interventi ci sonoanche alcune schede bibliografiche nella rubrica «Libreria» e re-censioni nella rubrica «Cinematografo», ma mentre quest’ultimaè esclusiva di Savinio (anche quando i contributi sono siglati onon firmati), a «Libreria» collaborano anche altri scrittori (comead esempio Alberto Luchini). Abbiamo quindi registrato gli in-terventi dubbi separatamente, ad eccezione di quelli depositatial Fondo, conservati dallo stesso autore96.La sua collaborazione al «Corriere Italiano», finora trascurata
dalla critica, è di grande importanza per il numero e la qualitàdegli articoli. Analizzando i contributi si può subito osservarel’affinità tra gli argomenti trattati e i generi letterari in cui l’auto-re si cimenterà in anni successivi, fino ai volumi più famosi. Il«Corriere», da questo punto di vista, può essere visto come unbanco di prova, una palestra di allenamento in cui si definisconoi caratteri della prosa saviniana, sia sul versante narrativo chesaggistico, dal genere storico e biografico (che porterà a Narrateuomini la vostra storia e Ascolto il tuo cuore, città), ai primi re-portages di viaggio (che rimandano a Dico a te, Clio), ai toni ap-parentemente divaganti di certi brevi brani che inauguranoquella straordinaria sistematizzazione del mondo che prenderàle forme di Nuova enciclopedia.La serie dei racconti pubblicati sul «Corriere Italiano» sotto
il titolo comune Storie e favole si pone in solidale continuità conquella del «Nuovo Paese». Savinio recupera un passo della Casa
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 421
97. Sul ritaglio di stampa conservato nel Fondo, Savinio corregge «bambini» in«banditi» e aggiunge alla fine: «Puerorum aetas improvida!».98. A. SAVINIO, Capitano Ulisse. Dramma moderno in tre atti con una giustificazionedell’Autore, Quaderni di «Novissima», 1934; si veda la Nota di Alessandro Tinterrinella ristampa Adelphi, 1989 e 19952 e G. ISOTTI ROSOWSKI, Dittico Capitano Ulisse-La casa ispirata, «Il castello di Elsinore», IX, 27 (1996), pp. 31-60.
ispirata, analogo a quello uscito sul «Nuovo Paese» il passato 25aprile (Le stagioni), e divaga con altre considerazioni sulla sta-gione autunnale cantata da poeti come Nietzsche e ritratta nellasua profonda dolcezza da pittori come Boëcklin e Giorgio deChirico (Storie e favole. Ottobrata, 12 ottobre 1923). Una rievo-cazione memoriale, sulla scia della recente stesura dei ricordid’infanzia, è Il fratello del sicario, pubblicato il 21 novembre1923, in cui Savinio traccia un ritratto di don Luigi Labella, l’a-bate marista della chiesa di San Dionigi ad Atene, primo confes-sore del piccolo Andrea de Chirico, poco convinto della santitàdel sacerdote cui «preferiva i brigantoni, quei terribili e simpati-ci bambini che empievano delle loro gesta le mie prime letture, ela cui vita era tutta un gioco di equilibrio sull’argine dell’infer-no»97. Al genere delle meditazioni svagate appartiene invecel’ultima delle Storie e favole: Meditazioni sui dolci (10 gennaio1924), in cui Savinio loda i dolci come affinamento delle facoltàsensibili che «richiede una inclinazione naturale alla fantasia e aitrasporti poetici».Ma la terza pagina del «Corriere» offre anche alcune antici-
pazioni interessanti dei futuri progetti dello scrittore. La più ori-ginale è costituita dal Ritorno di Ulisse (11 novembre 1923) incui è possibile riconoscere l’incunabolo del dramma CapitanUlisse, scritto e prodotto per il Teatro dell’Arte di Pirandello nel1925 (ma rappresentato solo nel 1934)98. Savinio sviluppa qui,in antitesi con l’iconografia tradizionale, l’immagine di un Ulissepoco sagace e scaltro, e anzi «l’uomo più ingenuo, più romanti-co, più fidente che abbia attraversato codesta vita», che con il ri-torno a Itaca, terra dei suoi sogni, compie una «inescusabile gaf-fe», e conosce una «tremenda delusione, la più tremenda delletante sparse e dimenticate lungo il fortunoso periplo». All’im-magine «vaghissima» di Penelope, che ha coltivato dentro di sédurante le lunghe peregrinazioni, si sostituisce la realtà di una
422 PAOLA ITALIA
99. Ma prima nella «Rivista di Firenze», 5-6 (settembre 1924), pp. 3-5; per entrambii racconti cfr. le corrispondenti Note al testo in SAVINIO, Casa «la Vita» e altriracconti, pp. 928 e 890.
donna «incredula, frigida da far venire i geloni in agosto, calco-latrice, attaccata ai beni palpabili e in fondo in fondo dimenticadi lui». La fuga verso nuovi viaggi sarà il suo destino. Il poetache lo farà sparire tra i flutti, vittima del «folle volo» della sua«canoscenza», sarà la sua salvezza. L’11 novembre, nel quintoanniversario della scomparsa di Apollinaire, Savinio scrive un ri-tratto violento, potente e sofferto dell’amico. Non lo ristamperàmai più, preferendo quell’Addio al poeta più giocoso e svagato,aneddotico e distratto che costituiva un capitolo della Casa ispi-rata (e che confluirà poi in Achille innamorato). Questo, invece,non è un medaglione ma un’istantanea tragica sul corpo immen-so e decomposto del poeta, abbandonato a morire di spagnola«nella sua cameretta bassa di soffitto, davanti l’irresponsabileidiozia dei quadri cubisti, vigilato dagli sguardi bianchi degliidoli congolesi». Guglielmo Apollinaio di Kostrowitzky, «viag-giatore condannato a portarsi due pesantissime valigie, una permano, in un viaggio senza stazioni né riposo»: «l’amore, sospira-to sempre, non conosciuto mai insino alla vigilia della morte: lastoria oscura, la storia piena di sospetto della sua venuta al mon-do erano i due costanti tormenti che travagliavano quell’animogentile e cavernoso assieme». L’aveva scoperto, ormai «verda-stro, marcio», Ungaretti, tornato dal fronte di Bligny con unascatola di toscani in regalo. In testa al corteo funebre, la madre«grinzosa, truccata, impennacchiata», ostinata a negare il geniopoetico del figlio («Rostand, voilà un poète!»), il «mal-aimé», il«bighellone delle due rive», il «poeta assassinato» (GuglielmoApollinaire, 11 novembre 1923). In aprile e maggio escono altridue racconti: Alla città della mia infanzia, dico (9 aprile 1924), incui Savinio recupera un brano di Sul dorso del Centauro (La tor-re distrutta), poi ripubblicato in Casa “la Vita” e Icaro (10 mag-gio 1924), un racconto di guerra che entrerà nella prima parte diAchille innamorato99.Un secondo gruppo di articoli è dedicato alla critica lettera-
ria, a partire da due libri diversissimi fra loro e diversamente va-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 423
100. Si vedano le ingenerose parole di Bacchelli a Maurizio Korah del 28 novembre1921 «non dar troppa importanza a Savinio, il quale con tutte le buone qualità che tued io gli riconosciamo, in fondo è un mediocre e un coglione» (R. BACCHELLI-V. CAR-DARELLI-M. KORAH, Lettere inedite (1919-1975), a c. di C. DI BIASE, Salerno, Edisud1990, p. 88).
lutati: Moscardino di Pea e Lo sa il tonno di Bacchelli (16 agosto1923). Per il primo il recensore non nasconde una vera e propriapredilezione: «Enrico Pea si classifica fra i puro sangue. Scritto-re toscano, nel significato preciso della parola. Ma per toscanonon si intenda fiorito, gentile, idillico. Altro che margheritine eviole del pensiero! Si dice toscano per dire etrusco. […] Un au-tore di razza, tra le cui mani la materia prende un aspetto di mi-to e si acquista così i diritti all’eternità». Per Bacchelli, invece,Savinio fa i nomi di Luciano, Collodi e Voltaire, tre autori delsuo parnaso ideale che ritorneranno più volte nella sua produ-zione. Come i romanzi di Voltaire, infatti, Lo sa il tonno possie-de un fine apertamente morale e una «uguale compiutezza di sti-le, una uguale ricerca dell’espressione chiara, una misura egualenella composizione». Ma la battuta finale, dopo tante lodi, che ilrecensore teme possano guastare al lettore il piacere di leggere iltesto («Affrettatevi dunque, o lettori, a leggere “Lo sa il tonno”,ma ricordatevi di queste mie parole: “È il libro più brutto enoioso che mi sia mai capitato tra le mani!»), lasciano l’impres-sione di un’ambiguità che non dovette piacere all’autore100. Unapesante stroncatura è invece riservata a Le terrain bouchaballe diMax Jacob – apprezzato negli articoli sulla «Ronda» – che «do-po aver lungamente ballato sulla corda della scemenza lirica[…] è sceso su quello più sodo della scemità verista» e ha offer-to uno spaccato di costumi provinciali che vorrebbe essere unacontinuazione di Madame Bovary, ma riesce solo a rappresenta-re «il Codice, la Magna Charta del luogo comune, del buon sen-so spicciolo, soprattutto della bestialità» (11 settembre 1923).Altre schede sono meramente informative e a volte non esenti
dal sospetto di una promozione editoriale, come quelle del 3 no-vembre, molto lontane dagli interessi saviniani, che hanno in co-mune però lo stesso editore, quel Carabba di Lanciano che do-po un paio di anni avrebbe pubblicato la Casa ispirata: «Qui danoi c’è chi continuamente si lamenta sulle miserrime sorti della
424 PAOLA ITALIA
101. Il 30 novembre 1923 il «Corriere Italiano» pubblica una lettera in cui Barilli rin-grazia Savinio dell’articolo che ha scritto su di lui, ma precisa di non essere d’accordonel giudicare Mascagni una «testa di legno».102. L’originale è conservato nel Fondo Savinio (Sc. 44 - Riviste I); viene ristampatosulla «Fiera Letteraria» il 20 novembre 1932.
coltura italiana, e altri che con ciglio asciutto lavora a migliorar-le. L’editore Carabba è di questi: se tutti facessero il proprio do-vere come fa lui, la nostra cultura rifiorirebbe in un fiat, tale unmandorlo tra un giorno e l’altro di primavera» (Libreria. «Auto-biografia» di Tagore, Il mondo che va di Costanzo Mignone, «De-litto e castigo» di Dostoiewski, «Nazionalismo» di Tagore, «»Ciòche si può capire della teoria della relatività senza la matematica»di Paolo Kirchberger, 3 novembre 1923). Sporadiche, infine, lerecensioni musicali («Emiral» del maestro Bruno Barilli vince ilConcorso nazionale della Musica. Bruno Barilli, 29 novembre1923)101, teatrali (Introduzione quasi critica ai «Sette contro Te-be» e all’«Antigone», 30 aprile 1924) e di balletti (Balletti russidi Sergio Diaghilew, 4 giugno 1924).Nella rubrica «Giostra» vengono riuniti articoli di varietà e di
costume, a volte di tono minore, a volte impegnati, come saran-no i suoi contributi dei decenni successivi: un intervento sul co-comero (Il cocomero, 28 agosto 1923)102, una condanna dellascelta del comandante la flotta greca di rifugiarsi a Salamina, iro-nizzata come velleitario tentativo di «ripristinare i fasti degli an-tichi tempi», dopo che «codesti fasti il nostro pubblico non liconosce più se non attraverso le visioni offenbachiane» e, infine,un ammonimento a coloro che sfoggiano «chiome alte, vibranti,esplodenti, monumentali e pur tremule e lievi» poco incliniall’«educazione» e al «bel portamento» del popolo italiano (Sim-boli, Sermone ai ben chiomati, Intesa intellettuale, Raffinati, 7settembre 1923); un divertito allarme contro il terror mamilla-rum: «l’ossessionante persecuzione di codesto organo tra i piùstupidi e repulsivi, pervicacemente esibito per le strade di Ro-ma» (Occhio alla mammella, 15 settembre 1923). L’intervento suI Greci d’oggi (13 settembre 1923), invece, è un imbarazzantetributo alla politica estera del governo. Dopo i fatti di Corfù (la«lezione» che Mussolini ha impartito alla Grecia) Savinio mostral’inferiorità della Grecia moderna – gretta e votata al masochi-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 425
103. Già pubblicato nel «Convegno», I, 5 (giugno 1920), pp. 45-6.
smo e al sarcasmo, figlia degenere di quell’ironia di cui i greciantichi erano stati gli inventori – rispetto all’Italia, allo scopo disollecitare quel timore e quel rispetto che «sono il fondamentomigliore nelle relazioni tra una nazione piccola e una grande».Nella sezione Commenti, invece, il 30 settembre 1923 trovanoposto un altro brano della Casa ispirata poi caduto dalla redazio-ne in volume (La nutrizione)103, un aneddoto su Croce (Il poveroSacerdote) e uno su Carrà (Interpretazioni).Con tre ritratti storici si inaugura il genere delle biografie che
porterà, come si è detto, a Narrate uomini la vostra storia. Il pri-mo medaglione – dove invano si cercherebbero i toni ironici deipiù indovinati ritratti saviniani e riaffiora invece il grossolanosciovinismo degli articoli sulla «Vraie Italie» – è dedicato a Cri-spi (Ritratto dell’uomo Crispi, 5 ottobre 1923), insigne figura di«uomo geniale e artista», che viene celebrato con toni enfatici etribunizi con il dichiarato scopo di glorificare i tempi presenti,risorti, dopo la depressione giolittiana, agli antichi splendori(«Oggi, infatti, grazie a uno di quegli uomini che la terra nostrafa nascere ogni tanto per la sua maggior gloria e per la sua mag-gior fortuna, l’Italia sognata da Francesco Crispi, è. E in questaItalia d’oggi, i mani del suo profeta – di Francesco Crispi – si ri-consolano»). Le tre puntate dedicate a Luigi, Principe di Borbo-ne, pronipote del Re Sole (12, 13 16 dicembre 1923) sonoconformi alla linea monarchica del giornale, ma l’intervista alpresunto successore di Luigi XVI, venuto in Italia per ricevere ilbeneplacito papale con cui aspirare legittimamente al trono diFrancia, tiene più del grottesco che dell’encomiastico. Il Re e lafiglia Maddalena, novella Cordelia di un Re Lear cieco, paionoimmersi «in un torpore di pesci a riposo sulla sabbia», elementifossili di un passato che può essere rievocato solo sotto lo scher-mo fantastico delle vicende rocambolesche del piccolo Delfino,cui era stato assegnato fittiziamente il cognome di Naundorff, edella realtà triste e patetica di questo «giglio di Francia nell’ac-quario». Sebbene ascrivibile al genere ‘encomiastico’, nel «Sal-mo» di Don Lorenzo Perosi (9 ottobre 1923) ritroviamo lo stiledel miglior Savinio, ironico e irriverente cronista della rentrée di
426 PAOLA ITALIA
104. Il religioso Lorenzo Perosi (1872-1956), compositore di oratori di stile wagneria-no e organista, divenuto nel 1898 maestro della Cappella Sistina.
Don Lorenzo Perosi104 a Fabriano di fronte al vescovo e allastampa tutta per l’esecuzione del Salmo secondo di Davide. Tan-to esilaranti le critiche, quanto convenzionali le lodi, anche se avolte, con un’enfasi involontariamente ironica («Alla signoraAdalgisa Minotti va tributata un’incondizionata lode. Ella so-stenne la sua lunga e faticosa parte con uno slancio, un calore euna maestria tali, che ci ricordano le atletiche gesta di Felia Lit-vine, cui la Minotti si avvicina anche per la corporatura. Essa èuna cantatrice generosa che non guarda a spese, ma si slancianella musica nonché con la voce, con le braccia e col petto, co-me un campione di tuffo nel mare» e ancora «Nel volto di donPerosi è la stessa espressione del bambino che, cessato di pian-gere, fissa l’oggetto che gli suscita una improvvisa gioia con gliocchi ancora bagnati di lucciconi!»). In occasione del duecente-simo della nascita di Kant, invece, il 3 maggio 1924 un trafilettopropone un Omaggio breve a Emanuele Kant, accompagnato dadue quartine di Schopenhauer. E di argomento kantiano è ancheil penultimo articolo pubblicato sul «Corriere», Filosofi in erba,tiepida recensione di uno studio di Passerin d’Entréves su Il fon-damento della Filosofia giuridica di Hegel appena uscito per leedizioni Gobetti.
Dal 16 al 19 ottobre invece, inviato speciale all’inaugurazionedel monumento ai caduti nel Casentino e alla visita del ministroGiuriati al monastero di Camaldoli e alla Verna, Savinio docu-menta gli eventi con tre articoli celebrativi, commissionati dalgiornale nel quadro del graduale processo di avvicinamento allaChiesa (L’inaugurazione del monumento ai caduti, 16 ottobre[non firmato]; Dai campi di Cerere. Giornata seconda del Casen-tino, 18 ottobre; Dai campi di Cerere. Terza e ultima giornata, 19ottobre 1923). È un Savinio piuttosto monotono, privo della suavena ironica e incline all’iperbole («Gentilissima e tenerissima lavisita all’Asilo infantile», «bellissimo lanificio locale», «bellissimidiscorsi di S.E. Giuriati», «sontuosissimo banchetto offertosi daquesto municipio e dalla locale sezione del fascio», «amore che
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 427
le popolazioni rurali nutrono all’on. Mussolini […] idolo sicuro,garantito, in cui si può avere fiducia piena», «indescrivibile en-tusiasmo delle popolazioni»), e solo nelle considerazioni paesag-gistico-mitologiche ritroviamo la penna dell’autore («Passandosotto Orvieto […] intravvedemmo un centauro che, rapita unadonna làpite, la portava al galoppo su per la rupe»). I toni nonsono molto diversi nell’articolo dedicato all’inaugurazione delrestaurato Palazzo Venezia (Palazzo Venezia nel rinnovato splen-dore, 31 ottobre 1923 e Il solenne ricevimento di ieri sera a Palaz-zo Venezia, 1 novembre 1923), eletto, per decisione di Mussoli-ni, a sede del Gran Consiglio Fascista e ritornato agli «antichifasti» («Ferveva dappertutto il lavoro dei legnaiuoli, tappezzieri,elettricisti: ma sotto la luce stesa dei lampadari ricchissimi, deilustri scintillanti di cristallerie, la trasformazione delle sale eragià manifesta nel suo insieme. Si può dire che non un millimetroquadrato dei soffitti, delle pareti e dei pavimenti deturpatiahimé! è rimasto scoperto: stoffe, velluti, tappeti, boschetti inte-ri di piante in ogni dove»).Di carattere diaristico e già indirizzati verso i futuri
reportages, sono invece articoli più svagati come il Viaggio forzo-so da Via Poli a Monte Cimino (3 febbraio 1924), dove si narradi una gita notturna al Monte Cimino compiuta in compagnia diun collega del giornale. Il viaggio successivo è invece verso Ge-nova (Dal paese di Mignon: I fiori della Riviera, 28 febbraio 1924e Diario del litoral fiorito, 11 marzo 1924) e una penna ironica evivace descrive l’orda di turisti tedeschi diretti verso la Rivieraoccidentale, sotto una pioggia scrosciante. Ma il viaggio cela,nemmeno troppo abilmente, uno scopo promozionale: il litoralefiorito viene tradotto in cifre con una denuncia della crisi dellafloricultura e un invito al governo perché intervenga a «restitui-re a questa importantissima industria nazionale la sua primitivaprosperità», con misure protezionistiche per difendere il merca-to dalla vicina Francia, che contrasta «con la tenacia che la di-stingue, questo specialissimo commercio litoraneo, per favorireil proprio».
Il contributo più importante di Savinio sul «Corriere Italia-no» è però costituito dagli articoli pubblicati nella prima rubrica
428 PAOLA ITALIA
105. Per i primi passi della critica cinematografica italiana, cfr. in particolare M. VER-DONE, Riflessioni di Papini sul cinematografo, in Giovanni Papini. L’uomo impossibile,Fondazione Primo Conti di Fiesole, Firenze, Sansoni 1982, pp. 218-9; G.P.BRUNETTA, Storia del cinema italiano. Il cinema muto 1895-1929, volume I, Roma, Edi-tori Riuniti 1993, pp. 107-29 (Le origini della critica), 269-94 (La fascistizzazione del ci-nema negli anni venti) e 303-12 (Nascita della critica) ed E. MONDELLO, Roma futuri-sta. I periodici e i luoghi dell’avanguardia nella Roma degli anni Venti, Milano, FrancoAngeli 1990, p. 45 e pp. 132-40. Se è «La Gazzetta del Popolo» ad avere inauguratonel 1908 la prima rubrica cinematografica fissa, affidata a Mario Dell’Olio (BRUNETTA,Storia del cinema..., pp. 119-20 e M.A. PROLO, Storia del cinema muto italiano, Mila-no, Il Poligono 1951, p. 32) e dal 1912 una pagina «interamente dedicata al cinemacon articoli e pubblicità», e altri quotidiani come «Il Giorno» di Napoli ne seguonol’esempio (con interventi di Matilde Serao), è altrettanto vero che queste recensionialtro non sono che pubblicità mascherate e «gli interessi produttivi fanno sì che l’esal-tazione e la stroncatura dipendano più dalla logica di scuderia della rivista che dall’in-teresse effettivo per la qualità del film» (BRUNETTA, Storia del cinema..., p. 124). E sedal 1926 si inaugura sul «Tevere» di Telesio Interlandi uno «spazio stabile piuttostoampio» con un articolo di Bontempelli e al cinema viene dedicata «per qualche mese,una pagina settimanale» (BRUNETTA, Storia del cinema..., p. 305) – ma si vedano le re-censioni sull’«Ambrosiano» di Edgardo Rebizzi riportate da V. MARTINELLI, Il cinemamuto italiano. I film degli anni venti 1923-1931, «Bianco e nero», XLII, 4/6 (luglio-di-cembre 1981) 4 voll., Edizioni di Bianco e Nero, 1980-1, p. 11, sin dal 1922 (ma perfilm girati nel 1923) – «è solo dal 1930 che si comincia a concedere spazio al cinemasui quotidiani e si crea istituzionalmente la figura professionale del critico cinemato-grafico» (G.P. BRUNETTA, Cinema italiano fra le due guerre. Fascismo e politica cinema-tografica, Milano, Mursia 1975, p. 84). MONDELLO, Roma futurista, p. 77, tuttavia so-stiene che la prima rubrica cinematografica su un quotidiano, «Lo schermo», sia statacreata da Bragaglia sull’«Impero» nel 1924, affermazione che va rivista alla luce delcontributo saviniano e delle affermazioni presenti nell’articolo di Savinio del 31 otto-bre 1923 qui riportate, punto di partenza di futuri approfondimenti non possibili inquesta sede.106. Questo primo approccio al cinema segna l’inizio di una passione che sarà duratu-ra: nel 1926, sul «Popolo di Roma», Savinio pubblica un intenso Omaggio al cinema-tografo, mentre dal 1936 al 1938 tiene la rubrica «La prime cinematografiche» sul«Lavoro fascista». Numerosi anche i suoi contributi al cinema come autore, raccolti,con qualche esclusione testimoniata nel Fondo Savinio, nel Sogno meccanico.
cinematografica apparsa su un quotidiano affidata a un letterato,un fatto importante, finora trascurato dalla critica saviniana e daquella cinematografica in generale105. La decisione di dedicare alcinema uno spazio fisso in forma di vere e proprie recensioni,viene presa dalla redazione culturale del Corriere» alla sua fon-dazione, come racconta lo stesso Savinio il 25 ottobre 1923 dan-doci una prova diretta della priorità dei suoi contributi106:
Contrariamente agli usi di tutti gli altri giornali italiani che non parlano dicinematografo se non nella precisa forma della pubblicità pagata, il «Cor-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 429
riere Italiano» è venuto nella determinazione d’iniziare una critica del ci-nematografo, eguale per importanza e serietà a quanto si va facendo daanni e secoli per teatri di musica e per quelli di prosa.
Alla richiesta del recensore di una tessera «di servizio» per pote-re accedere incondizionatamente alle sale cinematografiche,però, la maggior parte degli esercenti non risponde, suscitandola sua vivace reazione e la promessa di affilare le armi con una«critica giusta ma spietata». L’articolo sollecita un dibattito con ilettori che ci pare interessante riportare perché offre uno spac-cato dello stato della critica cinematografica del tempo. Il 31 ot-tobre, infatti, in Prime fucilate, Savinio riporta una lettera diprotesta di «assidui lettori» che sollevano dubbi sulla sua pre-sunta imparzialità e dichiarano che tutti gli esperimenti tentatisu altri giornali «dall’Epoca e dal Messaggero […] sono inglo-riosamente falliti, essendo le critiche non altro che articoli a pa-gamento, e frutto di vendette personali». L’unico tentativo riu-scito viene attribuito al «Messaggero meridiano», che aveva as-segnato la critica direttamente al pubblico. Savinio risponde ma-lignamente di non credere all’imparzialità e alla buona fede de-gli «assidui lettori» e si produce in una dichiarazione di intenti,che è anche un’appassionata difesa della libertà e della indipen-denza del critico:
La persona preposta alla critica cinematografica non è né un «direttore ar-tistico» né un «vecchio attore cinematografico». È un uomo che il cinema-tografo conosce intus et in cute, pur non avendo mai appartenuto al corpusmilitante e operante di codesta industria. La sua competenza, però, comela sua imparzialità, la sua spregiudicatezza e la libertà sua di giudizio, sonoassolutamente garantiti. Egli, non gravato da nessuna «macchia cinemato-grafica», non ostacolato da nessuna cointeressenza nei meccanismi finan-ziari che muovono questi ludi pubblici, potrà, come ha promesso, criticarespassionatamente e severamente il cinematografo, col doppio fine di con-tribuire al suo dirozzamento (se gli riescirà possibile) e d’illuminare il pub-blico. Egli giudicherà il cinematografo non dal solo lato artistico, ma daquello pure di «specchio dei costumi». Stima infatti, questo mostruoso uo-mo, che il cinematografo è lo specchio più fedele dei costumi attuali, e pereffetto di questa considerazione combatterà con tutte le sue forze a che lacinematografia italiana si rialzi dall’attuale suo stato di miseria, di volga-rità, di bruttezza e d’idiozia, affinché la gente di fuori non abbia a giudica-re l’Italia presente sull’esempio dei suoi film d’esportazione.
430 PAOLA ITALIA
107. Dei tre articoli usciti su «Galleria» solo uno è nuovo, mentre gli altri due sonogià parzialmente pubblicati sul «Corriere Italiano».
108. Così Savinio ricorda quell’anno di intense visioni cinematografiche: «Era il 1924.Abitavo a Roma e frequentavo assiduamente il cinematografo. Ventiquattro anni sonopassati, e ora al cinematografo non ci metto piede. È progresso o regresso? (La lucertola,«Corriere d’Informazione», 7-8 giugno 1948; SAVINIO,Opere. Scritti dispersi..., p. 714).
109. G.P. BRUNETTA, Spari nel buio. La letteratura contro il cinema italiano: settant’annidi stroncature memorabili, Venezia, Marsilio 1994, ad esempio, antologizza il terzo arti-colo di Savinio su «Galleria» a testimonianza di quegli intellettuali che «cedono alla fa-scinazione, si fanno toccare dalla luce pentecostale del cinema, tradiscono una qualcheconversione in atto», ma non riporta le recensioni sul «Corriere Italiano».
Egli dichiara inoltre che non avendo nulla da spartire con direttori, attorio dive, s’infischia di ognuna di queste persona singolarmente prese: lo-derà i buoni, i tristi acerbamente castigherà.
Le sue affermazioni, come vedremo, non verranno smentite, conuna sola eccezione. Le recensioni cinematografiche (29 in tut-to)107 sono tenute con regolarità dal 1 settembre 1923 al 4 giu-gno 1924, nelle rubriche «Cinematografo» e «Cinematografi» (o«Corriere cinematografico»), poi regolarmente nella rubrica fis-sa «Corriere del Cinematografo»108. Esse costituiscono il primoesempio di un interesse organico e non episodico per il cinemada parte di un quotidiano ed è oltremodo significativo che ciòsia avvenuto sulla pagina culturale di un giornale cui era statoassegnato un ruolo strategico nel riconoscimento del ruolo cul-turale del fascismo, e che sia stato scelto un intellettuale ecletti-co come Savinio in grado di muoversi con disinvoltura tra l’a-vanguardia e la restaurazione.Il fatto è rilevante non solo per la storia del cinema in Italia,
ma anche per l’evoluzione di Savinio stesso. La nuova forma ar-tistica, infatti, gli è particolarmente congeniale in quanto rappre-senta un’applicazione concreta della sua teoria sull’arte: antina-turalistica e antiveristica, e della «poetica della memoria» recen-temente messa in atto con Tragedia dell’infanzia. Ma ascoltiamodirettamente Savinio nei tre articoli usciti su «Galleria» dal gen-naio 1924, più impegnati e significativi delle recensioni sul quo-tidiano109. Nel primo, infatti (forte di poco meno di una ventinadi recensioni già uscite sul «Corriere Italiano»), egli abbozza unconsuntivo della sua teoria cinematografica:
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 431
110. Rivista del cinematografo, «Galleria», I, 1 (gennaio 1924), p. 55.111. La posizione di Savinio è in opposizione con quanto espresso da Bragaglia nel1911 sul cinema come «precisa meccanica, glaciale riproduzione della realtà» (A.G.BRAGAGLIA, Fotodinamismo futurista, Torino, Einaudi 1970, p. 27, citato da BRUNET-TA, Storia del cinema..., p. 104).112. Un accenno a Monaldi in BRUNETTA, Storia del cinema..., p. 209; il film, tuttavia,non è registrato tra quelli di Monaldi.
il cinematografo anzitutto costituisce una giustificazione per quanto inno-cente e grossolana, dell’arte quale noi l’abbiamo sempre intesa e propu-gnata: l’arte non come specchio diretto della realtà, ma come riflesso lon-tano e mnemonico di quella. Il cinematografo in questo si avvicina nonpoco agli spettacoli che vediamo nel sogno: azioni che si svolgono indi-pendentemente dalla nostra volontà e dal nostro desiderio, avvolte nellostesso silenzio, bagnate di una luce altrettanto sottile che penetra uominie cose fino a renderli trasparenti, denuda a tal segno la realtà da farla ap-parire inverosimile.[...]Il torto più grave che si possa fare al cinematografo, è nel considerar-
lo, come generalmente si fa, quale una riproduzione esatta della realtà, oper meglio dire di quella realtà superficiale e cutanea che ognuno avverte,e dietro la quale si crede non esservi se non il buio e il vuoto110.
La realtà si svela al cinematografo così come «effettivamente è ecome l’uomo, così la terra, il mare, il cielo, tutta la natura velataaltrimenti e impenetrabile, fuori che per i poeti e comunque perquelle creature privilegiate e rarissime che hanno sguardo lungoe fiuto sottile». Il cinematografo appare così lo strumento piùadatto per compiere quell’operazione artistica che Savinio haipotizzato negli articoli su «Valori plastici»: non riprodurre og-gettivamente la realtà, ma scoprirne il mistero e tradurlo in for-me fisse e durature: «Il cinematografo è una mitologia in atto:tanto più accettabile in quanto non è confinata necessariamentein un tempo mitologico»111. Savinio passa poi a parlare del filmpiù «importante e meritevole» apparso sugli schermi nel dicem-bre 1923: L’Otello di Gastone Monaldi112, anche se la recensio-ne è un’occasione per parlare più che del film, della figura diOtello nella storia letteraria e condannare L’Otello di Verdi-Boi-to, «nulla di meno Shakespeariano infatti, di più falso, conven-zionale, pompier». Ottima invece l’interpretazione del castdell’Otello tedesco (Jannings nei panni di Otello e Krauss in
432 PAOLA ITALIA
113. Si tratta dell’Othello tedesco, girato da Buchowetzki nel 1922 con Emil Jannings eWerner Krauss (G. SADOUL, Storia generale del cinema. L’arte muta (1919-1929), Tori-no, Einaudi 1978, p. 325). Emil Jannings, nato a Brooklin da genitori tedeschi, avevaesordito nel 1915 in un film di Lubitsch e sarebbe stato il protagonista assoluto dellacinematografia tedesca del primo dopoguerra. Del 1920 è Anna Bolena, poi ricordato.Werner Krauss, nato nel 1884 in Germania, esordisce in Caligari nel 1920 e affiancaJannings in alcune pellicole come Danton e i Fratelli Karamazoff del 1921.114. Sul secondo numero della rivista, tra l’altro, Vincenzo Tieri presenta la redazionedel «Corriere Italiano» corredata da una schiera di caricature, dove Savinio si meritaun breve profilo tra il misantropo e il blasfemo: «Poco dissimile, in questo [dire «pa-ne al pane e vino al vino» come Soffici], dal cinereo Savinio, penna forbita e lingua sa-crilega, che tanto odia il mondo quanto ama l’arte e la letteratura» (Il «Corriere Italia-no», «Galleria», I, 2 (febbraio 1924), pp. 23-32; la citazione a p. 26).115. Titolo italiano di Der Stier von Olivera, diretto da E. Schönfelder nel 1921.116. Mary Pickford (1893-1979) attrice e poi produttrice canadese, nel 1919 fondacon Griffith, Chaplin e Douglas Fairbanks la «United Artists». Pollyanna, recensitonel 1923, è girato nel 1919.117. Priscilla Dean (1896-1988), attrice americana celebre per le sue interpretazioniavventurose.
quelli di Jago)113, attori imparagonabili a quelli italiani e ameri-cani. In febbraio, nel secondo articolo uscito su «Galleria»114,Savinio mette in guardia da una facile esaltazione del cinemato-grafo contro il rischio estetizzante che minaccia l’intera arte del’900 (in cui sentiamo gli echi della sua personale polemica anti-dannunziana):
Il cinematografo è un mezzo di espressione come un altro [...] A determi-nare le qualità cinematografiche del cinematografo, esaltandole a tal se-gno da impiantare la teoria di uno stile cinematografico, si rischia di preci-pitare questa arte neonata nell’estetismo, pericolo stringente per il cine-matografo. [...] Insisto particolarmente su questo punto perché l’esteti-smo non è un vizio che minaccia il solo cinematografo, ma una tabe chedeturpa e corrode quasi tutta l’attività artistica del nostro tempo, dallapoesia come sapore di parole, alla pittura intesa come sapore di colori.
Lo spettacolo del mese che merita di essere ricordato è AnnaBolena, un’altra ricostruzione storica e un’altra interpretazionetedesca (di nuovo Jannings nella parte di Enrico VIII, un «atto-re magnifico» e un «artista di razza», apprezzato anche come ge-nerale Guillaume nel Toro di Oliveira il 10 maggio 1924)115;mentre viene stroncato Segnali d’amore con Mary Pickford, al-trove irrisa come «falsa minorenne»116, cui Savinio preferiscePriscilla Dean117, «l’esemplare più tipico dell’americana del
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 433
118. Anche se Savinio si affretta a precisare: «Non si vogliono con questo esaltare i be-nefici di un’arte collettiva, e anzi per parte mia ripugno come dalla peste da qualunquecollettivismo in arte», Rivista del cinematografo, «Galleria», I, 3 (marzo 1924), p. 43.
nord: un misto […] di carogneria e di dolcezza» («La perduta diShangai» al Capranica, 4 aprile 1924). Nel suo terzo e ultimo in-tervento su «Galleria», Savinio affronta i problemi della cinema-tografia italiana. Dopo la gravissima crisi del dopoguerra che havisto nel biennio 1922-3 il crollo dell’Industria cinematograficaitaliana e il fallimento dell’Unione Cinematografica Italiana, unsegno di ripresa è costituito nel 1924 dalla fondazione, per ini-ziativa del governo, dell’Unione Cinematografica Educativa (l’i-stituto LUCE). Obiettivo del governo è sostenere la rinascitacon una programmatica campagna di stampa, cui il «Corriere»(e con lui il recensore) si presta efficacemente. Ma nonostante la«carità di patria» dell’autore, realismo e buon senso offronospesso un quadro più disincantato che esaltato e una diagnosiscoraggiata che diventa un più generale giudizio sulla culturaitaliana:
Da qualche mese a questa parte assistiamo a sforzi poderosissimi dellenostre case cinematografiche, per ridar vita e decoro al film nazionale.Patetico e nobile sforzo cui noi per i primi saremmo desiderosi di dareuna mano, ove non ce lo sconsigliassero e i risultati pietosissimi che que-sto primo sforzo ha già dato, e soprattutto la nostra intima e irrimutabilepersuasione che per la cinematografia italiana non è speranza di salvezza.
In Italia – continua Savinio – «possono sorgere […] e affermarsitaluni artisti talentuosi e alle volte anche geniali, ma un’arte col-lettiva, vasta, nazionale, non sorge né può sorgere, perché lamaggior parte degli italiani sono non solamente inadatti e pigrialle arti belle, ma viziati ancora da una falsa coltura, da gusticorrottissimi, soprattutto da quell’estetismo balordo e bestialeche vediamo spargersi dappertutto e guastare ogni cosa, dal mo-numento al libro, dal teatro al cinematografo»118. Vedremo trapoco – affrontando direttamente la produzione italiana – come,nonostante le dichiarazioni iniziali, Savinio si trovi stretto trauna doverosa approvazione della politica cinematografica delgoverno e la personale valutazione dei film che si trova a dovergiudicare.
434 PAOLA ITALIA
119. Das Kabinet des Dr. Caligari, Germania 1920, diretto da Robert Wiene con Wer-ner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover, Friedrich Feher; il titolo erroneo [Galligaris]è del testo.
Le numerose recensioni del «Corriere» applicano più o menorigorosamente la riflessione teorico-critica espressa negli articolisu «Galleria». Nel primo contributo Savinio si pronuncia a favo-re di una contenutezza e sobrietà della recitazione, distinguendocon chiarezza tra cinema e teatro: «È il teatro che esige se maiquesti modi esagerati. Sullo schermo i sentimenti più profondi eintensi si traducono come nella vita in movimenti quasi imper-cettibili, i quali sono messi in luce dal cinematografo, che isolan-do l’elemento visivo della parola, fa convergere sul volto umanotutta l’attenzione dello spettatore. Il viso dell’attore è dunque ilmezzo di espressione della nuova arte nella stessa misura che lavoce è quello della musica» («Cinematografo», 1 settembre1923). In generale, i film visti per il «Corriere Italiano» non su-scitano grandi entusiasmi nel recensore. Se lo scopo è quello dirisollevare le sorti del cinema – in crisi in tutta Europa, e parti-colarmente in Italia, per la concorrenza americana –, la soluzio-ne può venire solo da un rinnovamento radicale delle tematichetrattate e da un aggiornamento delle teorie artistiche: «Parrebbeche il cinema per la sua natura dovesse favorire i tentativi piùaudaci; esso invece è di venti anni in ritardo sul movimento let-terario. Per intenderci è ancora ai romanzi di D’Annunzio e aidrammi di Bataille». Una scelta di campo ben precisa, quindi,per un cinema di ricerca e sperimentazione, in sinergia con i mo-vimenti artistici correnti.L’atteggiamento, tuttavia, è realisticamente in linea con le
aspettative del pubblico di un grande quotidiano e invano si cer-cherebbe in questi pezzi un giudizio sulle punte più audaci del-l’espressionismo avanguardistico tedesco o sulle prime provepresurrealiste, di cui Savinio poteva avere notizia dalle rivistestraniere, ma che in Italia non venivano distribuiti.È comunque la scuola tedesca a riscuotere i maggiori consen-
si: «Coi film tedeschi si è sempre a posto. I peggiori film tede-schi hanno pur sempre qualcosa che li salva dalla piena bana-lità», come mostra Il gabinetto del dottor Galligaris119, «primo
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 435
120. Cfr. SADOUL, Storia generale..., pp. 361-62.121. Titolo italiano di Merry-go-round, diretto e interpretato da Eric von Stroheim nel1923 (nel testo saviniano: «Giorgio Stroheim»).122. Titolo italiano di So sind die Männer, diretto da Georg Jacoby nel 1922.
film “espressionista” o semplicemente di avanguardia apparso inEuropa». Suscita elogi anche Der Golem di Paul Wegener (Wieer in die Welt kam: Come venne al mondo l’uomo d’argilla)120,del 1921, recensito il 30 marzo 1924, anche se la narrazione del-le disavventure provocate dal «golem», il magico automa d’argil-la della tradizione ebraica, ha richiesto l’uso di mostri, stregoni emagie lontani dal gusto «classico» più volte invocato come rap-presentante dei tempi nuovi. Positiva anche la valutazione del«cinismo simpaticissimo» di Stroheim («Donne viennesi» al Ca-pranica, 4 marzo 1924)121, uno dei «prodotti più torvi del ro-manticismo» in cui Savinio rileva uno «sforzo patetico, il caldodelle passioni e la tormentosa nostalgia di un mondo migliore»,mentre è tiepido (8 dicembre 1923) con uno dei prodotti da«minuetto» della scuola tedesca: Nell’anticamera del matri-monio122, un film «incipriato» che riscuote un gran successo daparte di tutti coloro che «sono forniti della speciale psiche delvoyeur».Su un’analoga contrapposizione tra una «pretesa rinascita
della classicità italiana» e «la spontanea rinascita, nonché in Ita-lia, nell’intero mondo, del romanticismo […] questa facoltà del-la speranza poetica, di questa figlia prediletta della fantasia, diquesta ispiratrice per eccellenza delle arti», si fonda anche l’ap-prezzamento – rara avis, trattandosi di un film francese – di Vio-lette imperiali (22 maggio 1924). Alla cinematografia francese –«summum della sciatteria» – non vengono infatti risparmiate lepiù pesanti critiche: trionfo di «pompierismo» e «scemissimopasticcio» («Il sangue di Allah» al Capranica, 9 novembre); una«delle solite arsenlupinerie, delle solite ruletabillerie di cui persi-no i nostri garzoni salumai hanno piene le tasche» («Il misterodella camera gialla» al Volturno, 10 novembre 1923), «paralitica,piatta, insipida, seccante, falsa» («La Battaglia» al Cinema Corso,18 maggio 1924). Un’eccezione è rappresentata invece da Crain-quebille (girato nel 1922 da Jacques Feyder e interpretato da
436 PAOLA ITALIA
123. Pollyanna, diretto da Paul Powell, USA 1920.124. Robin Hood, diretto da Allan Dwan nel 1922, con Douglas Fairbanks (1883-1939), attore americano noto soprattutto per aver ricoperto ruoli avventurosi, come inThe lamb (1914), His majesty the King (1920) e The mark of Zorro (1920).
Maurice de Féraudy), tratto dall’omonima novella di AnatoleFrance in cui un venditore di ortaggi parigino, ingiustamente ac-cusato di oltraggio alla polizia, finisce per dedicarsi al vagabon-daggio, dove l’ironia conquista «rilievo e plasticità» mediante untrattamento antirealistico e i personaggi non appaiono come «ri-sultano nella realtà, ma deformati e caricaturizzati quali appaio-no al giudizio dell’accusato» («Crainquebille» al Cinema Corso,22 novembre 1923). Ancora una volta per Savinio l’opera hasuccesso quando si allontana dai canoni del realismo.La produzione americana pecca invece di stupidità, mesco-
lando trame incredibili con suggestioni religiose («Vox feminae»al Volturno, 15 novembre 1923); proponendo campionesse dibuoni sentimenti come la «non meno clamorosa che minuscola»Mary Pickford in esempi di «deamicismo americanizzato»(«Polyanna» al Cinema Corso, 18 novembre 1923)123; film d’a-zione «lenti e melodrammatici» («Robin Hood» al Cinema Corso8 dicembre 1923)124; «ingenua perfezione tecnica» (S. M. Dou-glas al Cinema Corso, 9 novembre 1923), «americanate sciatte,balorde, stucchevoli» («Una settimana d’amore» al Cinema Cor-so, 4 marzo 1924), o ancora concentrati di luoghi comuni («Lafiamma del destino» al Cinema Corso, 4 marzo 1924), patetichedimostrazioni della mancanza di qualità ironiche nella donna(come Mrs. Mae Murray in «Jazzmania» al Cinema Imperiale, 15aprile 1924), ed esempi della «perfezione chirurgica, meccanica,glaciale sotto la quale il popolo americano nasconde il suo in-guaribile cannibalismo» («La città degli uomini silenziosi» al Ca-pranica, 1 maggio 1924).L’ultima recensione uscita sul «Corriere Italiano», il 4 giugno
1924 («La donna che vinse il destino» al Volturno), offre, conparticolare brio e sarcasmo, un concentrato dei difetti di questacinematografia:
un film americano scemo scemo, senza capo né coda, mediocrissimo tan-to per il soggetto quanto per l’esecuzione. Il manifesto promette «Nella
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 437
125. The Kid, diretto da C. Chaplin, First National, 1920 (Filmlexicon).126. Bavu, diretto nel 1923 da S. Paton.
lotta terribile contro il vizio atavico, trionfa il sublime amore di una don-na!» Hai detto un prospero! Alla sopradetta lotta contro il vizio atavico(leggi alcoolismo) vengono poi a mischiarsi altre lotte, di carattere banca-rio o borsistico. Assistiamo a gare di nuoto e ammiriamo il petto villosodel protagonista. Certe porte a ferro di cavallo ci empiono di stupore, co-struite evidentemente a quel modo per debellare gli iettatori. Ci rammari-chiamo che a un certo punto del dramma, metà dei personaggi siano az-zoppati. In ultimo due signori si uccidono coscienziosamente e con la me-desima rivoltella. Nell’apoteosi finale, due coppie si abbracciano con ar-dore, sotto la luna dell’amoroso maggio.Ciononostante, e nonostante i lunghi baci che i protagonisti si scam-
biano a ogni occasione, in mezzo a decorazioni agresti molto suggestive,noi dobbiamo confessare che miss Anna Nilson, bravissima a vincere ildestino dei giovani alcoolizzati, non fu altrettanto brava a vincere la no-stra noia.
Ma quando si avvicina al carattere europeo, il cinema americanodà i suoi prodotti migliori. È il caso di Charlot, che con Il mo-nello («Kid» al Cinema Imperiale, 2 dicembre 1923) sembra cen-trare in pieno le aspettative del recensore. Chaplin ha costruitoun personaggio «ideale» che ha la «la trasparenza dello spettro»,dove l’uomo sparisce. E sembra quanto di più vicino alla poeticaantirealistica saviniana e alla «poetica della memoria»:
È l’antiverista per eccellenza. Il «gioco» di Charlot si ravviva per un ele-mento indispensabile all’arte: l’artificio. Il travestimento è la qualità pri-ma ed essenziale di Charlot. La figura sua colpisce la nostra visibilità nondirettamente, ma traverso la memoria. Altri attori (Douglas p.e.) suscita-no in noi fantasie temporanee e senza conseguenze. Charlot si insedia nelnostro passato. Charlot è vero, come sono veri i miti. […]Una luce metafisica bagna questo dramma, come del resto tutte le ope-
re di poesia vera. Vi sono taluni particolari di una forza formidabile125.
Sarà difficile trovare ancora parole altrettanto entusiaste. Stron-cato infine il banale Don Giovanni Marana (4 marzo 1924), men-tre Bavù di Paton («Bavù» al Capranica, 11 aprile 1924)126 vieneavvicinato a un romanzo di Dostoevskij di cui possiede la stessa«illogicità drammatica, la stessa atmosfera di incubo».Per quanto riguarda la produzione nazionale, la principale
438 PAOLA ITALIA
127. In realtà «questo divertente mediometraggio di Toddi […] non ebbe problemidi censura. Solo il titolo lasciò perplessa la Commissione. Il presidente sottolineò:“Non è possibile lasciar circolare un film in cui si afferma che l’Italia è un paese dibriganti”. Toddi, che era presente alla proiezione in censura, si raddrizzò il monoco-lo e propose di aggiungere un punto interrogativo» (MARTINELLI, Il cinema muto...,pp. 59-60).128. Broken blossoms, diretto dal regista americano nel 1919.129. Unanime il giudizio della critica sulla coeva produzione italiana, cfr. ad esempioBRUNETTA, Storia del cinema..., p. 315: «le didascalie spezzano l’azione, la recitazionenon si distacca dall’enfasi dei codici dell’opera lirica, le scene di massa ripropongonoformule già collaudate».130. Attore e autore di svariati film anche negli anni Trenta e Quaranta, produce in
preoccupazione di Savinio è costituita dalla salvaguardia dell’im-magine dell’Italia all’estero («per sorprendere a nudo lo stato at-tuale della mente, della cultura, dei costumi italiani, ci basta an-dare a vedere un film italiano. Ma ecco che il cuore comincia apiangerci dirottamente»), tanto da plaudire la proposta del Pre-sidente del Consiglio, annunciata il 24 settembre 1923, di incre-mentare la censura cinematografica per dare fine alla pericolosacircolazione di film offensivi (cita il caso di un film sulla «manonera» italiana a New York, lasciato circolare nelle sale italianedopo un remake di doppiaggio, e viceversa quello di un film ita-liano vietato al pubblico per il titolo sconveniente, ma ironico,Terra di briganti)127. È scandalizzato, però, dalla censura che hacolpito il celebre film di Griffith Giglio infranto128, colpevolesolo di aver presentato «il caso di un padre alcoolizzato che mal-tratti la propria famiglia». L’immoralità, ingiustamente attribuitaal film, «sta spesso semplicemente nella falsità di una condizionepsicologica» (La decadenza del cinema; La censura; Notiziario, 10ottobre 1923). Raramente però i film italiani – pochissimi rispet-to a quelli francesi e americani – suscitano la sua approvazione,nonostante la rubrica sia stata istituita dal «Corriere» per mo-strare i segnali della rinascita del cinema nazionale e la sua supe-riorità sulla produzione straniera; un’impasse in cui possiamotoccare con mano la distanza di Savinio dal programma cultura-le del nuovo regime. Di fronte a una produzione di scarso valo-re, per qualità e quantità129, il recensore resta fedele all’impegnopreso inizialmente di fronte ai lettori. Con una sola eccezione: iPromessi Sposi di Mario Bonnard130.
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 439
questo biennio il celebre Trittico di Bonnard (MARTINELLI, Il cinema muto..., pp. 124-8),primo film italiano diviso a episodi: A morte, Signor ladro e Non è vero!; in quest’ultimotroviamo Jone Morino – sorella della futura moglie di Savinio: Maria Morino – nel ruo-lo dell’antagonista della prima attrice (la celebre Rina de Liguoro). Nel 1925 Bonnarddirige invece Il tacchino (ivi, pp. 22-43), tratto dalla commedia «Le Dindon» di Fey-deau (1896), un vaudeville penalizzato dall’«obbligato mutismo dei personaggi» (Re-bizzi sull’«Ambrosiano»); anche qui, nel cast, Jone Morino.131. Il film è assente dal citato repertorio di MARTINELLI, Il cinema muto...132. «I Promessi Sposi» al Cinema Corso, 28 dicembre 1923.
Il film viene proiettato al Cinema Corso di Roma il 28 dicem-bre 1923, dopo un gran battage pubblicitario che lo aveva pre-sentato come il «trionfo dell’arte cinematografica italiana»131.Nell’articolo, scritto a caldo, Savinio si mostra benevolo e acco-glie il film come «un grande sforzo della cinematografia italia-na», che spera possa «trarre la nostra arte cinematografica e l’in-dustria che a questa si connette, dallo stato infelicissimo in cuiambedue erano cadute»:
Nei Promessi Sposi abbiamo riconosciuto reali progressi ottenuti sui pre-cedenti film nazionali, e specie sugli ultimi. Progressi tecnici, anzitutto:nel taglio delle scene, nell’uso della luce, nel raggruppamento delle mas-se, nella ricerca e nel rilievo dei particolari. C’è ricchezza, ma accompa-gnata a sobrietà e buon gusto. Anche per quel che riguarda l’interpreta-zione del soggetto […] non abbiamo a dire se non del bene. Ottima ci èsembrata la signorina Emilia Vidali nella parte di Lucia, degno di ogni lo-de il signor Domenico Serra in quella di Renzo. Meno felice ci è parsoDon Abbondio, e lo stesso diremo per l’Innominato, Don Rodrigo, il car-dinal Borromeo, la Perpetua. Quanto all’attore che impersonava fra Cri-stoforo […], egli s’è comportato benissimo nella sua difficile parte, quan-tunque uno studio troppo fedele del russo Moiuskine potesse fare scam-biare ogni tanto Fra Cristoforo per Padre Sergio.Tutti gli episodi principali del grande romanzo sono stati resi con fe-
deltà e intelligenza. Spesso abbiamo sentito aliare in questo film lo spiritodi Manzoni.Avremmo desiderato tuttavia meno «visioni poetiche», meno chiari di
luna, meno dondolamenti di campagne: minore ricerca insomma del sug-gestivo.Dopo lo spettacolo di ieri, possiamo dire veramente che la cinemato-
grafia italiana è novamente in rifiorire. Rendiamo il dovuto merito a Ma-rio Bonnard, e consigliamo a tutti gli altri di seguire il suo esempio, stu-diando, perseverando e progredendo132.
440 PAOLA ITALIA
Un’approvazione contenuta, un pezzo diligente, una presenta-zione ‘in punta di forchetta’. Alquanto sospetta. Lo svela, infatti,tre mesi dopo, il terzo numero di «Galleria» (che, per essere unmensile letterario, poteva offrire libertà maggiore di quella con-cessa dal quotidiano) in cui Savinio recensisce nuovamente iPromessi Sposi, ma con altri toni:
Ora vediamo un po’ in che consistono questi tentativi di risollevare lesorti della languente cinematografia italiana. Se non andiamo errati, ilprimo di questi tentativi fu fatto con la ricostruzione cinematografica deiPromessi sposi […]. Ci facemmo un dovere (oneroso dovere!) di assiste-re alla «prima» di questo film «eccezionale», «trionfo dell’arte cinemato-grafica italiana», come dicevano i manifesti. Un fittissimo armento di au-tomobili padronali ingombrava la piazza in Lucina. Pareva di trovarsi al-la prima del Parsifal. Carità di patria ci vietò allora di parlare di quelfilm, come sarebbe stato giusto parlarne. Ma quale roba, quale roba citoccò vedere! Per un tour de force che ha del portentoso, il signor Ma-rio Bonnard e i suoi collaboratori erano riusciti a deturpare nel più igno-bile modo, una delle opere più alte che onorano la nostra letteratura.Dello spirito che anima il romanzo, neppure il più lieve soffio era rima-sto. Ardua faccenda era riconoscere in quei burattini che si agitavanostupidamente sullo schermo, i personaggi noti e cari a noi sin dalla pri-ma infanzia. A impersonare l’«Innominato», era stato scelto, nienteme-no, il «brillante» di una di quelle piccole compagnie drammatiche, chegirano per le cittadine di provincia. Don Abbondio, non sappiamo perqual dannatissimo caso, assomigliava come un fratello ad Anatole Fran-ce. Fra Cristoforo, che nella mente di Manzoni vuol essere un frate ro-busto e risoluto, più vicino a San Paolo che a San Francesco, nella ver-sione cinematografica si presentava nell’aspetto di una specie di padreSergio tolstoiano, con gli occhi bruciati dalla febbre mistica e con unabarba rada rada che il vento minacciava ogni minuto di portarsi via. Sen-za parlare poi della monaca di Monza, nella quale, sotto i veli monacali,non stentammo a riconoscere una di quelle mondane milanesi che ador-nano di sé la confetteria del Cova; senza parlare di quei quattro mascal-zoni che, vestiti ora da popolani, ora da lanzichenecchi e ora da monatti,s’arrabattavano disperatamente per comporre le grandi scene d’insieme.Di manzoniano, insomma in quel film non c’era che le sole didascalie,perché il signor Mario Bonnard, per un resto di delicatezza, le aveva tol-te direttamente dalla prosa di Manzoni senza metterci niente di suo, ciòdi cui gli va resa lode.
È un fatto, però, che a parte questo curioso caso di sdoppiamen-to critico, nessuno dei film italiani recensiti meriti le lodi del re-
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 441
133. Il corsaro, di Augusto Genina e Carmine Gallone, con Amleto Novelli, ArtistiItaliani Associati, 1923 (BRUNETTA, Storia del cinema..., pp. 315, 325 e 328 e MARTI-NELLI, Il cinema muto..., pp. 23-5). Regista e soggettista di film muti, è attivo anche inFrancia e in Germania. Con Carmine Gallone è però considerato tra gli «autori chepiù respirano le atmosfere e il clima del cinema europeo e che meglio riescono ad as-sorbire la crisi creando opere spesso di grande qualità e richiamo […] senza perderedi vista un’idea di film in cui si coagulino dei valori nazionali» (BRUNETTA, Storia delcinema..., p. 325). Il film viene recensito anche da Edgardo Rebizzi sull’«Ambrosia-no» (3 febbraio 1925), sulla «Rivista di letture» (aprile 1924) e da Arro su «L’Epoca»(7 marzo 1924) (MARTINELLI, Il cinema muto...).134.Messalina, di Ernesto Guazzoni, con Rina De Liguoro, Gino Talamo e AugustoMastripietri, Guazzoni Film 1923, uno degli ultimi prodotti dell’UCI, nonostante ilfallimento della Banca di Sconto avesse bloccato tutti i finanziamenti (BRUNETTA, Sto-ria del cinema..., p. 243), sviluppa alcuni nuovi accorgimenti tecnici, come l’«avvicina-mento della macchina da presa al volto degli interpreti»: «in Messalina il numero diprimi piani della protagonista è notevole e riesce a comunicare, grazie alla recitazionedi Rina De Liguoro (ultima diva del muto italiano), una forte carica di sensualità» (ivi,p. 315). Il film viene recensito trionfalisticamente da Rebizzi sull’«Ambrosiano» il 6aprile 1925 («Messalina è il trionfo della cinematografia italiana, è l’orgoglio di EnricoGuazzoni, è la rinascita della nostra arte»); da A. Bernabò sulla «Rivista cinematogra-fica» (10 giugno 1925), da Alberto Bruno su «Roma della domenica» (3 aprile 1924) ecensurato sulla «Rivista di Letture» (maggio 1925). Ebbe un grande successo in Italiae all’estero (The fall of a mistress in Inghilterra) e fu l’unico film italiano esportato inUnione Sovietica durante gli anni Venti (MARTINELLI, Il cinema muto..., pp. 75-8).
censore. Il Corsaro di Genina133 ad esempio, non viene rispar-miato: un film che prometteva una «fantasia dantesca» e doveinvece impera Sem Benelli, che doveva essere «pieno di movi-mento e di drammaticità, ed è invece lo spettacolo più balordo elento e seccante» che egli abbia visto, dove dominano scenepoetiche da cartolina illustrata con poesie di Ada Negri o Gio-vanni Bertacchi, e «il lato suggestivo» è dato «dai soliti torci-menti d’occhi della prima attrice, dalle solite tensioni di mascel-le e di muscoli del primo, dai soliti “sei tutta mia!” e “son tuttotuo!” che non commuovono più nemmeno le dattilografe». Né itoni sono più leggeri quando, con la scusa di recuperare la gran-dezza di Roma, si offrono improbabili anticaglie classicheggian-ti, con tutto il tronfio «armamentario esteriore della romanità»(«Messalina» al Cinema Corso, 12 aprile 1924)134.Qui si misura concretamente tutta l’indipendenza della posi-
zione culturale saviniana rispetto ai canoni fascisti e anche soffi-ciani, ancorati su un mito di classicità e romanità che avrebbeanche potuto affascinare il nostro autore. Per Savinio, al contra-
442 PAOLA ITALIA
135. Per cui cfr. G. MANACORDA, Interventi e testimonianze, «Lo Spettatore italiano.Rivista letteraria dell’Italia nuova» riproposta da R. TORDI, Bologna, Arnaldo ForniEditore 1982, pp. 37-42. Sullo «Spettatore italiano» Savinio pubblica anche la poesiaCanto d’addio (1 luglio 1924) ripresa dai materiali di Tragedia dell’infanzia, in cui con-fluirà con il titolo Nel fondo del mare (cfr. la Nota al testo a A. SAVINIO, Tragedia del-l’infanzia, a c. di P. ITALIA, Milano, Adelphi 2001, p. 206 n. 1).136. Così viene presentato sulle colonne del «Corriere Italiano»: «Lo Spettatore italia-no [...] si propone di essere il centro di raccolta di quanti si sentono nello stesso tem-po mossi dalla vita attuale italiana, e animati dalla volontà di organizzare le direttivaintellettuali e di esprimerne il carattere con i mezzi della poesia e dell’arte». Dal 2maggio 1924, inoltre, lo «Spettatore» lancia una pubblicazione quindicinale: «Terzapagina», una serie di piccoli volumi che raccolgono gli articoli di terza pagina dei piùimportanti scrittori e collaboratori della rivista, ampiamente pubblicizzata sul «Cor-riere» (cfr. il numero del 16 aprile 1924).
rio, una restaurazione del mito classico è impossibile, soprattut-to nelle forme che il regime cercava di accreditare. Il suo pensie-ro in proposito – che costituisce l’ultimo corollario della sua «fi-losofia delle arti» – è efficacemente espresso nella Nota a Gio-vanni Cavicchioli, uscita il 1 giugno 1924 sullo «Spettatore italia-no»135, il quindicinale diretto da Bottai e Frateili, che, nonostan-te la breve vita (esce per soli 12 numeri, dal 1 maggio 1924 al 15agosto-1 settembre 1924), rappresenta un’esperienza di rilievoin questo anno cruciale per la storia italiana.Nato come rivista letteraria in sostegno e fiancheggiamento a
«Critica fascista», naturale conseguenza del convincimento diBottai che il futuro del fascismo si doveva giocare sul piano in-tellettuale e culturale prima ancora che politico, mostra un lega-me molto stretto con il «Corriere Italiano», a partire dai collabo-ratori (il solito gruppo della «Ronda»): Cardarelli, Cecchi, Bal-dini, Bacchelli, Barilli, Montano, ma vi scrivono anche Agnolet-ti, Bragaglia, Franchi, Meriano, Pavolini, Spaini e Ungaretti136.È Soffici, inoltre, che nel maggio del 1924 stende il programmadella rivista nell’editoriale: Spirito ed estetica del fascismo, in cuifissa i principi estetici del nuovo movimento e chiede agli intel-lettuali italiani una presa di posizione sui rapporti tra arte e poli-tica. Sul secondo e terzo numero vengono pubblicate le rispostedegli intellettuali tra cui quelle di Corradini, Croce, Bacchelli,Bontempelli e Fracchia, tutti concordi nella richiesta di uno spa-zio autonomo per la cultura italiana. Croce, in realtà, rifiuta dirispondere, sostenendo la non efficacia dei questionari, mentre
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 443
137. Cfr. «Lo Spettatore italiano», 3 (1 giugno 1924), p. 185.138. Dopo il delitto Matteotti, infatti, Bottai interviene su «Critica fascista» con tre ar-ticoli, del 15 giugno e del 1 e 15 luglio, proponendo una revisione critica e un esamedi coscienza, ma il 22 luglio Mussolini, in una seduta del Gran Consiglio del fascismo,lo accusa di voler rischiare una «ricaduta nello Stato democratico-liberale». Da questomomento, messa a rischio la sua stessa posizione, Bottai si ritira, abbandonando «LoSpettatore italiano» al suo destino, convinto ormai dell’«inutilità di una rivista chenon era riuscita ad essere fiancheggiatrice del regime, cioè non era riuscita a creargliquell’alibi di dignità che un’accettabile estetica a suo nome e un folto gruppo di intel-lettuali operanti con un direttore fascista particolarmente in vista, avrebbero potutocostituire» (MANACORDA, Interventi e testimonianze, p. 41).
Bontempelli è più drastico: «Libertà assoluta, sfrenata. Lo Stato,fatto pratico, non può sotto nessuna forma, diretta e volontariadare incremento all’arte e al pensiero. Gli interventi dello Statoin questo clima superiore, non possono essere che nefasti». Nelterzo numero segue un appello Agli intellettuali d’Italia che ven-gono invitati a esprimere un proprio parere su «questo movi-mento politico di restaurazione e rivoluzione ad un tempo che èil fascismo: e, nel campo pratico, anche su un’eventuale azionedel governo Fascista»137. Lo scossone provocato dai fatti delgiugno 1924 ha conseguenze irrimediabili anche per le sorti del-la rivista. La posizione moderata e critica di Bottai – che pure siera schierato, con un sofferto editoriale del 1° luglio 1924: «Lastoria insegna che le rivoluzioni che trionfano con le armi si di-fendono con il pensiero e con la sostituzione anche violenta de-gli uomini che distrussero con gli uomini capaci di ricostruire» –perde consensi, mentre si rafforza il fascismo intransigente del-l’ala di Farinacci138.Prendendo spunto da una tiepida recensione a Romolo, la
«tragedia latina» di Giovanni Cavicchioli uscita nel 1924 a Bolo-gna da Cappelli con disegni di Giorgio de Chirico, Savinio ri-prende il discorso sviluppato su «Valori plastici» e chiarisce altripunti cruciali della sua poetica:
ciò che vale nell’arte è lo spirito lirico, contemplativo o statico; quello checi rivela l’essere in sé delle cose, il loro principio metafisico; regno, que-sto, soprattutto delle arti plastiche, delle arti cioè fuori del tempo e delmovimento. Nell’opera poetica è un elemento drammatico, di preparazio-ne alla visione lirica, il quale profondamente la inquina: ed essa si salva inquanto il poeta sa poi cantare, ascendere alle regioni dell’estasi; nell’operamusicale, invece, l’elemento ritmo finisce per essere appunto la sublima-
444 PAOLA ITALIA
139. Nota a Giovanni Cavicchioli, «Lo Spettatore italiano», I, 3 (1 giugno 1924), p. 250.
zione del movimento, anzi il movimento in sé, senza speranza di riposo insconfinamenti spaziali, un’orgia di tempo.Ora, l’elemento lirico dell’opera d’arte è appunto l’essere in sé, l’essere
eterno delle cose e dei sentimenti, fissato per l’eternità, per nostra eternagioia. Ma chi tale contemplazione ha alzato davanti a noi, aprendoci leporte del di là dei fenomeni, furono i greci, e lo spirito romantico che lipossedeva; lo spirito cioè della liberazione dalla contingenza e dal ritmo,dal movimento e dall’empirico, che trova sua massima espressione nellametafisica calma e riposo di loro statue e nei miti, fissi punti di riferimen-to poetico fuori dal tempo139.
Questo spirito – continua Savinio – è trasmigrato dai Greci aipopoli nordici, che hanno creato miti e saghe, mentre i nostripoeti non sono riusciti a creare una fusione con la tradizione, ilmito, la sensibilità artistica del popolo: «Così fatalmente, è nega-ta al nostro popolo la collaborazione con i suoi poeti, ciò che in-vece avviene, e non potrebbe essere altrimenti, nei paesi di tradi-zione romantica». Il mito latino, quindi, non esiste, e quando inostri tragici «abbandonano le loro vie» per tentare «ciò che sicompì ad Atene, a Weimar e alla Corte d’Elisabetta», fallirono.Considerazioni che permettono di criticare l’opera di Cavicchio-li, che ha provato a innestare la tradizione classica sullo spiritoromantico: «perché da noi il classicismo non è che un tentativonon mai riuscito di creare un mito (almeno formale) a ridossodella nostra grande e solitaria poesia». Una conclusione che sidovrà tenere presente nel considerare la produzione savinianadegli anni Trenta.
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 445
APPENDICE
Collaborazioni al «Nuovo Paese» (1923)
1. L’addio al poeta, «Il Nuovo Paese», 6 marzo 1923 [→ In poeta memo-riam [sic] «L’Esprit nouveau. Revue internationale illustrée de l’acti-vité contemporaine. Arts – Lettres – Sciences», n. 26, numéro spécialconsacré a Guillaume Apollinaire, ottobre 1924, s. pp. (comprende latraduzione francese di L’addio al poeta); → «La Nazione», 30 settem-bre 1933; → Addio al poeta, in Achille innamorato, ora in Casa «la Vi-ta» e altri racconti, pp. 36-40].
2. Il vaso di Pandora. Le sirene, «Il Nuovo Paese», 30 marzo 1923.3. Il vaso di Pandora, «Il Nuovo Paese», 25 aprile 1923.4. Il vaso di Pandora. Le statue sui tetti; Carmen paraclausitiron,
Encomio, «Il Nuovo Paese», 29-30 aprile 1923.5. Miscellanea. Ordine del passato, Quando la pioggia cessa, Il calcio del-
l’asino, Chiosa necessaria, «Il Nuovo Paese», 13 maggio 1923.
Collaborazioni al «Corriere Italiano» (1923-4)
1. Libreria. «Moscardino» di Enrico Pea e «Lo sa il tonno» di RiccardoBacchelli, «Corriere Italiano», 16 agosto 1923.
2. Passeggiate per Roma, «Corriere Italiano», 16 agosto 1923.3. Giostra. Il cocomero, «Corriere Italiano», 28 agosto 1923.4. Ricerca del passato, «Corriere Italiano», 29 agosto 1923 [← Sguardo
alle lettere francesi d’oggi: Marcel Proust, «La Bilancia», a. I, n. 3-4-5,maggio-luglio 1923, pp. 153-60; → Mistero dello sguardo, a c. di R.TORDI, Roma, Bulzoni 1992, pp. 105-9].
5. Cinematografo, «Corriere Italiano», 1 settembre 1923 [non firmato].6. Giostra. Simboli, Sermone ai ben chiomati, Intesa intellettuale, Raffinati.
e Libreria, «Corriere Italiano», 7 settembre 1923.7. Libreria. «L’amore di Beby» di Mura; «Le terrain Bouchaballe» di Max
Jacob; «L’inganno della carne» di Mario Puccini, «Corriere Italiano»,11 settembre 1923 [siglato «a.s.», ma presente in Archivio].
8. Cinematografo. I vecchi «films»; Sessuo Ayakawa; Leone Tolstoj e ilcinema; Notiziario, «Corriere Italiano», 12 settembre 1923 [siglato«s.a.l.»]
446 PAOLA ITALIA
9. I Greci d’oggi, «Corriere Italiano», 13 settembre 1923.10. Libreria. Per il ripristino della «cavalcata» nella città di Fermo, «Cor-riere Italiano», 14 settembre 1923.
11. Giostra. Occhio alla mammella, Siciomachia, «Corriere Italiano», 15settembre 1923.
12. Commenti. La nutrizione, Il povero Sacerdote, Interpretazioni, «CorriereItaliano», 30 settembre 1923.
13. Ritratto dell’uomo Crispi, «Corriere Italiano» 5 ottobre 1923.14. Il «Salmo» di Don Lorenzo Perosi, «Corriere Italiano», 9 ottobre 1923.15. Cinematografo. La decadenza del cinema; la censura; Notiziario, «Cor-riere Italiano», 10 ottobre 1923 [siglato «s.a.l.»].
16. Cacciando fiere in Africa» al Cinema Corso, «Corriere Italiano», 11 ot-tobre 1923 [siglato «a.s.», ma conservato in Archivio ds. e ritaglio].
17. Storie e favole. Ottobrata, «Corriere Italiano», 12 ottobre 1923.18. L’inaugurazione del monumento ai caduti, «Corriere Italiano», 16 otto-bre 1923 [non firmato].
19. Dai campi di Cerere. Giornata seconda del Casentino, «Corriere Italia-no», 18 ottobre 1923.
20. Dai campi di Cerere. Terza e ultima giornata, «Corriere Italiano», 19ottobre 1923.
21. Cinematografi, «Corriere Italiano», 25 ottobre 1923 [siglato «A.S.»].22. Cinematografi. Prime fucilate, «Corriere Italiano», 31 ottobre 1923.23. Palazzo Venezia nel rinnovato splendore, «Corriere Italiano», 31 otto-bre 1923.
24. Il solenne ricevimento di ieri sera a Palazzo Venezia, «Corriere Italiano»,1 novembre 1923.
25. Libreria. «Autobiografia» di Tagore, «Delitto e castigo» di Dostoiewski,«Nazionalismo» di Tagore, »Ciò che si può capire della teoria della rela-tività senza la matematica» di Paolo Kirchberger, «Corriere Italiano», 3novembre 1923.
26. Cinematografi. «Il sangue di Allah» al Capranica; L. R: Stevenson fi-schiato!; S.M. Douglas al Cinema Corso, «Corriere Italiano», 9 novem-bre 1923 [siglato «S.», ma presente in Archivio].
27. Corriere cinematografico. «Il mistero della camera gialla» al Volturno,«Corriere Italiano», 10 novembre 1923.
28. Il ritorno di Ulisse, «Corriere Italiano», 11 novembre 1923.29. Guglielmo Apollinaire, «Corriere Italiano», 11 novembre 1923 [siglato«S»].
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 447
30. Corriere del Cinematografo. «Padre Sergio» all’Olimpya. «Vox femi-nae» al Volturno, «Corriere Italiano», 15 novembre 1923 [siglato «S.»,ma presente in Archivio].
31. Corriere del Cinematografo. «Polyanna» al Cinema Corso, «CorriereItaliano», 18 novembre 1923.
32. Storie e favole: Il fratello del sicario, «Corriere Italiano», 21 novembre1923.
33. Corriere del Cinematografo. «Crainquebille» al Cinema Corso, «Corrie-re Italiano», 22 novembre 1923 [siglato «S.», ma presente in Archivio].
34. «Emiral» del maestro Bruno Barilli vince il Concorso nazionale dellaMusica. Bruno Barilli, «Corriere Italiano», 29 novembre 1923.
35. Corriere del Cinematografo. «Kid» al Cinema Imperiale, «Corriere Ita-liano», 2 dicembre 1923.
36. Corriere del Cinematografo. «Robin Hood» al Cinema Corso; «Nell’an-ticamera del matrimonio» al Capranica; «Gli oppressi» al Modernissimo,«Corriere Italiano», 8 dicembre 1923 [siglato «S.», ma presente inArchivio].
37. Luigi, Principe di Borbone, pronipote del Re Sole, «Corriere Italiano»,12 dicembre 1923.
38. Luigi, Principe di Borbone, pronipote del Re Sole, «Corriere Italiano»,13 dicembre 1923.
39. Luigi, Principe di Borbone, pronipote del Re Sole, «Corriere Italiano»,16 dicembre 1923.
40. *Corriere del Cinematografo. «Otello» al Cinema Capranica, «CorriereItaliano», 22 dicembre 1923 [→ Rivista del cinematografo, «Galleria»,a. I, n. 1, gennaio 1924, pp. 55-6; → parzialmente in Il sogno meccani-co, pp. 67-68].
41. Corriere del Cinematografo.«Così parlò Confucio» al Cinema Corso,«Corriere Italiano», 25 dicembre 1923 [siglato «A.S.»].
42. *Corriere del Cinematografo. «I Promessi Sposi» al Cinema Corso,«Corriere Italiano», 28 dicembre 1923.
43. Corriere del Cinematografo. «Anna Bolena», all’Imperiale e al Moder-nissimo, «Corriere Italiano», 9 gennaio 1924 [→ Rivista del cinemato-grafo, «Galleria», a. I, n. 2, febbraio 1924, pp. 54-5; → parzialmentein Il sogno meccanico, pp. 68-9].
44. Il povero trombone, «Corriere Italiano», 9 gennaio 1924 [non firmato,ma presente in Archivio].
45. Storie e favole: Meditazioni sui dolci, «Corriere Italiano», 10 gennaio1924.
448 PAOLA ITALIA
46. Viaggio forzoso da Via Poli a Monte Cimino, «Corriere Italiano», 3febbraio 1924.
47. Dal paese di Mignon: I fiori della Riviera, «Corriere Italiano», 28 feb-braio 1924.
48. *Corriere del cinematografo. «Donne viennesi» al Capranica, «CorriereItaliano», 4 marzo 1924 [siglato «A.S.», ma presente in Archivio].
49. Diario del litoral fiorito, «Corriere Italiano», 11 marzo 1924.50. Corriere del Cinematografo.«Come venne al mondo l’uomo d’argilla» al
Modernissimo, «Corriere Italiano», 30 marzo 1924.51. Corriere del Cinematografo. «La perduta di Shangai» al Capranica,«Corriere Italiano», 4 aprile 1924.
52. Alla città della mia infanzia, dico, «Corriere Italiano», 9 aprile 1924[← «Simplon», a. I, n. 7, settembre 1922, pp. 23-4; → «Mediterra-neo», a. XI, 13, 29 marzo 1941, p.11; → Alla città della mia infanziadico, in Casa «la Vita» e altri racconti, pp. 205-7].
53. Corriere del Cinematografo. «Bavù» al Capranica, «Corriere Italiano»,11 aprile 1924.
54. Corriere del Cinematografo. «Messalina» al Cinema Corso, «CorriereItaliano», 12 aprile 1924 [siglato «A.S.»].
55. Corriere del Cinematografo. «Jazzmania» al Cinema Imperiale, «Corrie-re Italiano», 15 aprile 1924 [siglato «a.s.», ma presente in Archivio].
56. Introduzione quasi critica ai «Sette contro Tebe» e all’«Antigone»,«Corriere Italiano», 30 aprile 1924.
57. Corriere del Cinematografo. «La città degli uomini silenziosi» al Capra-nica, «Corriere Italiano», 1 maggio 1924.
58. Omaggio breve a Emanuele Kant, «Corriere Italiano», 3 maggio 1924.59. Corriere del Cinematografo. «Il toro di Olivera» al Modernissimo,«Corriere Italiano», 10 maggio 1924.
60. Icaro, «Corriere Italiano», 10 maggio 1924 [→ «La Rivista di Firen-ze», nn. 5-6, settembre 1924, pp. 3-5; → Icaro, in Achille innamorato,ora in Casa «la Vita» e altri racconti, pp. 50-3].
61. Corriere del Cinematografo. «La Battaglia» al Cinema Corso, «CorriereItaliano», 18 maggio 1924.
62. Corriere del Cinematografo. «Violette Imperiali», «Corriere Italiano»,22 maggio 1924.
63. I Balletti russi di Sergio Diaghilew, «Corriere Italiano», 4 giugno 1924.64. Corriere del Cinematografo. «La donna che vinse il destino» al Voltur-
no, «Corriere Italiano», 4 giugno 1924 [siglato «A.S.», ma presente inArchivio].
SAVINIO, SOFFICI E LA POLITICA CULTURALE DEL FASCISMO 449
65. Filosofi in erba, «Corriere Italiano», 13 giugno 1924.66. Novellieri in boccio, «Corriere Italiano», 14 giugno 1924.
Collaborazioni a «Galleria» (1924)
1. Rivista del cinematografo, «Galleria», a. I, n. 1, gennaio 1924, pp. 55-6[contiene «Otello» al Cinema Capranica «Corriere Italiano», 22 di-cembre 1923←;→ parzialmente in Il sogno meccanico, pp. 67-8].
2. Rivista del cinematografo, «Galleria», a. I, n. 2, febbraio 1924, pp.54-5 [contiene «Anna Bolena», all’Imperiale e al Modernissimo ←«Corriere Italiano», 9 gennaio 1924; →parzialmente in Il sogno mec-canico, pp. 68-9].
3. Rivista del cinematografo, «Galleria», a. I, n. 3, marzo 1924, pp. 43-4[→ Il sogno meccanico, pp. 69-71].
450 PAOLA ITALIA