Ottiero Ottieri: la possibilità di un Sud e il viaggio (mancato) con Corrado Alvaro
Transcript of Ottiero Ottieri: la possibilità di un Sud e il viaggio (mancato) con Corrado Alvaro
Ottiero Ottieri: la possibilità di un Sud e il viaggio (mancato) con Corrado Alvaro
CLAUDIA BONSI
Dal momento che la critica si è già soffermata sulla dimensione
meridionalistica che connota parte dell’opera di Ottiero Ottieri1, so-
prattutto quello che è il suo romanzo più noto, Donnarumma
all’assalto2, vorrei tentare di fornire una mappatura dell’immaginario
ottieriano che prenda le mosse da Roma per arrivare a Milano3, e
quindi deviare verso il marchesato di Ivrea4
per poi scendere fino alla
Calabria di Alvaro, passando da Pozzuoli. Partirò non solo dai volumi
e dai contributi dati alle stampe, ma soprattutto da alcuni documenti,
fra i molti che si potrebbero portare all’attenzione del lettore e dello
studioso scorrendo le serie diaristiche, i materiali avantestuali relativi
alla produzione prosastica e poetica dell’autore, e l’epistolario, conse-
gnati da Ottieri stesso e, in seguito, dagli eredi, al Centro Manoscritti
1 Il punto di partenza bibliografico fondamentale sull’opera di Ottieri è il recente
volume mondadoriano O. OTTIERI, Opere scelte, scelta dei testi e nota introduttiva di
G. MONTESANO, cronologia di M.P. OTTIERI, notizie sui testi e bibliografia a cura di
C. NESI, Mondadori, Milano 2009, cui si va ad aggiungere il numero monografico
dedicato all’autore dalla rivista «Autografo», Le linee gotiche di Ottiero Ottieri. Per-
corsi testuali, 49, XXI, 2013. 2 G. IADANZA, L’esperienza meridionalistica di Ottieri: lettura critica del
Donnarumma all’assalto, prefazione di G. PAMPALONI, Bulzoni, Roma 1976. 3 La polarità tra Roma e Milano è stata indagata, con ampi ed aggiornati
riferimenti al dibattito sulle due culture, quella umanistica e quella scientifica, e alla riflessione sociologica e psicoanalitica contemporanea da C. NESI, Due culture, due
città: La linea gotica, «Autografo», 49, XXI, 2013, pp. 25-35. 4 Il riferimento è a L. BIANCIARDI, La vita agra, Bompiani, Milano 2011, p. 63,
dove si citano i «venditori di ogni livello al soldo del marchese d’Ivrea».
55
di Autori Moderni e Contemporanei dell’Università di Pavia5. Il per-
corso disegnato dalla narrazione, sia essa affidata alla sfera privata di
un diario o a quella pubblica di un romanzo, delinea un Meridione
molto distante da quello pittoresco e ridicolo che fa da scenario a tante
commedie all’italiana, o da quello arcaico e folclorico di un Alvaro o
di un Levi: è la possibilità di un Sud6
diverso, inedito, industriale,
benché destinato a vedere fallire le proprie velleità di progresso, fa-
talmente sganciate da un goffo e repentino sviluppo realizzatosi (e so-
lo parzialmente) su un piano strettamente materiale7.
Ma facciamo un passo indietro e vediamo da dove parte il traccia-
to geografico, emotivo e narrativo di Ottieri. Può essere utile per la
sua concisione questa auto-presentazione abbozzata dall’autore stesso
nel ‘53 sul proprio diario:
Curriculum vitae
Nato a Roma il 29 marzo 1924. Laureato in lettere all’Università di
Roma nel 1945. Presso la stessa Università ha seguito il corso di perfe-
zionamento in Letteratura inglese. Conosce l’inglese e il francese. [...]
Da alcuni anni ha lasciato gli studi letterari per dedicarsi a quelli psico-
logici (sotto la guida del prof. Musatti), di psicologia del lavoro indu-
striale ed economici. È in questa direzione che intende continuare8.
5 Una prima descrizione in N. TROTTA, Notiziario, «Autografo», 35, XIII, 1997,
pp. 185-192 e in S. ALBESANO (a cura di), A carte scoperte. Repertorio dei fondi lom-
bardi del Novecento: Archivi di persona, Officina Libraria, Milano 2009, pp. 97-98
(consultabile all’indirizzo http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-
archivistici/MIBA008734/). Mi permetto inoltre di rimandare ad A. ANTONELLO, C.
BONSI, Dolce vita, vita industriale, vita assurda. Le carte di Ottiero Ottieri al Fondo
Manoscritti di Pavia, «Autografo», 49, XXI, 2013, pp. 144-160. Le trascrizioni dei
brani tratti dai diari sono date secondo l’ultima lezione ricostruibile dal testo. 6 La formula è presa in prestito dal titolo del libro di M. HOUELLEBECQ, La
possibilité d’une île, Fayard, Paris 2005, trad. it. La possibilità di un’isola, Bompiani,
Milano 2005. 7 Lo scollamento tutto italiano tra sviluppo e progresso sarà denunciato da P. P.
PASOLINI, Sviluppo e progresso, in ID., Scritti corsari, Garzanti, Milano 2010, pp.
175-178. 8 Quaderno XIV; il brano è riportato interamente da A. ANTONELLO e C. BONSI,
Dai diari di Ottiero Ottieri, «Autografo», 49, XXI, 2013, pp. 117-134: 121-122.
56
Ed è in questa direzione che Ottieri, rampollo dell’antica nobiltà
toscana ma nato e cresciuto negli agi borghesi della capitale9, effetti-
vamente prosegue: trasferitosi a Milano nel ‘48, finisce per dedicarsi,
in un primo momento, all’attività editoriale, ma ne è ben presto nause-
ato, ricavandone una sensazione di alienazione rispetto al contesto
produttivo animato dall’apparato industriale10
. Ne La linea gotica,
romanzo-diario che Ottieri pubblica per Bompiani nel ‘62, l’autore fa
un’analisi lucida del lavoro culturale (editoria e giornalismo), con tan-
genze significative con analoghi ragionamenti di Bianciardi sul te-
ma11
:
Sto nella zona editoriale ambigua, abitata – come spesso nel giornali-
smo – da individui scontenti, spostati o falliti. Sono gli intellettuali-
impiegati (alla cui schiera mi sono aggiunto), peste della società e di se
stessi, angosciati e angoscianti, monotoni anche se di vivace intelligen-
za, sbattuti fra la novità perenne della cultura e la routine, eternamente
aspiranti ad una libertà che non si capisce se non si sanno meritare o se
non venga data loro da un mondo incomprensivo e crudele: la libertà di
“creare”. I profani si ingannano quando credono che quello editoriale
sia un lavoro più spirituale di tutti gli altri. Se la casa editrice non attra-
versa un periodo di eccezionale senso culturale, ne esce un’aria viziata
di letteratura fredda e di mestiere. Lo scrittore-impiegato viene usato
come una macchinetta che produce soffietti, avvisi pubblicitari. I libri
non li legge, li fiuta rapidamente tanto per sentire l’odore e trasformarlo
in pubblicità12
.
Nonostante tutto, il trasferimento al Nord è percepito come una
tappa necessaria, benché dolorosa, una lacerazione che trova il proprio
9 O. OTTIERI, Opere scelte, cit., p. LIII. 10 Ivi, pp. LXIV-LXV. 11 L. BIANCIARDI, La vita agra, cit., p. 108: «Come si misura la bravura di un
prete, di un pubblicitario, di un PRM? Costoro né producono dal nulla, né
trasformano. Non sono né primari né primari né secondari. Terziari sono e anzi
oserei dire, se il marito della Billa non si oppone, addirittura quartari. Non sono
strumenti di produzione, e nemmeno cinghie di trasmissione. Sono lubrificante, al
massimo, sono vaselina pura». 12 O. OTTIERI, La linea gotica, in ID., Opere scelte, cit., pp. 227-453: 251.
57
corrispettivo spaziale nella «linea gotica» che bipartisce idealmente la
penisola:
L’importanza del Nord e del Sud nella mia geografia sentimentale è
grandissima. Ho creato una linea gotica, che separa due zone dove io
vivo indifferentemente.
Passando in treno da Firenze e Bologna fin dalle prime volte sentivo
che, scavalcando l’Appennino, entravo in un altro mondo, la pianura
lombarda, il Nord.
Da questo Nord profondamente rifuggivo, pur imponendomelo come un
indispensabile passaggio...13
Milano è quindi solo il mezzo per sondare la realtà industriale e
avvicinarne il capitale umano: «Perché rimango a Milano? Solo per
l’industria, per la simpatia profonda, nascosta alla classe operaia. Non
sono chiacchiere. La simpatia e la malinconia che ispirano gli operai.
Ma bisogna andare più in fondo, come ha fatto la Weil, e, se possibile,
più in fondo ancora. Bisogna arrivare a delle certezze».
La mancanza di concretezza del settore quartario è causa di
un’insoddisfazione di fondo, che Ottieri cerca di placare inoltrandosi
nella periferia di recente industrializzazione, la quale non è ancora
riuscita a cannibalizzare l’ambiente rurale su cui si è impiantata:
Scoperta della periferia di Milano, del rapporto città-campagna. La fab-
brica nasce sul prato, dal prato, vicina alle cascine, ed alle vecchie chie-
se dei villaggi lombardi. Vedi Rogoredo, Greco, la Bovisa. A Rogoredo
l’acciaieria Redaelli sta nascosta fra le case di un borgo. I canali, i cam-
pi, la chiesa, e poi, i bagliori rossi delle fusioni, oltre il cancello della
fabbrica. La via Emilia, e la strada ferrata.
Scoperta di questo confine di Milano, di questa linea in cui la città e la
campagna si incontrano, come il mare e la spiaggia14.
13 Quaderno XII, nota risalente al 1948; da questa immagine trarrà spunto per
confezionare l’incipit de La linea gotica (cfr. O. OTTIERI, Opere scelte, cit., p. 229). 14 Quaderno XIV, nota risalente al 1951.
58
In città, specie a Milano, mi perdo nella selva delle sovrastrutture. Sod-
disfano bisogni che non ho, quindi mi schiacciano. In più, sono brutte.
Vado nell’unica oasi possibile, in periferia, tra città e campagna, dove le
fabbriche nascono dai prati, e così soddisfo il desiderio dell’evasione e
quello (storico-materialistico) di conoscenza delle strutture. In periferia
i prodotti infiniti della civiltà non hanno ancora preso quella vita auto-
noma (feticista) che fa impazzire chi vuole romperla per guardarci den-
tro. Ma la società, la civiltà, nascono dall’aiuto reciproco, dalla divisio-
ne del lavoro, istintiva e necessaria... Così almeno può pensare che la
nascita della società civile sia anch’essa naturale e mi consolo, accetto
pian piano i grandi dolori odierni, la cultura, i giornali, la burocrazia, il
commercio – per evitare di arrivare ad un amore fine a se stesso per il
primitivo, antimarxista per eccellenza e sentimentale per eccellenza15
.
Lavorare come redattore per «La Scienza illustrata»16
gli offre un
biglietto d’ingresso per le officine, ma solo come spettatore. Nel 1951,
dopo una visita all’Alfa Romeo, dichiara:
I reparti sono un inferno di rumore e di caldo, quasi tutti. I rumori vi e-
splodono come durante un bombardamento e ognuno sembra l’ultimo, il
definitivo, mentre non è che uno dei mille durante la giornata. Il caldo è
quello del fuoco liquido, del metallo travasato da un recipiente all’altro
come l’acqua.
Tutti quelli che conosco, e che non ci sono mai stati, mi piacerebbe di
portarli qui a vedere. Come importanza, non credo che i templi di Pae-
stum o un panorama marino dell’Italia meridionale, valgano di più. [...]
Che accadrebbe ad ambientare qui un romanzo? Quali storie umane si
dovrebbero inventare?17
15 O. OTTIERI, Opere scelte, cit., pp. 256-257. 16 Ivi., p. LXX. 17 Quaderno XIII; il brano, rielaborato e parzialmente confluito ne La linea
gotica, in O. OTTIERI, Opere scelte, cit., pp. 263-264, è riportato interamente da A.
ANTONELLO e C. BONSI, op. cit., pp. 120-121.
59
L’esperimento narrativo frutto di queste indagini sociologiche sul
campo e della successiva assunzione in Olivetti18
è Tempi stretti, pub-
blicato per i gettoni Einaudi nel 195719
: il plot (un classico triangolo
amoroso) si dipana all’interno di una fabbrica milanese, nevrotizzata
dalla necessità di ridurre i tempi di produzione. Ottieri annota sul suo
diario nel 1953, riferendosi allo stabilimento di Adriano Olivetti di I-
vrea:
Qui tutto si riduce a una questione di tempo: fare più in fretta possibile.
È tempo puro, il polo opposto della riflessione, della invenzione. Quan-
do il gesto dell’uomo è ridotto a un semplice meccanismo, allora si pen-
sa ad una macchina che lo sostituisca. E si ricomincia da capo, bisogna
inventare la macchina20
.
È quindi proprio l’ingegnere a dare a Ottieri la possibilità di ri-
scavalcare gli Appennini in senso contrario e di scoprire la Campania
dell’Ilva di Bagnoli e dell’avveniristico stabilimento di Pozzuoli, rea-
lizzato da Luigi Cosenza in vetro e acciaio («La natura nella fabbrica,
come vuole il Presidente»): «Qui tutti i problemi di Ivrea, sembra, si
allontanano, diluiscono. Proprio nel Sud, agricolo, questa mècca indu-
striale? È la solita astrazione olivettiana. (È lo sfruttamento del sole ai
danni degli uomini)»21
. Risale al ’54 questa dichiarazione di intenti:
Ho fatto una prima ricognizione laggiù. Non voglio affogare nella que-
stione meridionale, tanto meno nel folklore che la circonda. Altri lo pos-
sono fare meglio. La mia ancora è lo stabilimento, l’industria di origine
settentrionale. Certo, quelle fabbriche mi sono parse isolette perse nel
mare della civiltà meridionale. Riescono, riusciamo a creare una novità,
18 Ottieri infatti entra alle dipendenze di Olivetti come psicotecnico, formandosi
prima nello stabilimento di Ivrea nel ‘53 per poi lavorare a Pozzuoli, dal marzo al
novembre del 1955. 19 O. OTTIERI, Tempi stretti, Einaudi, Torino 1957, il secondo libro pubblicato
dopo l’autobiografico Memorie dell’incoscienza, Einaudi, Torino 1954. 20 Quaderno XIV. 21 Quaderno XVI; il brano è riportato interamente da A. ANTONELLO e C. BONSI,
op. cit., p. 128.
60
sia pure capitalistica? Contro al mare, al sole, ai milioni di abitanti della
costa, contro al paradiso o all’inferno del Mezzogiorno, sono sufficienti
i 300 operai del mio stabilimento, i 1500 dell’Ansaldo?22
Lo psicotecnico ragiona in termini dicotomici, sottoponendo gli
uomini del Sud ad implacabili procedure comparative, che registra
diligentemente nella cronistoria dell’esperienza puteolana, Donna-
rumma all’assalto:
Ma per ora è coi lombardi che preferisco parlare: ognuno mostra chiaro
il suo carattere, e facciamo insieme il confronto con gli stabilimenti da
cui ci hanno trasferiti, pieni di ricordi comuni, di tradizioni, di celebri
nomi.
I meridionali, quelli di Santa Maria, sono più monotoni, avendo tutti la
stessa gioia del posto; ignari, credono che l’unica industria sia questa
qui, isola affiorata da un mare senza continenti, anche in questa zona
che dovrebbe essere industriale23
.
I colloqui quotidiani con i candidati locali rettificano solo par-
zialmente antichi pregiudizi, o meglio, ne chiariscono ulteriormente le
cause storiche, mentre si intravede una possibilità di redenzione per
via aziendalistica:
L’uomo meridionale non è diverso dagli altri, ma è un uomo deformato.
Le avventure della sua vita, la storia, lo peggiorano e lo esaltano fuori
da comuni leggi. Ricchi e poveri, niente qui, nessuno scoglio, un appi-
glio, emerge, e tutti nuotano sotto il livello della coscienza collettiva24
.
L’operaio alla macchina o al banco anche a Santa Maria sta fermo nello
stesso anello che lo terrebbe a Torino, in Germania. Fuori sono quelli
che secoli di storia e di folklore li hanno fatti, intelligenti e troppo fanta-
siosi, dignitosi ma disordinati; tutti i luoghi comuni intorno al Mezzo-
giorno mi tornano a galla, veri. Un popolo che ama cantare. Badano al
22 O. OTTIERI, La linea gotica, cit., p. 362. 23 O. OTTIERI, Donnarumma all’assalto, in ID., Opere scelte, cit., pp. 3-225: 22. 24 Ivi, p. 115.
61
pregiudizio più che alla realtà, al lusso più che al necessario; non hanno
soldi, ma non li sanno spendere. Ai fatti preferiscono l’invenzione delle
parole. La storia li giustifica pienamente, avendoli deformati, ma la giu-
stificazione storica non riscatta oggi, domani, perché il male è male an-
che se determinato da una ragione; mentre si vive, su questa ragione non
si può riflettere ogni momento. Il male diventa colpa, razza.
Invece in fabbrica miglioriamo, loro e noi. Ci comprendiamo e ci asso-
migliamo, uniti dalla stessa produzione, cioè dalla stessa sorte. […]
C’è ovunque uno stesso silenzio di persone che corrono dietro al tempo,
e questa corsa costringe certamente alla schiavitù, ma mai come nel no-
stro stabilimento compare l’altra faccia di questa schiavitù necessaria: la
dura dignità, la costruzione giornaliera di una via di libertà25
.
Antonio Donnarumma, l’aspirante operaio che rifiuta di sottopor-
si alle prove psicotecniche, è l’ipostatizzazione della disoccupazione,
di quella «disoccupazione cronica» che è «l’alienazione vera, stori-
ca»26
del Sud, e allo stesso tempo, dell’uomo meridionale, del suo ri-
fiuto di assimilarsi, della sua testarda resistenza a un capitalismo sem-
pre e comunque antropofago, a dispetto di tutti gli sforzi di una dire-
zione illuminata.
Ben presto diventa chiaro che il laboratorio psicotecnico di Poz-
zuoli non è quello di Ivrea: qui, non esistendo equilibrio tra la doman-
da e l’offerta di forza-lavoro, il sistema delle assunzioni implode, me-
taforicamente e concretamente, e l’umanista venuto dal Nord archivia
il fallimento lavorativo per tornare alla letteratura («Crederanno che lo
psicologo parta per paura di Donnarumma. Infatti, oramai, parto»27
):
Così per la quarta volta nella mia vita rinuncio ad una carriera già avvia-
ta. La prima volta fu quando abbandonai la strada universitaria, a Roma;
la seconda quando lasciai la Mondadori, la terza quando lasciai la dire-
zione della Scienza Illustrata. Adesso lascio la Olivetti di Pozzuoli pro-
prio mentre cominciavo ad acquistarvi prestigio, autorità e competenza
25 Ivi, p. 156. 26 Ivi, p. 154. 27 Ivi, p. 222.
62
e mi avviavo verso il primo passo: Capo del Personale. La differenza,
però, fra questa e le altre volte è assai grande: prima me ne sono sempre
andato con piacere, adesso me ne vado con grande dolore e debbo
strappare le radici da questo mondo popolare, affascinante e snervante.
La ragione è sempre la stessa: la mia carriera è un’altra, è la carriera di
scrittore28
.
Quattro anni prima, nel ’51, Ottieri si era spinto ancora più nel
profondo di questo «mondo popolare, affascinante e snervante» del
Mezzogiorno, esperendo, in compagnia della moglie Silvana Mauri,
una Calabria filtrata dalla letteratura: «Settembre. Viaggio in Calabria
e a San Luca, favoloso paese di Alvaro, verso tutta la “questione me-
ridionale” e tutti i nostri miti del Sud»29
.
Ottieri si è formato sulla narrativa alvariana, come dimostrano le
lunghe trascrizioni di brani tratti da L’uomo è forte tra le carte giova-
nili30
, inoltre riferimenti allo scrittore calabrese sono disseminati nei
diari, e quindi travasati ne La linea gotica:
Tra Alvaro e la realtà c’è sempre una nebbiolina, poetica, ma una neb-
biolina. E quando descrive i posti, come la Calabria e l’Itinerario Italia-
no, dà illuminazioni bellissime, ma non descrive affatto dove ci si trova.
Si sta sempre sospesi.
Disdegna le strutture, i rapporti di produzione. Ma nemmeno questo è
del tutto vero. Li sublima. Che sia già uno scrittore vecchio, del venten-
nio?31
28 Quaderno XVIII; brano citato da A. ANTONELLO, «Parole per scrivere, guai
per vivere»: dal diario di Pozzuoli a Donnarumma all’assalto, «Autografo», 49, XXI,
2013, pp. 71-89:74. 29 O. OTTIERI, La linea gotica, cit., p. 271. Un ricordo del viaggio a San
Luca è nel libro della moglie S. MAURI, Ritratto di una scrittrice involontaria,
Nottetempo, Roma 2006, pp. 227-228. 30 Le trascrizioni si trovano sul verso di alcune pagine di un romanzo giovanile
inedito, L’eroe Daniele (IA 3/II); in un’altra cartella sono invece conservate le
impressioni di lettura de L’uomo è forte da parte di Ottieri, che datano alla metà di
gennaio del ‘42 (IA 17/1). 31 Quaderno XIV, appunto del 1952; il frammento, accolto ne La linea gotica,
viene modificato espungendo il titolo della raccolta alvariana di impressioni di viaggio e
sfumando il cenno diretto al fascismo: «Tra Alvaro e la realtà c’è sempre una nebbiolina,
63
Ottieri, al contrario, deciderà di descrivere in maniera estrema-
mente minuziosa i rapporti di produzione, e come questi si ripercuota-
no sull’individuo, nelle opere della stagione operaista, senza lirismi,
ma con uno «stile semplice»32
e uno sguardo quasi da etnografo, in
debito con la diegesi asciutta e distaccata dell’Alvaro di Gente in A-
spromonte.
In una lettera che non possediamo, Ottieri propone ad Alvaro
(probabilmente conosciuto tramite lo zio acquisito, Valentino Bom-
piani, amico ed editore dello scrittore)33
di accompagnarlo in un altro
viaggio in Calabria: i luoghi e la gente della letteratura potevano fi-
nalmente animarsi nel racconto di chi li aveva creati; il 29 settembre
del 1952 il vecchio scrittore risponde al giovane con una lunga repli-
ca34
:
Caro Ottieri,
io non mi so decidere di andare a San Luca. Vi manco dalla morte di
mio padre. Il più audace progetto che faccio di tornarvi, è di arrivare fi-
no al ciglio sul colle, dove mio padre aveva una casupola e un campo
con un orto, guardare il mio paese e tornarmene indietro. Mio fratello
mi scrive che la nostra casa è quasi in rovina e che bisogna decidersi a
venderla o a ricostruirla. Ho paura di tornarvi. Eppure so che avrei mol-
to da impararvi e da capire. L’unica sarebbe affrontare, dal 30 agosto al
30 settembre, il pellegrinaggio di Polsi. Ma anche là mi dicono che il
nuovo vescovo ha vietato i balli popolari che duravano notte e giorno in
ogni palmo di terra, e che cominciavano già sulle vie dei pellegrini che
poetica ma una nebbiolina. Quando descrive i luoghi, dà illuminazioni bellissime, ma
non si capisce mai bene dove ci si trova. / Parte dalle strutture, per allontanarsene
subito, liricamente; ha urgenza di sublimarle. Risente di essere scrittore fra le due
guerre, anche nel dopoguerra, quando i fatti d’Italia si sono aperti, spaccati, e sono
stati scoperti, senza nebbia e senza sublimazione» (O. OTTIERI, La linea gotica, cit., p.
298; un altro riferimento ad Alvaro è alle pp. 275-276). 32 Nel senso proposto da E. TESTA, Lo stile semplice: discorso e romanzo,
Einaudi, Torino 1997. 33 Com’è noto, Valentino Bompiani era lo zio della moglie, Silvana Mauri
Ottieri. 34 Lettera ms del 29-09-1952 (EP 1).
64
facevano voto di ballare; ha vietato gli sposi, per cui tutto attorno le
coppiette consumavano chili di polvere per devozioni, notte e giorno;
non c’è più che la musica in piazza e la gente costretta ad ascoltare in si-
lenzio. Né fiera, né indovine con gli occhi bendati in una pandella, né
zingari, né macellerie sotto gli alberi, encine nei boschi, né cantastorie.
Progettiamo un viaggio in Calabria, se vuole, forse di primavera, o
d’autunno, il prossimo, quando c’è il raccolto delle ulive e delle arance,
e la gente è fuori a questi lavori. Ma come forestieri tutti e due. Ho pau-
ra della mezza civiltà meridionale, della falsa intelligenza e cultura, del-
le false opinioni. Se avrò una macchina potremo muoverci. Entrare in
certi paesi la mattina presto, è dovunque uno dei più squisiti piaceri; in
Calabria è affascinante. Perché ha il suo bellissimo ordine naturale e la
sua nobiltà nella più squallida miseria. E anche la strada per arrivarci, e
anche gli alberghi dei capoluoghi dove si può vedere ciò che è più odio-
so e rivelatore della società meridionale, sono altrettanti avvenimenti. Io
poi li conosco come uno conosce le marchese della commedia dell’Arte.
La Calabria è solo parzialmente la stessa terra, affascinante e
spaventosa, descritta in Itinerario italiano35
, la Calabria di Gioacchino
da Fiore, Francesco da Paola e Tommaso Campanella, di «torri di giu-
stizia e castelli di utopia»36
, perché «anche là», a San Luca, il nuovo
vescovo ha proibito le manifestazioni più spontanee della comunità,
come le feste e i riti superstiziosi. L’unico modo di ritornare sarebbe
prendendo di petto lo straniamento, viaggiare come «forestieri tutti e
due», dato che il terrore della «mezza civiltà meridionale, della falsa
intelligenza e cultura» immobilizza lo scrittore. Ritorna la stessa diffi-
denza, già espressa nel breve scritto di tanti anni prima, per
un’interpretazione fuorviante e limitata del «mestiere intellettuale»,
che si traduce in molti casi, in una «corsa verso l’impiego e il funzio-
narismo»37
: ecco un’altra tipologia di uomo meridionale, l’intellet-
tuale-burocrate, agli antipodi rispetto a quella dell’operaio (o dell’aspi-
rante tale) di Donnarumma all’assalto.
35 C. ALVARO, Itinerario italiano, Novissima, Roma 1933, poi ripubblicato da
Bompiani, Milano 1941, da cui si cita. 36 Ivi, p. 346. 37 Ivi, p. 353.
65
Dopo aver discusso del viaggio in progetto, Alvaro prosegue det-
tando i compiti del nuovo scrittore italiano:
La questione, per uno scrittore, è di capire l’Italia. Chi riesce ad aprire
davvero quella porta della conoscenza può aprire un’epoca della lettera-
tura italiana. Tanta letteratura italiana che immagina l’Italia come
l’Arizona o Parigi, fa compassione. Bisognerebbe davvero muoversi e
imparare.
Ma credo che la sua attrazione pei viaggi sia un desiderio di evadere.
Come posso consigliarla su un possibile lavoro che le permetta di vivere
a Roma o in provincia? In provincia non so se resisterebbe. Roma dà
una certa indifferenza, o apatia, per cui non si desidera di fuggire. E for-
se ci si può lavorare bene, domati i richiami delle giornate di sole, che
non è facile.
Capire l’Italia, lavorando nella capitale, la capitale di Vedute di
Roma, di un’«antinatura» artificiale «uscita dalla fantasia d’un arti-
sta», che «resta sempre quella città indifferente cui approdammo spau-
riti nella prima giovinezza»38
. È per Roma che passa la linea gotica di
Alvaro: «È l’intelligenza e la primitività italiana fermate tra due climi,
due civiltà, due mondi, due punti cardinali, settentrione e mezzogior-
no. Il sud vi si è pietrificato come in un profondo strato geologico, il
nord vi si libera dai geli»39
. Lo scrittore parte dalla propria esperienza
personale per dare consigli e mettere in allerta il giovane destinatario
dai pericoli del «cattivo dilettantismo»:
Ma quale lavoro? Io ho ormai trenta anni di vita letteraria, e mi trovo a
fare quello che ho sempre fatto: articoli pei giornali. Non c’è promozio-
ne. A un certo punto si vorrebbe fare un lavoro più complesso, più raffi-
nato, i libri. Ma tocca scriverli quasi di nascosto, come se si trovasse
qualcuno. La sostanziale disistima se non addirittura il dispetto degli e-
ditori verso la letteratura, dà al nostro lavoro un senso di cattivo dilet-
tantismo. Così ci si trova sempre daccapo e non c’è che da sperare di
38 Ivi, p. 15. 39 Ivi, p. 17.
66
poter risolvere questo impegno con la vita per qualche fortunata circo-
stanza. La quale potrebbe anche essere un periodo di difficoltà e di im-
pedimenti e di grave bisogno. Così accadde a me di continuare qualche
cosa tra il 1928 e il 1938, quando la politica mi proibiva di assumere un
qualsiasi posto fisso e retribuito e dovevo arrangiarmi a vivere allo stato
brado. Ma cominciare, in Italia, non è difficile. È difficile concludere,
difficile potersi dedicare a quei lavori di lunga pazienza che sono
dell’età matura.
Tra il ’28 e il ’38 datano in effetti alcuni dei libri più riusciti, co-
me Gente in Aspromonte (1930), L’uomo è forte (1938)40
, gli appunti
di viaggio dello scrittore come corrispondente in Germania per
«L’Italia Letteraria» (1929)41
, i resoconti delle esperienze in
Turchia42 e in Russia
43: Alvaro in poche righe abbozza un ritratto dello
scrittore da giovane, perennemente in viaggio, «allo stato brado».
Verso la fine della lettera l’intonazione si fa parenetica, un’esortazione
a sfruttare ogni occasione della vita (persino il giornalismo, «se si
hanno molte curiosità e molto da sciupare») e a non perdere tempo,
senza pensare che per produrre qualcosa di buono sia necessaria la
«pace di un chiostro»:
40 I romanzi e i racconti sono riuniti in C. ALVARO, Opere, a cura di G. PAMPALONI,
apparati di G. PAMPALONI e P. DE MARCHI, 2 voll., Bompiani, Milano 1990. 41 Ora riuniti in C. ALVARO, Scritti dispersi (1921-1956), introduzione di W.
PEDULLÀ, a cura e con postfazione di M. STRATI, Bompiani, Milano 1995, pp. 233-
282; e in ID., Colore di Berlino: viaggio in Germania, a cura di A.C. FAITROP-PORTA,
Falzea, Reggio Calabria 2001. 42 ID, Viaggio in Turchia, con 36 illustrazioni, Treves-Treccani, Tumminelli,
Milano-Roma 1932, ora ripubblicato da A.C. FAITROP-PORTA, Falzea, Reggio
Calabria 2003. 43 Dell’avventura sovietica sono testimonianza un nutrito gruppo di articolo
usciti su «Omnibus», «La Stampa» e «Mediterraneo» tra il ‘36 e il ’37, e il volume C.
ALVARO, I maestri del diluvio. Viaggio nella Russia sovietica, Mondadori, Milano
1935, ristampato nel ‘43 da Sansoni, Firenze e, con il titolo I maestri del diluvio.
Viaggio in Russia, per Memoranda Edizioni, Massa 1985, quindi riedito da A.C.
FAITROP-PORTA, Falzea, Reggio Calabria 2004.
67
Nelle sue condizioni, caro Ottieri, come fu già per me, bisogna accettare
quello che offre la vita, cioè il lavoro, che è il primo dovere verso di noi
e verso quelli di cui abbiamo la responsabilità. Costringere questo a far
sacrifici per la nostra letteratura è supremamente immorale e inumano.
Bisogna fare quello che la vita ci permette, poco o molto che sia, sapen-
done cogliere tutte le occasioni. Per me, il mio ideale è sempre stato di
poter lavorare in continuazione, per sentirmi ancorato alla necessità,
poiché disprezzo le arie dei poeti. So pure che certe arie di poeti na-
scondono il più esatto senso pratico, diventano uno strumento di difesa,
e solo allora questa suprema scaltrezza di animale della poesia mi piace.
Se si hanno molte curiosità e molto da sciupare, si può praticare il gior-
nalismo, ma sapendo che è il nemico più terribile, quello che una ma-
gnifica pezza di stoffa costringe a darla via a campioncini e scampoli.
Altrimenti, nel lavoro quotidiano, riuscire a mettere insieme quel tale
lavoro, quel numero di pagine, magari uno o due al giorno; farsi quel
piccolo patrimonio che dapprincipio sembrerà un giuoco puerile e di-
sperato, ma che a un certo punto parrà tirato fuori dal tesoro di famiglia.
Ma non mettere mai tra noi e il nostro lavoro quell’attesa, quella spe-
ranza di svegliarsi geniali un giorno, che fa naufragare molte intuizioni
e disposizioni. Non aspettare mai domani. Se si osa subito, il tempo di-
venta lungo.
Non finirei di darle suggerimenti, e tutti inutili. Uno solo mi pare neces-
sario; seguire la vita con pazienza, senza pretendere troppo, specie di
questi tempi testati [?], tenendo a mente che a volte le occasioni pratiche
offrono il destro a far quello che immagineremmo doversi fare nella pa-
ce di un chiostro.
Le rispondo con molto ritardo, e mi scusi. Ho scritto questa lettera a sue
spese, a distanza di giorni. Faccia tanti affettuosi saluti a Silvana. Cer-
chiamo di rivederci presto, e parleremo ancora dei viaggi, del lavoro. Il
mio libro avvenieristico sarà pronto, spero, a gennaio. È, poi, un libro
realissimo, soltanto in chiave di fantasia. Il libro di saggi uscirà
quest’inverno. Sto lavorando molto. È anche vero che la giovinezza è
passata e non mi restano che i duri e vecchi frutti dell’inverno.
68
Il «libro avvenieristico» è, con tutta probabilità, Belmoro44
, ro-
manzo incompiuto (e pubblicato postumo) ambientato su una Terra
post-atomica dominata da un Ordine Mondiale, mentre il «libro di
saggi» è Il nostro tempo e la speranza. Saggi di vita contemporanea45
;
quest’ultimo, cui sono affidate le riflessioni dello scrittore
sull’evoluzione dei costumi di una società alle prese con il capitalismo
e la tecnologia, fa da contraltare teorico al nucleo narrativo di Belmo-
ro: tutt’altro che «duri e vecchi frutti dell’inverno».
Il viaggio a San Luca con Alvaro fu un viaggio mancato46
. Ma un
altro Sud attendeva Ottieri da lì a pochi anni: Pozzuoli alias Santa Ma-
ria, pervasa da quella «luce idillica e liquida»47
che filtra anche dalle
vetrate della fabbrica sul mare.
44 C. ALVARO, Belmoro, a cura di A. FRATEILI, Bompiani, Milano 1957. 45 ID., Il nostro tempo e la speranza. Saggi di vita contemporanea, Bompiani,
Milano 1952. 46 Alvaro non farà più ritorno a San Luca. L’ultimo ritorno a casa fu in
occasione della morte del padre, nel ‘41, tratteggiato nella lirica eponima del volume
Il viaggio, Morcelliana, Brescia 1942, ora ripubblicato a cura di A. C. FAITROP-
PORTA, Falzea, Reggio Calabria 1999, pp. 165-170. 47 O. OTTIERI, Donnarumma all’assalto, in ID., Opere scelte, cit., p. 23.
69



























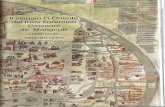




![Filippo Alison: un viaggio tra le forme [english texts only]_PRE-print](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63134e7c5cba183dbf070a2e/filippo-alison-un-viaggio-tra-le-forme-english-texts-onlypre-print.jpg)





