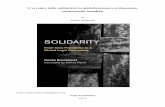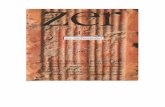Sistema Knoledge Based per la gestione visuale di un'apparato critico di un testo
osservatorio critico - germanistica.net
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of osservatorio critico - germanistica.net
Università degli Studi di Trento
OSSERVATORIO CRITICOdella germanistica
III - 8
OSSERVATORIO CRITICOdella germanistica
Ingrid Hennemann Barale, Luo-ghi dell’originario. Il tema dellinguaggio nella prospettiva sto-rica e nei progetti letterari delprimo romanticismo tedesco,Pisa, ETS, 1998, pp. 338, £.32.000
La discussione intorno aNovalis e il ruolo da luirivestito nel quadro dellaFrühromantik è stataspesso ostacolata, da noicome anche oltralpe, daun generico spiritua-lismo; anche se, conside-rando la situazione italia-na, contributi ben rigorosi sono stati appor-tati da Luciano Zagari. A questo punto, però,ci ritroviamo di fronte ad un’opera cui nonè esagerato riconoscere fortissimo rilievo:il titolo suona Luoghi dell’originario e l’au-trice è Ingrid Hennemann Barale, lagermanista che già aveva toccato la stessaarea storico-letteraria negli studi del volu-me Poetisierte Welt (1990).Non si può sfuggire, subito qui, alla neces-sità d’interpretare il frontespizio caricod’una densità semantica che ricorre poi lun-go tutto il libro, ma che ogni volta si scio-glie in un’eccezionale perspicuità e nitidez-za: “luoghi” può essere letto, infatti, con ri-ferimento a una geografia storico-culturalemolto vasta – si spazia dal testo sanscrito diSakuntala rivelato ai tedeschi da GeorgForster, all’intrico epistolare quale si infit-tì, al tempo di “Athenaeum”, tra Novalis e ifratelli Schlegel – oppure nell’accezione re-torica di coincidenze o emergenze innume-revoli, topoi, appunto di un “originario”,cioè di una dimensione linguistica assolu-ta, anteriore a qualsiasi finalità denominan-te e descrittiva (“la ricerca – come dichiara
la stessa Hennemann –ha preso le mosse dalontano e ha documen-tato come la progressi-va consapevolezza del-la crescente divarica-zione fra strategie lin-guistiche funzionali alleistanze classificatorie di
un’intelligenza rappresentativa o esposizio-ne obbiettivante e quel sottinteso di ognicomunicazione attraverso segni che è la vo-lontà di rendere l’altro partecipe di una me-desima esperienza, debba considerarsi unodei tratti caratteristici della cultura moder-na, riconoscibile in tutti i suoi principali in-dirizzi, nelle tematiche filosofico-linguisti-che e poetologiche di matrice empiristica erazionalistica non meno che in voci appa-rentemente isolate, come quella di Vico”).Risulta, d’altronde, più esplicito il sottoti-tolo che indica come oggetto della riflessio-ne critica “il tema del linguaggio nella pro-spettiva storica e nei progetti letterari delprimo romanticismo tedesco”; che, dunque,suggerisce una forte dicotomia, interna allagenerazione di “Athenaeum” ma decisivaper gli sviluppi successivi, tra la direzioneimpegnata al raggiungimento di quella “lin-gua perfetta” che era stata idealizzata come“adamica” e la ricerca di ciò che, con am-mirevole precisione terminologica,Hennemann definisce, guardando allaFrühromantik e comparando l’apporto teo-rico e storiografico degli Schlegel alla
2OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
OSSERVATORIO CRITICOdella germanistica
creatività di Novalis, “l’ipotiposi simbolicae la funzione mitopoietica della poesia”.Tale dicotomia, espressa nel testo dallacontrapposizione della prima parte del vo-lume sostanzialmente d’ambito storico-fi-losofico (anche con affondi verso l’antichi-tà classica – soprattutto verso Platone – e ildibattito medievale e rinascimentale) e laseconda parte dedicata alla caratterizzazio-ne della poetica novalisiana quale forte pro-posta di sintesi integrativa, risulta poi op-portunamente ricomposta e riconciliata neicapitoli finali, laddove si tratta felicementeormai di interpretare sezioni e pagine deidue romanzi intrapresi da Novalis a quelvertice della ricerca cui pose fine la morte.Man mano che dalle considerazioni teori-che il libro viene avvicinandosi allaInterpretationskunst, colpisce la circostan-za che siano costantemente citazioni dai te-sti di Novalis ad alimentare il ritmo serratodel discorso e che, all’opposto, grazie al-l’ingenuità e alla freschezza di una vera epropria passione letteraria si ritorni da quelleallo scavo sottile della pagina. Al propositovale forse la pena di citare qui un passonovalisiano singolarmente espressivo diquella “Chiffrenschrift” in cui Novalis iden-tificava una sorta di lingua geroglifica delsuo universo pluridimensionale; e prendereatto di quella coerenza con la quale questorilevamento, adibito a spiegazione delloslancio iniziatico dei Lehrlinge zu Sais, ri-sulti funzionale al topos della ricerca del“vero volto della vergine velata”: “figure chesembra appartengano a quella grande scrit-tura cifrata che si vede dappertutto, su ali,gusci d’uovo, nubi, neve, in cristalli e for-me di roccia, su acque che si stanno conge-lando, all’interno e all’esterno delle mon-tagne, delle piante, degli animali, degli uo-mini, nelle luci del cielo, nelle lastre di pecee vetro toccate e strofinate, nelle limatureintorno alla calamita e nelle strane combi-nazioni del caso”.
Aprendo la propria interpretazione a venta-glio sulla serie dei topoi fondamentali delsuggestivo e più grandioso esperimento nar-
rativo, Heinrich von Ofterdingen, Henne-mann realizza poi interventi che associanoalla finezza di lettura la capacità di coglierevarianti anche innovatrici rispetto alla tradi-zione esegetica. E dunque è opportuno chesi segnali qualche altro caso del genere.Circa i due episodi onirici in apertura delromanzo – il sogno del protagonista e quellodel padre – troviamo che il parallelismo con-venzionalmente riscontrato nella coppia,dopo essere stato apparentemente giustificatoda principi generali (“il sogno, in quanto tale,è da sempre simbolo di un sapere inziatico,e ciò per due motivi almeno: perché è un la-sciarsi guidare, un disporsi a procedere oltrese stessi, sospendendo le abituali autodifese,l’abituale autodisciplina e, dunque, gli abi-tuali confini della propria esistenza in mez-zo agli altri; e perché l’esperienza a cui contale sospensione ci si libera è un vedere percifre allusive, per simboli enigmatici che rin-viano a quanto resta normalmente occultatonella diaspora dell’esistenza quotidiana”),viene respinto – e questa è una novità im-portante rispetto ai commenti in circolazio-ne – per mettere in evidenza valori semanticie ideologici opposti ravvisando nel primol’annuncio del processo positivo verso lapoesia e nel secondo, invece, il ripiegarsi diun ruolo artistico, inizialmente auspicato,nell’opacità d’una quotidiana attività d’arti-giano.In modo analogo tutta questa parte finale dellibro approfondisce una serie di situazionidecisive: la contemplazione della “blaueBlume” (“il suo specifico significato puòesserci restituito solo approssimativamentedal complesso di idee che simbolicamenteaccorpa e che, a loro volta, sarebbe azzarda-to e improprio ricondurre a quei significaticon cui al medesimo simbolo furono asso-ciati in precedenti e più tradizionali conte-sti”); l’incontro con i mercanti nel viaggioverso Augusta; il commiato da Zulima, lagiovane orientale strappata alla sua terra conla ferocia dei crociati (serve a indicarel’Oriente, come “patria arcaica della poesia:una patria da cui le vicende storiche ci han-no separati”); e naturalmente, con proposte
3OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
ancora più intense, il grande Märchen cheoccupa il finale della prima parte e che giàZagari, in Mitologia del segno vivente(1985), aveva magistralmente illustrato.In sintesi, Hennemann riconduce questadifficile e dolorosa maturità di Novalis al-l’istituzione di un linguaggio utile, sempli-cemente e utopicamente, alla rappresenta-zione di ciò che si definisce qui “il caosragionevole” di un universo affidato auda-cemente alla poesia: un inevitabileossimoro, quale associazione e, insieme,conflitto della speculazione storico-ideolo-gica e dell’entusiasmo esegetico, sigilla cosìun lungo impegno e una chiara felicità dilettura.
Giorgio Cusatelli
Sprachbewahrung nach der Emigration. –Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. TeilI: Transkripte und Tondokumente. Hrsg.Anne Betten unter Mitarbeit von SigridGraßl (= Bd. 42 der Reihe Phonai/Text undUntersuchungen zum gesprochenenDeutsch, Tübingen 1995, VIII + 449 S.);zusätzlich CD mit 38 Originalaufnahmen.
Sprachbewahrung nach der Emigration. –Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. TeilII: Analysen und Dokumente. Hrsg. AnneBetten und Myriam Du-nour unterMitarbeit von Monika Dannerer (= Bd. 45der Reihe Phonai/Text und Untersuchungenzum gesprochenen Deutsch, Tübingen2000, XV + 481 S.); zusätzlich CD mit 41Originalaufnahmen.
Wir sind die Letzten. Fragt uns aus. –Gespräche mit den Emigranten derdreißiger Jahre in Israel. Hrsg. Anne Bettenund Myriam Du-nour unter Mitarbeit vonKristine Hecker und Esriel Hildesheimer(Bleicher, Stuttgart 1995, 456 S.).
Il vasto progetto di ricerca della linguistaAnne Betten, finanziato dalla DeutscheFoschungsgemeinschaft e dall’Università di
Eichstätt, si è svolto tra il 1989 e il 1995.Betten e le sue collaboratrici hanno condot-to un’indagine linguistica empirica in Israe-le tra gli immigrati di madrelingua tedescaancora viventi, nati tra il 1892 e il 1933.Circa 200 soggetti hanno reagito ad annun-ci pubblicati nell’autunno 1989 sulle dueriviste in tedesco di Israele, dichiarandosidisposti a essere intervistati. Le interviste,condotte da Anne Betten, Myriam Du-nour,Kristine Hecker e Eva Eylon (lei stessa sog-getto di un’intervista) si sono svolte comecolloqui con i singoli soggetti, della duratadi diverse ore, e sono andate avanti fino al1994. L’insieme delle registrazioni e dei te-sti trascritti ha preso il nome di Israel-Corpus.Il corpus raccoglie la lingua tedesca parlatadegli anni Venti e Trenta, con esempi deipaesi di lingua tedesca e di diverse aree del-la Mitteleuropa. I risultati della ricerca sonoraccolti nei volumi pubblicati rispettivamen-te nel 1995 (Phonai 42) e nel 2000 (Phonai45), che si presentano decisamente come unapubblicazione scientifica, e comprendono letrascrizioni di 254 registrazioni di intervi-ste a 121 soggetti. A ogni volume è acclusoun CD con 38 registrazioni, grazie alle qua-li è possibile ascoltare concretamente nellavitalità della lingua parlata questi importan-tissimi documenti.Wir sind die Letzten. Fragt uns aus si rivol-ge invece ad un pubblico più ampio; già iltitolo, citazione di un verso dell’omonimapoesia di Hans Sahl, ebreo tedesco emigra-to in America, vuole essere un richiamo alpotenziale di memorie ancora vive, ma trop-po spesso ignorate. Questo vale soprattuttoper gli ebrei di madrelingua tedesca emigratiin Israele, che a tutt’oggi sono stati intervi-stati di rado, e comunque assai più tardi chenon, per esempio, quelli emigrati negli USA(cfr. p.es. Hempel 1986). In effetti, bisognaconsiderare che l’emigrazione in Israelecostituisce una situazione del tutto partico-lare, in quanto, come ricorda anche AnneBetten nell’introduzione, Israele è l’unicopaese in cui non si parla mai di emigrazio-ne, ma sempre di immigrazione, a cui anzi è
4OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
stato dato il nome di ‘ascesa’ (Aufstieg, inivrit alija) nella ‘terra dei padri’, la Palesti-na, dal 1948 lo stato di Israele, dove hannotrovato rifugio almeno 55.000 ebrei di lin-gua tedesca. Più che in ogni altro paese, inIsraele è stato essenziale costituire, insie-me agli ebrei di altra provenienza, una nuo-va entità linguistica e culturale, e per farquesto era necessario, per un verso alme-no, congedarsi da quella Sprach- undKulturheimat in cui si era nati e cresciuti.Mentre entrambi i volumi usciti nel 1995costituiscono – sia pure con taglio diverso– una raccolta di materiale e di storie di vita,il volume Phonai 45 del 2000 è dedicatoessenzialmente all’analisi. In tutti i volumiil contenuto delle interviste è ordinato insezioni, che raggruppano per temi affinibrani delle singole storie di vita: la vita pri-ma dell’emigrazione, l’emigrazione, il nuo-vo inizio in Palestina, la cultura tedesca,quella ebraica e quella israeliana (compren-dente anche la questione dell’identità e ilproblema della lingua), i rapporti con ilpaese di provenienza. Come ha sottolinea-to anche Siegfried Grosse nel suo articolorelativo a Phonai 42 (Grosse 1996), l’ope-razione di taglio e montaggio per temi è una“tecnica sensata” per un libro destinato adun vasto pubblico, per evitare l’effetto dinoia che potrebbe insorgere in una letturain serie di resoconti di vita integrali. Peròcosì vanno inesorabilmente perdute deter-minate sottolineature delle singole storie divita, cancellate come brani ritenutiininfluenti alla ricerca. A mio parere, que-sta critica vale non solo per il volume dellacollana Phonai, ma anche per quello editoda Bleicher, in quanto alcune dichiarazionidiventano comprensibili appieno solo nel-la prospettiva dell’intero percorso di vita.Le esistenze di tutte queste persone sonostate segnate in modo indelebile dalla “sto-ria oggettiva”, cosicché si possono rintrac-ciare molti punti in comune, benché tra isingoli destini si possano segnalare anchenotevoli differenze. Infatti, le persone (pe-raltro, molte sono da considerarsi persona-lità note, come si può desumere leggendo
le brevi biografie accluse alla fine) hanno allespalle diverse situazioni, attività, lavori, equesta stessa varietà si rinviene anche nelmodo di reagire agli avvenimenti drammati-ci, anche se per lo più stupisce la flessibilitàcon cui questi sono stati affrontati. La forzad’animo e la vitalità di queste persone sonosorprendenti, come straordinaria è anche lalingua in cui raccontano – a proposito, utilis-simo è il glossario dei termini yiddish. Seb-bene le narrazioni siano esempi di linguaparlata spontanea, Betten rileva in primo luo-go un ricorso a modelli di costruzioni tipicidella lingua scritta maggiore che non nel te-desco standard attuale, quindi un orientamen-to ben percepibile alle norme linguistiche, sututti i piani, infine un notevole controllo nel-la gestione di costruzioni lunghe e ad inca-stro, con molte frasi secondarie, inserti, ag-giunte, realizzate per lo più senza vistosianacoluti o interruzioni. Per questi fenome-ni, Betten dà una motivazione strettamentelinguistica: tutti questi parlanti non avrebbe-ro potuto far propri quei radicali mutamentiverificatisi nella lingua tedesca a partire dal1945 e che per quanto riguarda la lingua par-lata vanno indubbiamente verso una sempremaggiore distanza dalla norma linguistica (ri-cordo qui che alle analisi più prettamente lin-guistiche è dedicato il volume Phonai 45, chetratterò più sotto). Per parte mia, vorrei quiavanzare anche un’ulteriore interpretazione,collegata strettamente con la complessa bio-grafia linguistica degli intervistati. Per lamaggior parte dei soggetti, il passaggio daltedesco all’ebraico moderno (ivrit), non è sta-to privo di difficoltà. Senz’altro questo haavuto a che fare con la grande diversità traqueste due lingue, ma anche con leattribuzioni psichiche di cui un parlante puòcaricare le lingue sulla base delle sue espe-rienze vissute o anche di quanto letto o im-parato (a questo riguardo sono estremamen-te interessanti gli studi di psicoanalisti sullasituazione di persone bi- e trilingui dopol’emigrazione; in Israele ricerche di questotipo sono state condotte per esempio daEmmanuel Vélinowsky; cfr. Mehler/Argen-tieri/Canestri 1990). Soprattutto, però, tutto
5OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
questo complesso va ricondotto al signifi-cato culturale, e cioè simbolico, che le duelingue assumono per le persone. Bisognaqui ricordare che Israele non si poteva iden-tificare con un’unica lingua e con una cul-tura omogenea, nemmeno con lo yiddish,parlato da moltissimi immigrati dell’Euro-pa orientale. Nella maggior parete dei casinon si è trattato solo di “conquista” dellaterra di Israele, ma anche della “riconquista”delle radici dell’ebraismo, perché spessoqueste non erano più presenti, e dovevanoinvece costituire la base comune di questostato dove i cittadini avevano le provenien-ze più disparate. Anche per questo è inte-ressante seguire come individui abituati adun’elevata dose di individualismo siano riu-sciti ad accettare la vita in comune neikibbutzim, e, più in generale, come abbia-no vissuto il maggiore orientamento versola collettività. Indubbiamente è qui che bi-sogna ricercare almeno uno dei motivi chehanno portato l’ebraico, per secoli rimastolingua scritta, a ridiventare lingua parlatacome ebraico moderno (ivrit).In questa costellazione specifica, meritasottolineare un altro elemento tra quelli chehanno trovato un’espressione linguisticanelle biografie, vale a dire il profondoradicamento degli ebrei di lingua tedescanella lingua e nella cultura tedesche, tantoche proprio questo gruppo – così si rilevadalle interviste – ha provato forse le mag-giori difficoltà a imparare l’ebraico; è veroche ufficialmente “non si può parlare di unacampagna contro il tedesco, quanto piutto-sto per l’ivrit” (Paul Alsberg), tuttavia il te-desco viene considerato “lingua nazista” edi conseguenza vengono smantellate le re-dazioni delle riviste in lingua tedesca. Gliebrei di lingua tedesca si sono trovati cosìin una situazione paradossale, in quantosono stati costretti a separarsi dalla loro pri-ma lingua, non da una lingua qualunque,ma proprio dalla lingua materna, che è ma-trice del sentire, della comunicazione e del-l’agire simbolico (a riguardo cfr. le nume-rose autobiografie di ebrei di lingua madretedesca, costretti all’emigrazione, per esem-
pio Ursula Hirschmann (1993); Ruth Klüger(1992)). L’elaborazione di questo processoha condotto a situazioni di bi- e plurilin-guismo molto eterogenee, in parte sentitecome fonte di arricchimento, in parte comefonte di insicurezza. Alcuni immigrati han-no intenzionalmente cancellato la culturatedesca, altri riescono a giungere ad una sin-tesi, problematica, ma anche feconda, conla nuova realtà. Diverse sono anche le rea-zioni in funzione dell’età degli intervistati,anche perché in genere per le generazionipiù giovani gli ostacoli linguistici sono statimeno ardui. Per molte persone la linguamaterna rappresenta la continuità nel corsodella propria vita, tanto che per alcuni haanche portato alla creatività linguistica.Questo elemento emerge con particolarechiarezza collegato alla questione dell’edu-cazione dei figli e di quale lingua parlarecon loro, dove molti intervistati hanno di-mostrato una notevole sensibilità a favoredella trasmissione della propria lingua ma-terna: “Mit den Kindern muß man die besteSprache sprechen, und das ist die Mutter-sprache” (Elsa Sternberg). Dalle intervistediventa chiaro che la questione non si fer-ma alla lingua, ma comprende anche la tra-smissione culturale in senso lato, vista come“ponte”, per esempio con i rinnovati con-tatti con i paesi di lingua tedesca e i loroparlanti.La seconda parte del progetto di ricerca,uscita quest’anno (Phonai 45), dà un’ulte-riore conferma al fatto che seguendo il temadella lingua si possono toccare punti chiavedei diversi percorsi di vita. Mentre Phonai42 era dedicato essenzialmente alle trascri-zioni dei documenti registrati, in questo se-condo volume sono raccolti i brani relativial tema della lingua, accompagnati daun’analisi linguistica dei documenti. Que-sta seconda parte più prettamente linguisti-ca è co-edita da Anne Betten e da MyriamDu-nour, visto che dal 1991 la linguista i-sraeliana segue il progetto insieme a Betten.La sezione tematica presenta tutti i branisignificativi dove è rilevante la questionedella lingua. Questi testi sono via via incen-
6OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
trati sulla lingua (o lingue) parlata nella casadei genitori in Europa, sull’uso linguisticonel privato e quindi durante la fase di istru-zione/formazione e di lavoro in Palestina/Israele, infine sul confronto a propositodell’attuale padronanza e uso delle diverselingue e la valutazione soggettiva della pa-dronanza delle varie lingue usate. Anchea questo volume, come già per il Phonai 42,è accluso un CD, che non è solo documen-tazione viva, ma serve anche come strumen-to per ulteriori indagini scientifiche.La particolarità di questi brani è la peculia-re combinazione di elementi già apparte-nenti alla storia della lingua con altri dellalingua contemporanea. La lingua parlata daisoggetti intervistati è infatti un tedesco par-lato attualmente al di fuori dell’area lingui-stica tedesca, ma che essenzialmente rap-presenta il tedesco parlato negli anni Ventie Trenta nei diversi paesi di lingua tedescae nell’Europa centrale e orientale. In que-sto modo si presenta una delle rare possibi-lità di studiare il cambiamento linguisticonella lingua parlata sulla base di materialeautentico. Ricordo che mentre per il tede-sco contemporaneo a partire dagli anni Set-tanta viene approntata una serie di corpustestuali anche per la lingua parlata, primadi quest’epoca per la lingua parlata sponta-nea non esiste alcuna documentazione. Pro-prio per questo bisogna riconoscere all’I-srael-Corpus un’importanza fondamentale,perché riesce a dare e conservare esempiper una lingua che né in Germania né inaltri paesi dell’attuale area linguistica tede-sca viene più parlata in questo modo. Comegià detto, questo viene messo in relazionecon il radicale cambiamento che al più tar-di con la fine della seconda guerra mondia-le ha riguardato la lingua tedesca, sia nel-l’uso scritto che in quello orale, e che si puòriassumere come un’apertura verso il par-lato. Peter von Polenz (1989), ripercorrendole diverse tappe dal tedesco moderno a quel-lo contemporaneo, nota che se inizialmen-te (dal 1770) si può parlare di “affermazio-ne della lingua della borghesia colta”, quin-di (dal 1870) di “affermazione della lingua
standard moderna”, per il tedesco attuale sideve invece parlare di “evoluzionepolicentrica”. Con questa formula si intendeuno sviluppo che non innalza a modelloun’unica forma linguistica, ma che invececonsente una varietà di forme diverse. Il ma-teriale qui raccolto sul tedesco degli anni Ven-ti attualmente parlato in Israele è ecceziona-le anche perché permette di seguire nellavividezza della lingua parlata processi di sto-ria della lingua e di sociolinguistica. Questotedesco, che è da considerarsi rappresentati-vo della lingua parlata dalla borghesia coltaprima dell’avvento del nazismo, è quindiun’inestimabile espressione della cultura ora-le dell’ebraismo tedesco degli anni Venti.Anne Betten aveva formulato la sua tesi prin-cipale già nel primo volume Phonai, cioè chein tutti gli intervistati sia ben percepibile unchiaro orientamento alle norme linguistiche,su tutti i piani della lingua:“Nicht nur in Phonetik und Morphologie istbei den meisten eine starke Ausrichtung ander Hochsprache zu registrieren […].Besonders auffällig […] ist jedoch der hoheGrad syntaktischer Normorientierung bei denmeisten Sprechern. […] Noch erstaunlicheraber ist, mit welcher Disziplin diejenigen, diein langen, verschachtelten Konstruktionenmit vielen Nebensätzen, Einschüben, Nach-trägen u.ä.m. sprechen” (Betten 1995:5).
Devono essere stati proprio questi due aspet-ti a far scegliere ad Anne Betten una frase diuno degli intervistati, Joseph Walk, come ti-tolo per la sua introduzione ai saggi conte-nuti in questo secondo volume: “Vielleichtsind wir wirklich die einzigen Erben derWeimarer Kultur”. Nel suo contributo AnneBetten fornisce ancora una volta importantiinformazioni sulle situazioni delle varie in-terviste, per poi passare in rassegna, semprericca di dettagli, i singoli contributi, che ri-guardano in particolare questioni di sintassidella lingua parlata e i tipici fenomeni delplurilinguismo, come il code-switching e leinterferenze. Betten avvalora la sua tesi sullepeculiarità linguistiche del corpus israelianonella sua analisi relativa a “Satzkomplexität,
7OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
Satzvollständigkeit und Normbewußtsein”dei testi delle persone intervistate. Altri con-tributi, analizzando determinati elementidella lingua del corpus, in generale confer-mano il notevole orientamento degli inter-vistati alla norma degli anni Venti, come peresempio quelli di Andreas E. Weiss su“Satzverknüpfungen in erzählendenPassagen des Israel-Corpus”, di ChristianAlbert sulla ripresa di frasi dopo insertiparentetici o di Astrid Kossakowski sulleinterruzioni di frasi, una caratteristica tipi-ca della lingua parlata, ma che in questocorpus israeliano ricorre con estrema rari-tà.Il contributo di Peter Mauser è in relazionecon questo gruppo di studi, in quantoMauser, analizzando la morfologia flessio-nale dei brani, ritiene che gli intervistati siorientino alle norme della lingua scritta.Questo di Mauser costituisce il passaggioal (secondo) articolo di Miryam Du-nour,in chiave sociolinguistica e di linguistica dicontatto, dedicato a “Sprachenmischung,code-switching, Entlehnung und Sprach-interferenz”, dove Du-nour si occupa inparticolare degli influssi dell’ivrit e dell’in-glese sul tedesco dell’Israel- Corpus israe-liano.Estremamente interessante è il primo sag-gio di Miryam Du-nour contenuto nel vo-lume Phonai 45, “Sprachbewahrung undSprachwandel unter den deutschsprachigenPalästina-Emigranten”, in cui sono conte-nute anche preziose informazioni sullo svi-luppo dell’ivrit.In questo secondo volume sono da rilevarequindi due contributi che rispetto agli altrihanno un orientamento leggermente diver-so: si tratta dei saggi di Maria Gierlinger eClaudia M. Riehl, in cui le autrici sulla basedi analisi puntuali di alcuni brani elaboranouna serie di interessanti riflessioni sulla tec-nica narrativa dei racconti. Il primo, quellodi Maria Gierlinger, vuole mettere in luce ifattori che concorrono a creare l’impressio-ne di vividezza di questi racconti. Questosaggio assume particolare valore soprattut-to se si pensa che la tesi principale su que-
sto corpus di testi afferma che questi par-lanti dimostrano un forte orientamento allanorma linguistica. In genere, nella linguaparlata la vivacità dell’espressione vieneprodotta con una serie di elementi lingui-stici considerati indicatori tipici della lin-gua della vicinanza (Sprache der Nähe),distinti da quelli tipici della lingua della di-stanza (Sprache der Distanz; a proposito diquesta differenziazione, cfr. Koch/Oesterreicher). Nella sua analisi dell’orga-nizzazione narrativa dei testi, Gierlingerosserva come, nonostante la lingua comples-sa ed elaborata, l’interazione di espressionimetacomunicative, cambi di prospettiva,ricchezza di dettagli, descrizione scenica,diano comunque luogo ad un’impressionedi vicinanza, nel senso di “lingua della vi-cinanza”. Da questo trae la conclusione chei modelli di organizzazione del racconto fi-nora elaborati dalla ricerche di linguisticatestuale sulla narrazione debbano essereulteriormente sviluppati e precisati; lo stes-so vale a suo parere per la tradizionale sud-divisione delle forme del discorso in testinarrativi, argomentativi ed espositivi.Claudia M. Riehl, sulla base di studi dipsicolinguistica e di psicologia della memo-ria, cerca di decifrare l’affascinante relazio-ne tra racconto autobiografico e memoriaautobiografica. Riehl, analizzando le diffe-renze tra diverse versioni di uno stesso rac-conto autobiografico, trova conferma delfatto che nella memoria biografica i singoliepisodi sono ordinati in una successionecronologica, scandita gerarchicamente, dieventi di maggiore durata (extended eventtime line). Gli episodi puntuali si ricordanomeglio se si possono collegare a dei filonidegli eventi di lunga durata, e soprattutto sehanno poi causato cambiamenti decisivi peril successivo corso della vita. Riehl notaquindi che, nel richiamare alla memoria leesperienze, un ruolo determinante è svoltodalle componenti affettive, che trovanoespressione in particolare a livello lessicale.Questo è particolarmente evidente in casiestremi, quando la forte marcatura affettivapuò portare ad identiche formulazioni nelle
8OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
due versioni. In questi processi un ruolofondamentale è quello dell’espressione de-gli affetti, che principalmente si verifica sulpiano lessicale e che può anche far sì chenel ri-racconto dello stesso episodio si ven-ga a ripetere letteralmente la medesima for-mulazione.Le analisi contenute in questo secondo vo-lume di Phonai fanno emergere una serie diinteressanti desiderata della ricerca, peròsono sicura che questo Israel-Corpus è an-cora ben lontano dall’esaurire tutti i suoipreziosi impulsi.In questa mia recensione prevalgono l’aspet-to della presentazione e un tono affermati-vo nei confronti dell’opera. Mi rendo contoche ciò non corrisponde allo stile critico cuici ha abituati l’“Osservatorio”. Sono peròfelice di poter rompere questa tradizione,perché la presentazione dell’“Israel-Corpus”e la sua analisi, oltre a rappresentare un ec-cezionale connubio tra ricerca diacronica esincronica, ha un valore culturaleincommensurabile. In tutte le interviste èevidente che è stato dato molto valore pro-prio all’ascolto delle storie che venivanoraccontate, non solo alla registrazione di un“endangered language”. Proprio qui vedol’eccezionalità del progetto di Anne Betten:alla persona intervistata viene dato spazioper trasmettere la propria identità linguisti-ca, al lettore (soprattutto di lingua tedesca)viene data l’opportunità di un confrontomolto vivo con il passato.
Bibliografia
J. Amati Mehler, S. Argentieri, J. Canestri,1990, La Babele dell’Inconscio – Linguamadre e lingue straniere nella dimensionepsicoanalitica, Milano (Cortina).S. Grosse, 1996, “Aus der Muttersprachekann man nicht emigrieren” in: Zeitschriftfür Germanistische Linguistik 24, pp. 80-87.H. J. Hempel (Hrsg.), 1984, Wenn ich schonein Fremder sein muß… Deutsch-jüdischeEmigranten in New York (1986) Frankfurt-Berlin-Wien (Ullstein).
U. Hirschmann, 1993, Noi senzapatria, Bo-logna, il Mulino.R. Klüger, 1992, Weiterleben. Eine Jugend.Göttingen (Wallstein) (trad. it. Vivere anco-ra, Torino (Einaudi)).P. Koch/W. Oesterreicher, 1985, “Sprache derNähe - Sprache der Distanz. Mündlichkeitund Schriftlichkeit im Spannungsfeld vonSprachtheorie und Sprachgeschichte”, in:Romanistisches Jahrbuch 36, pp. 15-43.P.v. Polenz, 1989, “Das 19. Jahrhundert alssprachgeschichtliches Periodisierungs-problem”, in: D. Cherubim/K.J. Mattheier(Hrsg.), Voraussetzungen und Grundlagender Gegenwartssprache. Sprach- undsozialgeschichtliche Untersuchungen zum 19.Jahrhundert, Berlin/New York (de Gruyter),pp. 11-30.P. Wagener / K.-H. Bausch, 1997,Tonaufnahmen des gesprochenen Deutsch.Dokumentation der Bestände vonsprachwissenschaftlichen Forschungs-projekten und Archiven, Tübingen (Nie-meyer).
Eva Maria Thüne
Elena Agazzi, Il corpo conteso. Rito egestualità nella Germania del Settecento,Milano, Jaca Book, 2000, pp.383, £. 38.000
Tutto il Settecento può essere letto come unariscoperta dell’individualità e quindi anchedell’essere umano in quanto totalitàpsicofisica. In contrasto con la focalizzazionedell’attenzione sulla sola res cogitans propriadel razionalismo cartesiano, le nuove scien-ze del Secolo dei Lumi, quali ad esempiol’estetica, la psicologia empirica, la moder-na storiografia ecc., rivalutano proprio il ruolodella res extensa, ovvero della “corporeità”dell’uomo, tanto come oggetto che come stru-mento di conoscenza. Per questo motivol’“antropologia”, in quanto scienza del“commercium mentis et corporis”, può esse-re considerata a ben vedere come la scienzamadre e il minimo comune denominatore di
9OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
tutte le nuove scienze dell’epoca. Lo stes-so interesse per la “gestualità” ovvero perla “mimica”, in quanto espressione corpo-rea di moti interiori dell’anima, rientra evi-dentemente in questa tendenza genera-le.In questo senso, dunque, il titolo del librodi Elena Agazzi appare assolutamente plau-sibile, visto che allude all’interesse dellevarie discipline che durante il XVIII seco-lo si occuparono del corpo dell’individuo esembrarono quasi contendersi il loro ogget-to. Il rinvio alla “gestualità” presente nelsottotitolo specifica d’altra parte un ambi-to particolare di questo interesse, mentreinvece il riferimento al “rito” rimanda aquella nuova apertura delle scienze lettera-rie verso l’etnologia, che è caratteristica dialcune tendenze critiche degli ultimi annisoprattutto negli Stati Uniti. Questo lavorosembra dunque inserirsi innanzitutto in quelfondamentale filone di ricerca dellaGermanistica, che a partire dalla fine deglianni Settanta si è occupato con importantirisultati degli influssi dell’antropologia sudiversi aspetti della letteratura del Settecen-to (cfr. ad es. il “Forschungsbericht” di W.Riedel, Anthropologie und Literatur in derdeutschen Spätaufklärung, JASL, 6.Sonderherft, Tübingen 1994, pp. 93-157).In realtà, però, non vi è traccia di tutta que-sta discussione ventennale della Germa-nistica nel lavoro in questione. Il libro diHans-Jürgen Schings Melancholie undAufklärung, che è stato per alcuni versi l’ini-ziatore e il capostipite di questo interesseper l’antropologia, viene ricordato solo disfuggita in riferimento ai “precetti delPietismo volti a sollecitare l’ascesi e la dietasia fisica che psichica” (p. 257, nota 75),mentre non vi si accenna nemmeno parlan-do del “corpo melanconico” di Aurelie odella “schöne Seele” nel Wilhelm Meister(cfr. pp. 252 sgg.). Manca anche qualsiasiallusione al grande simposio organizzatosempre da Schings su Der Ganze Mensch.Anthropologie und Literatur im 18.Jahrhundert, nonché ai numerosi testi sul-la “literarische Anthropologie” e in parti-
colare sul rapporto tra antropologia e roman-zo del XVIII secolo comparsi negli ultimiquindici anni.Questa assoluta ignoranza del discorso cri-tico degli ultimi vent’anni sul rapporto traantropologia e letteratura si riflette anchesulla conoscenza dei testi primari e in gene-rale della problematica stessa del discorsoantropologico. Solo in un unico punto dellibro Agazzi fa riferimento al medico JohannGeorg Zimmermann e ricorda quindi deifantomatici “Psychomediziner di Halle”, iquali “avevano approfondito le ricerchesull’ipocondria e sulla melanconia” (p. 254).A parte il fatto che il termine “Psycho-mediziner” risulta non solo inappropriato,ma quasi derisorio e canzonatorio – cosìpotrebbero venir chiamati oggi probabil-mente gli studenti di psichiatria dai lorocolleghi di medicina o di psicologia –, poi-ché all’epoca si parlava di “philosophischeÄrzte” e lo stesso termine “Psychologie”aveva un significato ben diverso da quellomoderno, Agazzi avrebbe potuto trovare si-curamente molte più notizie suZimmermann e sui “medici filosofici” del-l’epoca nel libro di Schings sulla malinco-nia o anche in quello del suo allievoWolfgang Riedl sulla Anthropologie desjungen Schillers, che pure viene ricordatoalmeno una volta in nota (p. 247, nota 55).Non è dunque un caso, se l’autrice del volu-me non riesce mai a cogliere l’aspettoprettamente antropologico che sta a fonda-mento di tutte le riflessioni dell’epoca sulproblema dell’“azione”, della mimica e dellagestualità, incorrendo così in numerosifraintendimenti. Ciò è evidente, ad esem-pio, nell’analisi dell’opera di BlanckenburgVersuch über den Roman, che rappresenta,come noto, una sorta di fissazione teoricadei principi fondamentali del “romanzo an-tropologico”, il quale aveva trovato la suamassima espressione nell’Agathon diWieland. Tutte le caratteristiche cheBlanckenburg ascrive al nuovo genere let-terario del romanzo – la rappresentazionedell’interiorità del personaggio e del suosviluppo, il rapporto di causalità che deve
10OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
legare non solo le azioni, ma anche l’influs-so delle circostanze esteriori ai moti del-l’animo e alle conseguenti azioni ecc. – nonsono in fondo altro che l’espressione im-mediata di quella problematica fondantedell’antropologia che è il commerciummentis et corporis. Non conoscendo peròquesta problematica, Agazzi giunge para-dossalmente a rinfacciare a Blanckenburgdi non fornire “ancora strumenti sufficientialla [...] più naturale caratterizzazione insenso antropologico” del personaggio (p.125) proprio dopo aver riassunto sullafalsariga di Lämmert le caratteristiche sa-lienti del romanzo antropologico.Il vero problema della teoria del romanzodi Blanckenburg, e quindi anche del “roman-zo antropologico”, non è rappresentato dal“dilemma tra creazione e rappresentabilitànel romanzo”, di cui parla il titolo di questosottocapitolo, bensì piuttosto da quella con-traddizione già da tempo riconosciuta dallacritica (che Agazzi però mostra di non co-noscere), tra il carattere necessitante delprincipio causale che domina il romanzo ela sua prospettiva finalistica, con la promes-sa di una soluzione armonica dell’evoluzio-ne del personaggio (cfr. ad es. il capitolodedicato all’Agathon in Werner Frick,Providenz und Kontingenz, oppure Schings,Der anthropologische Roman ecc.). Proprioperché non capisce il fondamento della teo-ria di Blanckenburg, Agazzi pretende da luil’impossibile e lo rimprovera, in maniera deltutto anacronistica, di non “riuscire a spic-care il grande volo verso la concezione ro-mantica del romanzo”, oppure sottolinea la“sua incapacità di immaginare la erlebteRede (il monologo interiore)” (112), o an-cora di non avere la stessa idea di “Bildung”di Goethe (128).Almeno altrettanto evidente quanto inBlanckenburg è la prospettiva antropologi-ca sia in Garve che in Engel. Il significatodell’importante saggio di Garve sulle diffe-renze tra gli scrittori antichi e moderni, cheanticipa in alcuni punti significativi il sag-gio di Schiller Über naive undsentimentalische Dichtung, viene addirittu-
ra stravolto da Agazzi, quando afferma cheEngel paventerebbe per “il nuovo genere let-terario per eccellenza, il romanzo”, una di-minuzione dello “scandagliamento psicolo-gico dei personaggi” e quindi “il rischiodell’impallidimento dei contorni delle figureper privilegiare le ‘idee’” (106). A parte ilfatto che Engel non parla mai in questo scrit-to del romanzo, egli, pur riconoscendo la su-periorità in molti campi degli antichi, attri-buisce infatti all’epoca moderna proprio il“vantaggio” (“Vorzug”) di una maggiorepenetrazione e profondità psicologica (cfr.Garve, pp. 75 sgg.).Il punto di vista antropologico è fondamen-tale anche per comprendere Engel, come èstato sottolineato soprattutto da Košenina(Anthropologie und Schauspielkunst), il qualerappresenta anche il solo riferimento criticosu Engel presente nelle pagine di questo li-bro. Benché Agazzi non lo riconosca, è in-fatti proprio una riflessione antropologica aspingere Garve a distinguere tra “That”,“Handlung” e “Bewegung” (cfr. 137 sg.), cosìcome è nuovamente una motivazione antro-pologica, e non un segno della “Gefühls-kultur” (p. 137), a fargli preferire il “dialo-go” al “racconto”. D’altra parte Agazzi sipreclude da sola la possibilità di intenderecorrettamente la problematica dell’azione,traducendo sia qui che a proposito diBlanckenburg il termine “That” come “fat-to” (cfr. p. 113: “Le Thaten sono fatti com-piuti”. Poco più tardi, a p. 123 oppone le“Thaten, anche se non Thaten nel senso epi-co del termine” [?], alle “Handlungen”, men-tre a proposito di Batteaux afferma che egli“interpreta i ‘fatti’ (Thaten) come ‘azioni’(Handlungen)”, p. 136). Sorprende, a propo-sito della “Handlung”, che Agazzi non pren-da assolutamente in considerazione nemme-no un testo come quello di Doris Bachmann-Medick, Die ästhetische Ordnung desHandelns. Moralphilosophie und Ästhetik inder Popularphilosophie des 18. Jahrhunderts,Stuttgart 1989, in cui questo tema viene in-dagato proprio a partire dalle opere di Garvee di Engel.La prospettiva antropologica è dominante
11OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
infine anche nelle Ideen zu einer Mimik, incui Engel afferma espressamente di prefe-rire una “anthropologische Naturwahrheit”a una “idealisierende Schönheit” (cfr. p.145). Di quest’opera fondamentale per ildiscorso sulla “gestualità” nel Settecento inGermania viene detto però poco e niente,perché Agazzi mescola nella sua trattazio-ne riflessioni del tutto personali alle rifles-sioni del traduttore in italiano delle Ideen,limitandosi poi a fornire semplici indicazio-ni sul contenuto dell’opera, che non permet-tono nemmeno di riconoscere la posizionedi Engel all’interno dell’importante dibat-tito svoltosi in Germania nella seconda metàdel Settecento tra sostenitori di una recita-zione “sentimentale” e sostenitori di una re-citazione “razionale” (Cfr. a questo propo-sito Košenina, Anthropologie und Schau-spielkunst, pp. 161 sgg.). Solo la conoscen-za di questo dibattito permetterebbe però diconferire un significato anche alla distin-zione ricordata nel volume tra gesti “volon-tari” e “involontari”, nonché ai riferimentialla recitazione dell’attore inglese Garrik(cfr. pp. 144 sgg.).E’ pur vero che il problema del “linguaggiodel corpo” non deve venir affrontato perforza solo da un punto di vista antropologi-co e che almeno altrettanto importante èanche il legame del discorso sulla gestualitàcon la tradizione retorica. A questo temaAgazzi dedica in effetti un capitolo della suaricerca (pp. 27-44), in cui cerca di ripercor-rere il passaggio dalla retorica all’antropo-logia, passando per la “civil conversazio-ne”. L’argomentazione, che prende le mos-se da una citazione mal interpretatadall’Universal-Lexicon (1735) di Zedler(pp. 27 sg.), passa poi a Cicerone eQuintiliano (pp. 29-31), salta quindi all’ope-ra in inglese di Gilbert Austin del 1806 (pp.31-32), ritorna a L’arte de’cenni (1616) diGiovanni Bonifacio (pp. 33-35), e approdainfine a Über den Umgang mit Menschen(1788) di Knigge (pp. 39-42), è tutt’altroche chiara e lineare, tanto più che viene in-terrotta da un inciso su Sulzer (p. 30) e so-prattutto da un excursus sul Prometeo di
Goethe (pp. 41 sg.), di cui è difficile capireil legame con il tema trattato. Anche la con-clusione sul supposto “escamotage” [?] neiconfronti del gusto da parte di Winckelmann(cfr. 42-44) non ha più nulla a che vederecon la retorica e appartiene evidentementegià al capitolo seguente (il tema verrà ripre-so di nuovo alle pp. 57 sg.). D’altra parte cipensa Elena Agazzi stessa a sminuire il va-lore di questa indagine, affermando primache non vuole addentrarsi nell’analisi deiprecetti oratorii (p. 29), e più tardi che nonintende “dilungarsi sulla tradizione apertadalla Civil Conversatione”, “perché quantodetto finora vale solo da introduzione al pro-blema della gestualità” (p. 37). E’ evidente-mente una conseguenza dello scarso valoreattribuito dall’autrice stessa a questo capi-tolo, il fatto che non vengano presi in consi-derazione due studi importanti su questotema, comparsi in Germania all’inizio deglianni Novanta, vale a dire le opere di RüdigerCampe, Ausdruck und Leidenschaft. ZurUmwandlung der literarischen Rede im 17.und 18. Jahrhundert, Tübingen 1990 (se nonerro, viene riportato solo nella bibliografia),e di Ursula Geitner, Die Sprache derVerstellung. Studien zum rhetorischenWissen im 17. und 18. Jahrhundert,Tübingen 1992.Se dunque né l’antropologia né la retoricacostituiscono il punto di vista da cui vieneaffrontato il problema del corpo e dellagestualità, ci si potrebbe senz’altro attende-re una considerazione che prenda le mossedalla prospettiva dell’estetica, la quale harappresentato effettivamente uno dei discorsicentrali del Settecento. Basta però già l’ul-tima nota del primo capitolo, in cui le operedi La Rochefoucauld, Fontanelle, Du Bos[Dubos?] e Montesquieu vengono definite“i testi più letti dagli estetologi tedeschi daWinckelmann in poi” (dove rimangono itesti di Boileau, Bouhours, Crousaz e so-prattutto Batteaux, tanto per rimanere tra gliautori francesi, a cui vanno aggiunti poi gliscritti degli inglesi Shaftesbury, Pope,Addison, Hutcheson, Young, Burke, Humeecc.?), per rendersi conto che la conoscen-
12OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
za dell’estetica del Settecento non è pro-prio il punto di forza di questo lavoro. Que-sta impressione viene confermatadefinitivamente dall’affermazione fatta nel-la stessa nota, secondo cui l’Aesthetica diBaumgarten avrebbe dato un “fondamen-tale contributo [...] ad una visione d’insie-me delle tendenze degli studi sul bello inGermania” [?]. Di fronte a simili afferma-zioni, non sorprende affatto se in tutte leconsiderazioni sui testi di Winckelmann,Lessing o Herder manca qualsiasi riflessio-ne di carattere genuinamente estetico, cheriguardi cioè la facoltà conoscitiva dell’ar-te.Benché il problema del rapporto tra le va-rie arti, in particolare tra scultura e lettera-tura, ma anche quello tra diversi generi let-terari come la rappresentazione teatrale el’opera narrativa, occupi una parte impor-tante di questo libro, pure non si può direche vi sia in esso nemmeno una reale ri-flessione semiologica. Nelle sue conside-razioni sul “dibattito intorno al Laocoonte”(pp. 54-72) Agazzi non tratta né dei temidibattuti all’epoca – non affronta cioè né ilproblema della rappresentazione del dolo-re o del patetico, né quello del rapporto trale arti, e nemmeno quello del rapporto trasignificato e significante ecc. –, né tantomeno degli sviluppi semiologici modernidi quella discussione. E’ quasi superfluorimarcare che anche in questo caso mancaogni riferimento alla vastissima letteraturasulle diverse problematiche proposte dallaLaokoon-Debatte, tra cui possono venir ri-cordati a titolo puramente indicativo i la-vori di David E. Wellerby, Lessing’sLaocoon: Semiotic and Aesthetics in theAge of Reason, Cambridge 1984, GunterGebauer (Hrsg.), Das Laokoon-Projekt:Pläne einer semiotischen Ästhetik, Stuttgart1984, e più recentemente Simon Richter,Laocoon’s Body an the Aesthetics of Pain:Winckelmann, Lessing, Herder, Moritz,Goethe, Detroit 1992.La riproposizione del dibattito in queste pa-gine non permette di capire né le analogiené tanto meno le differenze tra i singoli par-
tecipanti. Agazzi inverte anzi addirittura leloro rispettive posizioni, quando attribuiscead esempio a Winckelmann un giudizio pu-ramente estetico sull’arte, contrapponendo-lo a quello etico-morale di Lessing (cfr. p. 20e p. 59). Assolutamente confuso è poi il di-scorso sulla bellezza individuale, ovvero sul“carattere”, opposti alla concezione idealiz-zante dell’arte (cfr. p. 58), poiché proprio aquesto proposito le posizioni di Winckelmanne di Lessing sono molto più vicine di quantoAgazzi sembri credere. Il fatto poi che esat-tamente questa problematica sia stata porta-ta avanti e approfondita da Hirt proprio a par-tire dagli scritti di Winckelmann e Lessingsul Laocoonte e in un confronto diretto conGoethe, non è evidentemente giunto a cono-scenza dell’autrice, che non annovera Hirtnemmeno tra gli autori che hanno preso par-te alla Laokoon-Debatte (cfr. p. 63).E’ vero, d’altra parte, che non ci si possonoaspettare grandi chiarimenti su questo dibat-tito, da chi traduce il titolo della famosa ope-ra di Lessing Laokoon oder über die Grenzender Malerei und Poesie come Laocoonte oOltre i confini della pittura e della poesia (p.102). Tradurre “über” con “oltre” non indicainfatti solo ignoranza del complemento d’ar-gomento in tedesco – ignoranza ribadita piùtardi da Agazzi quando condensa il titolo delsaggio di Friedrich Schlegel Über GoethesMeister in Über dem [!] Meister (p. 251) –,ma rivela soprattutto la più assoluta mancan-za di comprensione dell’opera di Lessing.Non è infatti possibile pensare nemmeno inun attimo di distrazione che Lessing abbiavoluto andare “oltre i confini della pittura edella poesia”, quando il fine continuamenteperseguito in tutta l’opera è proprio quello disuperare l’“ut pictura poësis” e tracciare quin-di il più nettamente possibile i confini tra ledue arti.Di fronte a tanta confusione si può dunquesolo essere grati ad Elena Agazzi, per averdeciso di aggiungere una sua personale de-scrizione del gruppo del Laocoonte alle tan-te già esistenti, mettendo addirittura in luceaspetti che Winckelmann ha “evidentementetrascurato”, i quali avrebbero fatto perdere
13OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
valore alla dimostrazione di Lessing [?] (cfr.p. 60). Poche pagine più in là l’autrice rie-sce a fornirci anche due, “anzi, tre” nuoveragioni, “per cui Laocoonte non può grida-re, e queste sono ragioni che vanno ben ol-tre la stessa immaginazione diWinckelmann e di Lessing” [!] (p. 62).Benché non si parli mai né di “ekphrasis”,né di “Darstellung” nel capitolo dedicatoalla Kunstbeschreibung, dove sarebbe sta-to più logico incontrare questi concetti, pureElena Agazzi sembra aver avuto sentore diquella discussione che ormai da diversi annista occupando le indagini sui rapporti traarti plastiche e letteratura e ruota appuntoattorno a queste due categorie (si veda inparticolare il volume a cura di Boehm ePfotenhauer, Beschreibungskunst –Kunstbeschreibung, dal quale Agazzi ri-prende tre saggi rispettivamente di Graf,Krieger e Simon, trascurando invece signi-ficativamente proprio i contributi diPfotenhauer e Lenz che si occupano diWinckelmann e Heinse ovvero del Lao-coonte di Goethe). Se la problematicadell’“ ekphrasis” viene sfiorata solo duevolte (cfr. p. 120 sg. e p. 131), il binomio di“Vorstellung” e “Darstellung” ritorna inve-ce continuamente in superficie, simile a unfiume carsico, finendo per diventare un veroe proprio tormentone che non dice assolu-tamente nulla (cfr. pp. 9; 105; 122; 124;131; 135; 139 ; 172 sg.; 188; 192; 244). E’infatti addirittura stupefacente la disinvol-tura con cui Agazzi si serve di questi dueconcetti – tradotti rispettivamente come“rappresentazione interiorizzata”, oppostaalla “‘rappresentazione’ rivolta all’esterno”,che in alcuni casi diventa però addirittura“descrizione” [sic!] (cfr. p. 105) –, che inGermania sono stati invece oggetto di nu-merosi studi e monografie (cfr. per tutti illibro di Mülder-Bach, Im ZeichenPygmalions, che come dice il sottotitolo èdedicato appunto alla “Entdeckung der”Darstellung“ im 18. Jahrhundert”). Proprioin riferimento alla cultura tedesca, dove sul-la scia della filosofia leibniziana“Vorstellung” e “Darstellung” finiscono
spesso per coincidere e dove soprattuttoHerder e Klopstock hanno attribuito al se-condo termine significati ben precisi e as-solutamente centrali per le loro rispettivepoetiche, è però a dir poco inammissibileservirsi dei due concetti per dei giochini diparole che finiscono per rivelarsi o comple-tamente sbagliati o addirittura privi di sen-so. E’ così che Agazzi afferma già nella pre-messa che “nella poesia avviene unsuperamento della Darstellung [...] a favoredella Vorstellung” (p. 9), mentre è vero piut-tosto il contrario, poiché proprio Klopstockreclamerà per la poesia il termine di“Darstellung”, mettendolo tra l’altro in di-retta opposizione con la “descrizione”(“Beschreibung”) e facendo confluire in essotanto la “Vorstellung” che l’“Ausdruck”.Anche il riassunto che Agazzi offre dellacontrapposizione tra “antichi” e “moderni”fatta da Garve, il quale non utilizza comun-que mai i termini espressi in tedesco e mes-si in corsivo dall’autrice, rasenta quasi il ri-dicolo: “se gli antichi avevano reso poetica-mente la loro Vorstellung (la rappresenta-zione interiorizzata) delle cose sensibili (desdargestellten Dinges) [?], rimanendo fedelial piano della stessa Darstellung (descrizio-ne) [?] per la loro maggiore contiguità conil reale, i moderni hanno semplicementeesercitato la loro arte nella Darstellung derVorstellung (descrizione della rappresenta-zione) [?]” (p. 105). Agazzi non si accon-tenta però di giocare con questi due concet-ti già di per sé così bisognosi di interpreta-zione e di chiarimenti, ma introduce poid’improvviso anche il termine della “rap-presentazione (Repräsentation)”, che sareb-be entrato “in crisi verso il 1770” (p. 131).Più tardi veniamo però a sapere che già iromanzi di Madame de Lafayette conten-gono “il paradigma dello scetticismo neiconfronti del principio di rappresentazione”(p. 141), mentre la modernità delPigmaglione di Rousseau consisterebbe nel-la “risposta di una ‘rappresentazione corpo-rea’ (körperliche Darstellung) alla ‘rappre-sentazione pittorica’ (malerischeRepräsentation)” (p. 171). A questo punto
14OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
è veramente impossibile stabilire se il ter-mine “Repräsentation” sia da intendersi nelsuo significato politico, sociologico o piut-tosto semiotico. In quest’ultimo caso biso-gnerebbe però spiegarne il significato e inparticolare la sua opposizione alla“Darstellung” (cfr. sul rapporto tra questidue termini Mülder-Bach, Im ZeichenPygmalions), visto tra l’altro che in italianoi due concetti vengono tradotti con lo stes-so termineNon è assolutamente possibile ottenere ri-sposte a simili domande dal libro in que-stione, perché è evidente che Elena Agazziha solamente orecchiato alcuni termini ri-correnti nella discussione critica dell’ulti-mo decennio e si è sforzata di inserirli quae là, come delle specie di gemme che do-vrebbero dare splendore alla sua argomen-tazione, senza nemmeno sforzarsi di com-prenderne la portata e il significato. Unacosa simile si può affermare anche per ilconcetto di “rito”, il quale, pur comparendoaddirittura nel sottotitolo del libro, non di-venta mai oggetto di riflessione in nessunaparte dell’opera e compare solo qua e là aldi fuori di ogni contesto (cfr. pp. 22; 51; 92;106 sg.; 126 sg.; 189; 269). Nonostante ladefinizione di “rito” diffusamente citata dallibro di Braungart, Ritual und Literatur (p.126 sg.), non vi è infatti traccia nel librodella Agazzi di alcuna applicazione alla let-teratura dei metodi o dei risultati della ri-cerca etnologico-antropologica, quale po-trebbe essere ad esempio una riflessione sulrapporto tra teatro e rito ovvero, più in par-ticolare, tra gestualità teatrale e gestualitàpropria dei riti sociali codificati, oppureanche l’analisi di “rituali di passaggio” o di“iniziazione” simboleggiati in determinateopere letterarie (una simile analisi è già sta-ta condotta ad esempio sul Wilhelm Meisterda Michael Neumann, Roman und Ritus,1992). Le uniche cose che veniamo a sape-re da questo libro a proposito del rito, sonoil fatto che “a Blanckenburg manca ancorala consapevolezza dei rituali sociali che gui-dano le azioni dei personaggi” (p. 126),mentre invece Winckelmann sarebbe stato
“consapevole di tali rituali” nell’antica Gre-cia (p. 51) e Böttiger conosceva da parte suail “rituale che consente di collegare i gesti”(22). Scopriamo però anche che “il soggettopreferibile per la Handlung pantomimica” èrappresentato dai “rituali della quotidianità”(p. 189), mentre devono essermi completa-mente sfuggite le “considerazioni sullaritualizzazione del corpo nel sociale” (p. 269)alle quali Agazzi fa riferimento verso la finedel libro. Ancor più dell’utilizzo dei terminidi “Vorstellung” e “Darstellung”, il rinvio al“rito” nel sottotitolo del libro rivela dunquela sua natura di semplice specchietto per leallodole.Che la riflessione teorica non rappresenti pro-prio la forza di questo libro, viene conferma-to anche dal modo in cui Agazzi ‘interpreta’la recensione di Friedrich Schlegel delWilhelm Meister di Goethe, la quale non hatra l’altro – come molti altri capitoli esottocapitoli del libro – nulla a che vedere nécon il corpo (a parte il termine “Glieder”, fal-samente interpretato da Agazzi come meta-fora corporea, cfr. p. 96), né con la gestualità,né tanto meno con la ritualità. Non conoscen-do naturalmente la vasta bibliografia su que-sto scritto e in generale sull’ermeneutica diFriedrich Schlegel, Agazzi non riesce a co-gliere né la problematica né la genialità diquesto scritto, come dimostra chiaramentel’interpretazione veramente illuminante delromanzo goethiano a cui l’autrice giungedopo l’analisi della discussione di Schlegel:“L’illusione iniziale di Wilhelm, cioè che lacarriera artistica gli consenta di istituire unrapporto preferenziale con la sfera più inti-ma degli affetti umani e di soddisfare le pro-prie passioni, cade di fronte all’evidenza del-l’assoluta parzialità di un’ideale [sic!] che egliha costruito per antitesi a un milieu da cuiproviene come commerciante. Pian piano,abbandonando le velleità teatrali in nome diuna maggiore incisività nel quotidiano,Wilhelm cercherà un lavoro applicativo especializzato che non lo farà più sentire alie-no alla società, bensì perfettamente integratoin essa; si trasformerà in un medico nel suc-cessivo Wilhelm Meisters Wanderjahre.” (p.
15OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
95). C’era veramente bisogno di uno studioapprofondito dell’opera di Goethe e in par-ticolare del saggio sul Meister di Schlegel,per giungere a una simile conclusione chepotrebbe trovarsi in un qualsiasi manualedi letteratura tedesca per la scuola mediainferiore.Anche le ulteriori pagine dedicate al roman-zo di Goethe, sparse un po’ per tutta l’ope-ra, non conducono d’altra parte a risultatipiù significativi. Agazzi sembra scopriresolo ora quello che ormai è quasi un luogocomune, vale a dire che i Lehrjahre non siconcludono con l’avvenuta “Bildung” diWilhelm (cfr. p. 126, nota 91). Per afferma-re invece che nella prima parte del roman-zo vi è un’opposizione tra il mondo disor-dinato e caotico del teatro e quello ordinatodella borghesia, Agazzi deve citare MichaelNeumann (Roman und Ritus), il quale “pro-babilmente non ha seguito una cattiva pi-sta” individuando questa opposizione (p.252). E lo stesso Neumann deve garantireanche che “Mignon è figlia del destino edancor più della catastrofe [...] e pertanto sisottrae ad ogni condizione che non le gar-bi” [sic!] (p. 92). Sembra invece essereun’osservazione originale ed autonoma diElena Agazzi, quella secondo cui “Mignonè una creatura enigmatica, resa volutamente[!] androgina o meglio travestita da uomo,perché la sua natura risulti ambigua” (p. 92).Un’altra scoperta veramente rivoluzionariaè quella del carattere melanconico di Aureliee dell’“anima bella” nel sesto libro del ro-manzo (cfr. p. 252 sgg.). Anche le riflessio-ni sul significato e sulla funzione fondamen-tale nel romanzo del quadro del “krankerKönigssohn” (cfr. p. 258 sgg.) appaiono al-quanto in ritardo, oltre che assolutamentesuperficiali, dopo che Schings vi ha dedi-cato delle pagine importanti già nel 1985(cfr. il saggio Wilhelm Meisters schöneAmazone, in particolare pp. 173-206). Del-la gestualità nel Wilhelm Meister viene det-to invece solamente che Philine “è colei allaquale, insieme con Mignon, è più sempliceapplicare uno studio sulla gestualità” (p.252), senza però che una simile applicazio-
ne venga mai fatta.Se nell’analisi del Wilhelm Meister il pro-blema della gestualità non gioca praticamen-te alcun ruolo, anche le considerazioni sualtre opere letterarie come ad esempiol’ Agathon di Wieland (p. 182 sgg.) oppureil monodramma di Rousseau Pygmalion, ildramma goethiano Prometheus o ancora lasua Proserpina (p. 163 sgg.), contengonoben poco o nulla tanto sul corpo che sullagestualità. La stessa cosa vale però ancheper le pagine dedicate ai tableaux vivants(p. 188 sgg.), che si limitano tutt’al più afornire alcune informazioni aneddotiche.Considerato dunque che questo lavoro tra-scura tanto l’aspetto antropologico che quel-lo estetico e semiotico della gestualità, noneccelle per la profondità della riflessioneteorica e nemmeno per le interpretazioni deitesti letterari presi in esame, resta da chie-dersi ancora quali siano le tesi principali chein esso vengono sostenute. Proprio una si-mile domanda mette tuttavia in evidenza lamaggiore debolezza di questo libro, che noncontiene una sola tesi degna di questo nome,poiché anche le riflessioni sul rapporto traantichità e modernità, che iniziano già colprimo capitolo dedicato a Heine e ritornanopoi di quando in quando in maniera del tut-to inaspettata, non conducono in realtà adalcun risultato. Una conseguenza immedia-ta di questa mancanza di tesi da sostenere eda dimostrare è costituita dall’assolutacaoticità con cui è organizzato il materialetrattato. I titoli dei capitoli e dei sottocapitolisono stati aggiunti evidentemente solo in unsecondo momento, per creare un’apparen-za di ordine, poiché non rispecchiano maicompletamente il tema trattato, che spessoinizia già prima, oppure costituisce solo unaspetto marginale del capitolo. L’argomen-tazione procede poi veramente a ruota libe-ra, senza seguire mai una logica visibile elasciandosi trasportare, nel migliore dei casi,da semplici associazioni. Il più delle volte,però, riesce impossibile addirittura rintrac-ciare un qualsiasi legame che giustifichi ilpassaggio da un paragrafo all’altro. Già que-sto fatto rende la lettura estremamente fati-
16OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
cosa. Essa diventa però ancora più ardua,quando nell’argomentazione di Agazzi di-ventano nuovi e sconosciuti persino i testiche uno credeva di conoscere. E’ di volta involta sorprendente, infatti, cosa l’autrice rie-sce a far dire a Lessing, a Schiller, a Garve,a Blanckenburg ecc. e non si finisce mai dichiedersi cosa c’entrino ad esempio quellatal riflessione di Gottsched sull’opera, op-pure il Marionettentheater di Kleist, o an-cora i saggi di Schiller Über Anmut undWürde e più tardi Was kann eine gutestehende Schaubühne eigentlich wirken inquel determinato contesto. Il fatto è cheAgazzi estrapola sempre le citazioni dal lorocontesto, scorgendovi quindi problematicheassolutamente diverse da quelle che l’auto-re aveva inteso affrontare. Nel caso di cita-zioni più lunghe ciò diventa addirittura lam-pante, poiché non sono rari gli esempi incui il passo citato non dice assolutamentequello che l’autrice sostiene di leggervi.Se l’utilizzo della “Primärliteratur” è dun-que assolutamente pretestuoso e tutt’altroche scientifico, la stessa cosa si può affer-mare anche per l’uso della letteratura criti-ca. Abbiamo già visto che Agazzi non pren-de praticamente in considerazione nulladella letteratura esistente sui temi trattati.D’altra parte gli scarsissimi rimandi a qual-che saggio critico sono perlopiù insignifi-canti e casuali, in quanto non si riferisconomai alle tesi centrali di un lavoro, ma riguar-dano solo aspetti assolutamente marginali.Il rinvio alla letteratura critica non ha infat-ti alcuna funzione scientifica e sembra ob-bedire piuttosto a finalità puramentereverenziali ed encomiastiche, in particola-re quando si tratta degli “illuminanti sentie-ri aperti dalla germanistica italiana” (p. 37),i quali però forse preferirebbero brillare diluce propria e farebbero volentieri a menodi questa luce riflessa.Se la mancanza di tesi e di argomentazionelogica, l’utilizzo decontestualizzato epretestuale dei testi, nonché la funziona-lizzazione encomiastica dei rinvii alla lette-ratura critica non depongono certo a favoredella serietà e scientificità di questo lavoro,
anche l’evidente trascuratezza espressiva, ifrequenti errori di traduzione nonché le im-precisioni e l’approssimazione nei rimandibibliografici confermano ulteriormente lascarsa attenzione dedicata ad esso dall’autri-ce. Trascurando i numerosi refusi, che appa-iono inevitabili, disturba maggiormente lalettura il frequente utilizzo errato delle pre-posizioni (“cui si stentava di contrapporre”,p. 54; “i testi di cui Engel può rinviare per leproprie successive lezioni di mimica”, p. 140;“l’invito [...] di esprimere”, p. 185; “distinsetra il gusto libertino degli scritti francesi dal-l’approccio ingenuo di Goethe”, p. 225 ecc.).Oltre a frasi altisonanti e incomprensibili –gli esempi si sprecherebbero – Agazzi regalaal lettore anche delle tautologie veramenteuniche, come quando afferma, ad esempio,che i generi misti secondo Gottsched “nongiovano alla moderna concezione del princi-pio mimetico, che richiede fedeltà alla natu-ra e principio imitativo.” (100) All’utilizzo adir poco disinvolto di termini tedeschi – adesempio dei concetti di “Vorstellung” e“Darstellung”, ma anche di “Psycho-mediziner” – si è già accennato. Ma assolu-tamente fuori luogo è anche l’impiego delconcetto benjaminiano della “Jetztzeit” in ri-ferimento a Heine (p. 21) ma ancora di piùper indicare la funzione attribuita da Engelal dialogo (p. 137). E che dire poi del termi-ne tecnico schilleriano che da “sentimen-talisch” diventa “sentimental” (cfr. p. 15 e p.110), il quale ha in tedesco tutt’altro signifi-cato? Agazzi afferma inoltre che il termine“Gebärde” è stato sostituito nel tedesco mo-derno dall’espressione “Gestus” e dal suoplurale “Gesten” (cfr. p. 28). In realtà il sin-golare di “Gesten” è però rappresentato dalsostantivo femminile “die Geste”, e proprioquesto sostantivo, e non il foresterismo“Gestus”, che è privo di plurale e non vienenemmeno riportato né dal Wahrig né dalSansoni, costituisce il corrispettivo modernodella “Gebärde”.Della traduzione errata del sottotitolo delLaocoonte ho già detto, ma anche altri titolivengono tradotti in maniera alquanto arbitra-ria o addirittura in due modi diversi. Il Versuch
17OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
einer critischen Dichtkunst di Gottscheddiventa ad esempio Saggio di poetica ana-litica [!] (p. 99), mentre invece le Réflexionscritiques di Dubos rimangono giustamenteRiflessioni critiche (cfr. p. 166). D’altra par-te anche le Critische Betrachtungen über diepoetischen Gemählde der Dichter diBodmer diventano addirittura Osservazio-ni poetiche[!] sui dipinti poetici degli scrit-tori [!] (p. 123). Il testo di Herder Plastikviene reso a volte come Plastica (cfr. p. 65),altre invece come Scultura (cfr. p. 129),mentre l’opera di Garve intitolataAnfangsgründe einer Theorie derDichtungsarten aus deutschen Musternentwickelt, viene tradotta prima con Primielementi di una teoria dei generi poeticisviluppati sulla base di esempi tedeschi (p.139) e più tardi come Rudimenti di una teo-ria dei generi poetici sviluppata a partiredai modelli tedeschi (p. 172). Oltre a que-ste distrazioni, anche i passi citati conten-gono degli evidenti errori di traduzione chenon danno alcun senso (poiché infatti nonera mia intenzione controllare tutti i passitradotti, mi sono limitato ovviamente a quel-li dove già il testo italiano risultava incom-prensibile). E’ già stata rimarcata la tradu-zione errata del termine “Thaten”. Quandoperò l’autore dell’articolo Gebärdedell’Universal-Lexikon di Zedler affermache dai gesti naturali è possibile “dedurrela tendenza” (p. 27), non si capisce che cosavoglia dire, se non si risale al testo tedescoche parla di “das Gemüth ableiten”, ovverodi “dedurre lo stato d’animo, l’interiorità”.In un passo di Engel, che tratta dell’opposi-zione tipica della filosofia razionalista trapensiero e sensazione come “actio” e“passio” – e in cui Agazzi crede di poterleggere qualcosa sul “problema della carat-terizzazione dell’immagine in movimento”[?], che avvicinerebbe la teoria di Garve aquella espressa da Lessing nel Laokoon (cfr.p. 104 e p. 105) –, il sintagma “wir sindleidend” viene reso con “soffriamo”, inve-ce che con “siamo passivi” (p. 104). E dulcisin fundo scopriamo da una traduzione di unpasso dell’Agathon di Wieland che l’etera
Frine “fu abbastanza coraggiosa, nel corsodelle gare olimpiche, dal [sic!] fare l’interaGrecia giudice di quella bellezza per la qua-le, nella stessa sfilata, le tre dee si conten-devano il premio” (p. 184). In realtà, la solaidea che le tre dee che si contesero il pre-mio della bellezza sfilassero durante le gareolimpiche, è a dir poco assurda. Il terminetedesco “Aufzug”, che Agazzi traduce erro-neamente con “sfilata”, indica però anche ilmodo di presentarsi o di vestirsi, cosicché ilpasso dell’Agathon in questione va interpre-tato nel senso che Frine si presentò al popo-lo durante le gare olimpiche nella stessa te-nuta in cui si presentarono a Paride le tredee Giunone, Venere e Minerva, vale a diresenza vestiti. Nella citazione seguentedall’Agathon Agazzi traduce “das neidischeGewand” con “l’invidiabile abbigliamento”(p. 185), mentre l’aggettivo “neidisch” an-drebbe reso letteralmente con “invidioso” otutt’al più con “geloso”, poiché caratterizzametaforicamente l’abito che cercava di sot-trarre il più possibile agli sguardi curiosi ilcorpo di Danae.A parte il fatto che Agazzi attribuisce aSchröder dei versi sul rapporto tra natura edarte che sono invece di Lessing (p. 239. Cfr.Lessing, Sämtliche Schriften, edizioneLachmann, vol. I, p. 46) e considera Goetheautore del saggio Über die Gegenstände derbildenden Kunst (p. 260), che è invece ope-ra di Johann Heinrich Meyer, anche i riman-di bibliografici non sono privi di lacune eimprecisioni. Non si capisce, ad esempio,perché Agazzi, pur citando sia Cicerone cheQuintiliano in latino (cfr. p. 29 sgg.), nonrimandi ad alcuna edizione delle loro operee nella bibliografia riporti poi solo La for-mazione dell’oratore di Quintiliano e nes-suna opera di Cicerone. Nel riferirsi all’ope-ra di Engel Betrachtungen einigerVerschiedenheiten in den Werken der älteren[in realtà: “ältesten”] und neuernSchriftsteller, Agazzi rimanda invece primaai numeri di pagina attribuiti dall’editoredella ristampa (cfr. pp. 97-99 e pp. 103-105),per passare poi improvvisamente alla nume-razione del testo originale (pp. 106-108). E
18OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
che dire, poi, quando Agazzi rinvia a dellepagine assolutamente sbagliate per un lun-go passo tradotto dalle Reisen einesDeutschen in Italien di Moritz (nella nota67 di p. 192 si rimanda alle pagine 165-166,mentre in realtà il passo tradotto si trova ap. 414 dell’edizione delle opere di Moritzutilizzata da Agazzi. Un simile errore si spie-ga col fatto che Agazzi riprende il passo diseconda mano da un saggio di Bätschmann,il quale rimanda appunto alle pp. 165-166di un’altra edizione delle opere di Moritz.Cfr. Bätschmann, Belebung durchBewunderung, p. 357, nota 50)? Persinonella bibliografia l’opera di Schiller vieneattribuita addirittura a Friedrich Schlegel(cfr. p. 275: Schlegel, Friedrich, SchillersWerke. Nationalausgabe.).E’ evidente che queste e le molte altre im-precisioni che costellano l’opera non sonoin fondo che delle piccolezze, le quali tutta-via, sommate l’una all’altra, danno ugual-mente l’esatta misura dell’attenzione e del-l’accuratezza con cui il lavoro è stato svol-to.
Alessandro Costazza
Robert Mächler, Robert Walser, derUnenträtselte. Aufsätze aus vierJahrzehnten, herausgegeben von WernerMorlang, Zürich / München, Pendo, 1999,pp. 235, s. i. p.
Robert Mächler, autore della canonica bio-grafia Das Leben Robert Walsers (Genf,Kossodo, 1966), si è più volte cimentato conl’autore elvetico in una serie di contributidi cui il presente volume curato da WernerMorlang, decifratore insieme a BernhardEchte dei microgrammi walseriani, offre unascelta rappresentativa e stimolante. Notevolespazio è riservato alla religione (o meglioal tentativo di individuare in Walser una for-ma di religiosità) e alla lirica, temi questiche stanno particolarmente a cuore aMächler; nel volume trovano posto inoltre
note biografiche, studi a carattere compara-to, recensioni nonché Betrachtungen sui temipiù svariati.Nell’introduzione Morlang porta a conoscen-za del lettore rilevanti aspetti ed episodi del-la vita di Mächler (scomparso nel 1996) cheavvicinano quest’ultimo biograficamente al-l’autore di cui per decenni si occupò. Già ilcontesto famigliare si rivela sorprendente-mente simile: in Walser come in Mächler ilpadre commerciante scarsamente portato pergli affari è oggetto di disapprovazione da partedella madre, dalla labile costituzionepsicofisica e preoccupata delle convenzionisociali. Ma tra le analogie biografiche è la“psychiatrische Hypothek” (p. 25) ad avereil ruolo fondamentale: anche Mächler trascor-se, in gioventù, alcuni periodi in istituti dicura, in particolare fu ricoverato dal marzodel ‘28 allo stesso mese del ‘29 presso la cli-nica Maison de Santé di Malévoz, nel Vallese.Se i suoi famigliari si fossero rivolti ad unistituto psichiatrico della Svizzera tedescaegli sarebbe molto probabilmente stato inter-nato, come osserva Morlang, a Waldau, doveavrebbe conosciuto Walser, il quale fu qui ri-coverato nel gennaio del ‘29 per essere poitrasferito nel ‘33 a Herisau, dove sarebbe ri-masto fino alla morte (Natale 1956). Le lorostrade erano comunque destinate ad incon-trarsi, metaforicamente, alcuni decenni dopo.Infatti nel 1962, alla morte di Carl Seelig,tutore di Walser, l’esecutore testamentarioElio Fröhlich chiese al proprio amico d’in-fanzia Mächler di portare a termine la bio-grafia iniziata dallo stesso Seelig. Dopo qual-che incertezza egli accettò l’incarico; la de-cisione fu dettata dalla consapevolezza dellemolteplici affinità con Walser, una delle qua-li riconducibile alla comune esperienza dellamalattia mentale. Sebbene, dunque, Mächlernon avesse cominciato ad occuparsi di Walserdi propria iniziativa, quest’ultimo sembra poiessere stato costantemente al centro dei suoipensieri laddove egli rifletteva sui fenomeniletterari del Novecento. Tra i contributi rac-colti nel presente volume di particolare inte-resse per i Walser-Forscher potranno essereproprio quelli nei quali l’autore di Biel non è
19OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
oggetto specifico della trattazione, ma è ti-rato in ballo, talvolta inaspettatamente, instudi su personaggi e forme della letteratu-ra del nostro secolo.Talora Walser funge per Mächler da vero eproprio elemento ‘inibitore’: ad esempio,nel recensire un’antologia di lirica di lin-gua tedesca il biografo lamenta l’assenzadi un poeta come Heinrich Leuthold e soloin un secondo tempo si rende conto di averomesso di menzionare un ulteriore lirico cheavrebbe dovuto essere rappresentato nel-l’antologia, cioè il Nobel Carl Spitteler.Cercando di venire a capo di questo lapsusegli individua in Walser il responsabile ditale inconscia reticenza nei confronti diSpitteler. Lo scrittore di Biel ha infatti ca-ratterizzato il Nobel elvetico come “einIrrenarzt [...], der als kleiner Herrgott überden Narren thronte. [...] Er hat dies etwasImponierendes, aber auch etwas Krän-kendes” (p. 208) e questo suo giudizio ne-gativo ha inconsapevolmente influito sul-la considerazione critica mächleriana.L’episodio indica come Walser sia presentein Mächler a livello, si sarebbe tentati di dire,subliminare, condizionando in maniera in-volontaria taluni suoi processi mentali.Anche quando il biografo si cimenta in trat-tazioni teoriche riguardanti gli aspetti for-mali della creatività artistica il suo pensie-ro va a Walser, annoverato tra i rappresen-tanti più originali dello ‘Individualstil’(modo di esprimersi soggettivo tipico delleletteratura) che egli contrappone al‘Normalstil’ (dizione lineare e obiettiva ti-pica, per Mächler, della filosofia). Sebbenepossa essere rischioso parlare di norma edeviazione in riferimento al modo espres-sivo walseriano, che così potrebbe appariremero rispecchiamento di una costituzionepsichica anch’essa ‘deviante’ dai medicietichettata come schizofrenica, e sebbenela stilistica post-spitzeriana abbia espressosostanziali riserve nei confronti del concet-to di ‘norma’ linguistica, senza dubbioMächler in questo suo tentativo di caratte-rizzazione stilistica è animato dalle miglio-ri intenzioni ed offre osservazioni intrinse-
camente valide per una teoria dello stile let-terario.Altro sintomo dello spiccato e diffuso inte-resse di Mächler per Walser è ad esempio ilfatto che tra i 1046 aforismi del Tractatuslogico-suizidalis (Frankfurt a. Main, Fischer,1988) di Hermann Burger egli si soffermiproprio su quello riguardante l’autore di Biel(n. 115). Il biografo non condivide l’ideasecondo cui Walser si sarebbe autoannullatoa tal punto da rendersi inetto anche al suici-dio. Piuttosto, per Mächler egli avrebbe avu-to il coraggio di uccidere in sé, per usareuna designazione burgeriana, il ‘Mann ausWörtern’, cioè la creatività artistica, e so-pravvivere così per ben 23 anni in un istitu-to psichiatrico (come è noto, con il ricoveroa Herisau Walser pose fine alla propria atti-vità letteraria). La ‘Totologie’ di Burger -combinazione del tedesco tot e del latinototus - è per Mächler del tutto estranea allavitalistica Lebensbejahung walseriana. E’questo un concetto sul quale il biografo tor-na ripetutamente. Nonostante la Weltan-schauung per certi aspetti cupa di Walser(si pensi a Jakob von Gunten) e un paio ditentativi giovanili di suicidio, come lo stes-so scrittore confessa a Seelig, per Mächleregli non è da considerarsi pessimista comead esempio Spitteler (nel libro compare anzila designazione “der Humorist RobertWalser”, p. 64), e questo grazie alla valenzautopica dei suoi scritti, àncora di salvezzadal nichilismo. In particolare Mächler sisofferma, ad illustrare la componenteutopica walseriana, su tre prose dalle qualifrequentemente trae citazioni nei contributidel volume. Si tratta di Seltsame Stadt,Phantasieren e Träumen, evocazioni di unmondo altro dai tratti ora onirici, ora vaga-mente fantascientifici, ora lucidamente set-tecenteschi (talvolta schilleriani), oranebulosamente misticheggianti. In riferi-mento a quest’ultima dimensione, Mächler,conformemente ai suoi interessi religiosi,accosta - in maniera certo audace - l’atmo-sfera della prosa Träumen alla filosofia diConfucio e di Lao-tsu. Tali “utopistischeWunschbilder” (p. 56) derivano dalla insod-
20OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
disfazione di Walser nei confronti della cul-tura e della società del suo tempo; nei con-tributi Robert Walser für die Katz? e Ist allesfaul? Mächler charisce efficacemente laposizione a dir poco obliqua dell’artista ri-spetto alle correnti letterarie del tempo. Piùdel momento genetico di questo atteggia-mento oppositivo rispetto al reale interessaal biografo il momento della realizzazioneartistica delle proprie aspirazioni, appuntol’elaborazione dell’utopia. Egli è attratto daquella componente della scrittura walserianache più corrisponde alla natura intrinsecadella propria produzione: lo stesso Mächlerè infatti autore, come ci informa Morlang,di una serie di saggi a carattere filosofico incui vagheggia un modus vivendi ideale checontrappone alla realtà esistente. Anzi eglisi occupò dell’autore di Biel anche nellasperanza di poter suscitare interesse, in qua-lità di studioso walseriano, per i propri scrit-ti, aspettativa questa destinata a rimaneretale.Nel corso della lettura dei diversi contributinon si può non notare l’iterarsi di citazionioggi inflazionate per la frequenza con cuila Walser-Forschung ricorre ad esse. Carat-terizzazioni come “ein mannigfaltigzerschnittenes oder zertrenntes Ich-Buch”(Eine Art Erzählung) in riferimento alla pro-pria produzione, affermazioni come“Niemand ist berechtigt, sich mir gegenüberso zu benehmen, als kennte er mich” (DasKind III) o “Niemandem wünschte ich, erwäre ich” (In dem Reisekorb oder Wäsche-korb), stranote ad ogni studioso walseriano,sembrano qui alludere, nei diversi contestidei vari articoli, ad una concezionemächleriana del poeta di Biel che merite-rebbe di essere ulteriormente scandagliatanei suoi elementi costitutivi. Perché è que-sto uno dei pregi del volume: esso non soloinduce a rileggere almeno una parte del-l’opera walseriana per verificare taluni sug-gerimenti del biografo, ma, grazie alla scel-ta particolarmente riuscita dei testi, suscitacuriosità nei confronti dello stesso Mächler,la cui produzione saggistico-filosofica po-trebbe nei prossimi anni essere oggetto di
quell’attenzione che l’autore auspicava.
Anna Fattori
Matteo Galli, L’officina segreta delle idee.E.T.A. Hoffmann e il suo tempo, Firenze, LeLettere, 1999, pp. 356, £. 38.000.
Matteo Galli ha da poco pubblicato uno stu-dio critico su E.T.A. Hoffmann che si rivol-ge con generosità tanto a coloro i quali sioccupano da anni dell’autore - e probabilmen-te conoscono ogni piega della Sekundär-literatur che lo concerne - quanto a coloro iquali, muovendo i primi passi alla scopertadel romantico, prediletto per i Nachtstücke,potrebbero rischiare di percepirlo esclusiva-mente come lo ‘scrittore del perturbante’.Certo, la via interpretativa scelta da Galli èardua, perché spesso si snoda attraverso testipoco noti, come il frammento intitolato Dreiverhängnisvolle Monate (agosto 1813) e ildialogo sulla musica Der Dichter und derKomponist (settembre 1813), che gli permet-tono di far emergere l’impegno politico di unoHoffmann il quale per anni ha espresso il pro-prio sentimento antinapoleonico in modo perlo più cifrato, anche a latere delle opere veree proprie.L’impianto di L’officina segreta delle ideeconsente di seguire pazientemente gli umoripatriottici e le oscillazioni ideologiche delloscrittore a partire dalla storia dei suoispostamenti da Bamberga a Lipsia, poi aDresda, fino ad approdare a Berlino, facen-do emergere in rilievo sullo sfondo gli eventipolitici che si svilupparono tra la guerra fran-co-austriaca e l’esilio del Bonaparte all’Elba.L’indignazione nei confronti della politicanapoleonica è tutta ricostruibile grazie a scelteculturali che partono in sordina dallaNachtseite di una condanna esplicita del ti-ranno francese - prima ancora che Hoffmannsi affermasse come scrittore del ‘fantastico’ -in un mosaico costituito da recensioni musi-cali, da frammenti critici e da disegni carica-turali. Si comincia da una lusingante recen-
21OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
sione della Quinta Sinfonia di Beethovenper la “Allgemeine Musikalische Zeitung”,dopo che Hoffmann ha già lanciato i propristrali contro la borghesia berlineseacquiescente e filistea nel Ritter Gluck(1809), un racconto che fa emergere nellaÖffentlichkeit l’Hoffmann narratore, e in unsaggio dedicato all’allestimento dei dram-mi di Calderón de La Barca al teatro diBamberga. Sostenere un musicista comeBeethoven voleva dire affermare l’esisten-za e la sublime indipendenza di un mondodell’arte che non poteva essere in nessunmodo asservito ad una potenza terrena. Sen-za parlare di libertà, ma lodando il meravi-glioso regno dell’infinito musicale diBeethoven, Hoffmann affermava la gran-dezza di un impero che non esisteva nellasfera della realtà umana. E così, senza espor-si a cocenti delusioni e a una catastrofe del-la coscienza come era successo a Kleist, ilquale in un primo tempo aveva visto in Na-poleone “das prometheische Bild desLucifer, des Bringers des revolutionärenAufklärungslichts in die in fremd- undselbstverschuldeter politischer Finsterniszurückgebliebenen Territorien Europas”(Waldemar Bauer, Heinrich von Kleist:Utopischer Naturzustand und gesell-schaftliche Katastrophe, in: Heide N.Rohloff (a cura di) Napoleon kam nicht nurbis Waterloo, p. 287) Hoffmann si avvia aduna carriera di segreto barricadero a Dresdae a Lipsia, tra l’aprile del 1813 e il settem-bre del 1814. Proprio in questo anno sorgo-no le sue caricature allegorizzanti che cele-brano la capitolazione di Napoleone e cheaprono un gustoso paragrafo del libro diGalli, il quale stempera opportunamentel’impegnativa analisi dei testi muovendositra la satira politica e lo stereotipo cultura-le.L’ampio respiro con cui Galli in seguito puòtrattare Der Magnetiseur (1813) in chiavestoricistica, senza nulla togliere allo spes-sore letterario ed estetico del testo, si deveal fatto che il germanista ha già costruito lasua ampia premessa culturale sull’influen-za degli studi magnetici compiuti da
Mesmer e su quella che oggi chiamerem-mo ‘analisi dell’inconscio’ di GotthilfHeinrich Schubert nell’introduzione ai Not-turni pubblicata nel 1997. Qui Galli si eraattenuto allo standard interpretativo legatoall’interesse per i fenomeni paranormali,non senza lamentare l’assenza di una piùacuta Wahrnehmung del periodo post-napoleonico e delle sue ripercussioni sullaGermania da parte dei germanisti. La ma-novra di avvicinamento all’equazione fina-le Alban=Napoleone è comunque cauta e siavvale di un confronto tra il registro espres-sivo di Alban e quello attribuito a Napoleo-ne nello scenario apocalittico del campo dibattaglia di Dresda, dopo la sconfitta dellemilizie del Bonaparte (Die Vision auf demSchlachtfelde bei Dresden, marzo 1814).Galli prende commiato per una buona partedel suo studio da una lettura approfonditadella psicologia dei personaggi e punta di-rettamente all’’elaborazione letteraria del-l’attualità’ (p.58). Seguendo un preciso di-segno kulturgeschichtlich, Galli conduce undiscorso generale, parallelo a quello piùstrettamente storico-letterario, sul problemadella censura in Germania sotto Napoleo-ne, discorso che trova il suo punto di sboc-co nella preziosa sezione seconda dedicataalla Restaurazione. Anche se Galli ammet-te in tutta onestà l’esistenza di alcuni studidi valore sull’Hoffmann giurista(Segebrecht, Auhuber, Kollenbrock-Netz,Reuchlein e soprattutto Mangold), riescecon rara capacità di sintesi a trascinarci inun documentato viaggio nella vita di unoHoffmann impegnato nel ruolo di ImmediatUntersuchungskommissar e intento a de-nunciare i guasti dell’amministrazione del-la legge in opere come Die Elixiere desTeufels (1815), Das Fräulein von Scudèry(1819), Meister Floh (1822), e DieMarquise de la Pivardière (1822), tuttecomposte dopo il Congresso di Vienna e inparte dopo i Karlsbader Beschlüsse (1819).Metodologicamente, la lettura critica diGalli non fa una piega: si distinguono le ipo-tesi dalle certezze, gli indizi dalle proveschiaccianti. Le digressioni sul plot delle
22OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
opere in esame, che Galli affronta con co-raggio, pur ammettendo la difficoltà di isti-tuire una ‘mappatura’ organica del lavorohoffmanniano a partire da esplicite reazionidello scrittore alle vicende politiche del-l’epoca, vengono riordinate grazie ad unfelice escamotage: la classificazione ditipologie di mondi di corte nel contesto dellestorie narrate. E come erano stati associatia distanza il tema della difesa della libertàdelle idee (Parte Prima: 1809-1815) con lareazione contro il ‘maledetto arbitrio’ dellagiustizia dopo il 1819 (par. 2 delle Parte Se-conda), così la parte relativa alla satira con-tro le piccole corti tedesche, presente soprat-tutto nei Fantasiestücke in Callots Manier(par. 1 della Parte Seconda) trova il propriocoronamento nel discorso sul ‘filisteismoassoluto’ che chiude il saggio. Qui Galli puòfar sfilare i suoi beniamini davanti al letto-re, sottoponendoli ai raggi X della satiraanti-intellettualistica e distinguendo tra iGelehrten, i Fachidioten e i Charlatane. C’èchi dissimula meglio (Bildungsphilister) echi peggio (Philister) la propria mediocritàe chi assomma in sé entrambe le anime. Ma,lo abbiamo visto, la fiction copre solo conuna membrana sottile il diaframma semprepulsante dello scrittore polemista. Con l’ul-timo colpo di coda dello scorpione in ago-nia, Hoffmann fa penetrare nelle logore fi-bre della società della Biedermeier-Zeit ilveleno di un irriducibile che non si è maipiegato alla censura della libera espressio-ne, il vecchio cugino-alter ego di Hoffmanndi Des Vetters Eckfenster (1822), che vor-rebbe ancora frequentare la lira, la matita,la penna e la toga, ma è costretto a rasse-gnare le proprie dimissioni dalla vita confi-dando nella lungimiranza della nuova ge-nerazione.
Elena Agazzi
Federico Vercellone, Nature del tempo.Novalis e la forma poetica del romanticismotedesco, Milano, Guerini e Associati, 1998,pp. 152, £. 27.000
Ogni approccio critico al romanticismo devedi necessità porsi di fronte a precise scelte ditaglio e prospettiva, per chiarire e delimitareil suo oggetto e, eventualmente, metterlo inrapporto con le altre grandi manifestazionicontemporanee dello spirito del tempo, qualiad esempio il classicismo o l’idealismo. Inquesto senso il libro di Vercellone Nature deltempo. Novalis e la poetica del romanticismotedesco dice allo stesso tempo di più e dimeno di quanto promette dal titolo, costruen-do un quadro di riferimenti molto ampio nelquale però poi poco posto è lasciato ad un’ef-fettiva disamina del rapporto principale, cioèquello che lega i concetti filosofici con laparola poetica.Tempo e forma, cioè le due categorie che sifronteggiano nell’ultimo grande capitolo diquell’intricatissimo complesso di questioniestetico-filosofiche che si ricorda sotto ilnome di Querelle des Anciens et desModernes, sono analizzati in queste paginetenendo sempre presente sullo sfondo il con-cetto di “modernità” e quindi, per così dire, aritroso, nel loro valore di momento di pas-saggio, di risposta al grande dilemma circa ilmodo di ridare vigore ad una concezione ar-tistica che inizia a sentire il conflitto fra lanecessità di regole intrinseche universalmentevalide e il nuovo sentimento di una fratturainsanabile dovuta alla storicità, al tempo, allaconcrezione nel reale ormai incapace di ri-conoscersi espressione dell’universale. Lafede nella possibile esistenza di una formache sia compiuta rispondenza della natura ecolga così perfettamente l’universale nel par-ticolare - una fede che nelle pagine diVercellone si esemplifica nella figura diGoethe, un Goethe forse un po’ più “armoni-co” di quanto poi le sue pagine poetiche ineffetti rivelino - si incrina sotto l’irrompenteforza centrifuga del tempo come incarnazio-ne della storia e del soggetto. Nel corso del
23OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
lavoro e del suo sforzo di determinare le ca-tegorie filosofiche e culturali portanti di fineSettecento, di caratterizzare i due termini -classico e romantico - con cui si usa deno-minare il periodo, fissandoli in un rapportoche di volta in volta può essere tanto dicontrapposizione quanto di complementa-rità, la poetica romantica viene confrontatae, per così dire, completata con la visioneantagonistica in una serie di accenni e ri-flessioni che, partendo da Goethe, passanoper Hegel e approdano a Nietzsche. Puntodi partenza di questa riflessione per i roman-tici è, ovviamente, Fichte, nel cui concettodi immaginazione (Einbildungskraft) comeluogo di connessione fra riflessione e realtài giovani poeti trovano la breccia da cui farconfluire una temporalità capace di supera-re se stessa e la propria limitata storicità perrimandare necessariamente a un senso na-turale del divenire. Il confronto con il filo-sofo, la specificità della ricerca romantica el’originalità delle risposte teoriche e poeti-che elaborate, viene qui esemplificata tra-mite un’ampia analisi delle paginenovalisiane dedicate a Fichte (i cosiddettiFichte-Studien) e alla costruzione di una“enciclopedia” intesa come insiemecomposito di infiniti riferimenti e rimandiin cui ciò che è singolo si pone in relazionecon il resto, indicando così la via dell’asso-luto preclusa all’essere come “divenuto” neltempo.All’interno di questo quadro di riferimentiche fanno del tempo e della forma le cate-gorie estetico-filosofiche in lotta per affer-mare la dicibilità del mondo, la sua trasfor-mazione in segno artistico, va inserita ladefinizione critica delle strade poetiche per-corse dal romanticismo. Come nota giusta-mente l’autore “non c’è forse pensatore che,più di Novalis, abbia intrecciato l’indaginesulla natura con la propria attività artistica”(p.83), affermazione ribadita nel corso dellavoro da accenni e confronti con altre per-sonalità di spicco del romanticismo, primofra tutti Friedrich Schlegel. Proprio questapeculiarità, più che una supposta“rappresentatività” (sempre così difficile da
dimostrare oltre le generalizzazioni) dell’au-tore in seno al romanticismo, rende Novalisun soggetto oltremodo interessante per unaricerca di presupposti filosofici che deter-minano la nascita di un’arte autonoma, ba-sata sull’autogiustificazione. Spiace, perciò,che il capitolo dedicato a questo aspetto spe-cifico, cioè alla descrizione della parola po-etica scelta a realizzazione dei concetti filo-sofici sino a quel punto analizzati, sia cosìsuccinto, laddove invece ogni riga di Novalis(si pensi ad esempio alle Hymnen an dieNacht ricordate solo in una nota) offre ma-teriale copioso e interessante.
Donatella Mazza
Hartwig Schultz, Clemens Brentano,Stuttgart, Reclam, 1999, pp. 223, DM 12.00
Pubblicato nella collana “Literatur Studium”delle edizioni Reclam, il lavoro di Schultzsi rivolge in modo particolare a studenti dellescuole superiori e dell’università che voglia-no avvicinare un autore considerato tradi-zionalmente “prototipo del poeta romanti-co” (p. 8), la cui produzione letteraria è peròfrutto di una vicenda intellettuale segnatada recisi cambiamenti di percorso ed è per-tanto contraddistinta da una sostanziale ete-rogeneità di generi e di risultati. Con questolavoro Schultz si propone perciò non di “for-nire un’immagine particolare di Brentano”,ma di aiutare il lettore ad “avvicinarsi almateriale del tutto eterogeneo che di lui ci èstato tramandato” (p. 8). Una sezione di ca-rattere eminentemente biografico apre cosìquesta ricognizione nel mondo brentaniano.L’infanzia e giovinezza a Francoforte, i con-tatti con il primo romanticismo di Jena ne-gli anni 1799-1804, le tappe successive diHeidelberg, Vienna, Berlino, l’esperienzareligiosa del tempo di Dülmen (1818-1824)che culmina nell’opera di trascrizione dellevisioni mistiche della monaca A. K.Emmerick vengono qui ripercorse quali pas-saggi di un cammino verso una riscoperta
24OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
religiosità. Il ritorno dell’autore alla lette-ratura nei suoi ultimi anni di vita pare inquesto quadro interrompere il percorso inmodo sconcertante e sembra lasciarsi ricon-durre principalmente all’incoerenza di ca-rattere che contraddistingue il personaggio.Con questa prima presentazione della para-bola personale di Brentano, Schultz si ponenel solco della critica più tradizionale sul-l’autore, secondo la quale il suo ritorno alcattolicesimo si potrebbe inquadrare soloentro un rapporto rigorosamente antiteticocon la sua attività di scrittura poetica auto-noma e la produzione letteraria del periodopiù tardo risulterebbe assai a faticaavvicinabile, per interesse e valore estetico,ai brillanti risultati della precedente espe-rienza primoromantica. La pubblicazionedella fiaba di Gockel, Hinkel e Gackeleianel 1838, dopo gli anni dell’esperienza re-ligiosa e della sua ‘traduzione’ nel testo delBitteres Leiden unsers Herrn Jesu Christi(1833), segnalerebbe infatti, secondo l’au-tore, “che Brentano non prendeva più sulserio la propria svolta radicale verso la let-teratura di devozione” (p. 29). Quanto alvalore estetico delle opere composte dopola ‘reversione’, “solo parti della lirica (la li-rica per Emilie Linder, riscoperta solo dopola guerra) e singole riscritture tarde dellefiabe e dei racconti raggiungono [...] alme-no per approssimazione il livello artisticoche Brentano aveva toccato nei passaggi li-rici del suo romanzo primoromantico Godwiall’inizio del secolo” (p. 8).Alla base di questo atteggiamento verso ilcomplesso dell’opera brentaniana sta da unlato un’ottica interpretativa suggerita dallostesso poeta, che nelle lettere stilizza il pro-prio percorso di riavvicinamento allareligiosità cattolica nei termini di una scel-ta radicale che esclude ogni ritorno all’in-dietro, rigidamente alternativa ad ogni ri-presa di interessi eminentemente estetici;dall’altro una convinzione maturata daSchultz durante i lavori all’edizione criticadelle opere di Brentano, di cui egli è diret-tore. A sostegno della tesi secondo cui i te-sti del periodo tardo di tale autore non si
possono considerare opere di vera letteratu-ra, Schultz ricorda infatti che neanche il loroinserimento nel quadro dell’edizione criticaè riuscito a farli rientrare “nel canone dellaletteratura tedesca del 19. secolo” (p. 7). No-nostante la loro edizione nella “FrankfurterAusgabe” sia stata collegata in sede critica auna più precisa definizione del contesto sto-rico in cui essi si collocano quali esempi di‘Zweckliteratur’, il loro inserimento cometesti esteticamente significativi nell’ambitodella prosa d’arte del XIX secolo resta ai suoiocchi ancora molto problematico. In ognicaso, afferma Schultz, “lo sviluppo della pro-sa europea è passato del tutto oltre [simili]tendenze particolari (p. 149) e ha seguito poiben altre vie”.Sulla base di questi presupposti, Schultz sisofferma con particolare cura sulla liricabrentaniana, che soprattutto durante il perio-do giovanile gli pare raggiungere i risultatipiù alti e convincenti. Nelle “lyrischeEinlagen” del Godwi, ad esempio, egli vederealizzato l’ideale di semplicità e di sponta-neo contatto con la natura che caratterizza aisuoi occhi la tradizione romantica e cheBrentano ha peraltro di fatto contribuito acreare. Nel complesso di tono ‘sentimentale’e intimo accordo con il ritmo delle cose cheEmil Staiger ha indicato come base della stra-ordinaria musicalità di questi testi, Schultzriconosce il fondamento del fascino e dellagiusta notorietà delle poesie brentaniane. Incoerenza con tale modalità di approccio, an-che l’imponente iniziativa culturale, rappre-sentata dalla compilazione a quattro mani diDes Knaben Wunderhorn ad opera dell’au-tore e del suo amico Arnim, viene da Schultzpresentata per il suo valore di arricchimentodel repertorio poetico più che come iniziati-va dalle significative implicazioni culturali.Quando, infine, il centro dell’analisi si spo-sta verso il periodo della ‘reversione’ e versogli ultimi anni di produzione artistica dell’au-tore, il giudizio sul valore letterario dei suoitesti poetici si fa più reciso. Accanto alle poe-sie di occasione come il Mosel-Eisgangs-Liedsi ricorda la pur affascinante poesia tarda perEmilie Linder ma si chiude il discorso su que-
25OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
sto epilogo della parabola brentaniana so-stenendo che “la perfezione artistica del-le prime poesie non viene [di fatto da lui]più raggiunta” (p. 49).Anche nell’affrontare il quadro della prosadi Brentano, Schultz sembra tenere comeriferimento non esplicito ma sempre presen-te l’immagine di un primo romanticismoconnotato sul piano ideologico in modo as-solutamente positivo e considerato sul pia-no estetico come difficilmente ancoraeguagliabile nei decenni successivi. La va-rietà e mobilità del narrato del Godwi sonoda lui pertanto accuratamente collocate nelquadro della discussione contemporaneasulle forme dell’arte e nel quadro delle rea-zioni che il romanzo suscitò al suo appari-re. La retrospettiva sui racconti è invece giàvolta piuttosto a distinguere sino a dove lanarrazione si mantenga opera di letteraturaautonoma e dove invece vadano individuatii punti di contatto con prime forme di‘Zweckliteratur’. Il quadro delle fiabe vie-ne infine ricostruito attraverso un confron-to esplicito con la “tradizione europea delKunstmärchen” (p. 98) che il tempo diBrentano avrebbe riscoperto nella moltepli-cità dei suoi aspetti, e con un modello di‘Märchen’ popolare che corrisponde prin-cipalmente a quello fissato da Tieck con laraccolta del 1796. Schultz sottolinea comeBrentano abbia partecipato con questi testialla creazione della categoria romantica del-l’infantile, del ‘Kindliches’; individua glielementi che in essi confluiscono in unasorta di mitologia individuale e li confrontapiù volte con il modello ideale della ‘neueMythologie’ schlegeliana; inquadra il feno-meno delle riscritture tarde delle fiabe - diFanferließchen Schönefüßchen e di Gockel,Hinkel e Gackeleia - nel contesto della sem-pre più accentuata tendenza dell’autore amoltiplicare le prospettive di racconto, maanche sotto la confusione del narrato rico-nosce il persistere di alcuni irriducibili pre-supposti primoromantici. Il “postulatoprimoromantico” dell’’Homo poeta’(p.119), ad esempio, gli pare nascondersiancora sotto la scrittura della tarda fiaba di
Gockel, Hinkel e Gackeleia, dove la FrauRath, madre di Goethe, che prende la paro-la nella dedica, parla al protagonista bam-bino della necessità di “costruire i suoi ca-stelli delle fate sulle spalle alate della fanta-sia” - anche se va ricordato che, alla finedella citazione riportata, il testo mostra ilcrollo proprio di tale residua speranza e co-struisce sull’insensatezza di tale fiducia unafaticosa, nuova, forma di poesia.La lettura dei testi qui delineata corrispon-de in realtà pienamente ai presupposti cheSchultz indica all’inizio del suo libro. Que-sto lavoro - si legge al termine delle pagineintroduttive - muove infatti non da ultimodal tentativo di mostrare in che cosaBrentano si possa definire poeta romantico.Si è detto sinora dell’attenzione riservata daSchultz alle forme che avvicinano la scrit-tura brentaniana alle teorie elaborate dagliintellettuali del gruppo di Jena: con analogaattenzione l’autore si sofferma sui caratteridel suo personaggio, che la tendenza a‘poetizzare’ la vita rende quasi il prototipodello scrittore di inizio Ottocento. Ciò cheora comunemente si intende per “amore ro-mantico”, “serata romantica”, “libro roman-tico” (p. 8), scrive Schultz, rientra infatti inparte nell’ambito di esperienza da lui fissa-ta nelle opere e da lui esperita concretamentenel corso della sua vita. Intento della mono-grafia dovrebbe essere pertantoquello di av-vicinare questo poeta dall’esistenza inquie-ta a un pubblico che parte da questi presup-posti conoscitivi, mostrando quantoBrentano d’altra parte non sia mai stato “fe-lice, riposante in se stesso, immune controun mondo dominato dal razionalismo”, maal contrario, come “uomo dilacerato, segnatoda contraddizioni e paure, egli sia al tempostesso prototipo dell’uomo ‘moderno’, chetende sempre all’armonia ‘romantica’ manon la raggiunge mai” (p. 9).Questo particolare atteggiamento di ricercanei confronti dell’autore e della sua produ-zione letteraria porta Schultz conseguente-mente a non centrare l’indagine in modopreponderante sulla ricostruzione del con-testo storico da cui scaturiscono le opere
26OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
prese in esame. I riferimenti storico-filologici sui quali buona parte della‘Brentano-Forschung’ degli ultimi decenniha costruito le proprie analisi - soffer-mandosi anche su quegli esperimenti lette-rari che è difficile inquadrare entro catego-rie meramente estetiche - non rivestono qui,coerentemente con i presupposti del lavo-ro, un rilievo eccessivo. Per questo soprat-tutto la presentazione dei testi in prosa diBrentano può essere proficuamente integrataanche dalle numerose opere monografichedi inquadramento che lo stesso Schultz in-dica nella scelta bibliografica con cui con-clude il volume: la ricca introduzione di G.Schaub all’edizione dei racconti (Gold-mann, München 1984) può essere utile, adesempio, e a completare l’inquadramentotalora un po’ essenziale della produzionenarrativa breve di Brentano, i più recentistudi di H. W. Schmidt, A. Lorenczuk e B.Knauer, a integrare la retrospettiva sulle fia-be, in modo particolare sui rifacimenti tardidi Fanferließchen Schönefüßchen e diGockel, Hinkel e Gackeleia. La presentazio-ne delle opere drammatiche - di cui Schultzha peraltro curato l’edizione nella“Frankfurter Ausgabe” - si segnala inveceper la sua interna articolazione come un’uti-le via di accesso verso una parte della pro-duzione brentaniana che non ha conosciutosuccesso al tempo dell’autore e che ha rice-vuto anche da parte della critica una solorelativa attenzione.
Laura Benzi
Marino Freschi, Goethe. L’insidia dellamodernità. Roma, Donzelli Editore, 1999(Saggi. Arti e lettere), pp. 240, £. 32.000.
Irmgard Wagner, Goethe. Zugänge zumWerk. Reinbek, Rowohlt, 1999 (rowohltsenzyklopädie; 629) 256 S., 19,90 DM
Goethejahre bringen gewöhnlich eineVielzahl von Neueditionen und Anthologien
(etwa die umfangreiche Ausgabe derJugendwerke im Suhrkamp-Verlag, dieTaschenbuchedition der Hamburger Ausgabeoder solch skurrile Titel wie Goethesschlechteste Gedichte im Residenzverlag),Aufsätzen zu einzelnen Aspekten des Werkes(z. B. Zapperis Buch über GoethesRomaufenthalt), Biographien (der zweiteBand von Nicholas Boyles groß angelegterBiographie) und fiktiven Texten (etwa DieterKühns Roman über die Campagne inFrankreich: Goethe zieht in den Krieg) hervorund bereichern (?) so die seit langem schonunüberschaubare Goetheliteratur. Die Klageüber die Unmengen mehr oder minderbedeutsamer Sekundärliteratur, die man alsgewissenhafter Forscher zu wälzen hat unddoch eigentlich gerne außer acht lassenwürde, um den eigenen Forschungser-gebnissen den Reiz des Neuen und Inno-vativen zu verleihen, gehört mittlerweile zuden Stereotypen beinahe sämtlicherEinleitungen zu Schriften über Goethe. Alsprominentes Beispiel sei hier nur auf dasVorwort zu Karl Otto Conradys wichtigerGoethe-Biographie verwiesen: „Wer überGoethe schreibt, ist der Goethe-Forschungverpflichtet. Er hat von ihr gelernt, baut aufFundamenten, die Generationen vonForschern gelegt haben. Er steht in ihrerSchuld. Die Goethe-Philologie hat freilichlängst Ausmaße erreicht, die ein einzelnernicht mehr überblicken kann“ (Karl OttoConrady: Goethe: Leben und Werk. Frankfurtam Main: Athenäum, 1987, S. X). Statt, daßsich der Forscher jedoch von dieser desolatenSituation entmutigen ließe, bleibt er Optimist,vertraut auf die Originalität seines Beitragesund verfaßt flugs ein weiteres Goethe-Buch.Zu seiner Rechtfertigung kann er überdiesjederzeit auf ein Zitat aus Goethes eigenerFeder verweisen, wenngleich (oder geradeweil) es unter dem Titel „Shakespeare undkein Ende“ steht? „Es ist über Skakespeareschon so viel gesagt, daß es scheinen möchte,als wäre nichts mehr zu sagen übrig, und dochist das die Eigenschaft des Geistes, daß er denGeist ewig anregt“ (HA Bd. 12, S. 287). Dasläßt sich auch der Goethe-Forscher gerne
27OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
gesagt sein. Geschickt greift zum BeispielErnst Cassirer in einem Vortrag dieGoethesche captatio benevolentiae auf undmünzt diese auf Goethe selbst um: „DasBedenken, das hier Shakespeare gegenübergeäußert wird, muß sich in stärkerem Maßejedem aufdrängen, der es heute noch einmalwagt, von Goethe zu sprechen; [...]“(ErnstCassirer: Goethes Idee der Bildung undErziehung. In: ders.: Geist und Leben.Schriften. Leipzig: Reclam, 1993, S. 94).Cassirer fährt fort, daß von Goethes Werkweiterhin jene ewige Anregung ausgehe, derman sich kaum entziehen könne. Das giltnicht nur für Cassirer selbst, sondern fürbeinahe jeden Germanisten, denn es scheintso, als müsse man sich früher oder späterzu den Werken des Geheimen Rates äußern.Gewiß, die von Goethe und seinen Werkenausgehende Faszination ist ungebrochen.Immer wieder bieten sich neue Facetten,neue Sichtweisen und Ansätze fürDiskussionen. Doch ungeachtet derermunternden Worte Goethes und Cassirersmüßte sich die Goethe-Forschung aufgrundihres bloßen Umfanges die selbstkritischeFrage stellen: Goethe und kein Ende?Auch die Bücher von Marino Freschi undIrmgard Wagner müssen sich in diesemSinne zwei fundamentale Fragen gefallenlassen: Was bieten sie dem mit Goethe nichtbesonders vertrauten Leser und was findetder Goethe-Spezialist an Neuem vor. Hiermüßte vor allem die erste Frage beantwortetwerden, denn beide Bücher bieten imengeren Sinne keinen Beitrag zurDiskussion über Spezialfragen derForschung (obwohl Freschi seinem Bucheinen sehr kompakten Forschungsüberblickbeifügt und der vieldeutige Untertitel eineAuseinandersetzung mit „l’insidia dellamodernità“ in Aussicht stellt). Vielmehr sindsie, wie der jeweilige Obertitel „Goethe“vermuten läßt, als kompakte Einführungenzu Leben und Werk für Nicht-Fachleutegedacht.Während das anfangs erwähnte Goethebuchvon Karl Otto Conrady eine derartigeEinführung noch auf mehr als 1100 Seiten
entfalten konnte („So war ich trotz derbeachtlichen Seitenzahl, die mir der Verlageingeräumt hat, zur Konzentration auf dasWichtige gezwungen“ Conrady; S. IX),versuchen Wagner und Freschi Ähnlichesauf nur 250 Seiten zu leisten. Um wie vielesstärker muß auf so knappem Raum der Gradan Konzentration auf das Wichtige sein undeine entsprechend rigorose Auswahlgetroffen werden, um eine gewisseAusführlichkeit bei der Betrachtung derwesentlichen Werke zu gewährleisten? Oderwill man ein so komplexes Werk wie dasGoethesche in seiner Ganzheit in einerallgemein gehaltenen Zusammenschaubieten? Der Verfasser einer Einführung zuGoethes Werken sieht sich also zumLavieren zwischen Skylla (=Detailverliebtheit) und Charybdis (=Oberflächlichkeit) gezwungen und hier liegtzugleich das Dilemma derartiger Bücher;vor allem wenn sie sich mit sofacettenreichen Autoren wie Goethebeschäftigen. Sinnvollerweise hat sichIrmgard Wagner für ihre „Zugänge zumWerk“ weise Selbstbeschränkung auferlegtund die autobiographischen wie auch diewissenschaftlichen Werke Goethesweitgehend ausgeklammert. Wagnerversteht ihr Werk als „Gebrauchsbuch“, dassich an Leser wendet, „die mit demunstreitig bedeutendsten Dichter nicht nurdes deutschen Kulturkreises, sondern derModerne überhaupt nähere Bekanntschaftschließen, oder während der Schulzeitvermittelte Eindrücke auffrischen, erweiternund vertiefen möchten.“ (Wagner; S. 9)Daher handelt sie Goethes Biographie ingroben Zügen am Anfang ab und wendetsich anschließend einzelnen Werken zu, diein einem sehr sachlichen Stil und mitständigem Blick auf die literarische Formabgehandelt werden. Offenbar hat sie sichGoethes Maxime „Die Form will so gutverdauet sein als der Stoff; ja sie verdauetsich viel schwerer“ (Maximen undReflexionen, HA Bd. 12, S. 471 Nr. 753) zuHerzen genommen. Wagner reiht eine Se-rie knapper, in sich geschlossener Essays
28OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
aneinander, wobei immer auch Hinweise zurRezeption der Werke bei Lesern und in derForschung gegeben werden. Nützlich füreine schnelle Orientierung sind auch diekurzen Inhaltsangaben zu Goetheswichtigsten Werken.
Marino Freschi beschreitet mit seinem„Goethe“ einen riskanteren Weg, indem ersich mit dem gesamten Leben und Werkbeschäftigt. Dabei hält er sich - und hier liegtein weiteres Problem - an die Chronologie:Orientiert man sich streng am roten Fadendes Lebensganges, so müssen bei derchronologischen Abhandlung der Werkeständig Vor- und Rückgriffe in Kaufgenommen werden, insbesondere wenn sichdie Entstehung von Werken wie “Faust”über große Lebensabschnitte hinwegerstreckt oder der zeitliche Abstandzwischen Ereignissen und ihrer literarischenUmsetzung (“Italienische Reise”) sehr großist. Das chronologische Konzept, wie imFalle von Freschis Buch, läßt sich also nurmit Mühe überzeugend durchhalten,weshalb die klassische Künstlerbiographieüber Leben und Werk schon aus solchmethodischen Erwägungen nichtunproblematisch ist. Schmerzlich vermißtman bei Freschis Buch einige einleitendeBemerkungen über Vorgehensweise,Textauswahl, Grundtenor, Intention und diemögliche Zielgruppe seiner Studie. Er stürztsich stattdessen in medias res und beginnt,wie könnte es anders sein, mit denberühmten Eröffnungsworten von“Dichtung und Wahrheit”. Überhauptvertraut Freschi bereitwillig denautobiographischen Schriften, Briefen undGesprächen Goethes, während er dieeinzelnen Lebensstationen abschreitet.Kritische Anmerkungen zum Quellenwertund zur Selbststilisierung Goethesunterbleiben aber leider allzu häufig.Leben und Werke stehen bei Freschi ineinem sehr engen Zusammenhang. Greifenwir beispielsweise die Ausführungen überdie Sesenheimer Gedichte, hier das Gedicht“Mailied” (das leider nur in italienischer
Übersetzung zitiert wird) heraus: „Questafamosa poesia - [...] - è la conferma cheGoethe ama essere amato e che il suo senti-mento amoroso, la sua passione, cui alludequel “sangue caldo” è alquanto in ombranell’economia della poesia che è anzitutto uncanto di risveglio cosmico della primavera,più di amore universale che di passione sin-gola, liberamente intonato, con una travol-gente, rivoluzionaria liricità che comprimemetafore e ritmi. E questa volta vi è l’effettoirradiante dell’amore che suggerisce nuovicanti e balli al poeta non tanto perché amaquanto piuttosto perché è amato” (Freschi;S. 51). Gegenüber Freschis etwasschwelgerischer Deutung des Gedichts, beider er das Gefühl zunächst auf eineüberindividuelle Ebene hebt, um es dannwieder in den Bereich des Biographischenzurückzuholen, wirkt Wagners Interpretationregelrecht unsinnlich und etwasschulmeisterlich: “Mailied gilt als dasgelungenste der Sesenheimer Lieder. KeineSpur mehr von der überlastigenFormgebundenheit in Willkommen undAbschied: der auffälligen Zweiteilung derStruktur, den langen Strophen mit ihrenregelmäßig gereimten Langzeilen. Mailiederscheint dem unmittelbaren Hören nahezuformfrei. Gereimte wechseln mit reimlosenZeilen ab, der Reim ist durchaus männlich,d.h. minimal, da er nur jeweils eine Zeileumfaßt” (Wagner; S. 42). Konträrer könnenInterpretationen ein und desselben Texteskaum sein. Man könnte noch viele weitereBeispiele für die Unterschiede zwischenFreschis und Wagners Betrachtungs- undDarstellungsweise anführen. So enthaltenbeide Bücher jeweils ein Kapitel über Faust,wobei Wagner ihren Beitrag unter dasLeitmotiv der eigenwilligen und innovativenGestaltung von Mythen in Goethes Werkstellt. Sie zeigt, wie Goethe sichmythologische und mythische Vorlagen,darunter auch den Fauststoff selbst,anverwandelt und - wie etwa im zweiten Teildes Faust - ganz neue Mythen erfindet (dieMütter im ersten oder Euphorion im drittenAkt). Auch Freschi stellt ein ganzes Kapitel
29OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
unter den Titel „Faust“, allerdings schildertder Autor zunächst Goethes Rückkehr ausItalien, seine Emanzipierung von HerzogCarl August und Frau von Stein, seineBeziehung zu Christiane Vulpius undweitere lebensgeschichtliche Fakten.Anschließend geht Freschi kurz (und etwasoberflächlich) auf die Römischen Elegienein, bevor er zur Entstehungsgeschichte desFaust kommt. Mit Inhalt und Form beiderTeile des Faust setzt sich Freschi in äußerstkonziser aber wenig kompakter Weiseauseinander, denn auch hier kommt es zu„Sprüngen“. Überdies krankt die Inter-pretation etwas am Fehlen eines (zumindestfür den Rezensenten nicht ohne weitereserkennbaren) roten Fadens, zumal Freschiimmer wieder Querverweise auf dieEntstehung anderer Werke Goethes einstreutoder auch Hinweise auf die Rezeption desFaust in Italien. Diese „Unentschlossenheit“läßt sich an den Passagen über Gretchen undFaust verdeutlichen: „La sua tragedia poiimprovvisamente si trasforma in un’altra,umanissima e commovente, quella diGretchen e del suo amore, della sua dedi-zione e dell’abissale pulsione erotica e sen-timentale del mago. E’ di nuovo lareiterazione di quella colpa che Goethe haprovato abbandonando Friederike ed elu-dendo tutte le aspettative d’amore che hapur risvegliato, non incolpevole, con la suaseducente personalità“ (Freschi; S. 137).Freschi fährt mit Einlassungen über GoethesBindung zu Cornelia und Eisslerspsychoanalytische Deutung dieser beinaheinzestuösen Beziehung und deren Über-windung während des römischen Aufent-haltes fort, um dann zu dem autobiogra-phischen Gehalt Fausts zurückzukehren, deranhand einer Äußerung Goethes gegenüberEckermann belegt werden soll.Derartige Beispiele mögen als willkürlichaus dem Zusammenhang gelöst erscheinen,aber es geht dabei weniger um inhaltlicheStärken und Schwächen als vielmehr umdivergierende Darstellungsweisen, die sichaus unterschiedlichen methodischenAnsätzen bei vergleichbarem Inhalt und
Umfang ergeben. Die beiden hiervorgestellten Bücher stellen tatsächlich zweikonträre Möglichkeiten dar, sich extensiv(Freschi) oder intensiv (Wagner) auf relativwenigen Seiten mit Goethe zu beschäftigen.Freschis Buch enthält sicherlich zahlreicheinteressante und anregende Gedanken, aberinsgesamt stellt sich bei der Lektüre derEindruck ein, als sei das Streben nach einermöglichst vollständigen Auseinander-setzung mit Leben und Werk Goethes einkaum zu leistendes Unterfangen. Dieseskritische Resümee gilt - in nicht ganz sostarkem Maße und mit einer Akzent-verschiebung - für Irmgard Wagners Buch,dessen Stärke gerade in der Beschränkungund der Klarheit der Darstellung liegt.
Christoph Nickenig
Walter Benjamin, Il dramma barocco tede-sco, introduzione di Giulio Schiavoni, nuo-va edizione, Einaudi, Torino, 1999, pp.XXXV + 220, £. 36.000
Walter Benjamin, I “passages” di Parigi, acura di Rolf Tiedemann, edizione italiana acura di Enrico Ganni (Opere complete diWalter Benjamin, a cura di Rolf Tiedemanne Hermann Schweppenhäuser, edizione ita-liana a cura di Enrico Ganni, vol. IX),Einaudi, Torino, 2000, pp. XXXVI + 1.182,£. 130.000
I due volumi benjaminiani recentementepubblicati da Einaudi, pur differendo per lacollocazione editoriale - il primo è ospitatonella collana “Biblioteca Einaudi”, mentreil secondo figura tra le “Grandi opere” -,sono accomunati dal loro offrirsi come nuo-ve edizioni di testi a suo tempo già tradottie proposti dalla casa torinese. Tuttavia, icriteri filologici che paiono presiedere alladecisione di ripresentare in una veste muta-ta tanto lo studio sulla drammaturgia baroc-ca quanto il materiale che sarebbe dovutoservire a Benjamin per la stesura del pro-
30OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
gettato libro sul secolo XIX, un’epoca daosservare attraverso il vetro e il ferro deipassages parigini, determinano esiti contra-stanti e senza dubbio, almeno nel caso delPassagenwerk, destinati a stimolare un di-battito che sin d’ora si può prevedere asproe serrato.Malgrado siano trascorsi più di settant’annidalla sua pubblicazione per i tipi dell’edito-re berlinese Ernst Rowohlt, il testo baroccodi Benjamin continua ancor oggi a patire ipregiudizi ideologici e a scontare i mador-nali errori di valutazione scientifica che nedecretarono dapprima l’incredibilestroncatura nella sua veste originaria diHabilitationsschrift e ne segnarono in se-guito le molte traversie critiche. Per talemotivo va salutata con soddisfazione la nuo-va edizione italiana di Ursprung desdeutschen Trauerspiels, che rivede, con si-gnificative varianti, la traduzione di EnricoFilippini ospitata nell’ormai storicovolumetto della collana einaudiana “Ricer-ca critica”, risalente al 1971. E se in quel-l’occasione il densissimo studio su alcunifondamentali aspetti della drammaturgia epiù estesamente della spiritualità della Ger-mania del Seicento - perché tale vuol esse-re in primo luogo Il dramma barocco tede-sco, con buona pace di chi si ostina afrapporre fra sé e la pagina di Benjamin ildiaframma della lettura lukácsiana che pre-tende di interpretarla come “il riferimentopiù intimo all’odierna letteratura di avan-guardia” (Georg Lukács, Il significato at-tuale del realismo critico, Torino 1957, p.48) - conobbe la propria divulgazione in Ita-lia con il corredo di un’autorevolepostfazione di Cesare Cases, la nuova e pre-cisa traduzione di Flavio Cuniberto è pre-ceduta da un prezioso saggio introduttivoscritto da Giulio Schiavoni, che l’ha intito-lato in modo eloquente Fuori dal coro. Ineffetti, Il dramma barocco tedesco presentai risultati di una ricerca scrupolosa, ma persfortuna di Benjamin condotta in palese di-saccordo con la Geisteswissenschaft orto-dossa e conformista dell’epoca, la stessa chein un accesso di cieca boria negò all’intel-
lettuale berlinese la libera docenza motivan-do tale assurda decisione, non senza una buo-na dose di involontaria comicità, con la con-statazione secondo cui “den Geist kann mannicht habilitieren”. Uno dei principali meritidell’introduzione al ‘libro barocco’ consisteappunto nella meticolosa e documentata ri-costruzione dell’”inquietante disavventuraaccademica francofortese” (p. X) vissuta daBenjamin; d’altro canto, in questa sedeSchiavoni rinnova l’ipotesi suggestiva, e tut-to sommato fondata, che il fallimento diFrancoforte abbia rappresentato per lo stu-dioso un rischio calcolato, “una perdita dacui egli ebbe forse solo da guadagnare, al-meno sotto il profilo dell’indipendenza intel-lettuale” (p. IX). E se continua ad offenderela pochezza degli argomenti addotti a giusti-ficare il giudizio negativo di cui lo scrittobenjaminiano fu vittima - la relazione di HansCornelius sulla Habilitationsschrift si riassu-me in fondo nel richiamo ad un “incompren-sibile modo di esprimersi, da intendere sicu-ramente come un indice di confusione obiet-tiva” (cit. a p. XIX) -, dall’exposé inviato daBenjamin allo stesso Cornelius, opportuna-mente tradotto e inserito nell’introduzione in-sieme con la menzionata relazione, non è dif-ficile dedurre l’assenza di una qualsiasi vo-lontà chiarificatrice da parte del candidato.Del pari, già al momento della sua stesura,completata nel 1925, lo scritto in questionesi poneva in stridente contrasto con gli indi-rizzi della coeva Barockforschung tedesca, inuna pulsione antagonistica che si dimostreràpoi ancor più pronunciata in rapporto ai fu-turi sviluppi degli studi sul Seicento; il testobenjaminiano è infatti tutt’oggi valutato dapiù parti a guisa di un intervento estempora-neo, di cui non è possibile tacere i meriti, mache, osserva Schiavoni con la giusta pointepolemica, “viene poi di fatto neutralizzato nelmomento in cui ci si mantiene a rispettosadistanza da esso” (p. XXII, n. 31). In questosenso, nell’introduzione si dà conto delle va-rie posizioni emerse nel corso di un dibattitotrentennale (talora assai vivace, come nel casodello scambio di opinioni che tra il 1971 e il1973 vide protagonisti Cesare Cases e Ro-
31OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
berto Calasso), durante il quale taluni set-tori della vita culturale italiana si sono rive-lati ben più preparati di quelli d’oltralpe araccogliere la “sfida di Benjamin nei con-fronti dell’estetica e della Kunstwissenschafttedesca” (p. XXVII) e a percepire la voceisolata de Il dramma barocco tedesco fuorida un altro coro, quello di un’interpretazio-ne della letteratura e in generale della cul-tura del Seicento tedesco risultante dalladeleteria alleanza tra idealismo e storicismo,che Benjamin tiene in scacco strutturandola sua ricerca come un trattato, vale a dire“una forma di scrittura dall’andamento di-scontinuo che è basata sull’indugiomicrologico e che trasforma il testo in spa-zio di un’esperienza anziché in una chiari-ficazione concettuale” (p. XXVI).Occorre però aggiungere che riproporreoggi questo testo benjaminiano ai lettori ita-liani comporta la necessità di misurarsi conlo stesso problema che oltre quarant’anniorsono assillò Renato Solmi, il quale esclu-se il “trattato allegorico-erudito” dallasilloge Angelus Novus sia per le dimensio-ni sia per l’argomento, “da noi praticamen-te sconosciuto” (Introduzione a WalterBenjamin, Angelus Novus. Saggi e fram-menti, trad. it. di Renato Solmi, Torino 1962,pp. XVI e XIV). Bene fa allora Schiavoninella sua introduzione ad insistere sulla pe-culiarità dell’approccio benjaminiano allacultura del Barocco, evidenziandone la sin-cera attitudine eversiva nei confronti di unatradizione sintetizzata dal duro giudiziolukácsiano e dalla negativa e semplicisticavalutazione crociana del complesso dell’artee dell’estetica seicentesche, che imprigio-nano la civiltà barocca in un meccanismodi pesi e contrappesi ideologici e confes-sionali, che ora recano impresso il marchiodel cattolicesimo post-tridentino, ora espri-mono la crisi e il ripiegamento di unluteranesimo ormai arroccato su posizionidifensive e conservative. Inserite nella lorocornice originale di critica antistoricistica eantiidealistica, le riflessioni sul Trauerspielsi palesano in tutta la loro complessa e af-fascinante coerenza a chi si voglia accosta-
re ad esse tenendo a mente il passo dell’in-troduzione in cui si nomina “la volontà disalvare la frammentazione dei fenomeni,adunati attorno all’idea stessa di Trauerspielnella sua compiutezza monadica, attraver-so un accurato procedimento analitico chericorda la sistemazione dei tasselli di unmosaico e in cui la ricostruzione del tutto ègarantita mediante la combinazione dellevarie parti” (p. XXV). In base a tali indica-zioni, affrontare la lettura del Dramma ba-rocco tedesco, partendo dalla ricchissimaPremessa gnoseologica - nell’abbagliantevisione di Gershom Scholem “l’angelo conla spada fiammeggiante del concetto all’in-gresso di un paradiso della scrittura” (cit. ap. XXIII), equivale ad inoltrarsi assieme aBenjamin nel mondo dell’assolutoimmanentistico del Trauerspiel, sapendo chela scelta del trattato che ha per oggetto unpeculiare fenomeno artistico salvaguarderàl’opera dal rischio di configurarsi quale ari-da speculazione filosofica o, all’opposto,arrischiata operazione esegetica. Fa fede ditale convinzione l’idea, espressa nella Pre-messa, che il Barocco non sia “tanto un’epo-ca d’arte in senso proprio, quanto un’epocadella volontà artistica ostinata” (p. 29), làdove nella nuova edizione l’originale “einZeitalter weniger der eigentlichenKunstübung als eines unablenkbarenKunstwollens” (Gesammelte Schriften, vol.I/1, p. 235) viene reso in una forma forsepiù libera, ma senz’altro più efficace rispet-to alla versione del 1971, che qui leggeva ap. 35 “un’epoca meno segnata dal vero eproprio esercizio dell’arte che non da unincontenibile volere artistico”. E a volersisoffermare sulla Premessa gnoseologica,vera e propria chiave di volta del testo ba-rocco benjaminiano, anche l’avvertimentocon il quale l’autore sigilla le pagineintroduttive e istruisce chi lo voglia seguiresulla scabrosità del cammino da compiererisuona ora più intimamente connesso conl’intenzione di ‘salvare’ un’epoca dello spi-rito dall’aggressione storicistica: difatti le“ungeheuren Tiefen der Barockstimmung”(GS I/1, p. 237), che sempre minacciano di
32OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
spalancarsi ad inghiottire chi precipiti dallevette della conoscenza, risultano ben piùterribili se tradotte con “spaventosi abissidell’anima barocca” (p. 31), in luogo delle“spaventose voragini dello stato d’animobarocco” che comparivano a p. 37 dell’edi-zione del 1971.Il dissidio, abilmente aggravato da Benjaminfino a renderlo incompatibilità e dicotomia,tra tragedia aristotelica (e convenzionedrammatica comune alle letterature europeemoderne, con poche e significative eccezio-ni, come quella rappresentata da Calderón)e Trauerspiel, e poi tra simbolo e allegoriane Il dramma barocco tedesco si gioca tut-to secondo le regole di una dialettica degliestremi, di cui Gryphius, Lohenstein,Hallmann si rivelano maestri; e si tratta delleregole riassunte da Schiavoni nellafigurazione paradigmatica dell’allegoriabarocca in cui “la finitezza viene annienta-ta, ma al tempo stesso salvata” (p. XXXIV).Si apre in tal modo agli occhi dello studio-so del fenomeno Trauerspiel quel vertigi-noso panorama soltanto immaginato nellaPremessa gnoseologica, quella “estasi del-la creatura”, rappresentata dalla parola, che“è denudamento, dismisura, impotenza da-vanti a Dio”, e nel dramma barocco si tra-sforma in opzione artistica attraverso lascrittura, che rispetto alla parola “è il suoraccogliersi, è dignità, superiorità,onnipotenza sulle cose del mondo” (p. 177).Sia consentita un’ultima, marginale anno-tazione: nel contesto di un’edizione precisae puntuale, perché non imitare l’originaleSuhrkamp, riportando anche, in alto a de-stra nelle pagine dispari, gli illuminanti ti-toli dei brevi paragrafi in cui Benjamin ave-va suddiviso i due grandi capitoli del libro?
La pubblicazione dell’undicesimo volumedelle Opere di Benjamin nella traduzioneitaliana segna una svolta molto importantenell’annosa disputa che vede contrappostida una parte Rolf Tiedemann e HermannSchweppenhäuser, i curatori delleGesammelte Schriften benjaminiane edite daSuhrkamp, e dall’altra Giorgio Agamben,
che fin qui aveva curato l’edizione einaudianaattenendosi ad un ordine cronologico mai ri-conosciuto nella sua validità dagli studiosifrancofortesi. Questi ultimi, in una Avvertenzaeditoriale che fatica ad ingentilire i toni esa-cerbati da una polemica protratta troppo a lun-go, dichiarano ora di accettare in luogo diAgamben la curatela dell’edizione italiana esi impegnano a mantenere l’impostazione delloro predecessore, pur continuando a dubita-re della convenienza della linea finora segui-ta e asserendo di adottare tale scelta solo “percoerenza editoriale” (p. VII). Ma un’afferma-zione immediatamente successiva rinsalda lacongettura che dietro la riproposta delPassagenwerk si celi la volontà di rivalsa diTiedemann e Schweppenhäuser: “Nel presen-te volume”, scrivono i nuovi curatori delleOpere di Benjamin, “non si è tenuto contodelle modifiche introdotte a suo tempo daAgamben, riavvicinando così questa edizio-ne a quella tedesca” (p. VII). A ben vedere, il‘riavvicinamento’ si limita in fondo al ripri-stino dell’ordine con cui l’edizione tedesca,nel 1982, aveva raccolto ed esposto nel quin-to volume delle Gesammelte Schriften il ma-teriale di appunti e citazioni riunito daBenjamin nelle sue carte sotto la lettera J: sitratta della sezione del lavoro preparatorio peril grande libro parigino dedicata allo studiodi Baudelaire, che Agamben risistemò, perla traduzione italiana del Passagenwerk dalui curata e pubblicata nel 1986 con il titoloParigi, la capitale del XIX secolo, alla lucedel ritrovamento, nel luglio del 1981, di al-cuni convoluti che integravano il contenutodei manoscritti affidati da Benjamin aGeorges Bataille e da questi nascosti nellaBibliothèque Nationale di Parigi. Ora, la se-zione J è sì la più ponderosa tra quelle cheBenjamin aveva organizzato quale ipotesi dilavoro per l’opera che si andava configurandocome il suo Lebenswerk, ma questo non ba-sta ad allontanare un sospetto che si rafforzaconsiderando la sostanziale identità delle duetraduzioni qui in causa. Se è vero che i nuovicuratori dicono di aver ripreso con sporadi-che revisioni e correzioni i testi della prima,eccellente traduzione italiana, pare legittimo
33OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
interrogarsi sull’effettivo significato diun’operazione editoriale che a conti fatti nonprovvede tanto a colmare una lacuna nelladiffusione dell’oeuvre benjaminiano in Ita-lia, quanto piuttosto indulge ad avanzarepresunti diritti di proprietà e a regolare vec-chie controversie che di certo fino a questomomento non hanno giovato ad una discus-sione serena e pacata intorno alla produzio-ne dell’ultimo Benjamin.Con ciò, non vanno passati sotto silenzio imeriti da ascrivere ai “passages” di Parigi:così, grazie a questa edizione si puòauspicare un risveglio dell’interesse attor-no ad un’opera che nulla ha perso della stra-ordinaria tensione intellettuale che ne rav-viva ogni singolo episodio e traspare nelfulgore dell’onestà sottesa al frammento N18, 8, vera e propria dichiarazioneprogrammatica in cui Benjamin scrive:“Metodo di questo lavoro: montaggio lette-rario. Non ho nulla da dire. Solo da mostra-re. Non sottrarrò nulla di prezioso e non miapproprierò di alcuna espressione ingegno-sa. Stracci e rifiuti, invece, ma non per far-ne l’inventario, bensì per rendere loro giu-stizia nell’unico modo possibile: usandoli”(p. 514). A tale proposito, fa piacere notarein apertura del volume la traduzionedell’esaustiva introduzione di Tiedemannall’edizione francofortese del 1982: la let-tura degli appunti parigini di Benjamin, perla mole e per l’ampiezza dei riferimenticulturali che confluiscono in questo immen-so bacino, necessita infatti di una guida,funzione assolta in maniera egregia dallepagine introduttive del curatore, che man-tengono tutta la loro chiarezza anche a di-stanza di anni dalla loro redazione.Ma sono soprattutto le considerazioni cheTiedemann dedica all’agitato interrogarsi diBenjamin sui concetti di storia e distoriografia a calare il lettore nella reale di-mensione dialettica del Passagenwerk, ac-compagnandolo in una ricognizione rapidaeppure accurata degli anni che seguono lasupposta svolta del filosofo berlinese versoil materialismo storico e collimano con itempi della lunga e incompiuta gestazione
del libro parigino. “Le fonti metafisiche, difilosofia della storia e teologiche, da cui era-no scaturite tanto le opere esoteriche del suoprimo periodo quanto i grandi lavori d’este-tica fino al Dramma barocco tedesco, nonerano ostruite e avrebbero nutrito anche ilPassagenwerk” (p. XX), anticipa Tiedemannprima di condurci nell’officina letteraria diBenjamin, tra strumenti analitici di volta involta forgiati dalla sociologia marxiana edalla relativa denuncia del feticismo dellamerce (ma quanto più feconda della letturadel Capitale, ci ricorda il curatore, fu perl’esule la scoperta del Blanqui visionario diL’eternité par les astres!), dall’ambiguaflânerie baudelairiana, dove il nuovo mon-do borghese e metropolitano si disvela comefantasmagoria, sogno ad occhi aperti, op-pure dall’idea epifanica della salvazione,sempre da cogliere nella potenza deflagrantedell’istante in cui anche l’immagine del pas-sato “diviene immagine che dialetticamentesi rovescia, quale si mostrerebbe dalla pro-spettiva del messia o, in termini materiali-stici, della rivoluzione” (p. XXXII). Del tut-to opportuno appare quindi l’invito, rivoltodal curatore, ad iniziare la lettura del mate-riale raccolto da Benjamin dai due exposésdel 1935 e del 1939, il cui confronto con-sente di gettar luce sui profondi mutamentiintervenuti nella concezione storico-politi-ca del critico berlinese nel quadriennio tra-scorso tra le due relazioni. Non sembra in-vece giustificabile né motivata la pedante-ria con cui si suggerisce al lettore, in questoe in altri episodi reputato alla stregua di unosprovveduto, di “limitarsi in un primo mo-mento ai passi stampati in corpo maggiore,riservati alle riflessioni di Benjamin, e aquegli excerpta in qualche forma da lui com-mentati, anche se solo a livello embrionale”(p. XXXV), se subito dopo si insiste, ren-dendo giustizia alla metodica alacrità del-l’indagine benjaminiana, “sul fatto che lalettura di tutte le annotazioni, lo studio an-che dell’ultimo e più sperduto appunto, per-mette di intendere appieno le intenzioni del-l’autore” (p. XXXVI). Ribadendo che I“passages” di Parigi ripropone pari pari la
34OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
prima versione italiana, fatte salve poche einsignificanti revisioni della traduzione del1986 e una collocazione lievemente modi-ficata delle sette sezioni all’interno del vo-lume (in base ad “una sequenza di stampadei testi che non corrisponde alla cronolo-gia della loro stesura”, vien detto a p. 1180nella conclusiva Nota ai testi, quasi a volerdisapprovare persino in extremis i criteri diAgamben), resta da chiedersi perché anchedopo la svolta editoriale si sia rinunciato adintegrare le Opere di Benjamin con la tra-duzione del sontuoso e utilissimo apparatocritico-filologico che correda ogni volumedelle Gesammelte Schriften, perseverandoin tal modo in una decisione già biasimatada molti recensori, primo fra tutti FerruccioMasini sulle pagine de “L’Unità” del 19marzo 1982, all’indomani della pubblica-zione del primo volume dell’edizione ita-liana degli scritti di Benjamin. Continuainoltre a suscitare perplessità la scelta di tra-scrivere i testi e le citazioni in francese delPassagenwerk: come ha giustamente rileva-to Elisabeth Galvan parlando della recentetraduzione italiana del saggio benjaminianosu Bachofen, il francese del filosofoberlinese “presenta molteplici spunti di in-dagine e potrebbe stimolare la curiosità dichi traduce” (“Osservatorio Critico dellagermanistica” II - 4, p. 16). Ad esempio,perché costringere il lettore poco avvezzoalla frequentazione della lingua diBaudelaire a consultare il dizionario di fron-te all’asserto secondo cui “Le visage de lamodernité elle-même nous foudroie d’unregard immémorial” (p. 30)? Un’altra tra-duzione, tuttavia, compare alla fine del vo-lume a risollevarne le sorti dal punto di vi-sta della correttezza filologica: si tratta del-le 176 lettere, solo in parte già pubblicatein italiano in altre sedi, che costituiscono leTestimonianze sulla genesi dell’opera ripre-se dall’edizione tedesca e che, malgradooccorra convenire con il curatore che“Benjamin fu un corrispondente ‘cauto’,scrisse lettere tenendo sempre conto deldestinatario e molto spesso serbò per sénotizie fondamentali” (p. 1026), servono ad
illuminare le peregrinazioni materiali e spi-rituali dell’intellettuale berlinese. Nel carteg-gio intrattenuto con Kracauer, Scholem,Adorno e Horkheimer, Benjamin si confes-sa alla ricerca, talora spasmodica, diinterlocutori che lo aiutino a proseguire ilcammino verso la salvazione, il momento delrisveglio, verso l’immagine “in cui quel cheè stato si unisce fulmineamente con l’ora inuna costellazione” (p. 516).
Stefano Beretta
I mille volti di Suleika. Orientalismo edesotismo nella cultura europea tra ‘700 e‘800, a cura di Elena Agazzi, Roma,Artemide Edizioni, 1999, pp. 253, L. 50.000
La scena “alla turca” inserita in Le bourgeoisgentilhomme (1670), comédie-ballet, comevenne battezzato il genere nato dalla colla-borazione fra Molière e Lully, costituiva unmomento di parodia ironica e sagace delgusto ‘turchesco’ allora di gran moda in Eu-ropa. Nel 1918, la cerimonia turca espuntanella prima rielaborazione del Bourgeoismolièriano, Der Bürger als Edelmann, rea-lizzata nel 1912 come prologo dell’Ariadneauf Naxos da Hofmannsthal e Strauss,rioccupò il luogo che le era stato assegnatonel Seicento e sancì, dopo tante amarezze edifficoltà, il successo della discussa opera-zione voluta dallo scrittore austriaco.Parodistica citazione e libera invenzionemelodica, il sorriso malinconico di un’epo-ca alla deriva e il gusto di una teatralità ba-rocca, cui dava spazio la messinscena di MaxReinhardt, prendevano le mosse ancora unavolta dalla suggestione di atmosfere orien-tali, da quella curiosità per “l’altro da sé”,per una alterità antropologica e culturale pro-tagonista di quel gusto esotico che, con dif-ferenti valenze e spesso contrastanti risvol-ti, ha attraversato la cultura europea fra Set-tecento e Ottocento.L’appassionante vicenda dell’esotismo inEuropa ha costituito uno dei luoghi privile-
35OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
giati dei molteplici interessi di GiorgioCusatelli, maestro di più di una generazio-ne di germanisti (e non solo), al quale è de-dicato, in occasione del suo settantesimocompleanno, il volume I mille volti diSuleika. Orientalismo ed esotismo nella cul-tura europea tra ‘700 e ‘800, apparso per itipi di Artemide a cura di Elena Agazzi. Ilvolume miscellaneo offre, dopo e insieme aIl paese altro. Presenze orientali nella cul-tura tedesca moderna (Napoli 1983), unapreziosa sintesi del dialogo fra cultura tede-sca e Oriente, degli itinerari letterari e arti-stici dipanatisi in Germania a partire dalmondo orientale, di continuo definito eridefinito come luogo ora di una diversitàantropologica, religiosa, politica, ora comeoccasione per la costituzione di quel feno-meno che Elena Agazzi definisce, con feli-ce formula, di “auto-esoticismo” (Presen-tazione, p. 8).Nell’efficace sintesi tracciata dalla curatri-ce del volume, si ripercorrono le tappe checonducono dai prodromi degli studisull’orientalismo, rappresentati dalle pagi-ne dedicate da Herder alla cultura araba (ar-gomento su cui è incentrato lo studio diMargherita Cottone, Herder e la poesia ara-bo-islamica, pp. 59-67), passando attraver-so quel pilastro dell’edificio esotico costi-tuito dalle pagine del West-östlicher Divandi Goethe (ai cui aspetti “reattivi” e polemi-ci è dedicato lo scritto di GiuseppeBevilacqua, Goethe, Rückert e le Rosed’Oriente, pp. 127-135), soffermandosi sul-l’apertura dei romantici nei confronti dellacultura indiana e di quella cinese, fino al-l’esigenza moderna di rifuggire da ogni ten-tazione di “esotizzare” il mondo orientale ealla recente consapevolezza di una ricogni-zione delle diversità quale chiave di letturadella più autentica identità storico-politicadi popoli lontani, spesso infruttuosamenteassimilati in un unico profilo dai tratti indi-stinti e poco perspicui.La curatrice schizza anche una vivace pa-noramica di quei fenomeni di spettacolariz-zazione dell’esotico nelle avventure orien-tali di Richard Burton e dello ‘stravagante’
Pückler-Muskau, delle influenze chel’Oriente ha esercitato sulle arti figurativein tutta Europa, in coincidenza con la con-quista dell’Algeria e in vitale interazione conspunti letterari d’ispirazione esotica.L’Oriente si rifrange in mille immagini benlumeggiate dagli snelli ma significativi con-tributi del volume: come patria ideale di unasapienza antica, ma anche come sede di una‘barbarie’ dei costumi, proiezione di tantedegenerazioni morali provocate in Europadalla civiltà, viene presentato il regno diScheschian, nella sua preistoria e nel suoepilogo, nel romanzo politico wielandianoDer goldne Spiegel, come mette a fuocoBianca Cetti Marinoni nel suo saggio sullafunzione utopica e di verosimiglianza psi-cologica dell’ambientazione indiana delloSpecchio (Wieland tra realtà e utopia, pp.43-51); come luogo di una alterità intesacome antitesi ai mali d’Europa si connotal’Oriente nei romanzi poco noti di FriedrichMaximilian Klinger, indagati da Federica LaManna (I romanzi orientali di FriedrichMaximilian Klinger, pp. 69-77); come luo-go d’origine di lingua e poesia, cultura eciviltà, l’Oriente viene eretto a sommo toposdi un “grande Tutto” (Schlegel) dalla cultu-ra romantica, appassionata di storie delleorigini: agli scritti di Schlegel cheenucleano, a partire da un fitto dialogo conla cultura indiana, indoeuropea, asiatica ingenerale, i fondamenti delle teorie romanti-che, è dedicato il denso studio di MicheleCometa, Friedrich Schlegel tra Oriente eOccidente (pp. 87-98), che si sofferma sul-le tesi sviluppate nelle celebri lezioni,Geschichte der europäischen Literatur eGeschichte der alten und neuen Literatur, ein altri fondamentali scritti quali Übernordische Dichtkunst, sottolineando, al di làdell’apparente inversione di marciaregistrabile durante il periodo viennese conl’opzione a favore del carattere nazionaledelle saghe rispetto alla tesi della “mesco-lanza”, la grande portata innovativa delleintuizioni di Schlegel, riscontrabile anchein frammenti non destinati alla pubblicazio-ne.
36OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
Alcuni contributi toccano motivi sommer-si, curiosità e particolari del variopinto mo-saico ricostruito nelle pagine del volume:come quello di Elvio Guagnini, Esotismi del“Caffè” (pp. 35-41), dedicato a uno deitopoi esotici diffusi in ambito illuminista,dove la bevanda “d’oltremare” “assurge asimbolo e indice di una possibile conquistadi ragionevolezza” (p. 36) e il locale ad essadedicato a luogo di una moderna forma disocialità, divenendo motivo letterario privi-legiato per una critica sottile e arguta ai vizidella civilizzazione; o quello di EugenioSpedicato, Jean Paul, l’orientale (pp. 99-107), incentrato intorno al significatodell’“orientalità” in Jean Paul, definita “unatecnica di sopravvivenza, una sorta di sportestremo per farsi apprezzare da un pubbli-co sempre alla ricerca di punti esclamativi”(p. 102).In alcuni studi, l’indagine di un particolareaspetto del gusto esotico diviene preziosachiave di lettura dei nodi cruciali del feno-meno. Questo è il caso dell’affascinante ana-lisi al microscopio realizzata da AnnaChiarloni della lirica goethiana Vollmond-nacht, di cui la studiosa fornisce una nuovainterpretazione avanzata sulla base di un’in-dagine minuziosa del testo e alla luce dellasua genesi inscritta in un delicato momentodella biografia goethiana: il prestito da Hafisdiviene stralcio di una composizione chenella citazione dell’antico esprime dissonan-ze e inquietudini moderne (Für Liebende istBagdad nicht weit. Su di un prestito persia-no nel Divan di Goethe, pp. 117-125). Ed èanche il caso dell’appassionante studio diAlessandro Fambrini articolato, come ungioco di scatole, cinesi intorno all’operazio-ne di “desacralizzazione” dell’esotico effet-tuata, con modalità e risvolti differenti, daE. T. A. Hoffmann e da Chamisso in unaprospettiva che smarrisce, nella percezionedella lacerazione del moderno, anche quel-l’illusione utopica sopravvissuta nello spa-zio dell’esotico (Il sogno di Schlemihl e ilpidocchio di Menzies. Heimatochare di E.T. A. Hoffmann, pp. 149-158).L’Oriente del non “occidentalista” Rückert,
analizzato da Manfred Beller (Der Abend-länder im Morgenland. L’orientalismo let-terario di Friedrich Rückert, pp. 137-147),l’Oriente che si colloca sul punto d’interse-zione fra passionalità e rigore formale deighazal di Platen, indagati da Donatella Maz-za (“Der Turban statt des Hutes”. Riflessio-ni sui ghazal di August von Platen, pp. 158-166), l’ambivalente Oriente vagheggiato congusto oleografico, vissuto come esperienzarigenerante, ma in fine come luogo della de-lusione da Grillparzer nelle tappe del suoviaggio a Costantinopoli e in Grecia ricostru-ito da Nicoletta Dacrema (Verso Oriente. IlTagebuch auf der Reise nach Kostantinopelund Griechenland di Franz Grillparzer, pp.203-212): nei suoi “mille volti” messi in lucein questo volume si proietta quella ricerca dialterità che non è altro che un travestimentodella ricerca del proprio sé, intrapresa in undiscorso infinito con una polifonia di vocilontane.
Grazia Pulvirenti
Giuseppe Dolei, L’arte come espiazione im-perfetta. Saggio su Trakl, Roma, ArtemideEdizioni, 2000, pp.156, £.30.000.
Il volume di Giuseppe Dolei ha il merito diriportare all’attenzione dei lettori GeorgTrakl, poeta troppo spesso confinato nel ruologenerico di cantore del tramonto absburgicoe autore di alcune liriche esemplari da unpunto di vista stilistico e formale. Si trattadella ristampa, riveduta e aggiornata, del-l’omonimo saggio del 1978, pubblicato pres-so lo Heinz Verlag di Stuttgart e ormai esau-rito, che già all’epoca si schierava contro latendenza diffusa a concentrare l’analisi cri-tica su singoli aspetti e singoli componimentidel poeta salisburghese, isolandolo dal con-testo storico-culturale e costruendoattribuzioni, confronti e paragoni più o menostrumentali e approssimativi. Qui l’autorecerca piuttosto di affrontare con serenità e
37OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
obiettività gli sviluppi esistenziali e poeticidella parabola trakliana senza cadere nelleriserve di certa critica che tendeva a sepa-rare il Trakl poeta dal Trakl uomo,sottacendo o trascurando caratteristiche easpetti poco edificanti. A ciò si aggiunserole difficoltà incontrate nella datazione pre-cisa delle liriche che hanno generato equi-voci e confusioni e finito per ricondurre tuttal’opera trakliana alla categoria del “rifugionel mito di un parco atemporale”.Proprio dal sapiente intreccio di vicendebiografiche, ricostruzione di fonti e varian-ti, puntuale analisi dei testi risulta come lapur breve vita e la relativamente limitataproduzione trakliana, un centinaio di liri-che in cinque anni, testimoni un’evoluzio-ne poetica e una ricerca che, pur tragica,non si risolve in un atteggiamento statico ein una ispirazione monocorde. Le tristi vi-cende biografiche di Trakl, il difficile rap-porto con la madre, le vicissitudini scola-stiche, la relazione incestuosa con la sorel-la, l’abuso di alcool e droghe, l’instabilitàmentale, l’incapacità di inserirsi nel mon-do del lavoro, non rappresentano infatti solole tappe di un’esistenza sregolata e infeli-ce, ma si intrecciano con un altrettanto tor-mentato rapporto con la cultura dell’epoca.Al giovanissimo poeta che tenta di usciredalle strettoie del neoromanticismo e checerca invano di farsi strada come critico let-terario e autore drammatico, segue il Traklstudente, farmacista e impiegato fallito chesi accosta in modo contraddittorio e perso-nalissimo ad artisti, correnti e circoli cultu-rali dell’epoca e infine l’outsider che com-pleta il proprio progressivo processo dichiusura nei confronti del mondo esterno.Il saggio prende le mosse da un aforismatrakliano, all’origine del suggestivo titolodel volume, e vi ritorna nella postilla con-clusiva: “Sentimento dei momenti simili aquelli di un morto: tutti gli uomini sonodegni di amore. Al risveglio senti la realtàamara del mondo, in cui c’è tutta la tua col-pa non riparata; la tua poesia un’espiazio-ne imperfetta” (p.136). Mettendo in guar-dia il lettore dal lasciarsi sedurre dalla
musicalità e dall’ardito colorismo della liri-ca trakliana, Dolei analizza il sofferto rap-porto di Trakl con la propria “militanza”poetica, rapporto caratterizzato dalsuperamento di una tradizione culturale con-siderata ormai esaurita e dal tentativo di dareuna dimensione più ampia alle vicende pri-vate, alla ricerca di un ubi consistam esi-stenziale e poetico.Nella ricostruzione delle “tappe esterne dellacrisi” di Trakl, emergono alcuni momentifondamentali nello sviluppo di una poeticaautonoma: dalle premesse simboliste, attra-verso l’espressionismo e l’esperienzastrapaesana del “Brennerkreis”, all’elabora-zione di un proprio originale mondo mitico.A questo proposito l’autore del saggio sot-tolinea come nel caso dell’incontro di Traklcon l’opera di Rimbaud o di Hölderlin sipossa parlare non tanto di un semplice in-flusso, quanto di “elemento catalizzatore diun processo di crescita poetica”(p.30). Pro-prio dall’attento confronto tra testi affini perimmagini e tematiche risulta l’originalitàdella produzione di Trakl. Egli ricava dai“modelli”, reinterpretandoli, solo quegli ele-menti che può inserire nel mondo poeticoche va via via costruendosi, con una rivolu-zionaria opera di combinazione e contami-nazione. Così se da Rimbaud riprende la ca-pacità di trasfigurare “alchimisticamente” larealtà comune tramite parole immaginifiche,in Hölderlin scopre la concezione della po-esia come surrogato dell’esistenza reale,anche se ben presto affiora la tragica consa-pevolezza dell’artista che registra la fine diuna concezione orfica e del cristiano che nonvede più una possibilità di redenzione. Si-milmente l’analisi di Elis o del KasparHauser Lied mostra come la tradizione let-teraria fornisca a Trakl solo lo spunto percreazioni originali.In quest’ottica anche l’incontro di Trakl conl’espressionismo non va sopravvalutato. Lasua innata introversione gli impediva di es-sere parte attiva di un circolo o movimentoletterario, e non basta certo la presenza ditemi comuni o coincidenze biografiche, qua-li la morte in guerra, a farne un autore espres-
38OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
sionista. Nell’uso del colore, ad esempio,Trakl subisce sicuramente la suggestioneprima simbolista e poi espressionista, inparticolare di Kokoschka, ma, come mostral’edizione critica, non è possibile assegna-re un significato univoco ai suoi colori. Allostesso modo il rifugio temporaneo nel“Brennerkreis” corrisponde più ad un bi-sogno di comprensione umana che ad uncomune sentire culturale. La rivista “DerBrenner”, espressione di una letteratura pro-vinciale, conservatrice, bellicista, “agreste”,solo superficialmente può apparire vicinaal motivo trakliano del rifiuto delle “città dipietra”. L’ipersensibile Trakl vede i segnidella corruzione e della decadenza tantonelle città quanto nella campagna, anzi èproprio qui che avviene la distruzione del-l’idillio neoromantico attraverso immaginilontanissime dalle convenzioni.Il ricorso all’epistolario e alle testimonian-ze dei contemporanei si rivela particolar-mente utile nel mettere in evidenza comel’esperienza di vita e poesia di Trakl nonpossa essere semplicemente liquidata neitermini di estetismo asociale e aristocrati-co isolamento. La profonda fede religiosadi Trakl è fonte di sensi di colpa eautocensure laceranti, ma si trova parimen-ti alla base di un forte senso di responsabi-lità verso gli altri e verso la poesia. Trakl èconsapevole di non avere il diritto di “sot-trarsi all’inferno della città moderna” (p.62).Sotto questa luce la sua produzione e le suescelte estreme acquistano una coerenza este-tica e morale e testimoniano un percorso diprogressiva, se pur tragica maturazione.Nell’ultimo denso capitolo, dedicato agliesiti poetici della crisi esistenziale trakliana,l’analisi delle singole liriche, che cerca sem-pre di non perdere di vista una prospettivagenerale, testimonia un percorso che portaalla creazione di vari miti, ripresi dalla tra-dizione classico-biblica e letteraria, fino adarrivare all’originale e potente sintesi delleultimissime poesie. Si tratta di una sorta dicammino penitenziale, di “espiazione” ap-punto, che laicizza la passione cristiana conil ricorso a figurazioni molto distanti tra
loro, ricondotte tuttavia all’unità dalla capa-cità combinatoria di Trakl. Così anche le im-magini più tragiche e annichilenti, l’attrazio-ne per Lucifero, l’inscindibile legame tra na-scita e morte, il tema della stirpe maledetta siaccompagnano alla ricerca eroica di soluzio-ni estetico-esistenziali. In particolare il “mitodell’innocenza” come alternativa alla deca-denza nell’Helian prelude alla produzionedella maturità. Con abile mascheramento einsieme sublimazione delle proprie vicendebiografiche, Trakl finisce infatti con il pro-iettarsi in figure insieme innocenti e inco-scienti: il non-nato Elis che scende nelle vi-scere della terra per sottrarsi alla corruzionedella storia o il trovatello Kaspar Hauser,colto proprio alle soglie dell’incontro bruta-le con la coscienza storica.Anche sul motivo dell’Abendland che ha datoorigine a giudizi contraddittori sull’opera diTrakl, il saggio cerca di evitare facili conclu-sioni. Trakl, secondo Dolei, non era “cultu-ralmente consapevole della dimensione sto-rica del tramonto dell’occidente” (p.107).Troppo ristretto il suo orizzonte culturale etroppo urgenti i problemi personali perchépotesse elaborare un’analisi completa e obiet-tiva. Come mostra il confronto conHofmannsthal, Trakl non è un poeta colto,campione e vittima quasi della sovrabbon-danza del proprio retaggio culturale, ma èpiuttosto un autore istintivo che considera ilproprio esercizio artistico una “sofferenzariparatrice del mancato impegno per le ragio-ni degli altri” (p.145). Lo sfacelo è qualcosache viene innanzitutto avvertito sulla propriapelle e la guerra non è altro che la tragicaconferma della propria disperazione. La par-tenza del poeta per il fronte è lontanissimada ogni “attivismo”, al contrario il suo atteg-giamento resta ostentatamente passivo. Maproprio nell’inferno bellico per Trakl arrivail momento in cui sente di potere e dovereespiare definitivamente la propria fallimen-tare esistenza ed egli ci lascia con i suoi ulti-mi versi una sorta di testamento e nelcontempo di trasfigurazione mitica che lorende il “cantore più alto dell’umanità soffe-rente e umiliata dalla guerra” (p.145).
39OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
Così dopo avere analizzato decine di liri-che e avere indagato a fondo fra le carte del-l’autore, il saggio giunge alla conclusioneche Georg Trakl si colloca coscientemente“nel punto di sezione aurea tra l’impulsogiovanile alla chiusura egocentrica nel mon-do delle immagini e la consapevolezza de-gli anni maturi di non avere né il diritto néla possibilità di sottrarsi alla realtà” (p.135).Nella concezione dell’arte quale forma dimaledizione e di redenzione, espressione diun egoistico e asociale narcisismo e unicapossibilità di rispondere alla tristezza deitempi, Trakl ci appare vicino ad un altro suogrande predecessore austriaco, anch’eglispesso confinato nel ruolo di classico di-menticato, quel Franz Grillparzer che vissedrammaticamente il contrasto tra la sterilepurezza di una vita dedicata all’arte e allacontemplazione e la corruzione generatadall’obbligo etico-sociale di partecipare aldivenire storico.Proprio nell’aver ribadito come l’opera diTrakl si ponga tra le tentazioni estetizzantie la necessità della storia, nell’aver cercatodi dare un senso all’esperienza trakliana,senza imporgli l’appartenenza a questa oquella corrente filosofico-culturale, possi-bile fonte di condanne o esaltazioni unila-terali, risiede ancora oggi la validità di que-sto contributo critico. Il commento finale“Georg Trakl, vent’anni dopo” ribadiscel’originalità dell’opus trakliano. Al lettoredel saggio, a cui l’autore fornisce, oltre cheun’utile scelta bibliografica, una serie diinformazioni e commenti sugli sviluppi deldibattito critico, viene fornita una convin-cente chiave interpretativa che contribuiscead illuminare da nuove prospettive l’operadel “decadente” Georg Trakl e a trovare unadelle ragioni da cui deriva la ricchezzaevocativa e la particolare incisività dei suoiversi.
Alessandra Schininà
Arturo Larcati, Espressionismo tedesco, Mi-lano, Editrice Bibliografica, 1999, pp. 120,£. 15.000
La meritoria iniziativa rappresentata dallacollana “Storia dei Movimenti e delle Idee”si arricchisce di un contributo che interessadirettamente la germanistica: nella veste delvolumetto in formato ‘tascabile’, di rapidaconsultazione ma dal contenuto quanto maicurato e soprattutto mirato ad esaudire ri-chieste che vanno ben oltre la semplice in-formazione, appare ora questo studio diArturo Larcati, a dar seguito con la tratta-zione dell’espressionismo nei Paesi di lin-gua tedesca alla nutrita serie degli ‘ismi’ finqui affrontati dalla collana medesima. Nel-lo spazio di una pubblicazione dai chiariintenti didattici Larcati offre una visionecomplessiva dell’esperienza espressionista,riuscendo tuttavia a dare adeguata profon-dità critica alla propria analisi di quella en-tusiasmante e controversa stagione dell’ar-te del Novecento, in special modo per meri-to di un’oculata articolazione interna del la-voro. Alle necessarie premesse (in ogni casomai accompagnate da riflessioni scontate)che riguardano la storia del concetto e ilcontesto storico-culturale in cui matura l’ir-ruzione dell’espressionismo sulla scena del-la Germania guglielmina, l’autore conside-ra la diffusione della più significativa tra leavanguardie storiche sulla scorta di due pon-derate convinzioni su cui si fonda l’opera:si tratta in primo luogo dell’esigenza di ac-centuare, a scapito di generalizzazioni dinatura sociologica, la cui critica è leggibilein controluce in diverse pagine di Larcati, ilcarattere violentemente epifanico, si direb-be post-hofmannsthaliano dell’Erlebnis dalquale nasce l’arte espressionista. In secon-do luogo, è chiamata in causa qui laduplicità, produttivamente lacerante, di cuisi carica il rapporto degli espressionisti conla modernità, vissuto ora in funzione delgesto archeologico, del recupero di unsostrato mitico della civilizzazione, oracome incessante agitazione progettuale, ri-cerca molto spesso affannosa di un
40OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
adeguamento al dinamismo imposto dallatecnicizzazione dell’esistenza. Fedele asiffatte premesse, la disamina di Larcati pro-cede con piglio sicuro e accattivante inol-trandosi in territori dello spirito dove “lavitalità e la produttività dell’espressionismonon appaiono più tanto legate ad un genusproximus nella teoria o nella pratica del mo-vimento” (p. 38); questa affermazione nonsi traduce tuttavia nella rinuncia alla loca-lizzazione geografica - e quindi anche so-cio-politica, data la genesi inequivocabil-mente metropolitana della expressionis-tische Revolte -, ma getta le basi per quellache risulta essere l’operazione più origina-le del libro, vale a dire la scelta di concen-trare il discorso su quattro autori esemplari,da una parte Gottfried Benn e Georg Traklper la lirica e dall’altra Carl Sternheim eGeorg Kaiser per il dramma (e ben si giu-stifica qui lo scarso rilievo concesso allaprosa espressionista, realtà troppo effimerae, ove si eccettuino episodi capitali, come ilBebuquin di Carl Einstein, che l’autore nonomette di trattare, sempre acquattata dietrola rassicurante cortina della lukácsianatranszendentale Obdachlosigkeit). In parti-colare, nelle pagine che Larcati dedica aBenn e a Trakl appaiono in tutta la loro evi-denza e coerenza le linee di un disegnointerpretativo teso a rendere un’immaginedialetticamente problematica del movimen-to, avvertendo che “chi vorrà individuare imomenti innovativi della poesia espressio-nista dovrà cercarli non a livello di sistema,bensì di microstrutture, concentrandosi inparticolare sul linguaggio figurato” (p. 82sg.). Alla comprensibile assenza di una se-zione antologica l’autore ovvia così indiriz-zando la propria indagine verso l’opera didue poeti che assurgono qui a paradigmi dicontrapposte manifestazioni della sensibi-lità espressionista. Mentre nella lirica gio-vanile di Benn, come ci spiega Larcati, lavisione nichilista non costituisce l’apprododefinitivo, ma solo un momento, per quan-to assai importante, di una riflessione glo-bale sulla civilizzazione che per controipostatizza il depotenziamento del soggetto
nel nuovo mondo della tecnica, per Trakll’espressionismo “consiste nel montare, nel-le sue poesie, impulsi estremamente sogget-tivi e personali” seguiti e assecondati benoltre lo steccato “dei passaggi logici, dellerestrizioni semantiche o delle regole dellasintassi” (p. 93). Tanto il talora manieratocupio dissolvi benniano quanto il fantasticomondo trakliano, ci suggerisce Larcati nelsuo stile serrato ed incisivo, si fanno in talmodo emblemi di una poesia esperienzialevotata all’investigazione di uno spazio del-l’individuale in cui la matrice espressionistasmette di essere simulacro ideologico e sem-plice provocazione sperimentalistica, per in-vestire invece di inedite valenze, forseinsospettabilmente legate ad un nuovo, di-verso umanesimo, l’urlo, l’angoscia, il ter-rore, la guerra e tutto ciò che la modernitàevoca da ancestrali profondità che a torto sicredevano obliate per sempre nell’ebbrezzadel progresso e della civilizzazione.
Stefano Beretta
Enrico De Angelis, L’Ottocento letterario te-desco, Pisa, Tipografia Editrice Pisana, 2000,pp. 600, s.i.p.
Con questo numero dell’ “Osservatorio” siintende avviare una discussione sulle storiedella letteratura tedesca, o più correttamentedei paesi di lingua tedesca, di recente pub-blicazione o in corso di preparazione, che nonpotrà non coinvolgere una pluralità di pro-spettive metodologiche, storiografiche e difinalità ermeneutiche e didattiche assai ur-genti. Mai come oggi, considerando l’evo-luzione della storiografia letteraria degli ul-timi tre secoli, si avverte l’esigenza di unariproposizione e di una ricollocazione dellastoria della letteratura in un contestosocioculturale proprio in un’epoca che pareeroderne le premesse stesse, adducendo comecausa, ormai già un po’ sbiadita, ilsuperamento delle ideologie e lo smantella-mento della costruzione storicistica. È sin-
41OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
golare che di fronte a una generalizzata ri-chiesta di una ridefinizione dello statuto edell’impianto della storia letteraria non ab-bia finora trovato adeguato spazio nellagermanistica italiana un dibattito approfon-dito sulle recenti proposte editoriali di sto-ria della letteratura tedesca in lingua italia-na. Sul versante delle segnalazioni e dellerecensioni su riviste e periodici si rivolgemaggiore attenzione a singoli contributi, asaggi monografici, passando spesso sottosilenzio rilevanti edizioni o progetti di sto-rie letterarie che dovrebbero sollecitareun’approfondita riflessione su una tradizio-ne basata sulla sequenzialità degli eventiletterari e sulla contestualità storica, ritenu-te scontate e indiscutibili. Se è appuntoindiscutibile il nesso fra orientamento nelprocesso storico e storia letteraria, da inten-dere come contenitore che raccoglie, ordi-na, definisce indirizzi, percorsi mediante itesti letterari, più o meno mediati frutti ereagenti della storia, è altrettanto vero chesituazioni apparentemente contingenti,come ad esempio l’imminente riforma uni-versitaria, non potranno che determinare ac-celerazioni, mutamenti e correzioni nellastoriografia letteraria. È infatti significati-vo che editori, sensibili sia ai riflessi cultu-rali sia a quelli economici, sempre più spes-so negli ultimi tempi chiedano agli studiosidi letteratura collaborazioni e proposte con-crete per far fronte con strumenti adeguatiai nuovi ordinamenti didattici. Che d’altraparte il probabile, futuro incremento di te-sti e manuali storico-letterari sia dettato daragioni didattiche non potrà che conferma-re la problematicità, se non l’inattualità ne-gli ultimi decenni, di una storiografia lette-raria come espressione di un humus cultu-rale ad essa favorevole. Ma non è comun-que affatto scontato che le nuove genera-zioni siano impermeabili a una dimensionestorica del sapere, come se poi, ammesso enon concesso che lo siano, rivestano il ruo-lo di fautori e non di vittime di una tenden-za dominante.Per avviare una rassegna delle recenti sto-rie della letteratura tedesca, che proseguirà
nei prossimi numeri, ho scelto L’Ottocentoletterario tedesco di Enrico De Angelis peruna serie di ragioni che spero si chiarirannonel corso della recensione. La prima è che ilcorpus storico-letterario è preceduto da unasintetica ma densa introduzione metodolo-gica e concluso da un bilancio forse ancorpiù significativo perché vi si esplicitano lemotivazioni dell’intera operazione. L’auto-re definisce infatti la sua trattazione storico-letteraria un’autobiografia che deve reggerea un “esame epistemologico” perché ne va-luti il suo “valore di verità”. L’epilogo ineffetti non è riferito tanto all’opera in sé,quanto all’esperienza di vita, con le relativesoluzioni, dell’autore stesso che per accen-tuare il suo ruolo autoriale informa il lettoreche “ragioni esterne” lo hanno indotto a in-terrompere l’esposizione prima del 1914,contrariamente a ciò che egli stesso si erariproposto nell’introduzione. De Angelis,radicalizzando la sua funzione di narratoree in quanto tale di intellettuale, che riaffermatradizionali prospettive ermeneutico-esisten-ziali (“La nostra lettura di un testo […] èpreformata dalle letture che sono avvenuteprima di noi”), pone istanze e principimetodologici la cui problematicità superaforse il carattere talvolta perentorio della loroformulazione. Anche se l’unicità del narra-tore di una storia letteraria può considerarsida tempo superata, sono tuttavia interessan-ti la prospettiva dell’autore, che si confron-ta narrativamente con la storia, e ancor dipiù -e questo vale anche per le storie dellaletteratura composte a più mani - la convin-zione che il risultato della storia letteraria èpur sempre una costruzione. Non vi è dub-bio che vuoti, lacune, e zone di opacità nel-la rappresentazione di un periodo storico-letterario siano da attribuire al “narratore”che per costruire deve selezionare quei ma-teriali provenienti dal passato la cuiricomposizione e interpretazione dovrebbe-ro riproporlo nel presente con la maggioreattendibilità ed essenzialità possibili. Qui siindica forse uno dei nodi più problematiciintrinseci alla composizione di una storia let-teraria: la scelta dei criteri di selezione dei
42OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
contenuti, dei temi e delle forme chesostanziano una determinata epoca storica.A De Angelis va il merito di enucleare edelencare nell’introduzione tutte le difficol-tà, se non i limiti aporetici, di una costru-zione spesso solo descrittiva e priva di un’ar-chitettura epistemologicamente fondata,tanto da rendere plausibili alcune motiva-zioni sulla sua inutilità per eccesso, ad esem-pio, di generica approssimazione. I rischi ele tentazioni di attualizzazioni forzate, glisquilibri e gli sbilanciamenti dovuti al pri-vilegiare una corrente rispetto a un’altra, latendenza ad affermare, per necessità di sin-tesi, meccanici passaggi nel processo stori-co e nel rapporto fra testo e contesto, sonoaspetti prioritari di una storia letteraria co-struita talvolta come sommatoria di parti enon come unità aperta all’interpretazione.Inevitabile risulta ancora il riferimento allateoria della ricezione nei confronti della qua-le De Angelis oscilla fra un’esplicita ade-sione (“La storia letteraria è costruzione tut-ta intera e non solo in parte. Io ne sono par-te attiva come narratore nell’oggi. Il mioprediligere e decidere si pone nell’oggi, nonnello ieri”) e la negazione (“la presente sto-ria non intende collocarsi fra quelle ricon-ducibili alla teoria della ricezione. In que-sta ritengo ci sia troppo poco posto per ilnuovo”), ma in definitiva ne condivide pre-messe e finalità proprio per il forte taglio‘autobiografico’, unito a una disposizionedi comprensione del passato letterario.Avvicinandosi alla trattazione specifica, DeAngelis tiene a precisare ancora nell’intro-duzione che “questo libro è scritto da un nontedesco per non tedeschi”, perché “non puòporsi gli stessi fini della germanistica”. Noiaggiungiamo l’aggettivo ‘tedesca’, in quantoDe Angelis ritiene che l’eredità dellagermanistica, sviluppatasi a partire dallametà dell’Ottocento e della quale si trattaabbastanza ampiamente nel primo capitolodella seconda parte, faccia sentire il suo pesoanche in epoca contemporanea sulla basedi modelli e di principi etico-politici che me-riterebbero di essere attentamente verifica-ti. Al di là della dipendenza, nel segno di
una continuità, dalla germanistica del passa-to da parte di “germanisti non secondari” dioggi, si pongono qui interrogativi di fonda-mentale importanza per qualsiasi progetto distoria letteraria: chi la scrive, perché e perchi viene scritta. La risposta è lasciata soprat-tutto ai gruppi di lavoro che progettano unastoria letteraria, nei quali sarebbe opportunol’inserimento anche di germanisti non tede-schi proprio in considerazione di una teoriadella ricezione a più ampio raggio.La premessa fondante del volume di DeAngelis è che “la germanistica è pur sempreun derivato della critica romantica; entram-be hanno visto nella Dichtung una forma diconoscenza”. Se è indubbia la valenza cono-scitiva nella letteratura dei poeti dell’età clas-sico-romantica, considerandola un’emanazio-ne della forza creativa della Dichtung, rive-latrice di una forma di riflessione, non risul-ta pienamente persuasivo il passaggio seguen-te di De Angelis che sillogisticamente potreb-be essere così sintetizzato: la germanistica ècritica romantica, io sono un germanista (perquanto non tedesco), ergo continuo nel solcodella critica romantica. È una deduzione-con-clusione inseribile e forse plausibile nel-l’orizzonte ermeneutico dell’autore che fa dasfondo a questa ricostruzione dell’Ottocentotedesco, nella cui premessa gnoseologico-metodologica la “forma di riflessione” del-l’età romantica si estende un po’ a tutto ilsecolo che Nietzsche – mi si passi questa ci-tazione - definiva “più animalesco, più sot-terraneo, odioso, realistico, più ‘plebeo’ e ap-punto per questo ‘migliore’, più ‘onesto’, piùsottoposto alla ‘realtà’ di ogni genere, piùvero, ma debole di volontà, e triste e di cupacupidigia e fatalista”. De Angelis intende inrealtà mantenersi, in una sorta di sfida cherasenta il paradosso, sul terreno di “una lottapermanente e mai definita” con l’Ottocento,evitando descrizioni naturalistiche, manipo-lazioni e facili esercizi di egemonia sul pas-sato. Il suo discorso, condotto superando iltempo, ma tenendo anche conto di ciò che adesso è seguito, mira a una coerenza interna alpercorso concettuale che non può quindiescludere incoerenze che discendono dalla
43OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
extraletterarietà. A questo punto occorrechiedersi se ci siano anche una coerenza euna corrispondenza fra la premessa e l’epi-logo-apologo, ricchi di sollecitazioni e diprospettive propositive, e la trattazione stes-sa. L’opera, suddivisa in 10 parti, abbraccia cir-ca cento anni di storia della letteratura tede-sca, dal 1913 al primo Novecento. La sud-divisione, cui corrisponde nelle grandi lineeuna scansione temporale, è basata su idee etemi (il Nebeneinander, il popolare, le tra-dizioni, le grandi trasformazioni in camposociale, le varie forme del moderno) cheattingono alla “sociologia come tema diespressione letteraria” e “come esperienzafattuale”. L’Ottocento tedesco, non soloquello letterario, è ri-costruito con grandeabbondanza di materiali informativi e di ri-ferimenti storico-culturali grazie ai quali gliautori si muovono e si profilano facendosiriconoscere e apprezzare nel loro itinerarioletterario soprattutto da chi in realtà è già inconfidenza con loro per frequentazione eorientamento nella cultura del tempo. La vitae l’opera dello scrittore, che come quella diognuno non è mai lineare ed asetticamenteestrapolabile, viene restituita quanto piùpossibile nella rete di rapporti e nelle con-flittuali dinamiche dell’esperienza. Ma lavera novità del volume di De Angelis, chetiene in definitiva fede per coerenza e den-sità concettualizzante alle premesse teoriche,è data dall’inserimento nei vari capitoli dinumerosi, sintetici excursus in corsivo con iquali il narratore entra direttamente in sce-na come attore della storia in cui ritiene diessere ancora coinvolto, rendendo una buo-na volta visibile quell’orizzonte ermeneuticodi cui tanto si parla ma che raramente siconcretizza. Questi interventi hanno l’evi-dente scopo di alimentare criticamente edialetticamente la trattazione storica conprospettive spesso diacroniche, enunciate inun atteggiamento di coinvolgimento che nonesclude una dimensione straniante. Ad esem-pio, a conclusione del paragrafo su Due ri-flessioni sul romanticismo lontano, in cui fral’altro si ribadisce che “l’importanza di
concettualizzare i testi” è “un’eredità roman-tica”, De Angelis nell’Excursus: Dall’A allaZ afferma che la letteratura tedesca vera epropria copre un periodo di 182 anni, dal1774, anno del Werther, al 1956, anno dimorte di Brecht e di Benn. “Una nascita euna morte, un avvio e una conclusione. Quelche vi si trova in mezzo è ciò che ha moti-vato il presente studio: la sintesi di pensieroe immagine, la letteratura come conoscen-za privilegiata, spesso e volentieri più avan-zata della filosofia, della sociologia e di al-tre forme di conoscenza. Tale profilo ricevela sua impronta dal romanticismo”. Questeaffermazioni di per sé assai impegnative emeritevoli di approfondimento – il 1956 rap-presenta senza dubbio e sotto molti aspettiun anno di cesura, ma è forse discutibile checon questa data si estingua il binomio dipoesia e conoscenza, di ascendenza roman-tica, ammesso che questa combinazione siaun’univoca chiave interpretativa della stes-sa letteraura romantica - passano addirittu-ra in secondo piano di fronte a un’articola-zione metodologica che rinvia a sua volta aposizioni estetico-ideologiche. Con questeincursioni ermeneuticamente pilotate si in-tende indicare alternative nella periodiz-zazione della storia letteraria rilevandone inprimo luogo la problematicità e la relativi-tà. Lo conferma la variante di questo ex-cursus che De Angelis riporta subito dopo,attenuando fortemente il testo precedente,sulla base di presunte critiche che gli sareb-bero state mosse, esemplificando in tal modoil “bello sfumatino messo su tutto”, strate-gia non infrequente in ‘neutre’ storie dellaletteratura.Periodizzazioni, sistemazioni cronologiche,definizioni sono le finalità della storiografialetteraria e al tempo stesso ne rappresenta-no i limiti tanto più marcati quanto più siavverte che un’opera o un autore si sottrag-gono all’inserimento in classificazioni for-zatamente omologanti. Significativa in pro-posito è la discussione proposta da DeAngelis sulla definizione di Biedermeier,“nata, per così dire, a tavolino”, la cui “plau-sibilità” e “utilità” possono essere conser-
44OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
vate se metodologicamente i suoi canoni eparametri discendono dalle interpretazionidegli autori e non viceversa. Selezione, equi-librio fra i materiali selezionati, relatività deigiudizi sono i nodi che anche questa storiadella letteratura non scioglie, anzivolutamente esalta per proporre un atteggia-mento diverso verso il passato letterario allacui interpretazione – osserva De Angelis-non è “estraneo un gesto metafisico” per lasua intrinseca dialettica fra “attitudine aldisvelamento” e “persistenza di una zonaoscura”. Questa ipotesi risulta interessante,comunque in contrasto con la prevalenteprospettiva ermeneutica.Volendo a questo punto tentare di risponde-re agli interrogativi posti sopra: perché e perchi viene scritta una storia della letteratura,senza toccare istanze e motivazioni autobio-grafiche, peraltro in questo caso affermateda De Angelis stesso, si potrebbe insisteresul compito dello storico di portarecartesianamente a sistema “qualcosa di nonsistemato”, presentando quella mappaturache radica la letteratura nella storia legitti-mandone nel tempo l’esistenza. “Il sistema– commenta De Angelis – si porta la suagioia, poiché un sistema ha il suo fascinoestetico, ma ha pure i suoi noti limiti. […]Il fatto è che noi, spettatori o manipolatoriche vogliamo considerarci, vogliamo eser-citare la nostra egemonia sul passato: farloservire ai nostri scopi, continuarlo, sceglie-re alternative presuntivamente a esso inter-ne oppure no, sentirci superiori già per ilfatto che, essendo passato più tempo, sap-piamo più cose”. Ma l’equilibrio e il contri-buto conoscitivo di una storia letteraria do-vrebbero essere commisurati alla conserva-zione e alla valorizzazione della dimensio-ne “presistematica” del testo, perché que-sto non sia per così dire annullato nel con-testo. Sotto questo aspetto in De Angelis ècostante la preoccupazione di tenere in pri-mo piano l’opera letteraria anche se qua elà si colgono sbilanciamenti e accentuazionidiverse riguardo, ad esempio, alla citazionee all’analisi del testo, più frequente quest’ul-tima a proposito della letteratura della
Jahrhundertwende. Sproporzioni e squilibritematici e metodologici risultano tuttaviacontenuti se mediamente confrontati con nonpoche storie della letteratura composte a piùvoci, sebbene queste costituiscano per ragio-ni unanimemente riconosciute ormai la re-gola. Finora non si è discusso in modo sufficien-temente approfondito sul destinatario di unastoria della letteratura che, costruita per fil-trare e classificare la produzione di un auto-re o il programma di un movimento, ha unafunzione di selezione e di mediazione di untesto di per sé proposto e rivolto direttamen-te al lettore. Se la cosiddetta letteratura pri-maria si consegna in quanto tale al fruitore,che stabilisce con essa un rapporto imme-diato di comprensione, l’autore o gli autoridi una storia della letteratura si assumono ilgravoso compito di presentare e di spiegarecon essenzialità e attendibilità opere e perio-di storico-letterari di cui il destinatario puònon essere a conoscenza e può appropriarsial punto da compensare la mancata letturadell’opera stessa con le note conseguenze.Di fronte alle storie della letteratura occor-rerebbe raccomandare al destinatario l’atteg-giamento antitetico a quello del maestrinoWuz, protagonista del romanzo di Jean Paul,che si era creato una biblioteca interamenteautografa, inventando i contenuti di opere re-almente uscite. L’opera di De Angelis vuoleinvece essere a questo riguardo un deterrentee una sollecitazione al rinvio o al recuperodel testo letterario.
Fabrizio Cambi
INTERVENTI
Da Alberto Destro riceviamo il seguente in-tervento, che pubblichiamo come contribu-to alla discussione
Accenti, a capo e congiuntivi
Un professore non più giovanissimo si im-
45OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
provvisa maestro di scuola, e anziché re-censire come si deve due lavori recenti, pro-pone una anomala recensione anonima. Nonsolo non nominerò infatti gli autori, ma nep-pure i temi dei loro lavori. Nel piccolo mon-do della germanistica italiana, altrimenti, laloro identificazione sarebbe un gioco daragazzi. Ma questo è proprio ciò che nonvoglio. Voglio infatti parlare del peccato, manon dei peccatori.Perché, ecco la stranezza, si tratta di duebuoni lavori, impegnati, informatissimi, ecapaci di dire cose nuove sui loro temi. Nonc’è che da dirne bene. E allora perché, ci sichiederà, non citare apertamente nome ecognome degli autori, che ne saranno certogratificati? Perché, in realtà, questa noterellaintende essere critica. Fortemente critica,malgrado il giudizio positivo su questi la-vori. È un rebus? Niente affatto. Si tratta didue lavori ben fatti, informati e nuovi, mache strapazzano la lingua italiana. Incomin-ciamo dai peccati veniali, gli accenti. So –e non me ne importa molto, a dire il vero –di poter essere considerato pedante, ma sel’italiano distingue gli accenti grave e acu-to (una regola che si impara senza sforzo inquattro minuti d’orologio, provare per cre-dere), ha le sue buone ragioni, che sono fo-netiche, e cioè di sostanza linguistica. Cer-to, siamo abituati a sentire ben altro alla te-levisione che qualche ´e´ aperta o chiusa asproposito. Certi ´perchè´, magari accetta-bili come marca locale, se pronunciati daun annunciatore che come minimo dovereprofessionale dovrebbe avere non solo unabella faccia, o altro di bello da far vedere,ma anche una pronuncia corretta, mi risul-tano irritanti, segno di sciatteria, insommastrafalcioni. Ora se in un volume di ricercaletteraria (certo, di letteratura tedesca, mapur sempre scritto in italiano) gli accentisono trascurati, è segno di sciatteria lingui-stica. Intendiamoci, si può optare per unascelta a mio parere discutibile, ma che finoa qualche decennio fa era assai più diffusadi oggi, e cioè ignorare sistematicamente ladifferenza tra acuto e grave, e uniformaretutti gli accenti a grave. Quello che non ri-
sulta accettabile è la casualità. Così, in unodi questi due libri, trovo regolarmente e cor-rettamente ´è´ e ´perché´, ma poi un ´cioé´sistematicamente prevalente sulla formacorretta ´cioè´. Si è perso in tal modo il si-gnificato della parola, semplicissima con-trazione di ´ciò è´.Ma si tratta ancora – forse – di peccati ve-niali. Meno veniali sono certi a capo da bri-vido. Ora, anche qui, so benissimo che lanorma della sillabazione si sta allentando ra-pidamente, specie nei quotidiani, che han-no da combattere con le righe brevissimedelle colonne, che hanno costanti problemidi fretta, e che hanno evidentemente siste-mi informatici di sillabazione impostati sunorme del tutto particolari. Può darsi che sistia tornando alla prassi medievale – sì,quella dei manoscritti – che per risparmiarespazio e preziosa pergamena non conside-rava il problema e interrompeva semplice-mente sull’ultima lettera che trovava postosulla riga. Oggi le condizioni mi sembranotuttavia assai diverse, e gran parte del lavo-ro di sillabazione viene svolto in automati-co dal programma di videoscrittura. Ma at-tenzione: gran parte, non tutto. Il program-ma d’italiano procederà a dividere le silla-be secondo le norme italiane, e se si trovauna citazione in altra lingua, ad esempio intedesco, procederà, da animale laborioso mastupido qual è, a suddividere le parole se-condo le norme italiane. È qui che deve su-bentrare un correttore esperto della linguastraniera, ad aggiustare le cose. Qualche er-rore può sfuggire, ma tant’è, la perfezionenon è di questo mondo. Dove invece noncapisco più, è nei casi in cui la sillabazioneobbedisce a una logica che non è né italianané tedesca, ma semplicemente alla necessi-tà tipografica di riempire le righe in modouniforme. E allora escono ripetutamente, perfar un solo esempio, piccoli mostri come´au-ch´, con un a capo tutto consonanticoche in nessuna lingua può costituire una sil-laba. Con qualche sforzo, superando qual-che resistenza interiore, posso accettare lasillabazione selvaggia dei quotidiani – al-cuni, peraltro, non tutti – ma in un testo
46OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
scientifico, e di scienza letteraria, propriono.Infine un caso, solo un caso, entro una scrit-tura non certo elegante e anzi spesso fatico-sa, ma solitamente (salvo qualche forzatura)neppure del tutto sgrammaticata, di unosvarione grammaticale serio, che riesce in-concepibile in chi lavora scientificamenteproprio con e sulla lingua. Si tratta di un´benché ... andarono´ (il verbo è cambiato:non mi interessa mettere alla berlina un col-lega sicuramente serio, anche se linguisti-camente periclitante), che irride alla sintas-si italiana del congiuntivo.Proprio in questi giorni (fine ottobre 2000)la stampa riporta la notizia di una interaedizione dell’ultimo romanzo del più famo-so autore inglese di letteratura per bambinimandata al macero prima di essere immessasul mercato, perché vi era stato scoperto (daun piccolo lettore, poi!) un grave errore distampa. Quanto arriverebbe in libreria del-la recente produzione germanistica italiana,se adottassimo questi anacronistici criteri diquei poveri inglesi?
Alberto Destro
SEGNALAZIONI
Saggi
Carlo Angelino, Il terribile segreto diNietzsche, Genova, Il nuovo melangolo,2000, pp. 80, £. 15.000
Italo Michele Battafarano - Hildegard Eilert,Von Linden und roter Sonne. DeutscheItalien-Literatur im 20. Jahrhundert, Bern,Peter Lang, 2000, pp. 357, sFr. 78
Giuseppe Bevilacqua, Saggio sulle originidel Romanticismo tedesco, Milano, Sansoni,2000, pp. 257, £. 34.000
Pier Carlo Bontempelli, Storia della
germanistica. Dispositivi e istituzioni di unsistema disciplinare, Roma, Artemide Edizio-ni, 2000, pp. 256, £. 35.000
Franco Buono, Stemma di Berlino: poesia te-desca della metropoli, Bari, Dedalo, 2000,pp. 189, £. 28.000
Giulia Cantarutti (a cura di), Scrittori a Ber-lino nel Novecento, Bologna, Pàtron, 2000,pp. 216, £. 25.000
Remo Cantoni, Franz Kafka e il disagio del-l’uomo contemporaneo, Milano, Unicopli,2000, pp. 263, £. 30.000
Anna Chiarloni – Gerhard Friedrich (a curadi), Terra di nessuno. La poesia tedesca dopola caduta del muro di Berlino, Torino, Edi-zioni dell’Orso, 1999, pp. 262, £. 30.000
Sergio Corrado, Poesia in cerca di oggetto.L’invocazione dell’altro nei Gedichte an DieNacht di Rilke, Bologna, Monduzzi, 2000, pp.344, £. 50.000
Nicoletta Dacrema, Franz Grillparzer, dise-gni e problemi, Genova, Marietti, 2000, pp.141, £. 25.000
Enrica Yvonne Dilk, Ein “practischerAesthetiker”: Studien zum Leben und WerkCarl Friedrich von Rumohrs, Hildesheim -Zürich - New York, Olms, 2000, pp. 254, DM58
Marino Freschi (a cura di), La storia di Faustnelle letterature europee, Napoli, CUEN,2000, pp. 226, £. 24.000
Hans-Georg Grüning, Spielräume. Essays zuSprache, Literatur und politischer Kultur, Bd.I: Selbstdarstellung – Stereotypen –Kulturverrat, Ancona, Nuove ricerche, 2000,pp. 199, £. 28.000
Furio Jesi. Spartakus. Simbologia della ri-volta, a cura di Andrea Cavalletti, Torino,Bollati Boringhieri, 2000, pp. 107, £. 35.000
Peter Kofler, Gli itinerari dell’occhio. L’Ita-
47OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
lia nella rivista “Teutscher Merkur” di C.M. Wieland (1773-1810), Udine,Campanotto, 2000, pp. 205, £. 35.000
Primus-Heinz Kucher – Luigi Reitani(hrsg.), In die Mulde meiner Stummheit legein Wort... Interpretationen zur LyrikIngeborg Bachmanns, Wien – Köln –Weimar, Böhlau, 2000, pp. 293, öS 510
Lucia Mor, Introduzione alla Literatur-wissenschaft. Manuale d’orientamento perprincipianti, Milano, I.S.U., 2000, pp. 114,s. i. p.
Bruno Pompili (a cura di), Nietzsche e leavanguardie, Bari, Crav, 2000, pp. 200, £.20.000
Luca Renzi, Joseph Görres e i “teutscheVolksbücher”. Sul concetto di Volk e diVolksbuch nel romanticismo di Heidelberg,Udine, Campanotto, 2000, pp. 237, £.35.000
Marco Vozza, Attualità di Schiller. Il pro-getto di Educazione estetica-Grazia e di-gnità, Torino, Trauben, 1999, pp. 184, £.25.000
RIVISTE
Annali – Sezione GermanicaN.S. VIII (1998), 2Saggi: Simonetta Carusi, La teoriadell’epigramma in Lessing; VivettaVivarelli, “Die schwankende Zeit”. La per-dita dell’equilibrio e la minaccia dell’in-forme in Arminio e Dorotea di Goethe; Ste-fano Beretta, Il Faust e il dramma baroccotedesco. Considerazioni su un possibilesostrato della Tragödie goethiana; BarbaraDi Noi, “Un alito che tende a nulla”. IlCimitière marin di Valéry nella poeticarilkiana delle Elegie Duinesi e dei Sonetti aOrfeo; Giuseppe Dolei, Hofmannsthal e illibretto: fuga o restaurazione della paro-
la?; Giuseppina Scarpati, Sconfinamenti:percezione e linguaggio in IngeborgBachmann e Peter Handke; Magda Raffa, Lanegazione in nederlandese: tipologia e stra-tegie. Materiali: Francesca Terrenato, Karelvan Mander as a Biographer in RecentTesearch; Gaetano Biccari, ‘TragischesWollen’. Tragödientheorien im DrittenReich; Momme Brodersen, SiegfriedKracauer in Italia; Claudia Liver, ZurNeuregelung der deutschenRechtsschreibung. Recensioni.
Cultura tedesca 13 (Annali Goethe 2000)Con questo numero “Cultura tedesca” divie-ne quadrimestrale, prevedendo di dedicareannualmente un numero monografico aglistudi goethiani.Goethe e l’ItaliaMarino Freschi, Presentazione; RobertaAscarelli, Osservando la Rotonda diPalladio; Sandro Barbera, Goethe e le for-me del Singspiel; Andreas Beyer, “... wasein Mensch vermag...”. Anmerkungen zuGoethes Würdigung des Michelangelo; LucaCrescenzi, Praxis. Le note di Goethe alla vitadi Benvenuto Cellini; Cesare de Seta,Goethe, Tischbein, Kniep e AngelikaKauffmann: un problematico sodalizio. Peri 250 anni della nascita di Goethe; Gabriel-la d’Onghia, L’ eco di Die Voegel nel rac-conto del Viaggio in Italia; HelmutKoopmann, Goethe, Frau von Stein undItalien; Ernst Osterkamp, Goethe, Rom unddie franzoesische Kunst; Lia Secci, ISingspiele di Goethe a Roma; LucianoZagari, Figurazioni e ispirazioni musicalinell’opera letteraria di Goethe.
Cultura tedesca 14 – luglio 2000WeimarAngelo Bolaffi, Presentazione; AngeloBolaffi, Elogio di una repubblica “senzaqualità” , Gian Enrico Rusconi, Lezioni diWeimar; Heinrich August Winkler, Il para-dosso quale paradigma. Dalla Repubblicadi Weimar alla lezione di Weimar; Stefan
48OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
Breuer, Gab es eine “konservativeRevolution” in Weimar?; Carlo Galli,Weimar, Roma, Berlino. La prima democra-zia tedesca e il futuro europeo; DieterGrimm, Mißglückt oder glücklos? Vor 80Jahren trat die Weimarer Verfassung inKraft; Fulco Lanchester, Il dibattito politi-co-costituzionale e il modello istituzionaletedesco da Weimar a Bonn; Pier PaoloPortinaro, Weimar e la teoria politica delNovecento; Ulrich K. Preuß, Die WeimarerRepublik – ein Laboratorium für neuesverfassungsrechtliches Denken; KurtSontheimer, Lo spirito della Repubblica diWeimar. Saggi: Ursula Bavaj, L’invenzionedell’Eden. Friedrich Leopold Graf zuStolberg, Die Insel; Maurizio Pirro, ThomasMann e Stefan George; Francesco Fioren-tino, Ernst Jünger: dalla confusione del mo-dello agli archetipi della scrittura; IrmgardEgger, La città-un testo: Vienna nei roman-zi La scalinata e I demoni di Heimito vonDoderer; Leonardo Tofi, Sinestesie per vocee percussione. Sulle percezioni sensorialisimultanee nella Blechtrommel di GünterGrass. Interventi: Desmond Fennell, TheGerman Influence on Western Culture.Germany and the End of Europe. Recen-sioni.
Studi germanici(nuova serie) Anno XXXVII, 1, 1999Maria Rita Digilio, Esempi di focalizzazionelessicale nel corpus glossografico insassone antico; Lea Ritter Santini, Croci-fissioni. Uno scrittore e il suo quadro; Jörg-Ulrich Fechner, Der alte Meister und meinsehr früher verehrter lehrer – der mönchvon Fiesole“. Überlegungen zu StefanGeorges Sonett „Ein Angelico“; GiovanniSampaolo, Il tramonto della tragedia. ‚For-ma’ drammatica e ‘vita sostanziale’ nel gio-vane Lukács (1907-1915). Note – rassegne– profili: Elena Agazzi, Escapismo eautocelebrazione. La scrittura dei giovaniautori dopo la Wende; Alessio Trevisani,Lo spazio anelato. Corpo e parola nel“Tänzer Nijinski” di Ludwig Rubiner. Re-
censioni.Studi nordiciV – 1998Atti del convegno: Un giorno a Ekbátana.Sophus Claussen (1865 – 1931) e il fin desiècle
Studia theodisca VII, 2000
Mechthilde Vahsen – Freiheit, Gleichheit,Weiblichkeit. Henriette Frölichsfrühsozialistischer Utopieroman “Virginiaoder die Kolonie von Kentucky” (1820)Alessandro Costazza – L’entusiasmo dellaragione: poesia e filosofia in Schiller e Leo-pardi.Stefan Nienhaus – Gertrude Steins undTheodor Däublers PicassoRosalba Maletta – E. T. A. Hoffmann: retori-ca dei sentimenti e sorriso dell’umoristaPaola Gheri – Die Rosen des Bösen. Traklsund Rilkes Anfänge im Zeichen des fin-de-siècle.Gedanken zu einigen Motiven im Frühwerkbeider DichterFausto Cercignani – L’età dell’oro di Novalistra poesia e filosofiaBruna Bianchi – L’identità del poeta. Il testodi Ingeborg Bachmann
TRADUZIONI
Veza Canetti, Le tartarughe, trad. di Alessan-dra Luise, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 263,£. 29.000
Ernst Cassirer, Hölderlin e l’idealismo tede-sco, a cura di Andrea Mecacci, Roma,Donzelli, 2000, pp. 92, £. 18.000
Giorgio Cusatelli (a cura di), Athenaeum1798 – 1800, traduzioni, note, apparato criti-co di Elena Agazzi e Donatella Mazza, Fi-renze, Sansoni, 2000, pp. 982, £. 130.000
Albert Ehrenstein, Tubutsch, trad. Di HelenaJaneczek, Milano, Adelphi, 2000, pp. 78, £.12.000
49OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
Lisa Fittko, La via dei Pirenei, trad. diSarina Reina, Roma, manifestolibri, 2000,pp. 284, £. 35.000
Max Frisch, Fogli dal tascapane, trad. diDaniela Idra, Bellinzona, Casagrande, 2000,pp. 133, £. 22.000
J. Wolfgang Goethe, La forma delle nuvolee altri saggi di meteorologia, a cura di Ga-briella Rovagnati, Milano, Archinto, 2000 ,pp. 110, £. 10.000
Hermann Hesse, Demian. La storia dellagiovinezza di Emil Sinclair, a cura di Fabri-zio Cambi, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 196,£. 10.000
Ernst Jünger, Al muro del tempo, trad. diAlvise La Rocca e Agnese Grieco, Adelphi,Milano, p. 284, £. 34.000
Franz Kafka, Cinque storie di animali. Lametamorfosi dell’ebraismo, a cura diCamilla Miglio, introd. di Irene Kajon,Roma, Donzelli, 2000, pp. XXIV-143, £.25.000
Christiane Kohl, L’ebreo e la ragazza.Un’amicizia proibita nella Germanianazista, trad. di Emilio Picco, Milano,Baldini & Castoldi, 1999, pp. 406, £. 32.000
August Jacob Liebeskind, Lulu, o il flautomagico, cura e postfazione di Camilla Mi-glio, Roma, Donzelli, 2000, pp. 155, £.20.000
Elke Naters, Regine, trad. di AndreaMichler, Torino, Bollati Boringhieri, 2000,pp. 141, £. 30.000
Friedrich Nietzsche, Le poesie, a cura diAnna Maria Carpi, Torino, Einaudi, 2000,pp. 256, £. 16.000
Franz Overbeck, Ricordi di Nietzsche, Ge-nova, Il nuovo melangolo, 2000, pp. 104, £.20.000
Anna Seghers, La gita delle ragazze morte,trad. di E. Cortese, Napoli, Filema, 2000,pp. 60, £. 18.000
Jens Sparschuh, Il venditore di fontane, trad.di Matteo Galli, Firenze, Le Lettere, 2000,pp. 155, £. 25.000
Hans-Ulrich Treichel, Il fratello perduto,trad. di Silvia Bortoli, Torino, Einaudi, 2000,pp. 112, £. 18.000
Birgit Vanderbeke, Abbastanza bene, trad.di Agnese Grieco, Pescara-Milano, Le ve-spe, 2000, pp. 109, £. 20.000
Robert Walser, Diario del 1926. Frammen-to, a cura di M. Mantovani, Genova, Il nuo-vo melangolo, pp. 120, £. 14.000
Robert Walser, Poesie, a cura di A. Rossi,Bellinzona, Casagrande, 2000, pp. 105, £.25.000
50OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
Un’artistica rappresentazione di Esmoreit, figlio del re di Sicilia
a cura di Fulvio FerrariCollana Labirinti n 51 pp.182 £.30.000
Un saggio mago d’Oriente legge nelle stelle che un principe siciliano, nato quella stessa not-te, costituisce un pericolo mortale per il suo signore. Nello stesso momento, in Sicilia, il cugi-no del principe neonato, furente nel vedersi sfuggire la successione al trono del re ormai vec-chio, trama la sua morte.Ha così inizio l’artistica rappresentazione di Esmoreit, uno dei più antichi testi teatrali d’Eu-ropa a carattere profano, che non si propone di indurre gli spettatori al riso, ma li guida nelmondo rarefatto della fiaba e del romanzo cavalleresco.Un interessante frutto della civiltà nederlandese del XIV secolo, e una sorprendente testimo-nianza della varietà del teatro medievale europeo.
51OSSERVATORIO CRITICO
della germanistica
I - 8/9
Osservatorio Critico della germanisticaanno III, n. 8-9Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche - Trento 2000
Direttore Responsabile: Massimo Egidi
Redazione: Fabrizio Cambi, Alessandro Fambrini, Fulvio FerrariComitato esterno: Luca Crescenzi, Guido Massino, Lucia Perrone Capano, Grazia Pulvirenti,Aldo Venturelli, Roberto VenutiProgetto grafico: Roberto MartiniImpaginazione: C.T.M. (Luca Cigalotti)Editore: Maria Pacini Fazzi Editore - Lucca
Periodico quadrimestrale (febbraio, giugno, ottobre)Abbonamento annuale (tre numeri): £. 25.000Abbonamento estero: £. 36.000Numero singolo e arretrati: £. 10.000
Modalità di abbonamento: versamento sul conto corrente postale numero 11829553 intestatoa: MARIA PACINI FAZZI - LUCCA, specificando nella causale sul retro ABBONAMENTOANNUALE A ‘OSSERVATORIO CRITICO DELLA GERMANISTICA’, e indicando nome,cognome, via e numero, c.a.p., città, provincia e telefono, oltre al numero di partita i.v.a. per glienti, istituzioni, aziende che desiderano la fattura.
Manoscritti di eventuali collaborazioni e libri da recensire vanno indirizzati ai componentidella redazione presso il Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche,via S.Croce 65, 38100Trento (tel. 0461/881718, 0461/881723 o 881739; fax. 0461/881751; [email protected]).
Amministrazione e pubblicità: MARIA PACINI FAZZI EDITORE S.R.L., piazza S. Romano16 - casella postale 173 - 55100 Lucca; tel. 0583/55530 - fax 0583/418245; [email protected]
Stampa: Tipografia Menegazzo - viale S. Concordio 903 - LuccaAprile 2000
periodico in attesa di registrazione presso il Tribunale di Lucca
ISSN
OSSERVATORIO CRITICOdella germanistica
Università degli Studi di Trento
III - 8Lire 10.000
INDICE
Giorgio CusatelliIngrid Hennemann Barale, Luoghi dell’originario. Il tema del linguaggio nellaprospettiva storica e nei progetti letterari del primo romanticismo tedesco 1
Eva Maria ThüneSprachbewahrung nach der Emigration. – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel.Teil I: Transkripte und Tondokumente. Hrsg. Anne Betten unter Mitarbeit von SigridGraßl Sprachbewahrung nach der Emigration. – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel.Teil II: Analysen und Dokumente. Hrsg. Anne Betten und Myriam Du-nour
Wir sind die Letzten. Fragt uns aus. – Gespräche mit den Emigranten der dreißigerJahre in Israel. Hrsg. Anne Betten und Myriam Du-nour unter Mitarbeit von KristineHecker und Esriel Hildesheimer 3
Alessandro CostazzaElena Agazzi, Il corpo conteso. Rito e gestualità nella Germania del Settecento 8
Anna FattoriRobert Mächler, Robert Walser, der Unenträtselte. Aufsätze aus vier Jahrzehnten 18
Elena AgazziMatteo Galli, L’officina segreta delle idee. E.T.A. Hoffmann eil suo tempo 20
Donatella MazzaFederico Vercellone, Nature del tempo. Novalis e la forma poetica delromanticismo tedesco 22
Laura Benzi Hartwig Schultz, Clemens Brentano 23Christoph Nickenig Marino Freschi, Goethe. L’insidia della modernità Irmgard Wagner, Goethe. Zugänge zum Werk 26Stefano Beretta Walter Benjamin, Il dramma barocco tedesco Walter Benjamin, I “passages” di Parigi 29Grazia Pulvirenti I mille volti di Suleika. Orientalismo ed esotismo nella cultura europea tra ‘700 e ‘800 34Alessandra Schininà Giuseppe Dolei, L’arte come espiazione imperfetta. Saggio su Trakl 36Stefano Beretta Arturo Larcati, Espressionismo tedesco 39Fabrizio Cambi Enrico De Angelis, L’Ottocento letterario tedesco 40INTERVENTI Alberto Destro, Accenti, a capo e congiuntivi 44
Segnalazioni 46
I - 8/9