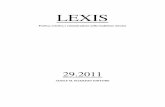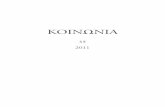Schede per il lessico critico petrarchesco. Rerum Memorandarum libri 1,13 e 2,20, in Le parole...
Transcript of Schede per il lessico critico petrarchesco. Rerum Memorandarum libri 1,13 e 2,20, in Le parole...
MARIA GRAZIA BLASIO
.
Schede per il lessico critico petrarchesco.
Rerum Memorandarum libri 1,13 e 2,20
Il manoscritto Parigino lat. 2201 (secc. XI-XII) — con il De anima di
Cassiodoro e il De vera religione di Agostino postillati da Petrarca —
presenta, come è noto, nell'ultima carta di guardia la lista autografa
introdotta da Petrarca con l'intestazione «Libri mei | Peculiares, ad
reliquos non transfuga sed explorator transire soleo» e, in un bifolio
iniziale, due preghiere a Cristo che recano le date 1 giugno 1335 e 10
giugno 13381. I tre elenchi di libri, scritti probabilmente nel 13332,
rispecchiano, è ormai giudizio concorde, i libri preferiti da Petrarca e
non quelli effettivamente posseduti3. Vincenzo Fera è tornato a commentare
il senso di questo catalogo indicando il profondo legame d'ispirazione che
lega la nota di Petrarca al testo della lettera di Seneca (epyst. 1, 2, 5)
1Per i codici postillati da Petrarca e le note autografe cfr. M. FEO,
Francesco Petrarca, in Storia della letteratura italiana, dir. da E. MALATO, X, La tradizione dei testi,
coord. da C. Ciociola, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 271-329: pp. 321-328.
Le postille al testo di Cassiodoro nel Parigino lat. 2201 sono state edite,
insieme con le preghiere, da M.C. BERTOLANI, Petrarca e la visione dell'eterno, Bologna, il
Mulino, 2005, pp. 273-285. 2 FEO, Francesco Petrarca cit., p. 326. 3 B. L. ULLMAN, Petrarch's Favorite Books [1923], ora in ID., Studies in the Italian
Renaissance, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973, pp. 113-133.1
cui Petrarca a suo modo rinviava4. Il testo dell'epistola senecana
chiarisce, infatti, come Petrarca volesse indicare pochi selezionati
autori, «auctores probati» dice Seneca, autori da approfondire e far
propri, tracciando i confini di una separazione negli ambiti di lettura di
altri libri destinati a diverse escursioni. «Distringit librorum multitudo
[…] Probatos itaque semper lege» ed infine «… soleo enim et in aliena
castra transire, non tamquam transfuga, sed explorator». In questo modo la
memoria scritta segnava i paragrafi di un capitolo determinato e poteva
rivelare l'assenza degli autori cristiani, con l’eccezione di Agostino ad
aprire i fogli su un nuovo leggio.
Se il complesso delle testimonianze lasciate dal poeta nel manoscritto
parigino, osserva ancora Fera, ben documentano le angolature dello sguardo
rivolto ai classici, non vi è dubbio che gli anni Trenta siano quelli di
più intensa sperimentazione, come testimoniano gli esordi compositivi del
De viris e dell'Africa, e che la biografia rappresenti l’unica forma
storiografica contemplata da Petrarca. Appena a ridosso di tutto ciò sta
la gestazione dei Rerum memorandarum libri, dove Petrarca avrebbe innestato
il modello dell'aneddotica di Valerio Massimo su un terreno affatto
diverso e tanto sufficientemente ampio da contenere le ragioni di un
deciso superamento di questa fase5. Valutazioni di tal genere indicano il
motivo strutturale che spiega l'abbandono dell'opera intrapresa in
Provenza e proseguita poi solo fino al IV libro a Parma fra il 1343 e il
1345. In un cerso senso i due motivi convivono. Il ricco materiale
conflito nelle Res memorande appare sapientemente sbozzato proprio dalle
questioni intimamente e allusivamente indicate con la nota sui peculiares e
non solo per il fatto che gli auctores della lista degli anni Trenta sono
ovviamente presenti a vario titolo nella rassegna, ma perché essi4 V. FERA, L’imitatio umanistica, in Il latino nell’età dell’Umanesimo, Atti del Convegno,
Mantova, 26-27 ottobre 2001, Firenze, Olschki, 2004, pp. 17-33. 5 Ibid., pp. 27-29.
2
suggeriscono argomenti di riflessione critica ai quali Petrarca rimarrà
imprescindibilmente legato. L'edizione del Billanovich (1943) mostra le
linee maestre che saldano la composizione delle Res alle letture
fondamentali in quel giro di anni della vicenda petrarchesca, a volte con
la ricostruzione diretta del percorso fino alle postille lasciate dal
poeta nei margini dei suoi codici6, come nel caso del Cicerone di Troyes,
dell'Apuleio Vaticano, del Parigino lat. 5054 con le opere di Flavio
Giuseppe, del Parigino lat. 8500 con Ausonio. Del resto Guido Martellotti
presentando il volume delle Prose petrarchesche edito da Ricciardi, pur
sottolineando il tratto schematico e scolastico dei Rerum memorandarum, ne
ravvisava con sicurezza la differenza rispetto alle compilazioni
precedenti, il diverso respiro dell'opera, l'allargamento dell'orizzonte
sui moderni, insomma il senso sicuro della prospettiva dato al discorso7.
Petrarca lasciava sedimentare la linfa delle sue letture in un'opera
programmaticamente segnata dalla presenza delle fonti, dagli auctores
6 FRANCESCO PETRARCA, Rerum memorandarum libri, edizione critica per cura di G.
Billanovich, Firenze, Sansoni, 1943; ID., Quattro libri del Petrarca e la biblioteca della
cattedrale di Verona, «Italia medioevale e umanisticica», n. s., VII, 1990, pp. 233-
262; puntuali riscontri sono indicati da C. TRISTANO, Le postille del Petrarca nel Vaticano
latino 2193, «Italia medioevale e umanisticica», XVII, 1974, pp. 365-468. 7 FRANCESCO PETRARCA, Prose, a cura di G. Martellotti e di P.G. Ricci, E.
Carrara, E. Bianchi, Milano-Napoli, Ricciardi 1955, p. XII. Ha recuperato questi
spunti - meditati nel lavoro di preparazione della nuova edizione dell'opera -
M. PETOLETTI, I classici e i moderni: percorsi all'interno dei «Rerum memorandarum libri», in Petrarca
nel tempo. Tradizione, lettori e immagini, Catalogo della mostra, Arezzo, Sottochiesa di
S. Francesco, 22 novembre 2003-27 gennaio 2004, a cura di M. Feo, Pontedera,
Bandecchi & Vivaldi, 2003, pp. 373-376. 3
presenti nell'elenco del manoscritto parigino: soprattutto Cicerone8,
Livio9, Virgilio, Orazio, Svetonio, Floro, Valerio Massimo, e ancora Seneca
(il retore e il filosofo identificati nella stessa persona) e Macrobio,
autori questi strategici per la riflessione teorica quanto lo era
Cicerone, e Plinio il Vecchio avuto a disposizione presumibilmente già nei
primi anni Quaranta10. Per la stesura delle Res memorande non si tratta,
dunque, di individuare il canone degli autori prediletti. In questo senso,
come si è detto, l'edizione curata da Billanovich mostra i legami genetici
8 Naturalmente Petrarca non poteva usare l'epistolario ciceroniano
scoperto a Verona a metà del 1345 e non aveva ancora avuto per le mani
Quintiliano, ricevuto nel 1350 da Lapo da Castiglionchio e postillato in momenti
diversi (cfr. M. ACCAME, Le postille del Petrarca a Quintiliano (Cod. Parigino Lat. 7720), in
«Quaderni petrarcheschi», V, 1988, in part. pp. 2-7) e neppure Varrone e gli
scrittori dell’Historia Augusta. Per il panorama delle acquisizioni petrarchesche di
codici cfr. ora la raccolta degli studi di G. BILLANOVICH, Petrarca e il primo
umanesimo, Padova, Antenore, 1996; FEO, Francesco Petrarca cit.9 Per la vicenda del codice di Livio posseduto da Landolfo Colonna
(Parigino lat. 5690) - letto molto presto ad Avignone ma acquisito da Petrarca
solo nel 1351 - cfr. P. DE NOHLAC, Pétrarque et l'humanisme, nouvelle éd. remanieé et
augmenteé, Paris, H. Champion, 1965, II, in part. pp. 14-33; G. BILLANOVICH, La
tradizione del testo di Livio e le origini dell'Umanesimo, I 1, Tradizione e fortuna di Livio tra Medioevo e
Umanesimo, Padova, Antenore, 1981, pp. 123-175, 208.10 L'abbondanza delle citazioni dal VII libro della Naturalis historia nel
percorso dei Rerum memorandarum, la presenza di almeno una postilla nei margini
della biografia di Cicerone contenuta nel codice di Troyes (f. 122) che rinvia
ancora allo stesso VII libro pliniano (Nolhac, Pétrarque, cit., I, p. 235) e una
postilla a Servio, In Aeneida, III 284, databile alla metà degli anni '40 lasciata
nel Virgilio Ambrosiano, sembrano confermare il fatto che Petrarca ebbe modo di
consultare l'esemplare di Plinio conservato nella biblioteca papale di Avignone
prima di acquisire nel 1350 l'attuale Par. lat. 6802. Su questo snodo rinvio al
commento di Marco Petoletti in FRANCESCO PETRARCA, Le postille del Virgilio Ambrosiano, a
cura di M. Baglio, A. Nebuloni Testa e M. Petoletti, Presentazione di G. Velli, I-
II, Padova, Antenore, 2006, II, nr. 887, p. 710. 4
con la lista dei peculiares che indirizzano l'impegno enciclopedico
intrapreso da Petrarca. Vale lo sforzo, invece, e può essere lecito
affrontare l'opera sia pure per segmenti minimi e nel reticolo dei testi
fruiti saggiare i criteri di selettività, le forme della renarratio, sempre
attivamente sperimentata, e nella messe di osservazioni recuperare ad
esempio gli spunti di riflessione intorno alla lingua, allo stile, forse
allo statuto della lingua volgare.
Come sempre il testo petrarchesco offre l'opportunità di aprire un
vastissimo laboratorio. Propongo qui, a titolo di contributo, un modesto
manipolo di schede intestate alla terminologia critica evidenziabile nel
capitolo tredicesimo del libro primo — sezione romana del trattato De studio
et doctrina — e ventesimo del secondo libro — sezione romana del De ingenio et
eloquentia — dedicati agli studi, alla cultura e alle opere letterarie di
Augusto di cui Petrarca leggeva nella biografia di Svetonio 11.
11 Riproponendo il testo di Petrarca indico, per chiarezza, fra parentesi
quadre i capitoli svetoniani direttamente implicati e conservo il corsivo
adottato da Billanovich nella sua edizione per evidenziare le differenze
rispetto alla fonte. Sulla scorta delle ricerche di Billanovich, sappiamo che
Petrarca ha posseduto uno Svetonio precedentemente all’acquisizione del codice
Berlinese lat. fol. 337, effettivamente usato almeno fino al 1340. Gli altri
manoscritti svetoniani sono l’attuale codice Oxford, Exeter College, 186 –
entrato nella biblioteca di Petrarca dopo il 1345 e ampiamente postillato - e il
miscellaneo Parigino lat. 5802 ottenuto molto più tardi e quasi privo di note di
attenzione sul testo di Svetonio. Billanovich giungeva alla conclusione che
nella stesura dei Rerum memorandarum Petrarca non sembrava attingere, in via
fondamentale, ai manoscritti conosciuti; tuttavia nuove evidenze potrebbero
emergere dall'attesa prossima edizione curata da Petoletti. Rinvio, per il
momento, ai saggi di Billanovich come presentati nella raccolta del 1996: G.
BILLANOVICH, Uno Svetonio della biblioteca del Petrarca (Berlinese lat. fol. 337) [1956], ora in ID.,
Petrarca e il primo umanesimo, Padova, Antenore, 1996, pp. 251-261; ID., Un altro Svetonio
del Petrarca [1960], ibid., pp. 262-296. Per la descrizione dei tre codici rinvio
inoltre alle schede di M. Berté nel catalogo di prossima pubblicazione La
5
Rerum memorandarum libri 1, 13
[1] Divus Cesar Augustus, divi Iulii filius, tam studiose paternis
vestigiis inhesisse traditur, ut gravissimis bellorum et imperii curis
oppressus et tot coniuratorum obsessus insidiis horas et momenta
colligeret, nec ullum tempus inutiliter labi sineret [Aug. 78]. Constat
inter comendum radendumque vel lectioni operam dare solitum vel scripture;
inter crebra quoque sompni, cuius parcissimus fuit, intervalla lectorum
sibi vel confabulatorum solatium adhibere [Aug. 79, 1]. [2] «Studia
liberalia» ut Suetonius ait, «ab etate prima et cupide et laboriosissime
exercuit. Mutinensi bello, in tanta mole rerum, et legisse et scripsisse
et declamasse quotidie fertur» [Aug. 84, 1]. Itaque «multa varii generis» ut
ait idem, «prosaica oratione composuit; itemque orationes ad populum et aliqua
de vita sua, quam tredecim libris, Cantabrico <tenus> bello nec ultra,
exposuit». [3] Scripsit et epygrammatum librum [Aug. 85, 1-2] et
epystolarum ad amicos [Suet., Vita Hor.], conditum facetissima gravitate ac
luculentissima brevitate; quod opus inexplicitum et carie semesum
adolescenti michi admodum in manus venit, multum frustraque postmodum
quesitum. Ceterum epystole aliquot sparsim a scriptoribus referuntur,
quarum indaginem studioso committimus lectori. [4] Nec latinis modo sed
grecis, nec rethoricis tantum sed et philosophicis delectatus est. Eo
pertinet quod Apollodori pergamei philosophi filiorumque eius Dyonisii ac
Nicanoris amicitiam quesivit, patremque grandevum iuvenis ipse secum, ne
ullis locis aut temporibus vacaret, ab urbe Roma Apolloniam usque perduxit
[Aug. 89, 1]. [5] Ex utriusque autem lingue auctoribus, quos studiosius
lectitabat, illa cupidius hauriebat que vel precepto vel exemplo ad
eruditionem vite morumque elegantiam pertinent private vel publice
biblioteca di Petrarca. 6
discipline; hec et diligenter annotata servabat et cum res exigeret vel
amicos vel totos exercitus vel provinciales aut urbanos magistratus
illorum interiectione commonefacere solebat [Aug. 89, 2]. [6] In audiendis
recitatoribus poematum sive historiarum sive alterius generis inventorum
mitis et patiens fuit. Omnino singulare hoc habuit, quia cum omnium,
precipueque principum, mos sit presentia contempnere, vetusta mirari, iste
unus etatis sue favit ingeniis [Aug. 89, 3]. Digna quidem sapientissimi
extimatoris veneratio. [7] Quenam enim etas illustrium apud nos ingeniorum
fertilior fuit? Marcum Varronem, Marcum Ciceronem, Crispum Salustium,
Titum Livium, Anneum Senecam, Asinium Pollionem, Virgilium Maronem,
Horatium Flaccum, Ovidium Nasonem, innumerabilesque alios uno tempore,
suis licet vivendi gradibus distantes, habuit, qui se invicem viderint vel
videre potuerint. [8] «Libros integros se natui recitare vel populo per
edictum notos facere» suetus erat [Aug. 89, 2]. Inventum paternum de
temporum ratione, unico errore comperto, super intercalandis scilicet
diebus, emendavit et, ut est scriptum in Saturnalibus, «omnem hunc ordinem
eree tabule ad eternam custodiam incisione mandavit» [Macr., Sat. 1, 14,
14-15]. [9] Nec poetrie expers fuit: extat enim in Virgilium carmen, breve
quidem, sed nec humile nec insulsum; aggressus et tragicum opus studio
ferventi, calle medio destituit delevitque; librum vero versibus exametris
inceptum consummavit, cui nomen est Sicilia [Aug. 85, 2]. [10] Quo ego
nonnunquam velut clipeo adversus obtrectatores meos uti soleo, inter multa
que impacatis michi latratibus obiectant, peregrinum et inauditum poematis
mei titulum frementes cui nomen est Africa; quod quidem variis hactenus
fortune repagulis dilatum heret inter manus diutius quam putabam. Sed ad
inceptum redeo12.12 PETRARCA, Rerum memorandarum libri cit., pp. 11-14. In chiusura del capitolo
il vivace accenno alle polemiche intorno al titolo dell'Africa, scelto
sull'esempio del poema augusteo, già evidenzia lo stretto scambio; in Africa IX
440-442 si allude al problema «[…] Quo terris sidere rapto | Heu heu quam vereor7
Esaminiamo ora alcuni luoghi che interessano la terminologia critica.
I, 13, 2 Itaque «multa varii generis» ut ait idem, «prosaica oratione
composuit; itemque orationes ad populum…»
A fronte della lezione «prosa oratione» di Svetonio13 — iunctura
rintracciabile con la forma prorsa o prosa nel latino post-classico (Sen.
epist. 94, 27; Col. 11, 1, 1; Front. Aur. 1, 22N; Gell. 19, 7, 13) e in due
luoghi pliniani14 — l’occorrenza «prosaica oratione» raccoglie la flessionene quid tibi durior etas | Ostrepat et titulis insultet ceca decoris»; nella
postillatura del manoscritto Laurenziano Aquisti e Doni 441, le note a «titulis»
Attende e «decoris» vel 'paratis' sottolineano appunto l'attenzione di Petrarca per il
'titolo apprestato'. Cfr. V. FERA, La revisione petrarchesca dell'Africa, Messina, Centro
di studi umanistici, 1984, pp. 455-456.13 ? L’apparato critico dell'edizione (p. 12) indicava la possibilità che
la lezione «prosaica» provenisse da un codice di Svetonio posseduto da Petrarca
o da una cattiva lettura. Ringrazio comunque Monica Berté che ha ricontrollato
il microfilm del codice di Oxford, Exeter College, 186, f. 20va. Quanto alla
lezione di Petrarca orationes ad populum a fronte di hortationes ad philosophiam in
Svetonio, Billanovich - nel già citato intervento del 1960 sullo Svetonio di
Oxford appartenuto al Petrarca e sugli altri codici di Svetonio a lui
riconducibili - avvertiva che il Berlinese e l'Oxoniense avevano più o meno la
lezione corretta - orationes ad philosophiam Berl., f. 14v; hortationes ad phylosophiam,
Oxon., f. 20v - e che l’esito in Petrarca, probabilmente frutto di una citazione
mnemonica condizionata dal passo immediatamente precedente, si allineava
comunque alla situazione di mancata revisione dell'opera (BILLANOVICH, Un altro
Svetonio cit., p. 287). 14 «…Cadmo, qui primus prorsam orationem condere instituit» (nat. 5, 112);
«prosam orationem condere Pherecydes Syrius instituit Cyri regis aetate» (nat.
7, 205). Per tutti i luoghi citati cfr. s.v. «prorsa» in Oxford Latin Dictionary, Oxford,
Claredon Press, 1982, p. 1499. Anche nel caso della tradizione pliniana cui ebbe8
aggettivale prosaicus di largo uso medievale15, riconfermata da Petrarca
anche in Rerum memorandarum 2, 17 nella sezione De ingenio et eloquentia dove si
propone il confronto strategico fra i due più alti modelli di eloquenza
latina: «[7] Ut tamen Virgilius oratione prosaica, sic iste [sc. Cicero],
ut est apud eundem Senecam [contr. 3, praef. 8], in carminibus defecit». Sono
accesso Petrarca non si può escludere la presenza di prosaicus come variante, ma
l'eventuale occorrenza non muta i termini della questione.15 Prosaicus è flessione del latino tardo recuperata a partire da Venanzio
Fortunato («Prosaico quotiens direxi scripta ralatu!»: Carmina 7, 11, 1; Vita
Martini 2, 468: «Cuius prosaicus cecinit prius acta Severus»). Cfr. Mediae Latinitatis
Lexicon minus, composuit J.F. Niermeyer […] perficiendum curavit C. Van De Kieft,
Leiden, Brill, 1976, p. 864. Dal confronto con lessici medievali consultati da
Petrarca - Papia e il Catholicon sono presenti con Donato e Prisciano nella
sezione «Grammatica» della nota sui peculiares - risulta che il lemma non è
presente nel Vocabulista di Papia che pure ricorda Ferecide come antichissimo
autore in prosa: «prosa est producta oratio et a lege metri soluta; prorsum enim
antiqui productum dicebant et rectum. Alii prosam aiunt dictam ab eo quod sit
profusa vel spaciose proruat nullo sibi termino prefinito; prosae autem studium
sero viguit quam versuum: omnia enim versibus prius condebantur; prius apud
Graecos Pherecydes, apud Romanos Apius soluta oratione contendit» (PAPIAS,
Vocabulista, Torino, Bottega d'Erasmo 1966, p. 272 [rist. anast. dell'ed.
Venetiis, Philippus Pincius, 1496]; prosaicus è invece lemma registrato da
Uguccione da Pisa, come è noto il lessicografo più consultato da Petrarca: « [1]
Proson grece, latine dicitur longum, productum vel prolixum vel rectum; [2] unde
prosus -a -um, longus et productus et prolixus, et proso -as, producere, [3] et
hec prosa -e, oratio producta et a lege metri soluta, quasi a prolixitate
verborum, quia non coartatur numero pedum vel sillabarum, sed in longum pro
voluntate producitur.; [4] vel prosa quasi profusa, vel quasi prorua, quia
proruat spatiose et excurrat nullo termine sibi prefixo; [5] unde hec prosula
diminutivum; [6] et prosaicus -a -um, unde prosaico -as, prosaice scribere vel
dictare […]» (UGUCCIONE DA PISA, Derivationes, edizione critica princeps a cura di E.
Cecchini [et alii], I-II, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2004, II, p. 999);9
le uniche due occorrenze rintracciabili nel corpus delle opere
petrarchesche16 e possono evidenziare, anche in questo, lo stato di
incompiutezza e mancata revisione in cui fu lasciato il lavoro;
successivamente Petrarca adotterà il sostantivo prosa — mai nella iunctura
«prosa/prorsa oratio» — già ampiamente ricorrente nelle Institutiones di
Quintiliano.
1, 13, 3 Scripsit et epygrammatum librum et epystolarum ad amicos,
conditum facetissima gravitate ac luculentissima brevitate; quod opus
inexplicitum et carie semesum adolescenti michi admodum in manus venit,
multum frustraque postmodum quesitum.
Cesellato con il garbato e un poco fantasioso ricordo di una giovanile
lettura17, il giudizio sulla raccolta di epigrammi e di epistole ad
familiares riesce ad attivare l'idea di un ampio registro stilistico-
retorico. Il primo pannello del dittico «conditum facetissima gravitate»
sfiora un elegante effetto ossimorico amplificato dall’uso del superlativo
e dalla presenza ravvicinata dei due diversi ingredienti che danno il
gusto e il taglio voluto all'ornato stilistico18; la congiunzione della
seconda iunctura «luculentissima brevitate» - in identico cursus velox el'etimologia di Uguccione è poi fedelmente riprodotta da Giovanni Balbi come
flessione all'interno della voce prosa, ma con l'aggiunta anche di un lemma
autonomo: «Prosaicus -ca -cum in prosa est et corripit penultima» (JOANNES BALBUS,
Catholicon, Westmead, Gregg, 1971 [rist. anast. dell’ed. Mainz 1460]). 16 Ho consultato i testi della raccolta digitale F. PETRARCA, Opera Omnia, a
cura di P. STOPPELLI. 17 Billanovich (ad loc., p. 12) suggeriva che Petrarca aveva forse potuto
costituire una raccoltina di brani epistolari trascritti dagli autori che li
riportavano come Seneca e Giuseppe Flavio, quest'ultimo ricordato esplicitamente
nella Senile 14, 1. Cfr. anche L. REFE, Le postille del Petrarca a Giuseppe Fravio (Codice
Parigino Lat. 5054), Firenze, Le Lettere, 2004, pp. 64-65. 10
omeoteleuto - rafforza l'effetto combinatorio nella qualità della narratio
brevis che si esplica positivamente come «chiarissima concisione» quando è
ben modellata, capovolgendo l’obscuritas sanzionata da Orazio «...brevis esse
laboro, | obscurus fio» (ars 25-26). La brevitas non plasmata porta
all’oscurità, all’esatto contrario della chiarezza e dello splendore19.
Dunque Petrarca è intento ad una riflessione critica che, adottando la
terminologia codificata, elabora comunque moduli espressivi originali e di
solida efficacia. La questione della brevitas incardina una norma estetica
tanto fondamentale quanto complessa perché riguarda il criterio di
selettività — ad esempio necessario nel genere storiografico — come la
ricchezza, la densità, la chiarezza dei concetti, la concatenazione
sintattica, il rapporto che s' instaura a livello linguistico e retorico
fra ordo naturalis e ordo artificialis.
18 Come è noto il codice ciceroniano di Troyes (Bibl. Municipale, 552)
appartenuto a Petrarca presenta una lacuna nel testo del II libro del De oratore
(f. 286r) all’altezza dei §§ 246-287 dove si parla anche delle facetiae e quindi
non consente di seguire la lettura del poeta nei passi di Cicerone che
presiedono alla identificazione del genere (de orat. 2, 248): «Haec igitur sit
prima partitio: quod facete dicatur, id alias in re habere, alias in verbo
facetias […] Sed de hoc mementote, quoscumque locos attingam unde ridicula
ducantur, ex isdem locis fere etiam gravis sententias posse duci…». L'uso di
conditus in senso retorico è confrontabile in altri luoghi petrarcheschi: ad
esempio in sen. 2, 3, 1 ancora un passo di matrice ciceroniana: «Quanta vis esset
eloquii, lepore simul et ratione conditi, atque hinc verbis, hinc sententiis
affluentis, sepe re cognitum atque compertum est». FRANCESCO PETRARCA, Res seniles. Libri
I-IV, a cura di S. RIZZO con la collaborazione di M. BERTÉ, Firenze, Le Lettere,
2006, p. ***. Ringrazio Silvia Rizzo e Marco Petoletti con i quali ho discusso a
questo proposito.19 Cfr. Isid. etym. 10, 154: «luculentus ab eo quod sit lingua clarus et
sermone splendidus».11
1, 13, 5 Ex utriusque autem lingue auctoribus, quos studiosius
lectitabat, illa cupidius hauriebat que vel precepto vel exemplo ad
eruditionem vite morumque elegantiam pertinent private vel publice
discipline; hec et diligenter annotata servabat et cum res exigeret vel
amicos vel totos exercitus vel provinciales aut urbanos magistratus
illorum interiectione commonefacere solebat.
Nei puntuali riferimenti alla lettura degli auctores, gli annotata, come
scrive Petrarca leggendo da Svetonio ad verbum excerpta, sono ad esempio i
lemmi, le definizioni, le sentenze da sottolinerare, indicare, conservare,
rendere più facilmente fruibili a distanza di tempo, come appare
copiosamente nella postillatura dei codici petrarcheschi20, sicché era
individuata, per rimanere al testo in questione, proprio nell'attitudine
di Augusto a prendere appunti per richiamarli alla memoria nelle diverse
occasioni, con destinatari e uditòri diversi. Un altro luogo interessante
è in Mem. 3, 93, 1-3 dove fra gli esempi di saggezza, alla fine di due
lunghe sequenze dedicate ai personaggi della storia e della cultura prima
latina e poi greca, compare un capitolo rivolto alle sentenze anonime che
un uso prolungato ha tradotto in proverbi resi celebri dagli stessi
autori. Petrarca sottolinea l'efficacia comunicativa e la pregnanza in
particolare di quelli diffusi «in sermone vulgari», per i quali
l'altissimo apprezzamento è tanto più rilevante perché consapevolmente20 Per il significato delle ‘note’ petrarchesche che raccoglievano le
sentenze degli antichi cfr. le osservazioni in margine alle letture oraziane in
FEO, Petrarca cit., p. 412; ID., ‘Sì che pare a’ lor vivagni’. Il dialogo col libro da Dante a
Montaigne, in Agnolo Poliziano poeta scrittore filologo. Atti del Convegno internazionale di
studi, Montepulciano, 3-6 novembre 1994, a cura di V. Fera e M. Martelli,
Firenze, Le Lettere, 1998, pp. 245-294; A. TORRE, «Lege memoriter». Petrarca e l'arte della
memoria, «Lettere italiane», 56/1, 2004, pp. 13-49. Per l'individuazione di
versi sentenziosi e aforismi nel Petrarca volgare si attende uno studio di Elena
Strada sui versi sentenziosi nel Petrarca volgare. 12
giustapposto al connotato negativo e difettivo concernente proprio il
passaggio da una genesi sapienziale e autoriale, ancorché oscura o resa
tale dal tempo, all’ambito di diffusione nel volgare come lingua dei
rustici, della gente semplice, o di coloro che deficitano per età:
3, 93. [1] Sunt quedam et sine auctore famosissima longo usu in
proverbium versa et velut omnium hominum approbata consensu. Qualia sunt
innumerabilia in sermone vulgari, que vel horrens villicus vel tremens
anus sic enuntiet interdum ut mirari nos cogat et subsistere et repetiti
verbi laudare sententiam acumen ornatum vim sonum magnificentiam
brevitatem, denique vel in silentio fateri nichil de tali re melius,
nichil verius, nichil sapientius, nichil elegantius etiam ab eruditissimis
ac disertissimis dici posse. Nimirum a talibus nec ab aliis a primordio
dicta sunt, licet ea postmodum et spectata veritas et memorie amica
brevitas in vulgus effuderint. [2] Multa quoque huius generis passim per
auctorum libros offendimus, e quibus exempli causa pauca subiciemus […]21.
Il discorso sembra implicare la questione del rapporto fra lingua
scolastica /letteraria e lingua in uso, auctoritas e consuetudo22. E coinvolta
risulta ancora, come strumento dotato di straordinaria potenza, la forma21 PETRARCA, Rerum memorandarum libri cit., p. 179. 22 Interessanti le postille vergate poi nel suo codice di Quintiliano (Par.
lat. 7720): in margine a inst. 1, 5, 71 «Usitatis (sc. verbis) tucius utimur, nova
non sine quodam periculo fingimus» Petrarca avrebbe apposto Nota e altre note e
segni di attenzione anche in margine ai paragrafi successivi dove Quintiliano
affronta distesamente la questione. Cfr. ACCAME, Le postille cit., p. 42. Sulla
preminenza da assegnare alle parole in uso, da attingere in primo luogo nella
tradizione autoriale, perché le parole sono simili alla moneta secondo la
metafora quintilianea più tardi ripresa anche da Lorenzo Valla, cfr. S. RIZZO,
Ricerche sul latino umanistico, I, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, pp. 15-
73: pp. 65-68. 13
breve alleata della memoria «memorie amica brevitas»23. La riflessione di
Petrarca accosta due tipologie che possono rimanere distinte o anche dare
luogo a contaminazioni nello sviluppo del discorso24. Si tratta delle
espressioni proverbiali che hanno una marcata afferenza con l'ambito della
lingua quotidiana non scritta (la iunctura «pervulgatum-proverbi locum» è,
ad esempio, in Cicerone, Tusc. 4, 36 proprio con riferimento ad un uso
allargato dei termini); la seconda configura appunto le sententiae raccolte
23 Ancora una riflessione sulla brevitas muove dalle sentenze eraclitee
prelevate da Seneca (epist. 58, 23 e 70, 1-4). Petrarca si rammarica di non
poterle tenere a memoria a distanza di anni «tam breviter quam obscure» (Mem.
III, 80, 1) esse si dimostrano. All'oscurità delle espressioni più che alla
complessità semantica Petrarca sembra legare la maggiore labilità della memoria;
in realtà la sensibilità petrarchesca percepiva una raffinata figura retorica a
struttura antitetica ispirata dall'icona eraclitea del movimento perpetuo ed
inafferrabile scelto dal poeta come esempio: «In idem flumen bis descendimus et
non descendimus» (ibid.), una metafora del volgere del tempo che rompe le stesse
categorie spazio-temporali con le quali viene immaginato e rappresentato dalla
mente umana: «Ceterum incomprehensibilem temporis fugam hoc elogio significare
voluit, que quoniam in flumine sensibus apertior est, idcirco de flumine loqui
maluit » (ibid.). Nel codice laurenziano di Orazio posseduto da Petrarca (Laur.
XXXIV, 1) il luogo delle Satirae 1, 10, 9-12 in cui si parla del cardine della
brevitas come norma che sorregge il ruolo dell'oratore, del poeta e dell'uomo
urbano «est brevitate opus-poete» rimane segnato da Petrarca con graffa di
attenzione. Cfr. E. ROSTAGNO, L'Orazio laurenziano già di Francesco Petrarca, Roma, La
libreria dello Stato, 1933, f. 120v; G. BILLANOVICH, L’Orazio Morgan. Il giovane Petrarca
tra i grandi studi e le nuove rime [1985], in ID., Petrarca e il primo umanesimo cit., pp. 41-58;
M. FEO, Petrarca Francesco, in Enciclopedia oraziana, III, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 405-425: pp. 405-407, 414. Sul tipo di graffa
usato nel codice laurenziano cfr. M. FIORILLA, Marginalia figurati nei codici di Petrarca,
Firenze 2005, p. 25, nota 14.24 Cfr. ora il recente contributo di G. CALBOLI, Aforismi a Roma, in Teoria e storia
dell’aforima, premessa di V. Roda, introduzione e cura di G. Ruozzi, Milano,
Mondadori, 2004, pp. 17-38. 14
dalla tradizione autoriale che dovevano interessare il poeta, oltre che
per il contenuto morale, anche per la struttura linguistica, per il ritmo
impresso alla parola e alla frase, per l’incisiva brevità, interessi
appunto documentati nei notabilia dei manoscritti petrarcheschi.
La cultura di Augusto, l'abilità oratoria, la scrittura consumata dalla
tensione verso la semplicità e la chiarezza, lo stile tendente ad un
equilibrato atticismo misurato con l’avversione per i termini desueti
(inusitata) che puzzano di muffa (fetores), i termini con i quali Svetonio
alludeva alla retorica asiana, come pure il modo di parlare, l'uso di
motti di spirito e di arguzie, di vocaboli sapidi e originali di cui
l’imperatore faceva uso per aumentare l'espressività dell'eloquio, tutti i
caratteri presentati da Svetonio si compongono nella definizione di un
modello. Augusto entra nella notizia degli auctores latini prìncipi
dell'eloquenza proprio con l'importante testimonianza di Svetonio circa
l'eredità di Cesare raccolta dal suo successore anche sul piano della
scelta stilistica:
2, 20. [1] Cesaris Augusti ingenium tam promptum invenio ut versus ex
tempore factos cum inter amicos referret interrogaretque cuius poete
versus extimarent, «nichil aliud responderetur quam cuiuscunque forent esse
optimos» [Aug. 98]. [2] Sed quod ad hunc actum pertinet puto nullum equari
posse Nasoni poete, qui — ut est apud Senecam [contr. 2, 2, 8]— hoc seculum
amatoriis non artibus tantum sed sententiis implevit. De exundanti quidem
facultate carminum Ovidius ipse gloriatur [Trist. 4, 5, 19-26], nec
mendaciter. Sed ad Augusti eloquentiam revertor. [3] Non laboro inter
eloquentie principes ipsum collocare, nisi quantum ad iocos et facetias,
in quibus primum tenebit locum; sed subripere fame eius nolo, quod clari
sibi tribuunt scriptores: pronuntiavit dulci et proprio quodam oris sono,
eleganti ac sobria usus eloquentia, sententias ineptas fugiens,
15
precipueque verborum inusitatorum, ut verbo ipsius utar, fetores horruit.
[4] Unum in loquendo studium: intelligi et quam clarissime conceptum
mentis exprimere. Hinc et prepositionibus et coniunctionibus abundare,
quibus incomptior sed plane luminosior resultat oratio et intellectus
rerum expeditior. [5] Ignota sectantes sprevit irrisitque; et castigavit
in suis hunc morem, insaniam vocans ea loqui vel scribere que admirationis
plus quam intelligentie illatura sint animis audientium [Suet. Aug. 84 e
86]. Inheserat sibi quidem, ut arbitror, paternum preceptum, quod proxime
cum de Iulio Cesare loquerer inserui25.
Dislocando i capitoli della biografia in diversi punti dell'opera,
Petrarca aggiorna la sua fonte rendendola permeabile e interattiva con
altre26. Così appare l'inserzione del confronto fra i due stili poetici di
Augusto e di Ovidio e poi, a proposito della struttura polisindetica25 PETRARCA, Rerum memorandarum libri cit., pp. 56-57.26 Aug. 84 «[1] Eloquentiam studiaque liberalia ab aetate prima et cupide et
laboriosissime exercuit. Mutinensi bello in tanta mole rerum et legisse et
scripsisse et declamasse cotidie traditur. Nam deinceps neque in senatu neque
apud populum neque apud milites locutus est umquam nisi meditata et composita
oratione, quamuis non deficeretur ad subita extemporali facultate. [2] Ac ne
periculum memoriae adiret aut in ediscendo tempus absumeret, instituit recitare
omnia. Sermones quoque cum singulis atque etiam cum Liuia sua grauiores non nisi
scriptos et e libello habebat, ne plus minusue loqueretur ex tempore.
Pronuntiabat dulci et proprio quodam oris sono dabatque assidue phonasco operam;
sed nonnumquam infirmatis faucibus praeconis uoce ad populum contionatus est».
Aug. 86 «[1] Genus eloquendi secutus est elegans et temperatum uitatis
sententiarum ineptiis atque concinnitate et reconditorum uerborum, ut ipse
dicit, fetoribus; praecipuamque curam duxit sensum animi quam apertissime
exprimere. Quod quo facilius efficeret aut necubi lectorem uel auditorem
obturbaret ac moraretur, neque praepositiones urbibus addere neque coniunctiones
saepius iterare dubitauit, quae detractae afferunt aliquid obscuritatis, etsi
gratiam augent». 16
preferita «in loquendo» da Augusto, elemento che rende il discorso
«incomptior sed plane luminosior», Petrarca implica un giudizio sulla
elegantia e sulla perspicuitas, sulla necessità di adeguare il discorso al
pubblico e chiama ancora in causa il profilo negativo della obscuritas
incidente sul piano lessicale, sintattico, narrativo ed infine ideologico.
Il confronto con il ritratto letterario di Augusto crea i preupposti di
una proiezione mimetica resa esplicita, con la tecnica del
contrasto/dissimilazione, da ultimo nel messaggio della Posteritati:
Eloquio, ut quidam dixerunt, claro ac potenti; ut michi visum est,
fragili et obscuro. Neque vero in comuni sermone cum amicis aut
familiaribus eloquentie unquam cura me attigit; mirorque eam curam
Augustum Cesarem suscepisse. Ubi autem res ipsa vel locus vel auditor
aliter poscere visus est, paulo annisus sum; idque quam efficaciter,
nescio: eorum sit iudicium coram quibus dixi. Ego, modo bene vixissem,
qualiter dixissem parvi facerem: ventosa gloria est de solo verborum
splendore famam querere27.
Questa trafila appare allora ben tracciata nei Rerum memorandarum. I
versi oraziani dell'Ars poetica (25-26) sono esplicitamente addotti in Mem.
4, 97, 3 per rimproverare a Valerio Massimo di aver omesso una parte
importante dell’aneddotica riguardante Deiotaro, facilmente desumibile
dalle fonti ciceroniane, rendendo così incomprensibile il discorso perché
mutilato della polemica di Cicerone contro le credenze superstiziose28. La
27 Posteritati 12. Leggo il testo, egregiamente commentato, in GIOVANNI
BOCCACCIO, Vita di Petrarca, cura di G. Villani, Roma, Salerno, 2004, pp. 106-135: p.
110 28 Cfr. le osservazioni di R. FUBINI, Luoghi della memoria e antiscolasticismo. I
Rerum memorandarum libri, in Visuelle Topoi. Erfindung und tradiertes Wissen in den Künsten der
italienischen Renaissance,[hrsg. von] U. Pfisterer, M. Seidel, Deutscher Kunstverlag,17
definizione delle tipologie di narratio brevis d'altro canto sembra confermare
un punto di grande interesse, quello che concerne le osservazioni di
Petrarca circa i rapporti fra latino e volgare. A favore della linea
critica tracciata da Michele Feo29 e Mirko Tavoni30 - secondo la quale
Petrarca condivideva la visione medievale che intende il latino e il
volgare non come lingue differenti ma come registri stilistici diversi
nell’ambito di una sola lingua - Silvia Rizzo31 ha ricordato il giro di boa
della famosa lettera a Boccaccio su Dante (Fam. 21, 15, 24-25). L'epistola
(databile al 1359) reca ancora l'inserto della citazione senecana (contr. 3,
praef. 8) che aveva sostenuto il confronto fra Virgilio e Cicerone nei Rerum
memorandarum. Qui preme sottolineare come all'altezza di quest'opera
Petrarca abbia disegnato un tracciato a tre punte di diamante per
rappresentare i tre differenti stili all'interno di una lingua unica. La
riflessione sul volgare si evidenza nel secondo libro con il recupero di
aneddoti e motti faceti di cui Dante sarebbe stato protagonista:
2, 83. [1] Dantes Allegherius, et ipse concivis nuper meus, vir vulgari
eloquio clarissimus fuit, sed moribus parumper contumacior et oratione
liberior quam delicatis ac fastidiosis etatis nostre principum auribus
atque oculis acceptum foret.
München-Berlin, 2003, pp. 171-181. 29 M. FEO, Petrarca, in Enciclopedia Virgiliana, IV, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1988, pp. 53-78. 30 M. TAVONI, Latino e volgare, in Storia d'Italia, diretta da R. Romano, V 1,
Milano, Fabbri, 1990, pp. 217-240. 31 Su tutto questo cfr. i recenti contributi di S. RIZZO, Petrarca, il latino e il
volgare, «Quaderni petrarcheschi», 7 (1990), pp. 7-40, e ora rifluito in EAD.,
Ricerche cit., pp. 15-73.18
Dal passo si può implicitamente dedurre che Petrarca intendeva appunto
afferenti al bacino della lingua vulgaris sia il latino degli illitterati32
sia il volgare colto (eloquius) di Dante. In secondo luogo l’importante
presenza di Dante inserito nella tradizione dei dicta, iocalia, apophthegmata
farebbe anche intendere che in quelle forme, appunto avvicinabili
all’antica tradizione latino-italica del saturnio, si potesse radicare la
pianta dei due stili. Nei capitoli delle Res memorande dedicati
all'eloquenza di Isocrate e ai numeri oratorii che costringevano sotto
regole le parole sciolte della prosa (Mem. 1, 33 e 2, 32), Silvia Rizzo ha
individuato i punti della riflessione che riguardano i diversi generi
dell’eloquenza33, fino ad arrivare alla conclusione che Petrarca stesse
32Alla stessa costellazione semantico-lessicale mi sembra si possa
affiancare la polemica contro la lingua dei traduttori latini di Aristotele: […]
Ego autem curiosior sum quam necesse est: moveor tamen quia, cum prescriptis
aliisque claris et crebris testimoniis Aristotilem non minus eloquentia quam
scientia copiosum legam, in libris tamen eius qui ad nos venerunt scientie certa
fides, eloquentie vestigium nullum est. Unde grandis michi stupor oboritur. [7]
Illos mentiri constat elingues simul ac procaces, qui quoniam Aristotili suo,
quem semper in ore habent, similes esse nulla modo possunt, illum sibi similem
nituntur efficere, dicentes eum, ut qui altissimis rebus intenderet, omnis
eloquentie contemptorem, quasi in altis rebus nulla verborum claritas possit
habitare, cum contra sublimem potius scientiam altus deceat stilus,
verissimumque sit quod a Cicerone dictum est. «Cum» inquit, «de rebus grandibus
dicas, ipse res verba rapiunt. Ita fit cum gravior, tum etiam splendidior
oratio» (Mem. 2, 31, 7-8). Da cfr. anche il passaggio nelle Invective contra medicum
quendam: […] Quo enim tua hec impertinens et absurda relatio? Ubi, undique
victus, ac consternatus animo, et oblitus tui, - quis non risu pereat? - ad
inimicum tandem fugiens, minime latinis quidem aut congruis, sed maternis atque
vulgaribus verbis, ydiota rudissime, Priscianum in auxilium tuum vocas (3, 5).33 Nel manoscritto ciceroniano di Troyes ( Bibl. Municipale 552, f. 304rb)
segni di attenzione e una nota a margine del testo di Cicerone (or. 174-176= IV
libro del De oratore per Petrarca) esplicitano il nesso istituito da Petrarca con 19
pensando alla prosa ritmica e poetizzante come quarto genere - in aggiunta
alla tradizionale tripartizione in tre generi (prosaico, metrico e
ritmico) - cui Petrarca alluderebbe con l’espressione ysocratice habene della
Familiare 1, 1, 6. Una situazione interessante si prospetta, a mio avviso,
anche in Mem. 2, 36, dove compare Antipatro di Sidone reso celebre da
quella dote naturale per l'improvvisazione poetica, ricordata nel passo
ciceroniano del De oratore (3, 194-195), e la cui abilità Petrarca assimila
appunto alla naturale facilità del sermo vulgaris (in Cicerone si nomina il
vulgus imperitorum), affatto mancante nelle prove di innominabili
improvvisatori moderni:
2, 36. [1] Antipater sidonius quidam tam exercitati ingenii fuisse
traditur, ut versus exametros aliosque diversorum generum ex improviso
copiose diceret. Quocunque animum linguamque vertisset nichil operosius
illi quam sermo vulgaris aliis solet et numeri aderant et carmina
resonabant.[2] Fecisse feruntur idem ex modernis quidam, sed tam
pueriliter tamque ridicule, ut iudice me nec nomen nec locum inter
illustria mereantur. [3] Deinceps parumper frena stilo laxentur, ut, non
tam preterito defessa quam venturo se preparans labori, in aliquod vicinum
gratumque diversorium deflectat oratio.
Le postille e le note di attenzione presenti nel codice ciceroniano di
Troyes (f. 297r) tracciano la sinopia di questa pagina. Dalle parole, in
capoverso nel codice, «in oratione autem pauci» (De orat. 3, 192) Petrarca
disegna la manicula di attenzione con l'indice puntato; segue Aristoteles sul
margine sinistro del testo che si riferisce alle clausole finali della
il luogo di Macrobio (Sat. 7, 1, 4) in cui si affronta la questione. Cfr. RIZZO,
Ricerche cit., pp. 43-53 (la postilla è edita a p. 45).20
prosa (3, 193); quindi Antipater (3, 194)34 e la postilla Nota, quod quidam
moderni, sed tam ridiculi ut ne nomine digni sunt35; ancora, nel margine destro della
colonna b, la lunga porzione di testo «mirabile est-perfectumque cernunt»
(3, 197-198) è evidenziata tutta da una graffa marginale a forma di
fiorellino a tre puntini e tratto discendente ondulato, con la notazione
iniziale Lege hoc; a margine di «Sed poete non ignoscit, nobis concedit» si
pone Nota, poete non percipi quod oratori percipitur. Se avviciniamo, dunque, il
capitolo petrarchesco al contesto più largo dei passi del De oratore (3, 195-
198) possiamo pensare che Petrarca avesse in mente, sulla scorta diretta
di Cicerone, la riflessione teorica sui generi dell'eloquenza e il
rapporto fra lingua artificiale e lingua naturale (volgare), nonché il
fatto che il vulgus, secondo Cicerone, fosse stato in gradi di percepire e
34 «[193] Duo enim aut tres fere sunt extremi servandi et notandi pedes, si
modo non breviora et praecisa erunt superiora; quos aut chorios aut heroos aut
alternos esse oportebit aut in paeane illo posteriore, quem Aristoteles probat,
aut ei pari cretico. Horum vicissitudines efficient, ut neque ei satientur, qui
audient, fastidio similitudinis, nec nos id, quod faciemus, opera dedita facere
videamur. [194] Quod si Antipater ille Sidonius, quem tu probe, Catule,
meministi, solitus est versus hexametros aliosque variis modis atque numeris
fundere ex tempore tantumque hominis ingeniosi ac memoris valuit exercitatio,
ut, cum se mente ac voluntate coniecisset in versum, verba sequerentur; quanto
id facilius in oratione, exercitatione et consuetudine adhibita, consequemur!».35 La postilla su Antipatro è stata edita da Nohlac (Pétrarque cit., I, p.
242) e poi da Billanovich (PETRARCA, Rerum memorandarum cit., p. CXIX e p. 67).
Sull'impiego del manoscritto di Troyes copiosamente implicato nella stesura
delle Res memorande, insieme con il Vaticano lat. 2193 e il Parigino lat. 8500,
Billanovich ipotizza che «Petrarca deve averli ottenuti mentre ancora operava in
Provenza: dunque nel 1342, e poi se li portò nel settembre 1343 verso l'Italia»
(BILLANOVICH, Quattro libri cit., p. 255). Tuttavia il collegamento con le Res
memorande, evidentemente frutto di un lungo lavoro di raccolta, potrebbe
indicare una datazione delle postille non così prossima all'inizio della stesura
dell'opera (gennaio 1343).21
giudicare sia il ritmo oratorio sia le regole e l'armonia della scansione
metrica36. Il capitolo dedicato ad Antipatro sembra allora confermare la
visione della coesistenza fin dall'antichità di lingua colta e lingua
volgare in una prospettiva per così dire storicistica e diacronica, come è
stato autorevolmente affermato in altri casi, una visione attenta a
individuare nella storia della lingua le parti in assoluto decadimento e
36 Cic. De orat. 3 «[195] Illud autem ne quis admiretur, quonam modo haec
vulgus imperitorum in audiendo notet, cum in omni genere tum in hoc ipso magna
quaedam est vis incredibilisque naturae. Omnes enim tacito quodam sensu sine
ulla arte aut ratione quae sint in artibus ac rationibus recta ac prava
diiudicant; idque cum faciunt in picturis et in signis et in aliis operibus, ad
quorum intellegentiam a natura minus habent instrumenti, tum multo ostendunt
magis in verborum, numerorum vocumque iudicio; quod ea sunt in communibus infixa
sensibus nec earum rerum quemquam funditus natura esse voluit expertem. [196]
Itaque non solum verbis arte positis moventur omnes, verum etiam numeris ac
vocibus. Quotus enim quisque est qui teneat artem numerorum ac modorum? At in
eis si paulum modo offensum est, ut aut contractione brevius fieret aut
productione longius, theatra tota reclamant. Quid, hoc non idem fit in vocibus,
ut a multitudine et populo non modo catervae atque concentus, sed etiam ipsi
sibi singuli discrepantes eiciantur? [197] Mirabile est, cum plurimum in
faciendo intersit inter doctum et rudem, quam non multum differat in iudicando.
Ars enim cum a natura profecta sit, nisi natura moveat ac delectet, nihil sane
egisse videatur; nihil est autem tam cognatum mentibus nostris quam numeri atque
voces; quibus et excitamur et incendimur et lenimur et languescimus et ad
hilaritatem et ad tristitiam saepe deducimur; quorum illa summa vis carminibus
est aptior et cantibus, non neglecta, ut mihi videtur, a Numa rege doctissimo
maioribusque nostris, ut epularum sollemnium fides ac tibiae Saliorumque versus
indicant; maxime autem a Graecia vetere celebrata. Quibus utinam similibusque de
rebus disputari quam de puerilibus his verborum translationibus maluissetis!
[198] Verum ut in versu vulgus, si est peccatum, videt, sic, si quid in nostra
oratione claudicat, sentit; sed poetae non ignoscit, nobis concedit: taciti
tamen omnes non esse illud, quod diximus, aptum perfectumque cernunt. Itaque
illi veteres, sicut hodie etiam non nullos videmus, cum circuitum et quasi orbem22
le stutture da ripristinare. Se la elaborazione delle Res memorande
presenta molti importanti tasselli di riflessione teorica, la stessa
approderà, più tardi, a quella operazione di legittimazione ab antiquo della
poesia volgare che è stata individuata come operazione tutta umanistica
nel testo della Familiare 1, 1, 6 a Ludovico di Beringen (1350):
Et erat pars soluto gressu libera, pars frenis homericis astricta,
quoniam ysocraticis habenis raro utimur; pars autem, mulcendis vulgi
auribus intenta, suis et ipsa legibus utebatur. Quod genus, apud Siculos,
ut fama est, non multis ante seculis renatum, brevi per omnem Italiam ac
longius manavit, apud Grecorum olim ac Latinorum vetustissimos celebratum;
siquidem et Athicos et Romanos vulgares rithmico tantum carmine uti
solitos accepimus».
I generi di eloquenza e le diverse forme della narratio esemplificate
nella raccolta delle Res memorande indicano, fra l'altro, il fronte aperto
su due questioni che si evincono in nuce dalla scrittura del ritratto di
Augusto e che posso qui solo enunciare. La prima, collegabile ad una
tradizione che dai classici passa alle poetiche medievali, concerne il
nesso della facetia con l'elegantia, sul quale si gioca uno dei punti
fondamentali della svolta impressa dall'umanesimo. La seconda riguarda le
tecniche di scrittura e l'ambito di fruizione delle facetiae per lo spazio
che esse condividono con varie forme di narratio brevis e per lo specifico
connotato di elevata ed immediata pregnanza semantica che risulta dalla
combinazione di elementi logici e verbali, come nel caso del motto di
spirito. Perché se è vero che tutti questi generi si apprezzano negli
verborum conficere non possent, nam id quidem nuper vel posse vel audere
coepimus, terna aut bina aut non nulli singula etiam verba dicebant; qui in illa
infantia naturale illud, quod aures hominum flagitabant, tenebant tamen, ut et
illa essent paria, quae dicerent, et aequalibus interspirationibus uterentur».23
ambienti cortigiani e curiali - come dimostra anche l'invio della sezione
De facetiis ac salibus illustrium al cardinale Giovanni Colonna suo protettore -
l'apporto critico di Petrarca mostra gli agganci con un esercizio
letterario impegnato a misurarsi a tutto campo con la storia della lingua
e della letteratura tanto sul versante del volgare, quindi dello stile
legato ad una scottante matrice non colta o ritenuta tale, quanto, come è
ovvio, su quello del latino come lingua scolastica e letteraria per
eccellenza, e poi, se fosse possibile, anche del greco. La presenza, sia
pure in controluce, di Dino fiorentino – forse Dino del Garbo - «qui etate
nostra gratissime dicacitatis adolescens fuit» (Mem. 2, 60; 2, 82), di
Dante, di figure femminili, come nell'episodio che vede Mabilia Colonna
interloquire e tener testa alla maliziosa insinuazione di Bonifacio VIII
«in sermone mordacissimus» e infine ammansito «muliebri facundia» (Mem. 2,
56), insomma tutti gli spunti legati al vasto bacino linguistico del sermo
cotidianus, possono far intravedere, nel volgere incompiuto dei Rerum
memorandarum libri, la strada che Petrarca stava compiendo al 'crocevia'
dell’universo linguistico del suo tempo.
24