Onorio I e la tradizione occidentale, in "Augustinianum" 27/3 (1987), pp. 571-615
Transcript of Onorio I e la tradizione occidentale, in "Augustinianum" 27/3 (1987), pp. 571-615
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE
Status quaestionis e definizione deI problenla
Nel 1948 P. Galtier in un suo artieolo dedieato aHa questione di Onorio 1 diehiarava: «l'aeeord s'est fait, sen1ble-t-il,sur la doetrine professee par le pape Honorius dans sa premiere lettre» 2. In efIetti sembrava allora essersi stabilito UD
aecordo di massima fra gli studiosi: orlnai eadute le aeeusedi monotelismo e nl0noenergismo, si rieonosceva ehe il rifiutodeI pontefiee per la formula due energie rivestiva un earatterepiu formale ehe sostanziale, mentre !'i!nprudente eonfessioneuna volonta, veniva ora letta eome una generiea eonforrnita divoleri ehe non eseludeva, di per se, la presenza d'una volontaUlnana nel Salvatore 3. Tale aeeordo, pero, si liInitava al sempliee rieonosein1ento dell'ortodossia in Onorio e non eon1prendeva un efIettivo eonvergere di giudizi in merito al contenutodottrinario delle due lettere, sul quale perrnanevano incertczzee perplessita.
Coseiente della parzialita di sin1ili risultati, P. Galtier riprendeva la questione impostando il problema su nuove basi e,forse per la prima volta, veniva tentata un'analisi aecurata e
1 P. Galtier, La premiere lettre du pape HOl1orius: SOllrces et eclaircisseInents , in Gregorianum 29 (1948) 42-61.
2 Ibid., p. 42.3 Cfr. C. Hefele-H. Leclercq, Histoire des Conciles, 111/1, Paris 1909,
pp. 359-364; E. Amman, Honorius leT, DTC VIII, Paris 1927, ce. 130-132;V. Grumel, Recherehes sur l'histoire du monothelisme, in Echos d'Orient28 (1929) 274ss. Queste non sono ehe indieazioni di luassin1a e la bibliografia da allora si e ulteriormente aeereseiuta. Per un esame esaurientedella stessa, nonche di tutta la questione, rimandiamo al piu reeenteG. Kreuzer, Die Honoriusfrage in Mittelalter und in der Neuzeit [Päpsteund Papsttum, 8J, Stuttgart 1975. Per notazioni bibliografiche piu aggiornate cfr. Di Berardino, Onorio papa, in Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane 11, Roma 1984, 2483-2484 (:= d'ora in poi DPAC).
572 E. ZOCCA
specifica sulla fon ti della prima lettera. Sebbene la sua ricercasi limitasse all'an1bito terminologico, ulteriormente circoscrittoall'esame della sola communicatio idionlatum e deI termineoikonlia - dispensatio 4, essa era gia in grado di fornire risultati di notevole interesse. Lo studioso infatti, attraverso unesame terminologico esaustivo, ripercorreva la genesi di un particolare aspetto deI linguaggio di Onorio fino a rintracciarne lefonti patristiche; in tal modo egli riusciva a ricondurre la frasecontroversa «l'economia dell'umanita assunta» ad un'espressione d'uso corrente presso i Padri, generahnente impiegata perindicare l'umanita assunta dal figlio di Dio, e coglieva, nelpasso da cui era tratta, un riconoscimento formale della "volonta umana di Cristo 5.
Nel corso di tale esame si era venuta evidenziando la presenza d'un rapporto costante fra Onorio ed alcuni autori dellatradizione occidentale, con particolare riferimento a LeoneMagno ed Agostino 6. Galtier anzi, a proposito di quest'ultimo,osservava: «Mais l'idee d'un echange d'appellation qui le faitpasser de cette constatation a celle d'un vouloir unique semblebien lui - a Onorio - venir de Saint Augustin» 7. Questa osservazione era basata esclusivamente su alcuni passi agostiniani concernenti la cOlnmunicatio idiolnatum 8 e la possibilita d'un preciso rapporto fra Onorio e l'Ipponate in meritoal problema della volonta non veniva ulteriormente indagata,tuttavia P. Galtier con le sue intuizioni dischiudeva un nuovo
4 P. Galtier, La premiere lettre, pp. 48-61.5 Cfr. ibid., pp. 59-61. Alle pp. 54-55 l'autore presenta una discussione
critica sui giudizi formulati precedentemente, i quali con maggior 0 minore convinzione ricalcavano la posizione di Schneemann (Studien überdie Honoriusfrage, Fribourg 1864, pp. 46-47). Questi vedeva "nelle paroledeI papa un'accomodamento della natura umana che Cristo ha accettato,una condiscendenza liberamente consentita alla nostra debolezza (cfr.Hefele-Leclercq, ap. eit., p. 362; E. An1man, art. eit., p. 104). Accanto atale interpretazione ne esiste una piu antica, ricordata sia in Hefele-Leclercq (pp. 362-364) che da Amman (pp. 102-105), secondo la quale Onorioconsidererebbe le parole di Cristo un semplice modo di parlare perdare un esempio agli uomini.
6 Cfr. P. Galtier, La premiere lettre, pp. 48-51. Bisogna notare chel'autore non sottolineava esplicitan1ente la presenza d'un tale rapporto,tuttavia esso risulta evidente dagli esempi citati.
7 [bid., p. 51.8 Aug. e.s. Arria11. 8 (PL 42, 688); e. Max. 11, 20, 2-3 (PL 42, 788-789);
trin., I, 13, 28 (CCL 50, 69-71); cfr. P. Galtier, La premiere leUre, p. 50.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 573
rorizzonte per gli studiosi dell'Honoriusfrage e suggeriva implieitamente un'ipotesi di rieerea: la via della tradizione oeeidentale.
Tale indieazione non venne raeeolta ed un reeente studiosulla eontroversia monotelita 9 sembrerebbe muovere in direzione opposta: F. Careione, ehe ne e l'autore, pur n10strandodi eonoseere l'artieolo eonsiderato 10, appare infatti maggiorn1ente influenzato da autori di eultura tedesea, in partieolaredal Kreuzer 11, e propone una lettura deI pensiero di Onorioin ehiave totalmente «orientale». Per esprimerei piu ehiaramente, Careione, riprendendo un veeehio n1otivo dell'Honoriusfrage, eonsidera determinante l'influsso esereitato da Sergiosulla eomposizione delle due lettere 12 ed aggiunge, di propria,l'ipotesi ehe il pontefiee avesse una eonoseenza personale dellaeultura teologiea dominante in Oriente, ivi eomprese aleunequestioni terminologiehe di non searso rilievo. In eonseguenzadi tale prospettiva il pensiero deI papa viene eonsiderato eomeperfettamente aderente aHa problematiea deI patriarea bizantino, ed il partieolare monotelismo eonfessato da Onorio e identifieato ean quella farma di monotelismo ipostatieo, di stamposeveriano, propugnata dallo stesso Sergio 13.
9 F. Careione, Sergio di Costantinopoli ed Onorio I nella controversia monotelita deZ V II s., Roma 1985.
10 Esso viene eitato nella bibliografia generale (p. 14) ed alla nota29 di p. 60.
11 G. Kreuzer, op. cit.12 Fra i sostenitori di questo veeehio motivo si possono rieordare,
a titoIo d'esempio, H. Grisar, Papa Onorio I ed iZ conciZio ecumenicodeZ 680-681, in AnaZeeta .Romana 1 (Roma 1899), p. 400; HefeIe-Leelereq,op. eil., p. 392; J. Pargoire, L'Eglise Byzantine de 525 Cl 847, Paris 1905,p. 159; V. Grumel, Reeherches sur l'histoire du monothelisme, in Eehosd'Orient 27 (1928) 167; ete. A queste eIeneo si pub senz'altro aggiungere ilKreuzer, sebbene gia si mostri in '1ui una tendenza spieeata ad inserire laposizione di Onorio in quella linea di pensiero aIessandrina ehe giunge aTeodoro d Faran e, di B, fino a Sergio (efr. Kreuzer, op. eit., pp. 55-56).
13 La dipendenza di Onorio da Sergio, sotto queste partieoIareaspetto, viene indagata daI Careione (pp. 59-68) nell'ambito deI rapportoeompIessivo fra i due. Piu ampio spazio trova inveee una trattazionespecifiea sulle aseendenze deI monotelismo professato da Sergio. Dopoun esame piuttosto ampio delle possibili fonti, l'autore eonelude evidenziando uno stretto rapporto fra Ia eristologia di Severo (sostenitore d'unmonofisismo ({ apparente» e dunque sostanziaInlente ortodosso) e quelladi Sergio, eon partieolare riferimento aHa questione dell'energia edellavolonta. Severo infatti, pur sostenendo due eategorie di operazioni nel
574 E. ZOCCA
Una tale varieta di proposte induee a eredere ehe sia ormaigiunto il momento di eonsiderare eon piiI attenzione il problema globale delle fonti di Onorio. Troppo spesso infatti si dimentiea ehe il pontefiee visse in un ambiente di stretta osservanza ealeedoniana 14, ehe aveva selnpre guardato eon diffidenzaall'ardita speeulazione orientale; ipotizzare quindi un'influenzadeeisiva di Sergio su Onorio, 0 una speeifiea dipendenza di
Salvatore, avrebbe sempre insegnato ehe l'operazione nel Verba inearnato e uniea poiehe unieo e l'operante, aHa stesso modo in eui unieae la volonta poiehe unieo eilvalente. Egli dunque avrebbe eonsideratoil principium quod (secondo la piu tarda terminologia scalastica) dell'attivita edella volonta di Cristo, non il principium quo, eome inveeeaveva fatto Leone Magno nel suo eelebre Tomus. Di eonseguenza, mentreLeone faeeva diseendere dalla duplieita di nature la duplieita delle operazioni (e delle volonta), Severo partendo dall'unita di persona nonpoteva ehe eonfessare una operazione ed una volonta. A questa dottrinasi sarebbe dunque ispirato Sergio, sebbene poi, per motivi irenieo-pastorali, preferisse adottare la formula unico operante, piu neutra e meglio eoneiliabile, a suo avviso, eon l'ortodossia ealeedonese. L'infelieeeonfessione una volonta, sarebbe stata invece, sempre seeondo F. Careione, una ineauta innovazione introdotta da Onorio, della quale il patriarca presentl tutte le perieolose eonseguenze (efr. le pp. 21-68).
Con tale prospettiva non mi sembra eoneordare l'analisi eondottada F.M. Lethel (Theologie de l'agonie du Christ, Paris 1979), ehe vedenello Psephos di Sergio Ia «earta di fondazione deI monotelisn1o bizantino» (p. 17). Tale monotelismo, earatterizzato dalla negazione d'unavolonta umana in Cristo e dall'affermazione, nel Salvatore, della solavolanta divina, avrebbe avuto aseendenze diverse rispetto a quelle dichiarate dal Careione. Infatti, nonostante Lethel non neghi l'esistenzad'un preeiso rapporto eon alcuni aspetti della eristologia monofisita (ap. 28 viene dato un riferimento a Teodoro di Faran), eoglie poi la principale radiee deI nlonotelismo di Sergio in un passo deI Nazianzeno.Tale passo, analizzato minutamente e posto in relazione eol testo parallelo deI patriarea, rivela in effetti singolari affinita eon quest'ultimo,poiche mostra un'identiea confusione fra «alterita » e «eontrarieta »,
in merito alla questione della volonta di Cristo.Le due diverse prospettive, quella di Careione e quella di Lethel,
se non si eseludono deI tutta, neanche possono considerarsi selnplicemente eomplementari. Ad ogni modo proprio Ia reiazione istituita, anostro avviso convincentemente, fra i1 testo deI Nazianzeno e l'esposi·zione di Sergio dovrebbe stimolare una riflessione piu approfondita sull'approvazione « sans reserve» (Lethel, p. 46) cli Onorio. (Oltre alleindieazioni fornite nei testi citati efr. sulla cristologia di Severo: J. Lebon, La christologie du monophysisme syrien, in Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegen~vart, Wurzburg 1951-54 [= Chalkedon], T,pp. 425-480; A. Grillmeier, GesiL il Cristo nella fede della Chiesa, I/2, Breseia 1.982, p. 945).
14 Cfr. A. Grillmeier, Vorbereitung des Mittelalters, in Chalkedon II,pp. 791-839, in part. 823s5.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 575
quest'ultimo da una eristologia di matriee alessandrina 15, nonrisolve il problen1a, ma 10 eompliea, introdueendo una eontraddizione patente fra l'ambiente e l'uomo. Pertanto un'indagineapprofondita sulle fonti delle due lettere si impone ora eomeimpreseindibile, poiehe solo ripereorrendo la tradizione seguitadallo stesso pontefiee sara possibile render eonto delle moltediffieolta poste dal testo e rieolloeare il diseorso di Onorionella sua giusta luee.
Onorio e la tradizione occidentale: indicazioni sull'ambitocronologico.
Rintraeeiare i fattori ehe determinarono l'atteggiamentodi Onorio si rende diffieile per l'esiguita dei dati in nostro possesso. Com'e nato rimangono solo due lettere relative alla questione in esame 16, mentre il resto dell'epistolario non presentaelementi di interesse eristologieo 17. Esso fornisee tuttavia utiliinformazioni sulla personalita e l'opera di questo pontefiee; lelettere hanno infatti earattere eminentemente pratieo e dimostrano la viva parteeipazione di Roma alla vita eeelesiale epolitiea della Pars Occidentis. eio ehe in esse si evidenzia maggiormente e la deeisa affermazione di Onorio in favore deIprimato romano, prin1ato ehe trova la sua giustifieazione teologiea nella figura di Pietro prineipe degli apostoli 18.
15 Questa almenD e la tesi ehe sembrerebbe suggerire il Careione,rilevando la eompetenza di Onorio (cfr. F. Carcione, op. eit., pp. 61s).
16 Tali lettere, di cui la seeonda e frammentaria, sono riportate inNlansi, XI, 537-544; 579-581; J. Hardouin, l1eta coneiZiorurn et epistoZae deeretaZes 111, Paris 1714-15, ce. 1319ss.; PL 80, 469-484; Liber pontificalis,ed. L. Duehesne, Paris 1886, I, pp. 323-328. Tuttavia oggi e possibile leggerle nella moderna edizione eritiea di Kreuzer (op. eit., pp. 32-46 e 48-53)senz'altro piil. affidabile. Nel presente lavoro esse verranno eitate secondo quest'ultima edizione e la sua pratica suddivisione interlineare.
17 Per l'epistolario di Onorio efr. PL 80, 470-484 e PLS 4, 1656-1659.18 Cfr. ep. 2, PL 80, 469 C (essa pero e eonsiderata spuria da C. Sil
va-Tarouea in Gregorianunl 12 [1931] 44); ep. 8, PL 80, 478 B; ep. 9, PL 80,479 B; ep. 10, PL 80, 430 A (spuria per PLS 4, 1657). Sul primato papalecfr. M. Macearone, La dottrina deZ primato papale dal IV all'VIIIs. nellerelazioni con Ze Chiese oceidentali, in Le Chiese nei regni dell'EuropaoccidentaZe, ed i loro rapporti con Roma fino all'800, Spoleto 1960, pp.633-742; P. Conte, Chiesa e primato nelle lettere dei papi deI VII s., Milano 1971.
576 E. ZOCCA
In tal posizione Onorio si mostra degno successore di UD
Damaso 0 d'un Gregorio Magno e soprattutto a quest'ultimofu spesso avvicinato per la sua azione in campo politico e percerti atteggiamenti antiretorici ed antifilosofici 19. D'altro cantonon bisogna dimenticare ehe fra questi due grandi ponteficisi inserisce la figura e l'opera di Leone Magno il quale, purrivestendo un ruolo fondamentale nella crisi cristologica deI suotempo, non trascuro la difesa delle prerogative petrine 20, riconoscendo nell'apostolo e nella tradizione le basi autentiche dell'autorita papale 21. A lui in modo particolare sembra ricollegarsi il nostro autore 22, condividendone inoltre la naturalediffidenza per speculazioni troppo ardite 23 e, quasi di conseguenza, una sincera sollecitudine per i simplices espressa se·condo lTIoduli straordinariamente affini 24.
19 Cfr. ~. Amman, art. eil., cc. 94-95; P. Conte, op. cit., p. 33; G.Kreuzer, op. cit., p. 17, ed in part. iss. passi di Gregorio Magno: moral.18, 27; 25, 7; 33, 10 (PL 76, 83 A, 684 AB, 328 Be). .
20 In particolare egli si oppose al canone 28 che, privilegiando l'importanza politica della sede, avrebbe condannato Roma, citta apostolicama non piil imperiale, ad un inarrestabile declino. Cfr. in part. le se·guenti epistole di Leone edite in Silva-Tarouca, S. Leonis Magni epistolaecontra Eutychis haeresim [Textus et Documenta (= TD), 20], Roma 1935:ep. 104, pp. 93-97; ep. 105, pp. 97-100; ep. 106, pp. 100-105; ep. 107, pp. 105106; ep. 114, pp. 106-108; ep. 119, pp. 108-112 e V. Monachino, 11 canone28 di Calcedonia e S. Leone M., in Gregorianum 23 (1952) 531-565. In generale sulla dottrina deI primato presso Leone cfr. P. Brezzi, S. LeoneM. nella storia deZ suo tempo, in Annali deZ P. I stiluto superiore discienze e Zettere «S. Chiara » 11 (1961), 1-17, in part. 11ss.; B. Studer, Leoder Grosse und der Primat des römischen Bischofs, in Unterwegs zurEinheit. Festschrift für H. Stirnimann, Freiburg 1980, pp. 617-630.
21 La tradizione rappresentava, sia per Leone ehe per Onorio, unlegame sicuro con Ie fonti stesse deI pensiero eristiano ed il pontefieepoteva dirsene interprete solo nella misura in eui il suo pensiero simantenesse eoerente eon quelle dei Padri e con l'elaborazione eonciliare.Per Leone ad es. efr. ep. 38 (ed. Silva-Tarouca, S. Leonis M. epistolaecontra Eutychis haeresint [TD, 15], Roma 1934, p. 25; ep. 124 (ACO 11/4,159); ep. 129 (TD 20, 141-142); ep. 145 (TD 20, 150); ep. 164 (TD 20, 163); cfr.inoltre A. GriUmeier, Christ in Christian Tradition 11/1, Oxford 1987,pp. 120ss.
22 Su ruolo evalore della tradizione in Onorio efr. I lelt. 11. 29ss.;171 ss; 190 S5. (Kreuzer, 33, 40, 41).
23 Si leggano per tutti questi due passi: Leo. M., Tomus ad Flavianum, vv. 4ss. (ed. Silva-Tarouca, S. Leonis M. Tomus ad FZavianum[TD 9], Roma 1932, pp. 20-21); Onorio I lelt. 11. 295-304 (Kreuzer, p. 45).
24 L'interesse per i simplices, molto vivo in Onorio, viene espresso(Kreuzer, 11. 295-304, p. 45~ con un richiamo all'immagine dei pescatoried al versetto paolino: videte ne qui vos decipiat per philosophiam etinanem fallaciam (Col. 2, 8); entrambi gli elementi si ritrovano nell'ep.164 (ACO 11/4, 111-112) di Leone.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 577
Queste poche osservazioni rimandano alla stessa indicazione forni ta dall'esan1e terminologico di P. Galtier 25: Onorioera immerso nella cultura deI suo ambiente e legato per piiJ.aspetti alla tradizione occidentale. Sembra dunque lecito chiedersi per quale motivo egli avrebbe dovuto rivolgersi altrovenella sua speculazione teologica. Se infatti non si pub negarel'influsso esercitato sul pensiero latino dalla tradizione orientale, rin1ane pur vero ehe la cristologia occidentale conobbefin dai tempi di Tertulliano uno sviluppo suo proprio 26. Anzicon Agostino, attraverso Leone 27, si determinb in parte unflusso di ritorno e la cristologia latina fece sentire la propriavoce, spesso provocatoria, in tutto l'Oriente cristiano: il Tomus Leonis ricevette nelle discussioni conciliari deI Costan-
25 Cfr. l'analisi dell'art. di P. Galtier a pp. 572 s.26 Secondo G. Moioli (Cristologia. «Momento» storico - Lettura
delle fonti, Milano 1980, p. 494) la tradizione seguita da Leone non sarebbe ne antiochena ne alessandrina, bensl tipicamente occidentale.Questa si sarebbe svolta secondo una forma mentis chiarificatrice (dallecaratteristiche quasi geometriehe) in direzione d'un discernimento fraeib ehe di autentico le due tradizioni esigevano fosse affermato di fronteal mistero di Cristo. D'altro canto J.N.D. Kelly (lI pensiero cristiano delleorigini, Bologna 1972) aveva gia sottolineato ehe se in Occidente primadi Calcedonia sembrava esser n1ancato il vivace interesse speculativocaratteristico dei Padri orientali, cib era in parte dovuto al fatto eheTertulliano era riuscito arender conto in modo soddisfacente di entrambi gli aspetti ehe apparivano necessari ad una sana e corretta dottrina cristologica (p. 408). Infatti proprio per il contributo di teologideI calibro di Tertulliano ed Ippolito il pensiero latino deI periodo preniceno fu piu rapido rispetto a quello greco, nel formulare una completae perfezionata cristologia (p. 184). Per quanto tali affermazioni richiedanod'essere accolte con le necessarie precauzioni, e innegabile la presenzanel monde occidentale di una impostazione cristologica rispondente acaratteristiche sue proprie, non immediatamente ricon9ucibile a categorie antiochene 0, tantomeno, alessandrine.
27 Per il collegamento Agostino-Tomus Leonis-Calcedonia cfr. B.Studer, Dio Salvatore nei Padri della Chiesa, Roma 1986, p. 279. Per unapprofondimento sui rapporti fra Agostino e Leone cfr. A. Granata, Notesulle fonti di S. Leone M., in Rivista di storia della Chiesa in Italia 14(1960) 275-282; M. Pellegrino, L'influsso di S. Agostino su S. Leone M. neisermoni sul Natale e sull'Epifania, in Annali deI P. Istituto Superiore discienze e lettere «S. Chiara » 11 (1961) 102-132; B. Studer, Consubstantialis Patri-consubstantialis matri. Une antithese christologique chez Leon leGrand, REAug 18 (1972) 87-115; Id., 11 concetto di consostanziale in LeoneM., Aug 13 (1973) 599-607; Id., «Sacramentum et exemplum» c1zez St.Augustin, REAug 10 (1975) 87-141; Id., Una persona Christi. Ein augusti..nische Thema bei Leo dem Grossen, Aug 25 (1985) 452-487; G. Hudon,Leon le Grand, DSp 9, c. 601. .
578 E. ZOCCA
tinopolitano 111 l'appellativo di «stele d'ortodossia» 28 e principalmente suHa sua base, anehe se non esclusivamente suquesta, si giunse alla confessione ditelita e dienergita ehe portoaHa condanna di Onorio 29.
Per tali ragioni non ci sembra fuor di luogo proporre unalettura deI pensiero di Onorio in chiave «oeeidentale », 0 comunque tentare un esame delle fonti ehe si rivolga principalrnente a quest'an1bito culturale.
Ma dove cercare? i\.nche il pensiero latino, come quellogreco, ebbe un lungo ed ampio sviluppo, percio scegliere unperiodo 0 un autore determinato pitlttosto ehe un altro, po..trebbe apparire arbitrario. E' necessario rintracciare un puntofermo, un preciso momento ehe, pur inserendosi nel flussocontinuo dell'elaborazione teologica, segni una tappa fondamentale in tale processo. Un simile momento pub essere indi..viduato nel concilio di Calcedonia e, insieme ad esso, nellariflessione cristologica di Leone Magno. K. Rahner si posela questione significativa: Calcedonia, fine 0 inizio 30? Questoconcilio fu diversamente recepito in Oriente ed in Occidente;11 esso sembro lasciar aperti' tanti e tali interrogativi da imprimere, proprio attraverso le polen1iche suscitate 31, nuovo hnpulso aHa ricerca; qui al contrario esso venne considerato puntod'arrivo e momento risolutivo della crisi cristologica, lnentrele sue definizioni di fede erano sentite come perfettamentein sintonia con il T01nus 32.
28 Mansi XI, 221 A; 636 DE.29_Si legga in particolare la sessione XIII di questo concilio dove la
discussione verte principalmente sul riconoscimento deI leoniano agitenim utraque forma (Mansi XI, 525ss.).
30 K. Rahner, Chalkedon. Ende oder Anfang?, in Chalkedon 111, pp.3-49. A Grillmeier intitolava nello stesso modo il capitolo conclusivo deIsuo Gesü il Cristo nella fede della Chiesa (pp. %9ss) e recentemente B.Studer (Dia Salvatore, pp. 304-308) riprende la questione riferendosi esplicitamente ai due autori eitati.
31 Per le polemiehe suseitate dal Caleedonese in Oriente efr. J. Lebon,La christologie, passim; L. Perrone, Le Chiese di Palestina e le controversie cristologiche, Breseia 1980, in part. le pp. 89-136. Per quantariguarda l'Oeeidente, generalmente molto piiI favorevole al eoneilio, efr.A. Grillmeier, Mit ihm und in ihm, Freiburg 1975, in part. pp. 395ss.
32 Cfr. M. Simonetti, Le controversie cristologiche da Apollinare aGiustino, in La cristologia nei Padri della Chiesa, Roma 1986, pp. 23-54;in part. 45-46 (sull'argomento efr. anehe W.H. Frend, The Rise of theMonophysite Movement, Cambridge 1972). In merito ai rapporti fra Leo-
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 579
A tali eonsiderazioni di earattere generale si aggiungainoltre la preeisa indieazione forni ta dalle diseussioni deI VIeoneilio eeumenieo. A proposito di queste P. Conte affermaesplieitamente: «la reeezione della dottrina romana - suggestione di Agatone - si inquadrava in un riehiamo assiduo aLeone e a Caleedonia »33. Seorrendo gli atti delle varie sessioni,si puo notare ehe l'aeeettazione deI IV eoneilio e della eristologia di Leone veniva infatti eonsiderata una diseriminanteper giudieare della ortodossia 0 eterodossia dei vari personaggichiamati in causa 34. Va infine segnalato ehe in questa stessasede, fra le diverse testimonianze patristiehe addotte in favoredell'ortodossia, non si trovavano Padri latini posteriori al Caleedonese (eontrarian1ente a quanta avveniva per i Padri orientali) ed i soli autori menzionati erano Ambrogio, Agostino eLeone Magno 35.
Sen1bra pertanto metodologieamente eorretto rivolgersi inprima luogo a questo determinato periodo storieo al fine diindagare l'effettivo rapporto ehe lego Onorio alla tradizioneteologiea deI suo ambiente, rimandando solo ad un seeondomomento il eompito di approfondire la rieerea, nel tentativodi rintraeeiare eventuali tramiti fra il nostro autore e questaformulazione dottrinaria eronologieamente distante.
ne ed il siInboIo ealeedonese efr. in part. A. Grillmeier, Gesit il Cristo,pp. 933ss. (pp. 958-963 sulle fonti deI sinlbolo), mentre per le diffieoltasuseitate dalla diffusione deI Tomus in Griente rimandiamo aneora aJ. Lebon, La christologie, pp. 468ss.; e L. Perrone, Le Chiese di Palestina,p. 100.
33 P. Conte, Primato papale nel VI concilio ecumenico, in ArchiviurnHistoriae Pontificiae 15 (1977) 80. A proposito deI ruoIo fondamentalegioeato daI eoneilio di CaIeedonia nelle dispute mono-ditelite efr. A. GriHnleier, Christ in Christian Tradition, p. 13.
34 Cfr. nota 30 ed aneora le sessioni 11, X, XII, XVIII (rispettivamente: Mansi, XI, 217-221; 393; 421; 525-527; 636). Cfr. anehe G. MoioIi,op. cit., p. 337 ed il seguente giudizio di Grillmeier: « ... against the illogieality of the monothelites, the foundamental prineiples of Chalehedon,whieh eoneerned only the person of Jesus Christ and the relation ofdivine and human nature in this person, are extended to the questionof the will and aetivity» (Christ., p. 13).
35 Cfr. Mansi XI, 221; 369-372; 393-396; 421; 424; 523-527. E' neeessariorare menzione a parte per Vigilio, ehe fu papa romano, ma fortementevineolato a Bisanzio ed all'imperatriee Teodora. Ad ogni modo egli verrapresto eliminato dalla diseussione per opera dei legati papali ehe protestarono i1 falso letterario (efr. Mansi XI, 221-229; 528). Aneora su Vi·gilio cfr. infra, n. 55.
580 E. ZOCCA
Onorio, Calcedonia ed il Tomus ad Flavianum.
Si aeeennava sopra al valore vineolante ehe assunse la definitio fidei ealeedonese. Questa ineontro in Oeeidente un indubbio favore e fu sentita eome intimamente rispondente aeategorie di pensiero affatto latine. 11 eoneilio di Caleedonia,anzi, venne presto eonsiderato « il piu latino di tutti i eoneili»e eon le sue ehiare formulazioni di fede influenza per seeoliil linguaggio teologieo oeeidentale 36.
Di eonseguenza non stupisee ehe eehi deI Caleedonese tornino eon tanta evidenza nelle lettere di Onorio. Questi si palesano in modo partieolare nell'uso insistito dell' Et~ xcxt eXu--ro~,
o piu brevemente --rov rx.u--rov 37, e nell'impiego degli avverbi&auYlu--rwC;, eX--rpe1t--rwc;, eX~L(xLpe--rwc; 38, frequentemente riproposti.La stessa struttura della Christusbild ealeedonese si laseia eogliere trasparentemente nel eorso della trattazione: tutti glielementi fondamentali deI simbolo vengono riproposti senzaaleuna esitazione e, se da un lato si sottolinea potentementel'unita di persona, dall'altro viene definita eon ehiarezza ladistinzione delle due nature, ehe mantengono intatte le rispettive proprieta 39.
Queste prime eonsiderazioni gia invitano ad escludere lapossibilita d'un eollegamento eon Severo, dato ehe questi avevasempre avversato il Caleedonese, rifiutando in partieolar modoqualsiasi ripartizione delle proprieta fra Ie due nature 40. Certo
36 Cfr. l'introduzione in Chalkedon 11, pp. 763-764 e inoltre A. Grillmeier, Vorbereitung, p. 792, che cosi si esprime: «Die Einfacheit undKlarheit des chalkedonischen Christusbildes war aber zur Denkform deslateinischen Christentums geworden ». B. Studer (in Dio Salvatore, pp.308ss.) tuttavia non considera la diffusione deI Calcedonese in Occidentecosi incontrastata, e sottolinea la presenza di determinate difficolta daessa incontrate.
37 11 primo torna alle 11. 56; 213-214; 285-286; 386 (Kreuzer, 34, 41-42;44; 50); mentre il secondo alle 11. 41; 48; 55; 389; 394; 395 (Kreuzer, 34;50; 51).
38 Cfr. le 11. 44-45; 71-72; 415 (Kreuzer, 34; 35; 51).39 Riferimenti espliciti alle due nature compaiono 5 volte nella
prima lettera (11. 53; 75; 261-262; 286-287; 315-316) e 4 nella seconda. Inoltre le 11. 373-386 conducono un discorso molto impegnativo sulla distinzione delle due nature in senso decisamente leoniano (il brano e riportato quasi integralmente alle nostre pp. 585s).
40 Cfr. J. Lebon, La christologie, in part. p. 534 ss.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 581
si potrebbe obiettare ehe ne1 VII s., dopo l'esperienza deI neoealeedonismo 41, 1a linea di demareazione fra eristo10gia ca1eedonese e severiana non sembrava piu eos1 netta come un tempo,10 stesso Sergio, pur proelamandosi fede1e a1 eoneilio, ne propone una 1ettura nuova, piü vieina all'eredita eiri11iana e, dieonseguenza, faeilmente eoneiliabile eon eerte istanze di Severo 42. Tuttavia non possiamo traseurare ehe il nuovo orientamento, privilegiando un'impostazione eiri11iana, re1ega in seeondo piano la eristologia di Leone e ne rifiuta implieitamentegli aspetti piu tipiei.
Onorio, al contrario, mostra ne11e sue lettere UD ehiaroinflusso 1eoniano ed anzi, 1a stessa reeezione deI Caleedonese,sembra in lui quasi filtrata attraverso la partieo1are sensibilitacristologiea deI suo grande predeeessore. Se infatti tentianlouna lettura eomparata di I e 11 lettera, simbolo ealeedonese eTomus ad Flavianum, otteniamo il seguente schema 43:
[ lettera
11. 35-3711. 37-5011. 51-5311. 53-5411. 55-5611. 57-6611. 67-76
11. 76-9911. 96-10011. 100-117
11. 145-15411. 210-221
Simbolo
v. 18v. 18vv. 5-6; 17
vv. 2; 16; 23
vv. 17-21
vv. 17-21v. 11
vv. 2; 16; 23
Tomus adFlavianum
v. 59vv. 94-95vv. 98; 59v. 100v. 127vv. 127-130vv. 54-55; 58-59 (efr.
vv. 126ss.)vv. 126ss.; 57-58v. 90vv. 61-68 (efr. vv.
28-29)(efr. vv. 57-67; 25)vv. 101; 94-98
41 Sul neoealeedonismo efr. Ch. MoeHer, Le ehaleedonisme et leneo-ehaleedonisme en Orient de 451 a la {zn du Vle s., in Chalkedon 1,637-720; M. Riehard, Le neo-ehaleedonisme, in Melanges de seienee religieuse3 (1946) 156-161; L. Perrone, Le Chiese di Palestina, pp. 224-285.
42 Cfr. F. Careione, op. eit., pp. 33 ss.43 Per i testi di Onorio e deI Tomus si fa riferimento alle edizioni
gia segnalate. Per il sin1bolo ealcedonese ci si riferisee aHa suddivisionein stiehi adottata da 1. Ortiz De Urbina, Das Symbol von Chalkedon,sein Text, sein Werden, seine doglnatisehe Bedeutung, in Chalkedon I,388-390.
582
11. 252-26311. 282-28611. 313-317
11 lettera
E. ZOCCA
v. 94v. 94v. 94
11. 373-38611. 381-38611. 386-38811. 389-39411. 404-416
vv. 16-17 vv. 94-98vv. 16-21 vv. 54-55
vv. 121-126vv. 12-15 vv. 87; 102; 57vv. 16-20 v. 94
Premesso che le re1azioni segnalate non comportano unaspecifica identita verbale (non sempre almeno), ma indicanosemp1icemente un convergere di contenuti, possiamo fare a1·cune osservazioni.
In primo 1uogo, 10 schema sopra considerato, evidenzia unrapporto frequente fra Onorio ed i vv. 16·21 deI simbolo; quindiesso segnala un parallelismo fra questi medesimi richiami equelli a1 Tomus; infine si nota 1a presenza di a1cune relazionico1 solo TOlnus a prescindere da1 simboIo, mentre non si dannorelazioni inverse, cioe con il simbolo a prescindere daI Ton1us 44.
Ponendosi in una prospettiva astorica, simili rilievi po·trebbero indieare un prevalere di interessi per l'epistola dogmatica rispetto alle definizioni conciliari, tuttavia conoscendo ilclima teoIogico in cui visse il nostro autore, bisogna senz'aItroconeludere che essi sono Ia riprova piiJ. evidente di quantasopra aecennato: per Onorio Ia recezione deI Ca1cedonese passa, recta via, per Ia cristologia di Leone. La stessa frequenzadei richianli ai vv. 16-21 deI siInbolo offre una chiara indicazione in proposito: fu infatti proprio in questi versetti ehesempre si rieonobbe un piiJ. vivo influsso leoniano. Se poi Iacritica moderna tende a ridinlensionare tale incidenza, valorizzando il eontributo d'aIeuni autori della tradizione orientale,45quest'opinione non sembra certo essere stata presentita 0 eon-
44 Esclusi i rilievi terminologici considerati a p. 580.45 Cfr. nota 32 e pili in part. sul simbolo: A. de Halleux, La de-fi
nition christologiqu.e a Chalcedoine, in Revue theologique de Louvain 7(1976) 3-23, 155-170.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 583
divisa da1 pontefiee, la eui lettura deI Caleedonese si svolgetutta in ehiave «oeeidentale».
Eppure proprio il rapporto eon Leone, ehe sotto questoaspetto si mostra tanto vlneolante, appare insieuro laddoven1anehi un legame preeiso eon il simbolo: la trattazione dell'energeia, ad esempio, nonostante il riferimento esplieito alTomus, selnbra svolgersi talora indipendentelnente da esso,mentre quella su cOlnmunicatio idion1atul11 ed impeccantia assunle ampiezza tale da suggerire l'apporto di altra fonte. Comesi vede, sulla base dei soli testi qui considerati, non e possibile giungere a eone1usioni eerte in merito aHa tradizione seguita da Onorio. Oecorre quindi approfondire l'esan1e, estendendolo ad altri seritti di I ...eone e, ove la situazione 10 riehieda,a quelli di autori diversi.
Nel diseorso eris tologieo di Onorio possono distinguersidue centri d'interesse: la questione dell'energeia e quella dellavolonta. Seguiren10 anche noi l'artieolazione deI pontefiee imperniando la ricerea su questi due an1biti fondamentali.
Onorio e la questione dell'energeia
AHa base della eontroversia mono-dienergita si trova il v.94 deI T0111US ad Flavianum 46. Questo fu lungamente osteggiatoin Oriente sia dalle Chiese monofisite, sia in Palestina, sia presso tutti eoloro che in questa manifesta distinctio fra natura assumente e natura assunta colsero il segno d'una eristologia eccessivamente divisiva, se non addirittura nestoriana. Ripreso daSergio, nella sua lettera ad Onorio, il v. 94 rimbalzo aRoma eonil suo eoroHario di polemiehe, per essere nuovan1ente eitato dalpontefice nelle sue due lettere. Percio, prima di procedere oltre,sara eonveniente riportare i passi di Leone, Sergio ed Onorio,relativi al medesimo argomento:
46 Cfr. TD 9, p. 26.
584
Leone
E. ZOCCA
(v. 94) Agit enim utraque forma cum alterius communione'quod propriunl est, Verbo scilicet operante quod Verbi est, etcarne exsequente quod carnis est,(v. 95) Unum horum coruscat miraculis aliud subcumbit iniuris,(v. 96) Et sicut Verbum ab aequalitate paternae gloriae nonrecedit(v. 97) ita caro naturam nostri generis non relinquit.(v. 98) Unus enim idemque est vere Dei Filius, etc. (continuasullo scambio di attributi) 47
Sergio
(Mansi XI, 533D): &AAeX [J.~AAO'J, Xel&&7te:p el~ &Y~el~ Xelt otxoUfLe:v~xell
7telPelÖEÖWXOCeH O'uvoöo~, EVel xell 't'o'J elu't'ov u~ov fLOVOYEV~ 't'ov xup~ov
~fL(~V 'IYlO'ouv Xp~cr't'ov, 't'o'J &AYl&~'JOV &EOV EVe:pye:r:v O[J.OAoyEr:V 't'cIw 't'e:
&E~el Xelt &'J&pW7t~'Jel, xell 7t~O'elV &E07tPZ7t~ Xel~ &v&pW7t07tPE7t~ eVEpye:~elV
E~ ZVOC; Xelt 't'ou elu't'ou O'e:O'elPXW[1EVOU &e:ou AOyou &Ö~el~PE't'Wc; 1t'pO~
E'JOC~, Xelt 't'ov elu't'ov &VelcpEpe:O'&el~.
(Mansi XI, 537 A): xell ofLoAoye:r:V 't'ov fLovoye:v~ U~O'J "rou &e:ou,
't'ov oV't'el Xel't'eX &A~&E~OC'J &EOV &[J.el xell ClV&pW7tO'J, 't'ov elu't'o'J EVe:pye:r:v
't'cX. &Er:el xell &\I&pW7t~\lel xell E~ E'JOC; xocl "rOU od)"rou crzacxpxU)fLz\lou
0zou A6you, Xel't'cX. cp&&crel\l't'Ec; SCPYl[J.E'J, 7t~O'elV 7tPO~E'Jel~ &fLEpLcr't'wc;
Xel~ &Ö~el~PE't'Wc; &E[el\l 't'E xell &'J&pw7tLvYl'J E\lEPYE~el\l. 't'ou't'o yexp ~[J.~C;
o &Eocp6poc; EÖ~Ö&O'XE~ Asw'J Ö~elPP~ÖYl'J E~7tW\l . E\lEPYEr: yexp EXel't'EP~
fLoPcp~ fLE't'eX 't~c; &el't'spou xO~'JW'J [elc; 07tEp '~Ö~O\l ~crXYlXEV 48.
47 Ibid.48 Mansi, XI, 533 D: «Ma piuttosto, eome ci hanno tramandato i
santi sinodi eeumeniei, si eonfessasse ehe l'unieo e medesimo Figlio unigenito, il nostro Signore Gesu Cristo, vero Dio, ha operato Ie eose divine e umane e ehe ogni energia divina e umana proeede indivisibilmente dall'unieo e medesimo Logos di Dio inearnato, al quale unieo emedesimo si rieonduce ». Mansi, XI, 537 A: « •.• e eonfessare l'unigenitoFiglio di Dio, ehe e seeondo verita Dio e uomo insieme, il quale mededesimo opera le eose divine e umane. E da quello, uno e n1edesimo,verbo di Dio inearnato, eome abbiamo detto, proeede indivisibilmente edineonfusamente ogni azione divina ed umana. Questo infatti ci insegnaLeone dieendo ehiaramente: opera infatti in entrambe le forn1e, neI·l'unione dell'una con l'altra eib ehe ha avuto eome proprio ».
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 585
Onorio
(11. 35-54) Ol-lOAoyouvTEe; TOV xup~ov 'IYJcrouv Xp~crTOV l-lScr[T"IJV &zou
x~t &V'&P6)'7tWV SVEPYOUVT~ TeX. '&E~~, l-lEcr~TEUOUcrYJe; T~e; &V&p(t)7tOTYJ
TOe;, T~e; EVW'&E(crYJe; ~uT0 T0 '&E0 AOY0 x~'&' U7tOcrTrxcr~V. xrxt TOV
rxUTOV SVEpyOUVTrx TeX. &V'&p~7t~ vrx &cpp&crTWe; xrxt l-lOVOyEVWe; rtpocr
AYJcp'&E(crYJe; T~e; crrxpxoe;, &Ö~rx~pETWe;, &TpE7tTWe;, &crUyXUTWe;, TZ)\E~We;
'" Q.' \ t , l' ,I.' \ '" Q. , l' Q.'TYJe; 'lTEOTYJTOe;. xrx~ 0 EXI\~l-l'i"rxe; EV crrxpx~ TO r.e; 'lTrxUl-lrxcr~ TEI\E~~ 'lTEOT-
YJT~, rxUTOe; EcrT~V 0 xrxt T~e; crrxpxoe; TeX.e; Ö~rx'&EcrE~e; TO~e; OVE~Ö~cr[.LO ~c;
"rOU 7t&-&OUe; EVEpy~crrxe; TEAE~Oe; '&EOe; xrxt &V'&pW7tOe;, EIe; l-lEcr(TYJe;
-&sou xrx~ &v'&p~7tWV EV EX~TEp~~e; T~~e; CPUcrEcr~ Aoyoe; creX.p~ ysv6l-lEVOe; ... (continua sullo scambio di attributi).
(11. 210-221) ÖT~ yap 0 xup~oe; ~~wv 'IYJcrouc; Xp~crToe;, 0 utoe; x~~
Aoyoe; TOU '&EOU Ö~' oiS Ta 7taVT~ SyEVETO, sIe; x~t 0 ~UTOe; EcrT~V SVEp
ywv Ta '&E~~ x~~ Ta &v'&p~re~v~ TEAE(We; ~t &s~rx~ yp~cprxt x~~ cp~VEpWe;
&reOÖE~xvuoucrL . 7tOTEpOV OE ÖLa Ta EPY~ T~e; '&EOTYJTOe; xrxt T~e; et.v
&pW7tOTYJTOe; l-l(~ ~ ÖUO EVEPYEL~L WcpEAOV 7t~P~YEVOl-lZV~~ AEYScr&rxL
~ VOE~cr'&~L T~UT~ repoe; ~l-lae; &V~XE~V O\)X WcpELAOV.
(11. 252-263) Ei yap EV &AAO Le;, TOUTzcrTLv sV TO ~e; ~EAEcr~V TO~e; iö(o ~c;,
TO 7tVEUl-l~ TOU XpLcrTOU 7t0AUTp67twe; SVEPYE~ sv T4i ~WcrL xrxt
XLVOUVT~L x~t Eicr(, 7tocrep l-laAAOV ÖL' E~UTOU TOU l-lEcr(TOU '&EOU x~t
&V'&P~7tWV 7tAYJPzcrT~T~ x~t TEAELOT~T~ x~t 7t0AUTp.07tWe; x~~ &~p&
crTwe; ~[1.ae; ÖSOV EcrT~V Ol-lOAOYE~V 't'~ XOLVWV(~ Exrx1'EPrxC; cpucrzwe;
~UTOU EVEPYE~V;
(11. 283-286) tA7tAOTYJTL xrxt &AYJ'&E(~ Ol-lOAoyouvTEe; TOV XUpLO\J ~tJ-wv
'IYJcrouv Xp~crTov TOV EV~ x~t TOV rxUTOV EVEPYOUVT~ sv T~ &E[~ x~t
&v'&P<07t[v-n cpUcrEL.
(11. 312-317) EV~ l-lE'&' ~tJ-wv TOV XUpLOV ~tJ-wv 'IYJcrouv XpLcrTov TOV
u[ov TOU '&EOU TOU ~WVTOe;, '&EOV &AYJ&~VOV sv ÖUO CPUcrEcr~V EVEpyOUVTrx
Ta T~e; '&EOTYJTOe; xrxt T~e; &V'&PW7t01'YJTOe;.
(11. 373-381) &AA' ExrxTsprxe; Tae; cpucrELe; EV T0 EV~ XpLcrT0 EV T~
CPUcrLX~ EV01'YJTL ~vwtJ-svrxe; tJ-ETa T~e; '&~1'EPOU XOLVWV(rxe; EVEpyoucrrxe;,
x~t 7tp~XTLXae; OtJ-OAOYE~V 0cpE(A0lJ-EV. x~t T~V tJ-EV '&E[~V EVEpyOUcrrxv,
& Eicrl TOU '&EOU, T~V ÖE &v-&PW7t[vYJv &7t0TEAOUcrrxv, Ta 1'~e; cr~pxoe;
OU ÖLYJpYJlJ.SVwe; OUÖE crUYXEXUtJ-SVWe;.
586 E. ZOCCA
(11. 402-416) &AA' cl'J"t"t p,~a~, ~'J"t"~'JE:c.; AEyoua~'J sVEpyZLC(V, OEG') '~:L(i~
"t"O'JE'JOC E'JEpyOU'J"t"oc Xp~a"t"o'J "t"0'J x.up~o'J E'J EXCl"t"~pCl~~ 'Tot~~ qJucrzcr~'J
&AYJ'&W~ O!-LOAOYE~'J. xoct cl'J'Tt "t"w'J ouo E'JZpYE~WV, E~OC~pz'&E((rr,c.; "t"~c.;
7tP0a-fJYOP~Cl~ 'T~c.; O~7tA~c.; E'JSpyE(OCc.;, au't"cX~ f.L&AAO'J 'Tele; 01)0 c.ovas~~
!-LE'&' ~~W'J XYJpU~OUÜ~, "t"OU"t"Ea"t"~'J 't"~~ &z6"rYJ't"o~ xocl 't"~c.; crocpxoc; 'T~e;
7tpOaAYJep&EtaYJc.; €'J 't"<}) E'J~ 7tpOaW7tep 'TOU ~OVOYZ'JOUC U~OU 't"OU nIX't"
p6~, &auyx.U1:'u)~, &Ö~Cl~PE't"u)~, &'t"pZ7t't"We;, Z'JZpY01JaOCc.; '!cX '~O~OC 49.
Una lettura parallela dei tre testi consente di fare alcuneosservazioni.
Come si puo notare Sergio, nel riportare l'espressione leoniana, introduce due alterazioni sintattiche: in prin10 luogotrasforma l'originario nominativo utraque forn1a in un dativo
49 11. 35-54: «Confessando ehe i1 Signore Gesu Cristo, Inediatorefra Dio e gli uomini, opera 1e eose divine per la Inediazione dell'umanitaunita ipostatieamente a1 verba di Dio, e ehe ha operato 1e eose umanenella earne ehe in modo ineffabile e unieo fu unita aHa divinita ineonfusamente, immutabilmente, perfettamente. E eolui ehe risp1endette ne11acarne per i portenti della perfetta divinita. e 10 stesso ehe aderl aneheaHa eondizione dell'umanita negli oltraggi della passione, uno e 10stesso, Inediatore fra Dio e gli uOlnini, in entrarrlbe 1e nature ... » 11.210-221: «Infatti le seritture din10strano an1pian1cnte ed ovunque eheil 110stro signore Gesu Cristo, figlio c verba di Dio, per mezzo deI qua1efurono fatte tutte le eose, e uno e 10 stesso, ehe opera Te eose divinee le eose umane perfettamente. Se poi a causa de.lle opere della divinitae dell'umanita si debba dire e eonsiderare ehe ne derivino una 0 dueoperazioni eia non deve riguardare noi ». n. 252-263. «Se dunque neglialtri, eioe neUe proprie membra, 10 spirito di Cristo opera in moltin10di, ne1 modo in eui vivono, si n1uovono e sono, quanta piu dobbiamoeredere noi ehe egli, n1ediatore fra Dio e gli uomini, per 1a eomunione[ra 1e due nature, operi per se stesso pienamente e perfettamente inlTIolti ineffabili Inodi ». 11. 283-286: «Confessiamo semplieemente mavcraeemente ehe il nostro signore Gesü Cristo, uno e 10 stesso, operanella natura divina ed in que11a umana ». 11. 312-317: «un solo signorenostro Gesu Cristo, il figlio deI Dio vivente, Dio vero, operante in duenature, 1a divina e la umana ». 11. 373-384: «Piuttosto eonviene eonfessarc 1e due nature nell'unieo Cristo, eongiunte in 1ui mediante un'unionenaturale, operanti e operatriei per la eomunione di entrambe. E eertodobbiamo rieonoseere ehe la natura della divinita opera le eose propriedella divinita e 1a natura umana quelle ehe sono proprie della earne,senza divisione ne eonfusione ». H. 402-416: «Ma in luogo di quell'unieaenergia di eui parlano alcuni, ebene eonfessare veridieamente l'unieoCristo Signore ehe opera in entrambe le nature. CoSI in 1uogo delle dueenergie, ora ehe .Ja terminologia relativa a quelle e stata eliminata, ebene inveee predieare quelle stesse due nature insieme eon noi, eioe lanatura della divinita e que11a della carne assunta, ehe operano ineonfusalnente, indivisibilmente ed ineotrovertibilmente le eose 101"0 proprie ».
(Per i Itesto greeo efr. Kreuzer, pp. 33-34; 41-42; 43; 44-45; 46; 50; 51).
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 587
EX~1"EP~ [lOpq;~ 50, quindi rende il latino quod propriunt esteon l'espressione greea Ö1tEp tö~o'J eO"x"tJx'E'J, sostituendo eosl alpresente est il perfetto ~O"X"tJx'E'J. La prima alterazione, ehe none giustifieata dal eontesto leoniano, si mantiene nell'an1bitoortodosso, detern1inando solo uno spostamento di prospettivadalla duplieita di nature all'unita di persona; la seeonda inveee,se letta in relazione eon la preeedente, risulta piu equivoea,rieeheggiando, ci sembra, alcune diffieolta severiane nel rieonoseere il mantenimento d'una effettiva ({ ripartizione» delleproprieta naturali dopo l'inearnazione 51. Questa seeonda alterazione, eomunque, non viene ripresa dal pontefiee, quindi nonci interessa approfondirne il signifieato in questa sede. L'altra,al contrario, torna in Onorio: eostantemente nella prima lettera, in alternanza eon un riehiamo eorretto deI T0111US, nellaseeonda. Cio nonostante, esalninando il eontesto, e impossibileeoneludere per un'identita di posizioni fra Onorio e Sergio 52.
Questo per un triplo ordine di fattori:
a) Onorio gioea sul valore deI greeo energeia, intendendoloara eome il latino operatio, singolo atto eonereto, ora eomeeapaeita operativa, facolta naturale 53. Nella prim.a aeeezioneegli assume eom.e soggetto la persona unica di Cristo, nell'altrasi riferisee selnpre alle due nature 54;
b) Onorio riprende non il solo v. 94, eOll1e il suo interloeutore, n1a il eontesto ampio della frase, ivi eompresa la partieolare forma di COn111'IUnicatio idio11'latum proposta da Leone 55;
so Nonostante la scarsa perspicuita dell'edizione Mansi, i critici concordano su questo punto: W. EIert, Ausgang altkirehliehell Christologie,Berlin 1957, p. 239; G. I(reuzer, op. eit., p. 14.
51 Tali difficolta si ricollegano d'altronde all'antica discussione intorno alle forlllule cristologiche in duabus-ex duabus naturis. Sull'argo~
Inento cfr. J. Lebon, La christologie, pp. 534 ss.; P. Galtier, St. Cyrilleet St. Leon a Chaleedoine, in Chalkedon T, pp. 358 ss.; A. Gri11nleier,Gesu il Cristo, pp. 931 ss:; e piiI recentemente M. Sinlonetti, Le eontroversie eristologiehe, p. 49.
52 L'opinione d'una identita di posizioni fra i due e stata ripresarecentemente da F. Carcione, op. eil., p. 63.
53 Cfr. E. Amman, art. eit., c. 101; Hefele-Leclercq, op. eit., p. 335;Tixeront, op. eit., p. 163; G. Kreuzer, op. eit., p. 56; F. Carcione, op. eit.,pp. 61 ss.
54 Cfr. per il primo caso: 11. 35-53; 210-211; 252-263; per il secondo:11. 373-376; 414-416.
55 Quest'ultimo rilievo appare particolarmente significativo poicheconsente di escludere la possibilita d'un legame fra Onorio e Vigilio al-
588 E. ZOCCA
e) se Onorio nella prima lettera, pur eon tutte le limitazioni segnalate J sernbra oseillare fra la posizione di Sergio (signifieata dall'unico operante) e quella di Leone (riehiamatadall'insistenza sull'intatta distinzione delle nature), nella seconda lettera il suo rapporto eon il Tomus si preeisa in unriehiamo piu eorretto, mentre i due termini E'Jzpyouae<; xcxl7tPrlX"C'LX.cXC; sottolineano l'effettiva e eonereta attivita delle duenature 56.
Come si pUD notare, dopo un attento esame, Ia posizionedi Onorio appare, nonostante tutto, piu. vieina a quella di Leoneehe non a quella di Sergio. Resta da ehiarire, e vero, l'alterazione deI Tomus, tuttavia e possibile ipotizzare ehe, proprianegli seritti deI suo predeeessore, Onorio trovasse una giustifieazione al proprio eomportamento.
Se eonsideriamo tali scritti nel periodo anteriore a Caleedonia, essi non eonfermano Ia nostra ipotesi; Leone non siera aneora seontrato eon I'opposizione determinata dalla diffusione deI suo Ton1us in Oriente, dunque non avvertiva la neeessita di eereare una eoneiliazione fra la propria dottrina, ehiarama forse un po' statiea, e le istanze piu valide della cristologiaeirilliana. Se perb ci rivolgiamo al periodo sueeessivo, possiamo notare ehe il papa, solleeitato dalle eontinue polemiche,
meno nelle fornle in eui questo si disnodo di fronte ai patriarehi costantinopolitani ehe si basarono sull'autorita dei due pontefiei per giustifieare le proprie affermazioni monotelite e monoenergite. I doeumentivigiliani allora esistenti condannavano esplieitamente il partieolare tipodi communicatio idiomatum inlpiegato da Leone nel Tomus ed anatemizzavano ehiunque 10 adottasse. Inoltre eircolava aRoma, forse aneora aitempi cli Onorio, una lettera ehe, generalmente attribuita a Vigilio (inquei tempi), anatemizzava espressamente Leone eon il suo agit enimutraque forma. Di eonseguenza una dipendenza di Onorio da Vigilio appare altamente improbabile. D'altro canto se Onorio avesse voluto scegliere un'autorita per suffragare le proprie posizioni non si sarebbe certorivolto ad un papa ehe aveva laseiato in Oeeidente pessimo ricordo dise ed uno scisma aneora irrisolto (per i testi vigiliani introdotti neieodici dei V concilio efr. ACO IV/I, 187-188; per la lettera riportata daLiberatus nel suo Breviarium efr. PL 68, 1041. Per Ia discussione criticasui testi efr. P. Conte, Primato papale, p. 17, allo stesso rimandiamo pp. 80 ss. - per un esame sulla posizione dei patriarchi eostantinopolitani di fronte ad Onorio e Vigilio. Infine notizie generali su Vigilio in:E. Amman, Vigile, DTC XV/2, 2924; Id., Trois chapitres, DTC XV/2, 19001911; M. Simonetti, Tre capitoli, DPAC 2, 3507-3508; B. Studer, Vigile,DPAC 2, 3591). Sulla communicatio idiomatum cfr. infra, pp. 597ss.
56 Cfr. V. Grumel, art. cit., a nota 3, p. 281.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 589
compl uno sforzo di precisazione dogmatica, impegnandosi aformulare la propria dottrina in una versione piu accettabileper gli alessandrini. Le tappe di questa evoluzione si colgononegli scritti posteriori al 451, dove si nota, fra l'altro, una ripresa deI problema dell'energeia. Riporteremo nell'ordine cronologico i passi piu significativi per il nostro tema 57:
Aprile 453, s. 64, 4 (CCL 138 A, 392-393): Cum ergo in unoDomino nostro Iesu Christo vero Dei atque hominis filio, divinarrl confitemur de Patre naturam, humanaln de matre substantiam, Zicet Verbi Dei et carnis una persona sit, et utraque essentia communes habeat actiones, intellegendae tamen suntipsorum operuln qualitates, et sincerae fidei contempZationecernendum est ad quae provehatur humilitas infirmitatis,et ad quae incZinetur altitudo virtutis; quid sit quod caro sineVerbo non agit et quid sit quod Verbum sine carne non efficit...
Aprile 453, s. 65, 1 (CCL 138 A, 395): Quamvis ergo ab illoinitio quo in utero Virginis Verbun1 caro factum est, nihil umquam inter divinaln h1umanamque substantiam divisionis extiterit, et per olnnia incrementa corporea unius personae fuerinttotius te111poris actiones, ea ipsa tamen quae inseparabiliterfacta sunt, nulla pernlixtione confundimus, sed quid cuius naturae sit, ex 0p1erum qualitate sentimus, nec divina enim humanispraeiudicant, nec humana divinis, CUl'n ita in idipsum utraqueconcurrant, ut in eis nec proprietas absumatur, nec ]Jersona genlinetur.
Giugno 453, ep. 124 ad PaZestinos (ACO 11/4, 161-162): Qual11vis ergo in uno domino nostro I esu Christo vero Dei atque ho·111inis fiZio verbi et carnis una p'ersona sit et utraque essentiacommunes habeat actiones, intelligendae tamen sunt ipsorun1operum qualitates et sincerae fidei contemplatione cernendumest ad quae provehatur humilitas infirmitatis et ad quae incli·netur altitudo virtutis, quid sit quod caro sine verbo non agit,et quid sit quod verbunl sine carne non efficit...
(...) Quamvis ergo ab illo initio quo in utero Virginis verbum caro factuln est, nihil umquam inter divinam hunlanalnque substantiam divisionis extiterit et per omnia incrementa
57 Per la datazione dei singoli scritti ci riferiamo alle indicazionifornite da A. Chavasse in Inargine aU'edizione critica dei sermoni (cfr.CCL 138, p. cliv ed inoltre le note ai 55. relativi).
590 E. ZOCCA
corporea unius personae fuerint totius ten1poris actiones, eaipsa tamen quae inseparabiliter facta sunt, nulla permixtioneconfundi1nus, sed quid cuius formae sit, ex operum qualitatesentimus, nec divina enim humanis praeiudicant nec humanadivinis, cum ita in id ipsum utraque concurrant, ut in eis necproprietas absumatur nec persona geminetur.
(...) in tantam unitatem ab ipso conceptu Virginis deitate eth,umanitate connexa, ut nec sine hOlnine divina nec sine Deoagerentur humana.
Dicen1bre 457, s. 96, 2 (CCL 138 A, 594-595): (...) unigenitusDei Filius, aequalis pier omnia Patri, nostrae adsulnptionesubstantiae, manens quod erat, dignatus est esse quod nonerat, verus scilicet hon10, verus Deus, qui absque cuiusquamsorde peccati, integram sibi nostran1 perfectamque naturamveritate et animae et carnis univit, et intra uterun1 beatae Virginis matris Spiritus sancti virtute conceptus, nec editionempartus, nec primordia fastidivit infantiae, ut Verbum Dei Patris hurnanam sibi inesse substantiam et deitatis potentia etcarnis infirmitate loqueretur, de corpore habens corporeasactiones, sp'iritales de deitate virtutes... ut qui haec cred'unt,dubitare non possint quid h'umanitati adscribere, quid debeantadsignare d'eitati, quia in utroque unus est Christus, qui et deitatis suae potentiam non amisit, et veritatem perfecti hominisnascendo suscepit.
Agosto 458, ep. 165 ad Leonem In1peratorem (ACO 11/4,115-117): Licet ergo in uno domino lesu Christo vero dei atquehOlninis filio verbi et carnis una persona sit quae inseparabiliter atque indivise communes habeat actiones, intelligendae tan1en sunt ipsorum operUln qualitates et sincerae fidei contemplatione cernendum est ad quae provehatur humilitas carniset ad quae inclinetur altitudo deitatis, quid sit quod caro sineverba non agit et quid sit quod verbum sine carne non efficit...
(...) quamvis itaque ab illo initio quo in utero virginis verbum caro factum est, nihil umquam inter utramque forn1alndivisionis extiterit et per omnia increnlenta corporea uniuspersonae fuerint totius temporis actiones, ea ipsa tanzen quaeinseparabiliter facta sunt, nulla permixtione confundimus, sedquid cuius formae sit, ex operum qualitate sentimus.
(...) In tantam unitatem ab ipso conceptu virginis deitate ethumanitate conserta, ut nec sine homine divina nec sine Deoagerentur humana.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 591
Nel prin10 dei sermoni eitati, databile all'aprile 453, laproblematiea si presenta aneora molto vieina a quella deI Tolnus, soggetto dell'attivita di Cristo sono sempre le due naturenella 101"0 reeiproea eomunione. Interessante per noi e l'impiegodeI termine actiol1es (raddoppiato nel sueeessivo operul'n) ehenel presente signifieato (speeifiei atti eonereti), rieorda l'interpretazione data da Onorio al tern1ine energeia.
11 seeondo sermone, di qualehe giorno posteriore, oflreuna prospettiva parzialmente diversa. Anehe se l'aeeento eontinua a eadere sulla distinzione di nature, ora, per la primavolta, le actiones sono dette unius personae.
I passi sueeessivi sono tratti dall'ep. 124 ehe Leone indirizzo, nel giugno dello stesso anno, ai monaei palestinesi indifesa deI propria Tomus edel eoneilio. La lettera ineorpora itesti dei s. 64 e 65 pronuneiati poeo prima. Questi, nel passaggiG, subiseono solo qualehe leggero ritoeeo, forse per eonnettere meglio unita di persona e distinzione di nature. Nella stessadirezione sembrerebbe muovere anehe l'ultimo passo, soprattutto per quell'agerentur ehe laseia indeterminato il soggettodell'azione.
Segue nel nostro eleneo il s. 96. Esso fu pronuneiato neldieelnbre 457, eon 10 seopo evidente di contrastare la propaganda monofisita esereitata aRoma dai mereanti egiziani 58.
Qui Leone, pur eonservando la eonsueta distinzione fra proprieta umane e proprieta divine, si mostra piu deeiso nel rieondurre le actiones ad un soggetto unico, ehe ora viene indieatoesplieitamente nell'uniea persona deI Dio-uomo.
Infine troviamo l'ep. 165, indirizzata all'imperatore Leonenell'agosto 458. Essa fu seritta dal papa per rispondere adun'esplieita riehiesta di ehiarimenti in lnerito ai deereti diCaleedonia, allora impugnati dai monofisiti. La lettera risented'un notevole sforzo di precisazione dogmatiea ed aeeoglie itesti dei s. 64 e 65 attingendoli, non qui direttamente, ma dall'ep. 124 59. 11 voeabolario tratto dai sermoni, e eonservato nellalettera precedente, viene rivisto e corretto. In partieolar modo, per il tema ehe qui ci interessa, subiseono modifiche ilprinlo e I'ulthno dei passi riportati. Nel prima infatti eadono i
58 Cfr. s. 96, 1, CCL 138 A, 591.59 Cfr. A. Chavasse, CCL 138, p. cliv.
592 E. ZOCCA
tern1ini utraque essentia ehe reggevano il verbo habeat (com..Inunes habeat actiones) eos! ehe questo, attraverso il relativaquae, si rieollega immediatamente all'una persona. In tal modole actiones eomuni non dipendono piu dalle due nature, bens!dall'uniea persona di Cristo. Nell'altro passo, inveee, il termineconnexa viene sostituito eon conserta, forse sentito dall'autoreeome piu effieaee 60.
L'esame dei preeedenti testi impone almeno due eonsiderazioni. La prima di earattere prettamente dottrinario: perLeone l'unita di persona rimane il eonvergere di due, la risultante dell'ineontro fra natura divina e natura umana, quindiun punto di arrivo e non un punto di partenza 61. Egli non rieonosee aneora l'elemento personale di Cristo nell'ipostasi deIVerbo, tuttavia, negli scritti posteriori a Calcedonia, eomineiaa mostrare un'apertura signifieativa verso una eristologia piuunitaria, ehe gli eonsente di rieonoseere esp,zicitamente la persona unica di 'Cristo come soggetto eomune delle azioni divine edumane.
La seeonda inveee ha earattere storieo-dogmatico: Leone fuspinto a riconsiderare le proprie posizioni da preeise solleeitazioni esterne. Lo dimostra 10 sviluppo dottrinario suceessivoal eoneilio, 10 dimostrano i destinatari delle lettere (0 l'oceasione dei sermoni), 10 prova in partieolare l'ep. 165, nella qualeegli, pur impegnandosi in una strenua difesa deI eoneilio, prefer! sostituire al discusso v. 94 i passi sopra riportati, fornendo eos!, seeondo Duehesne, una versione «addoleita» deITomus 62.
Poteva Leone essere in questo d'esempio ad Onorio? Ladomanda e quasi retoriea. Onorio, come il suo predecessore, sitrovo nella neeessita di cereare un terreno d'ineontro eon la
60 Anche H. Arens (Die christologische Sprache Leos des Grossen.Analyse des Tomus an den Patriarchen Flavian, Freiburg 1982) segnalala sostituzione dei due termini (p. 473, nota 88), ma non avanza alcunaipotesi in merito. Le ricerche condotte da chi scrive nei lessici attualmente in uso, non hanno portato ad alcun risultato certo, mancandoper il latino uno strumento valido anche in campo dogmatico. Lasciamoquindi ancora aperto il problema limitandoci, anche noi, a segnalarnela presenza.
61 Cfr. B. Studer, Una persona Christi, pp. 483 sS.; Id., D'io salvatore,p. 302; A. Grillmeier, Christ., pp. 150 ss.
62 Cfr. Duchesne, Histoire ancienne de l'Eglise 111, Paris 1906-1910,p. 484; Id.,L'Eglise au IVe s., Paris 1925, p. 391. Sulla cristologia post-calcedonese di Leone si legga A. GrilIrneier, Christ., pp. 149 ss.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCClnENTALE 593
cristologia cirilliana. Fossero passati pochi anni, come perLeone, 0 circa due secoli, come per Onorio, l'influsso di Cirillodominava gran parte della teologia orientale e Sergio stesso,interlocutore deI pontefice, ne risentiva forten1ente. Sara dunque sembrato logico al nostro autore cercare suggerimenti nelpensiero di Leone. Questo poteva giustificare la formula unicooperante, ma non ne consentiva l'interpretazione «severiana})che trapelava dalla lettera deI patriarca. Onorio allora accolsesolo in parte la nota alterazione deI Tomus e cerco di « destrutturarne}) la prospettiva, ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Lasua doppia accezione deI termine energeia, il riferimento a1contesto ampio della frase leoniana, l'accento continuo sull'intatta distinzione delle nature, muovono certo in questa direzione. Ma Onorio presto avvertl l'inadeguatezza d'una similesoluzione e, forse in seguito all'incontro con i delegati di Sofronio, cOluprese la necessita d'un ulteriore chiarimento. Scrisseallora una seconda lettera, nella quale l'effettivo valore dellaformula unico op'erante in due nature, veniva precisato attraverso un richiamo corretto al Tomus, cui si aggiungeva l'esplicita definizione delle due nature con1e « operanti e operatrici }).
11 suo rifiuto per la forn1ula dienergita deve quindi ritenersi puramente verbale, non essendo motivato da alcuna limitazione di principio 63. Non esiste una reale possibilita d'incontro fra le posizioni di Onorio e quelle di Sergio, ne un'eventuale dipendenza da Severo, poiche questi fra l'altro aveva anatemizzato chiunque «a causa della diversita delle cose operate- definisse - due nature operanti 0 forn1e naturali» 64. Dallelettere elnerge solo un rapporto coerente e continuo con ilmagistero di Leone, un magistern attualizzato e adeguato allemutate esigenze deI dibattito cristologico, ma, in definitiva,sostanzialn1ente rispettato.
63 Cfr. V. GrumeI, art. eit. a nota 3, p. 282.67 Ep. 2 ad Oecun1. Questa Iettera fu Ietta nella actio X deI VI COl1
eilio eeumenieo (Mansi XI, 444).
594
11 prob1ema de11a volonta.
E. ZOCCA
Una diseussione seria sul presunto monotelismo di Onorionon pub basarsi su una singola frase (<< quindi eonfessiamo unavolonta »), piu 0 meno avulsa dal proprio eontesto, ma deveeonsiderare l'insieme della eomplessa argomentazione deI pontefiee 65, tenendo presenti le eause ehe la determinarono, l'obiettivo ehe intendeva eonseguire e le fonti eui si rieollegava.
11 eomplesso artieolarsi della risposta di Onorio fu senz'altro eondizionato dalla speeifieita della problematiea avanzatada Sergio. 11 patriarea infatti, partendo da un'impostazione eristologiea di tipo alessandrino, aveva rifiutato la possibilita d'unaprofessione ditelita (a suo avviso neeessaria eonseguenza d'unaeonfessione dienergita) poiehe questa, ammettendo in Cristola presenza contemporanea di due voleri opposti, avrebbeintrodotto una pericolosa spaecatura all'interno dell'unita dipersona. 11 suo ragionamento era sempliee e, apparenten1ente,eonvineente: se nell'episodio dell'agonia nel Getsemani si fosserieonoseiuta l'espressione d'una volonta umana autentiea, eapace quindi di determinarsi autonomamente in un senso 0
nell'altro, si sarebbero allora dovuti introdurre in Cristo due« soggetti volenti» distinti e contrari, poiehe un soggetto unieonon pub avere contemporaneamente due volonta opposte riguardo al medesimo oggetto. eib sarebbe stato empio e contrarioalla dottrina dei Padri, i quali hanno sempre insegnato «ehemai la earne deI Signore, razionalmente animata, ha con1piutoil suo movimento naturale separatamente, ne di propria iniziativa, in eontrasto eon l'ordine deI verba di Dio, unito ad essaipostatieamente; questo movimento naturale essa l'ha eompiuto solo quando, come e nella misura in eui il verbo di Diol'ha voluto. E per parlare piu chiaramente, eome il nostroeorpo e retto, diretto e ordinato dall'anima intellettuale e ra·zionale, eosl per il Signore Gesu, l'intero eomposto umano eramosso sempre ed in tutto dalla divinita deI suo Logos - quindi - la passione edella carne, mentre l'energia e della divinita »66.
65 Individuiamo l'insieme dell'argomentazione di Onorio sul problema deUa volonta neUe 11. 35-170 dell'ed. Kreuzer (pp. 33-40).
66 Cfr. Mansi XI, 533 E - 536 AB.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 595
L'inconsistenza d'un simile ragionalnento e stata provatain anni recenti da F.M. Lethel il quale, nel corso d'una analisiacuta ed approfondita sul testo di Sergio, dimostra ehe il patriarca nella sua argomentazione confondeva opposiziol1e e alterita, applicava erroneamente il principio di non contraddizione (poiche un soggetto unico pub avere contemporaneamentedue voleri opposti riguardo al medesimo oggetto se cib si produce sotto due rapporti differenti) ed introduceva di conseguenza una seconda confusione fra «volonta volente» e «volonta voluta » 67.
L'argomentazione di Sergio non era dunque cosl convincente come sen1brerebbe ad una prima lettura e 10 stesso Ono..rio dovette accorgersene. Egli forse non afferrb tutte le implicazioni filosofiche poste in luce dal critico moderno, ma certorecepi gli spunti teologici piu significativi ed intorno a questiarticolb Ia propria risposta. Cosl se il patriarca, adeguandosiin definitiva al vecchio schema logos-sarx 68, aveva relegatol'umanita di Cristo in secondo piano, Onorio al contrario sisforza di porne in luce il ruolo fondamentale in ordine al disegno salvifico e richiama, con acuta sensibilita teologica, l'antica querelle sull'anima umana deI Salvatore 69. Nel tentativodunque d'apportare chiarimenti e correzioni, egli sceglie di se·guire il percorso logico proposto dal suo interlocutore [a) passaggio dal probIen1a dell'energeia a quello della volonta; b)
opposizione di voleri; c) episodio evangelico deI Getsemani; d)
67 Cfr. F.M. Lethel, op. cit., pp. 36-49.68 Anche se l'espressione « razionalmente animata » (VOEpW~ €'-Vuxw!J_ev1jv)
lascia trasparire una consapevolezza della presenza in Cristo di un'animaumana razionale (cfr. G.W.H. Lampe, A Patristic Creek Lexicon, Oxford1961, p. 1555), Sergio non mostra di riconoscere in questa un autentico fattore teologico ed il successivo paragone fra Cristo e 1'uomo, fra Logos edanima umana, riconduce inequivocabiln1ente allo schema 16gos-sarx (perun approfondimento sugli schemi cristologici 16gos-sarx e Z,6gos-anthropos, (cfr. A. Grillmeier, Cesu il Cristo, passim. Piil specificamente per ladiscussione sull'anima umana di Cristo: A. Gesche, L'ame humaine deJesus dans la cristologie du IVe s., in Revue d'histoire ecclesiastique S4(1959) 385-425; E.L. Fortin, Christianisme et culture philosophique au Ve s.La querelle de l'ame humaine en occident, Paris 1959; R. Cantalamessa, Lacristologia di Tertulliano [Paradosis, 18], Fribourg 1962; A. Grillmeier,Quod non assumptum-non sanatuln, LTK 8 (1963) 954-956; C. MicaeHi, L'anima umana di Cristo nella teologia occidentale tra il IV e il VII s. Traccedella presenza di Origene, Aug. 26 (1986) 261-272).
69 Cfr. nota precedente.
596 E. ZOCCA
interpretazione deI medesimo ed esclusione d'ogni opposizionedi voleri in Cristo] , ma ne varia 10 schema introducendo alcuni excursus di carattere esplicativo. In tal modo il discorsoriceve un'articolazione nuova e piu complessa che segue, all'incirca, questa traccia:
a) passaggio dal problema dell'energeia...excursus sulla communicatio idiomatum
.. a quello della volonta
b) opposizione di voleriexcursus sull'impeccantia
c) episodi evangelici
d) interpretazione dei medesimi ed esclusione d'ogni opposizione di voleri.
excursus sull'aspetto soteriologico delI'esempio dato da Cristo in quanta uomo.
La prospettiva viene dunque ad anlpliarsi rispetto a Sergioe lascia supporre, per l'iter argomentativo, l'apporto d'unafonte particolare. Per individuare questa fonte 0, piu in generale, la tradizione seguita dal pontefice in merito al problemadella volonta, occorre esaminare la trattazione relativa sottotre aspetti distinti e complementari: l'impostazione cristologicadi base, le fonti dei singoli temi toccati (con particolare riferimento agli excursus) ed infine il collegamento istituito fra ivari temi.
Per quanta riguarda la prospettiva cristologica, possiamosenz'altro affermare che Onorio costruisce la propria rappresentazione sullo schema logos-dnthropos. Conduce ad una simile conclusione la presenza di taluni elementi significativi:
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 597
a) un doppio riehiamo all'immagine di Cristo «mediatorefra Dio egli uomini », eoneetto questo di ehiara provenienzaagostiniana e leoniana 70;
b) L'impiego di una tipiea forma di eomn1unieatio idionzatuln ehe si distingue dall'uso alessandrino ed eben attestatain Oeeidente 71;
c) un riferimento implieito alla diseussione sull'anima uma·na di Cristo, signifieato dalla eitazione letterale di Le. 19, 10,versetto piu volte rieeheggiato da Leone in eontesti analoghi,e presente in un frammento damasiano eon esplieito riferimenta alla polemiea antiapollinarista 72;
d) una valorizzazione deI ruolo svolto dall'umanita di Cristo nel dramma della passione, espressa attraverso il motivosoteriologieo dell'esempio (motivo svolto seeondo modi e eategorie leoniane ma di derivazione agostiniana) 73.
70 Onorio definisee Cristo «mediatore fra Dio e gli uomini », pertre volte nella I lette alle 11. 36-37, 51-52, 257-258, e per una volta nella11 lette alla 1. 353 (rispettivanlente Kreuzer, 33, 34, 43, 49'). Per la eentralitaehe il eoneetto di «Mediatore » assunse nella eristologia di Agostino eLeone efr. J.N.D. Kelly, op. cit., pp. 483 sS.; G. Moioli op. eit., pp. 294 sS.;A. Grillmeier, Gesu il Cristo, pp. 940-941; B. Studer, «Sacramentum etexemplum », p. 88; Id., Dio salvatore, pp. 284 ss. Su Leone in part. efr.A. Grillmeier, Christ., pp. 153-156.
71 Sulla communicatio idiomatunl neHa I lett., efr. le 11. 46-96 (Kreuzer, 34-36). Sull'argomento efr. P. Galtier, La premiere lettre, pp. 48-53;T.J. van Bavel, Reeherches sur la christologie de St. Augustin, Fribourg1953, pp. 57-73.
72 Per Damaso efr. PL 13, 351-352: Et ubi erit, illud dictum Domini,venit filius hominis salvaret quod perierat totum? Id est in anima etin corpore, in sensu atque in. tota substantia suae naturae. Si ergo totushomo perierat necesse fuit ut id quod perierat salvaretur; per Leone efr.ep. 59 (TD 15, 43); s. 52, 1; s. 54, 2; S. 62, 4 (CCL 138 A, 307; 318; 380); perOnorio efr. 11. 148ss (Kreuzer, 38-39). Il eollegamento fra Lc. 19, 10 e laquestione delI 'anima umana di Cristo, per quanta possa sembrare ovvio,tuttavia non e dei piil frequenti, ad esempio Agostino, pur sottolineandospesso l'assunzione di tutto l'uomo da parte delllogos, non 10 riporta(almeno per quanta ci e stato possibile aeeertare basandoei su indieiseritturistiei). La presenza quindi d'un tale eollegamento in Damaso,Leone ed Onorio, eioe in tre pontefici, induee a formulare l'ipotesi ehesi fosse stabilita aRoma, 0 piit limitatamente nell'ambiente pontifieio,una tradizione esegetiea ehe legava Lc. 19, 10 a speeifiei interessi soteriologici connessi aHa presenza di un'anima umana in Cristo (per Jadiseussione sull'anima umana rimandiamo aneora alla n. 68).
73 Per la trattazione speeifiea sul motivo dell'esempio e sul rapporto fra Leone ed Onorio efr. infra, p. 603 ed in part. note 89 e 90.
598 E. ZOCCA
Come si aeeennava sopra, Onorio riprende quel eoneettod(<< mediatore » ehe, nelle forme qui esposte, appare d'origineagostiniana e leoniana. La signifieativa eolloeazione di un pri..mo richiamo ad esso in apertura di diseorso, assume quasil'aspetto di una diehiarazione programmatiea. 11 pontefiee in..fatti, solleeitato dalle argomentazioni di Sergio, intende porrein luee eome sia proprio la con1presenza di due nature intattee complete, nella persona uniea deI Salvatore, a eostituire ilfondamento soteriologieo dell'inearnazione. Per tal motive eglinon passa bruseamente dal problema dell'energeia a quelle dellavolonta, eome aveva fatto il suo interloeutore, ma si diffondein una lunga esposizione sulla communicatio idiomatu111. Forse10 spunto immediato per un simile passaggio fu tratto dal To..l1'lUS ad Flavianun1 ehe, dopo la eelebre frase Agit enin1 utraque forma introdueeva la trattazione sullo seambio di attributieon.le seguenti parole Unun1 hlQrum coruscat n1iraculis, aliud subcun1bit iniuris 74, trasparentemente rieeheggiate dal nostro autore 75. Ad ogni modo e interessante notare ehe Onorio, purpartendo dal Tomus, eon1e dimostrano appunto i richiami aivv. 94-95, non prosegue sulla medesima linea, ma preferiscerifarsi direttamente a quel teste agostiniano ehe la eritiea moderna rieonosee aHa base deila trattazione leoniana 76, eioe ileap. VIII deI C. s. Arrian. Se infatti eonfrontiamo i passi diAgostino, Leone ed Onorio sul medesimo argomento, possiamoeonstatare ehe la parentela fra i tre risulta detern1inata solodeI fatto ehe Tomus e I lette di Onorio, risalgono entralubiad una medesima fonte, mentre se proviamo a traserivere unodopo l'altro il passo dell'Ipponate e quello deI nostro autore,noteremo ehe la eorrispondenza fra questi ultimi e quasi perfetta:
Per quanta riguarda l'origine agostiniana di questo motivo cfr. B. Studer,« Sacramentum et exemplum».
74 Cfr. i vv. 94-95 deI Tomus ad Flavianum (TD 9, 26) e la nostrap.584.
75 Cfr. Onorio, I lett. 11. 46-50 (Kreuzer, 34).76 Ci riferiamo in part. ai vv. 126-132, ossia quelli nei quali si evi
denzia un'affinita con Onorio. Sul rapporto fra il Tomus ed il c. s. Arrian.cfr. TD 9, 28 nota c; A. Granata, art. eil., pp. 279-280; H. Arens, op. eit.,pp. 517 ss.
Agostino:
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 599
«(...)et Filium hominis dieitur deseendisse de eoelis, quamvissit ex ea quae in terra fuerat virgine aSsUl11ptus; et Filius Deidieitur erueifixus et sepultus, quamvis haee 11011 in divinitateipsa qua est Unigenitus Patri eoaeternus, sed in naturae humanae sit infirlnitate perpessus. Nam Filium hominis deseendisse de eoelo, ipsum dixisse sie legimus: Nenzo aseendit ineoelum, nisi qui de eoelo deseendit, Filius hominis, qui est ineoelo (10 3, 13). Unigenitum vero Filium Dei erueifixum et sepultum, omnes etiam in Symbolo eonfitemur. Unde est et illudApostoli: Si eninz eognovissent, numquan! Dominum gloriaeerucifixissent (1 Cor. 2, 8). Hane unitatem personae ChristiJesu Domini nostri, sie ex natura utraque eonstantem... utquaelibet earUlll voeabulum etiam alteri impertiat, et divinaehunlana ,et humanae divina, beatus ostendit Apostolus» 77.
Onorio:
« Egli stesso figlio deH'uomo seese dal eielo, eom'e seritto fuerocifisso il signore di maesta, mentre eome Dia non potevapatire aleuna sofferenza umana, e la sua earne non seese da]cieIo, ma fu assunta dalla santa genitriee di Dio, pereio eoslparIa la verita nei vangeli: nessuno sale al cielo se non chidiseese dal eielo, il figlio dell'uon1o ehe e in cielo (.10. 3, 13), equesto eertamente per insegnarei ehe la earne passibile eunita aHa divinita ineffabilmente e straordinariamente, aHostesso nl0do in eui appare ehe sono eongiunte permanendoIa distinzione, senza meseolanza ne eonfusione. CoSI ehe eertosi possa comprendere come per una ragione meravigliosa ledue nature sono unite pur mantenendosi distinte. In aeeordoeon eib l'apostolo diee ai earinzi: parlialno della sapienza trai perfetti, ma non della sapienza di questo secolo, ne dei principi di questo secolo ehe svaniranno. Ma parliamo della sapienza di Dio ehe e nascosta nel mistero, se infatti l'avesseroconoseiuta non avrebbero crocifisso il Signore di Maesta (1Cor. 2, 6-8). Mentre pero la divinita ne poteva essere eroeifissa, ne poteva fare esperienza delle passioni umane. Pereiosi puo dire in entrambe i modi sia ehe Dia patl, sia ehe l'umanita seese dal eielo 78 ».
77 Aug., c. s. Arrian. 8 (PL 42, 688-689).78 Onorio, I lett. H. 55-96 (Kreuzer, 34-36,).
600 E. ZOCCA
Onorio, non solo riprende le nledesime eitazioni serittu~
ristiehe, introdueendole seeondo una sueeessione identiea, mariproduee anehe una doppia eitazione di 10. 3, 13, ehe nel eontesto originario sembrava rispondere piü ad esigenze stilisticheehe logiehe. Pertanto il rapporto fra il nostro autore ed Agostino deve eonsiderarsi non mediato, almeno in questo easo,dall'opera di Leone, ma diretto ed autonomo.
A questo punto e leeito ehiedersi quale motivo possa averindotto il pontefiee ad abbandonare la eomoda sintesi leoniana,gia utilizzata in preeedenza, per ricercare un Iegame eosl diretto eon l'Ipponate. Potremmo trovare una risposta allargando Ia Iettura deI passo agostiniano al eontesto immediato, eioea quei eapp. VII e VIII ehe presentavano un interessante collegamento fra questione della volonta e COn11'nUl1icatio idiolnatum, ma risehieremillo in tal modo di trarre eonelusioni affrettate. Conviene quindi eontinuare l'esame dei singoli temi,eereando di determinare di volta in volta le rispettive fonti;solo dopo ehe questa breve indagine sara stata eompiuta, potremo riprendere il problema suaeeennato per affrontarlo subasi piü sicure.
Tornando aIl'esposizione sulla comn1unicatio idiomatu111,vediamo ehe essa si eonelude eon la frase « quindi eonfessiam.ouna volonta deI Signore Gesu Cristo, giacche evidentementedalla divinita fu assunta la nostra natura non il peeeato» 79,
ehe, a sua volta, introduee UD lungo excursus sulla questionedell'impeccantia di Cristo. Tale excursus, nelle intenzioni delpontefice, dovrebbe diInostrare l'assenza nel Salvatore di qualsiasi opposizione di voleri. L'argomentazione si basa ehiaramente sulla dottrina agostiniana deI peeeato originale; ad essariehiamano l'insistenza sulla lex nlenlbroruln, la distinzionefra valore positivo e negativa deI termine caro 80, Ia eitazione
79 H. 96-100 (Kreuzer, 36-37).80 Agostino si soffermo spesso a considerare il valore deI termine
caro sia per un personale interesse relativa al linguaggio biblico, sia perspecifiche esigenze derivanti dalla polemica manichea e pelagiana (nell'impossibilita di offrire qui una lista anche approssimativa dei numerosissimi riferimenti, rimandiamo all'index generalis deI Migne in PL 42,134-137). Tuttavia non troviamo, ahneno fra le opere autentiche, U!1fl-
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 601
infine di quei versetti paolini ehe tanto spazio ebbero nellaeostruzione dottrinaria dell'Ipponate 81. Tuttavia, in questo medesimo tratto della lettera, tornano echi evidenti deI TonlUs 82
ed in genere di Leone. Anzi il diseorso sull'assenza in Cristo diogni opposizione di voleri sen1brerebbe trovare un riscontro nelseguente passo leoniano:
Nihil enün carnis suae habebat adversum, nec äiscordia desideriorum gignebat cOlnpugnantiam voluntatun1, sensus corporei vigebant sine lege peccati, et veritas affectionurn submoderalnine deitatis et mentis, nec tenlptabatur inlecebris neccedebat iniuriis 83.
serie di citazioni scritturistiche, pro e contra, paragonabHe a quella diOnorio; compaiono, e vero, numerosi distinguo sul significato deI termine in an1bito esegetico, chiare attestazioni sul valore positiva dellacarne (particolarmente in ordine alla polemica antimanichea), ed alcunidei collegamenti presenti in Onorio (p. es. Gen. 6, 3 e 1 Cor. 15, 50 inc. Adim. 12, CSEL 25, 50; oppure 1 Cor. 15, 50 e Ronz. 7, 22-25 in s. 362,13, PL 39, 1620; 0 ancora Job. 19, 26 e Le. 3, 6 in civ. 11, 19, CCL 48, 860),n1a, per quanta si possa rilevare un'ideale assonanza di contenuti, il riscontro resta sempre parziale. Un rapporto piiI preciso sembrerebbeinvece ipotizzabile con un sermone pseudo agostiniano edito dal Caillau(in S. Augustini opera omnia XXIII, Paris 1842, pp. 165-168) ed oggi inPLS 4, 954-956. Esso riporta una lista di citazioni molto vicina a quelladeI nostro autore e divisa, appunto, in pro e contra. Mancando perquesto sermone studi specifici, le informazioni in nostro possesso sonoestremamente scarse. Sappiamo che esso fu ritrovato nel cod. Cassinensis XII, databile non posteriormente all'XI S. (cfr. Bibliotheca Cassinensis, Abazia di Mante Cassino 1873, p. 164), ehe va ritenuto antiquus emostra diverse affinita con Tertulliano ,particolarmente, per il branoehe qui ci interessa, con resurr. 10 (cfr. G. Marin in PLS 4, 867). In effettifra il testo tertullianeo (in CCL 2, 932-933) ed i'l nostro sermone esisteuna notevole corrispondenza, riportando entrambi i medesimi riferin1entibiblici, Tertulliano pero non distingue eosi esplieitamente come l'autoreignoto le due serie di citazioni. E' difficile trarre eonclusioni: non sembra ci sia luogo per supporre una dipendenza di Onorio dal testo tertullianeo, mancando la distinzione fra 'le due liste, mentre, eome si diceva,un rapporto fra il nostro autore ed il sermone pseudoagostiniano rimanepossibile sebbene non sieuramente aeeertabile. Onorio avrebbe potutoconoscere questo sermone (come fa supporre l'antiquus di Morin) edutilizzarlo credendolo autentico, oppure sia Onorio che l'ignoto autorepotrebbero essersi ispirati, indipendentemente, ad un'on1elia dell'Ipponate oggi perduta. Siamo nel campo delle ipotesi. L'unica cosa certarin1ane '1'allure agostiniana di questo distinguo sul tern1ine carne, di piile impossibile dire.
81 Cfr. p. es. in RaIn. 44-46 (CSEL 84, 24-30).82 Per gli echi dal Tomus in questa parte della lettera cfr. il nostro
schema delle pp. 581-582.83 Ep. 35 (TD 15, 17).
602 E. ZOCCA
Influenza agostiniana e leoniana vengono quindi a sovrapporsi e confondersi, ne cio puo stupire dato ehe la dipendenzadi Leone dall'Ipponate in merito aHa dottrina deI peccato originale e dell'hnpeccantia e fatto noto. Anzi, a proposito diquest'ultima, basti leggere la trattazione ehe Agostino ne diedein can!. !'11ax. 14 per eomprendere quanta sia stretto il legamefra i tre autori 84. Pili interessante nel senso d'un signifieativoinflusso leoniano sembrerebbe invece la ehiusa finale dell'interatrattazione:
« E' infatti seritto non venl1i per tare Za mia voZonta nla quelladeZ Padre mio ehe mi ha lnandato e non eio ehe io voglio n1aeio ehe tu vuoi 0 Padre ed altre cose deHo stesso tipo. Cibnon riguarda un'opposizione di voleri, ma l'eeonomia dell'umanita assunta. Queste eose infatti furono dette per noi, eui diedeun'esempio affinehe seguissimo le sue arme, quale il pio maestro ehe istruisee i diseepoli affinehe eiaseuno di noi, in ognieireostanza, anteponga aHa propria volonta queHa deI signore» 85.
In questo breve passo Onorio riprende quei 111edesiJni episodi evangeliei nei quali la tradizione oeeidentale ravviso unaprova manifesta della presenza in Cristo d'una reale volontaUlnana; in tal senso, ad esempio, li riehiarnavano Alnbrogio, Agostino e Leone, autori piu volte eitati dal VI eoncilio eeumenieo,quali rappresentanti della dottrina ortodossa 8C'. Anche in considerazione d'un sin1ile rilievo non sembra attendibile l'ipotesiehe il nostro autore scegliesse proprio questi stessi episodiper comprovare una professione di fede autenticamente monotelita. D'altro canto l'analisi condotta da P. Galtier sul termine
84 Cfr. conZ. Max. 14 (PL 42, 720 ss.). Per i rapporti fra Leone cdAgostino riInandiamo alla nota 27.
85 11. 155-170 (Kreuzer, 39-40).85 Per quanta riguarda Ambrogio e Leone ei riferialTIO in part. alle
testimonianze eitate da questi due autori (Ambr. tide, 11, 5 ss., CSEL 78,70 ss.; exp. Lc. IV, 11, CCL 14, 10; Leo M., ep. 165, ACO 11/4, 117) neHesessioni VIII e X deI VI eoneilio eeumenieo (efr. Mansi XI, 369-372; 393396), mentre per quanta riguarda Agostino, dato ehe i riehiami deI coneilio non eomprendono testi relativi ai brani evangeliei qui considerati,ricordiamo eome esempio signifieativo c. Max 11, 20, 2-3 (PL 42, 789 ss.),testo al quale Onorio sembrerebbe rieollegarsi per piu aspetti (cfr. aproposito della con1municatio idiomatum e deI termine oikamia, P.Galtier, La premiere lettre, pp. 50 S.; G. Kreuzer, ap. ci:.. p. 36 n. 143 ep. 39 n. 153; mentre a proposito deI problema della volonta efr. infra, pp.603 ss.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 603
oikonOl11ia - dispensatio, eonsente oggi di rieolloeare l'argomentazione deI pontefiee nella sua giusta luee 87. Onorio infatti,attraverso la frase «l'economia dell'umanita assunta », avrebbe inteso riferirsi semplieemente all'inearnazione, eonsideratanella sua prospettiva soteriologiea; nessuna eoneessione quindiad atteggiamenti larvatamente doeeti, D1a solo un preeiso riehiamo al ruolo svolto dall'umanita di Cristo nel dramma dellapassione.
Fra le testimonianze addotte dallo studioso eomparivanodiversi autori della tradizione oeeidentale, fra i quali Ambrogioed Agostino, tuttavia maneava, stranamente, Leone. Eppureanehe in quest'ultimo e possibile trovare un'espressione si111ilea quella deI nostro autore - susceptae enin1 incarnationisdispensatio - signifieativamente inserita nel eontesto d'unaviva attenzione per il fine soteriologico dell'umana sofferenzadi Cristo 88.
Di nuovo quindi si evidenzia un rapporto fra Leone edOnorio, rapporto ehe trova eonferma nell'epilogo deI branocitato. Qui Onorio sembrerebbe aver riecheggiato il seguentepasso leoniano:
Unde salvator noster filius Dei universis in se credentibus elsacramentum condidit et exemplU11'l, ut unUl11 adprehenderentrenascendo ,alterum sequerentur imitando. Hoc enim docetbeatus Petrus apostolus dicens: Christus passus est pro nobis,relinquens vobis exemplunl ut sequamini vestigia eius (1 Ptr.2, 21) 89.
L'affinita fra il testo citato e l'ultima frase deI nostro autoree manifesta. Anche se in mancanza d'una precisa identita verbale non possiamo concludere per una dipendenza certa, rin1ane tuttavia innegabile un'ideale assonanza di contenuti e lapresenza d'una sensibilita comune nei confronti di determinateproblematiche 90.
87 Cfr. P. Galtier, La premiere lettre, pp. 53 S5.
88 Cfr. Leo M., S. 68, 1-2 (CCL 138 A, 414-415).89 S. 63, 4 (CCL 138 A, 384-385), nel contesto d'un riferimento aHa
sofferenza umana di Cristo.90 Una simile affinita e riscontrabile anche nci seguenti passi leonia
ni: ep. 31 (rD 15, 10); S. 21, 2 (CCL 138, 87-88); s. 58, 5; S. 59, 1; s. 63, 4;s. 65, 2; S. 67, 5 (rispettivamente in CCL 138 A, 347-348; 340; 385; 396-397; 411).
604 E. ZOCCA
L'influsso leoniano sembra dunque prevalere in quest'ultillla parte della trattazione, eppure una conclusione simile sa·rebbe inesatta : in primo luogo perche Leone fu largamentetributario di Agostino nella sua rappresentazione cristologica 91,
in secondo luogo perche l'argomentazione di Onorio presenta,nel collegamento dei vari temi, un percorso pressoche identico al seguente passo dell'Ipponate:
Propter hanc ergo unitatem personae, non solum filiul'n hOl1Zinis dixit descendisse de coelo, sed esse dixit in coelo, Clanloqueretur in terra. Non ergo voluntatem sua111 feeit; quia peecatum non feeit: sed voluntatem illius qui eU111 misit. Tuneenim facit hon10 voluntatem Dei, quando facit justitia111 quaeex Deo est 92.
Come si puo notare, Agostino parte dall'unita di persona, comefara Onorio richiamandosi al concetto di «mediatore », prosegue con la corrzmunicatio idiomatum, che il pontefice tratta inbase al c. s. Arrian., accenna alla questione della volonta, laddove il nostro autore introdurra la sua presunta confessionemonotelita, quindi si richiama aHa dottrina dell'impeccantia,esattamente come Onorio, fa un riferimento a 10. 6, 38, ancoracome Onorio, ed infine opera un collegamento (non deI tuttoperspicuo a dire la verita) fra l'obbedienza di Cristo e quelladell'uomo, appunto COllie avviene nella chiusa finale sopra indicata.
Pertanto i singoli richiami deI pontefice a Leone non possono escludere la presenza, contemporanea, d'un rapporto coerente e continuo con l'Ipponate. Tuttavia anche in questo caso,come per i capp. VII e VIII deI c. Ser1'n. Arrian, un precisointerrogativo invita a procedere eon cautela: come puo conciliarsi un'eventuale dipendenza di Onorio da Agostino in meritoal problema deHa volonta, con la ben nota affermazione « quindi eonfessiamo una volonta »? Se la frase di Onorio viene lettacome espressione di un monotelismo di tipo severiano, nonesiste un'autentica possibilita di eonciliazione poiche Agostinofu sicuramente ed esplicitamente ditelita, riconoscendo la presenza in Cristo d'una reale volonta umana, accanto aHa divina;
91 Rimandiamo ancora aHa nota 27.92 C. lV1ax. 11, 20, 3 (PL 42, 790).
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 605
ma se ammettiamo per le parole deI pontefiee un'interpretazione diversa, eoerente eon quel eontesto nel quale si trovanoinserite, allora l'ipotesi d'un aeeordo eon l'Ipponate e tutt'altro ehe indimostrabile.
Tornando a eonsiderare il c. s. Arrian., eon riferimento aleontesto immediato deI passo ripreso da Onorio, possiamo notare ehe anehe qui, eomenel brano deI c. Max. Agostino instauraun eollegamento fra communicatio idiomatum, problema dellavolonta, impeccantia e riehiamo all'obbedienza di Cristo 93. Inpartieolar modo appare molto stretto il Iegame fra l'assenza,nel Salvatore, di quell'opposizione di voleri ehe deriva al·l'uomo dalla sua natura viziata, e l'obbedienza perfetta eheegli stesso mostro dinanzi al volere deI Padre. A proposito diquest'ultimo eollegamento il testo presenta aleune interessantiosservazioni ehe ci aiutano, fra l'altro, a eomprendere aleunitratti oseuri dell'ultimo brano eitato:
Quamquam et hoc ipsum quod dicit Jesus, Descendi de coelo,non ut facialn voluntatem nleam, sed voluntatem ejus qui memisit (10. 6, 38); ad illud referatur quod homo prius Adam(de quo dicit Apostolus, Per unurn hominem peccatuln intravitin mundunt, et per peccatum mors; et ita in omnes hominespertransiit, in quo onznes peccaverunt ( Rom. 5, 12), faciendovoluntatem suam, non ejus a quo factus est, universuln genushumanun1 propagine vitiata culpae et poenae fecit obnoxiznn.Unde a contrario, per quem liberandi fuera1nus, non fecit voluntatem suam, sed ejus a quo missus este Ita quippe hocloco dicitur voluntas sua, ut intelligatur esse propria contravoluntatem Dei. lVeque enim cum obedimus Deo, eaque obedientia dicin1ur ejus facere voluntate1n, nolentes id faciTnus,sed volentes, ac per hoc si volentes id facimus, quomodo voluntatenz nostram non facinzus, nisi quia illa dicitur voluntas,nostra, quando scriptura ita loquitur, quae intelligitur essepropria contra voluntatem Dei? Hanc habuit Adan1, ut in illomoreremur: hanc non habuit Christus, ut in illo viveremus(c. s. Arrian. 7, PL 42, 687).
L'affinita eon la problematiea generale deI nostro autore e notevole. In partieolar modo eolpisee quel breve periodo sull'obbedienza umana, dal quale sembra debba seaturire ad ogni n10-
93 Cfr. c. s. Arrian., 7-8 (PL 42, 687-689).
606 E. ZOCCA
mento un'aftermazione «monotelita» sul tipo di quella presente in Onorio. Tuttavia cib non avviene ed Agostino sembraqui arrestarsi sulla soglia, quasi timoroso di compiere l'tl1timopasso e trarre le Iogiche conseguenze deI suo ragionamento.Ma altrove egli si spinge oltre e, nell'en. Ps. 93, troviamo unafrase che ben potrebbe giustificare tutta l'argomentazione deIpontefice, ivi compresa la sua preStlnta confessione monotelita:Quo1nodo autel11 complexus est Dominus ex duabus voluntatibus unam factam in hominem quem portabat? 94 La rispostadata dal!'Ipponate a questo interrogativo si articola per interosul motive dell'obbedienza, nel confronto costante fra l'uomo(comune) e Cristo, iI Dio-uomo.
La differenza fra Onorio ed Agostino consiste dunque esclusivamente in quel ex duabus. Differenza notevole, e vero, macompensata in parte dal contesto in cui il pontefice inserl lasua infelice frase e, soprattutto, da quel continuo, ostinato,ripetitivo insistere sulla reale umanita di Cristo.
Oggi non siamo in grado di conoscere con assoluta certezza le letture di Onorio, tuttavia la sua dipendenza dall'Ipponate sembrerebbe irrefutabile. Troppo simile e il criterio argomentativo, troppo chiari e precisi i riscontri con le lineegenerali deI suo pensiero antropologico e cristologico. Possiamo dunque concludere suggerendo per il nostro autore unaprospettiva malta vicina, se non addirittura identica, a quelladi Agostino: la volonta di Cristo e duplice a livello ontologico,poiche due sono le nature che mantengono intatte le rispettiveproprieta, ma e una sul piano psicologico 0, piu propriamente,etico, poiche il Salvatore non contemplando in se quell'opposizione di voleri che deriva all'uomo dalla lex membrorum, fuin tutto e volontariamente obbediente al G'enitore: consonanset conveniens est filii voluntas ad voluntatenz Patris 95. Cosl siera espresso Agostino in un'opera scritta in quel medesimocontesto di polemica antiariana dal quale abbiamo tratto lamaggior parte dei passi qui citati, e cosl avrebbe potuto espri..lnersi Onorio se gli fosse stato chiesto un chiarimento sul suofamoso «quindi confessiamo una volonta ».
94 En. Ps. 93, 19 (CCL 39, 1319).95 Cfr. conl. Max. 20 (PL 42, 736).
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE
Da Leone ad Onorio.
607
L'analisi svolta ha posto in rilievo una serie di preeisi riferimenti ad Agostino, Leone Magno e sin1bolo ealeedonese. Inlinea di prineipio la presenza di tali elementi non erea diffieoltapoiehe sappiamo quale peso assunsero queste tre autorita inOceidente, tuttavia non possiamo traseurare ehe un lungo lassodi tempo separava il nostro autore dall'elaborazione teologicadei ss. IV-V. Nel periodo intereorso varie eontroversie teologiehe agitarono l'Oriente, ed il ITlondo latino, nonostante unageneralizzata indifferenza, ne fu in taluni easi eoinvolto 96. Perquanta il problema piu urgente rimanesse qui la polemiea antiariana, poiehe ariani erano per 10 piu i barbari invasori, gliambienti teologieamente piü sensibili ed il papato non si sottrassero ad un impegno in tal senso 97. Assistiamo eosl allo svolgersi d'un rieeo seambio epistolare fra i pontefiei e l'Oriente,nonehe al sorgere d'una letteratura antin10nofisita latina 98. Taleproduzione letteraria risulto in genere largamente tributariadeI passato e scarsamente originale dal punto di vista speeulativo. 11 rieorso ai grandi Padri della tradizione oeeidentale( maanehe orientale) divenne via via piu frequente e naequero, proprio in questo periodo, i primi florilegi 99. Raeeolte, per eosldire, «private» si affianearono sieuramente a quelle edite egiunte fino a noi, n1entre un eorredo di testimonianze patristiehe diveniva strumento indispensabile in qualsiasi disputa teologiea. Neanehe l~eone Magno, ehe serisse agli albori di questonuovo orientamento eulturale, volle sottrarsi all'uso ehe siandava diffondendo ed aeeompagno le sue epistole dogmatieheeon una pieeola serie di citazioni tratte da autori ormai «eon-
96 Cfr. G. Bardy, La repercussion des controverses christologiquesen Occident entre le concile de Calcedoine et la mort de l'empereur Anastase (451-518), in Chalkedon 11, pp. 771-789; A. Grillmeier, Vorbereitung,pp. 791-839.
97 Cfr. M. Simonetti, La produzione letteraria latina fra romani ebarbari (ss. V-VIII), Roma 1986, in part. pp. 11 s.
98 Su questa letteratura cfr. M. Simonetti, La letteratura antimonofisita d'Occidente, Aug. 18 (1978) 487-532.
99 Sui florilegi latini in generale cfr. H. Chadwick, Florilegiunz,RACh 7, 1131-1160; I-LM. Rochais, Florileges spiritueis, DSp 5, 435-460;F. Brunhölzl, Lateinische Florilegien, in Theologische Realenzyklopädie 11,219-221. Per i florilegi agostiniani cfr. J.T. Lienhard, The Earliest Florilegia 01 Augustine, in Augustinian Studies 8 (1977) 21-31.
608 E. ZOCCA
saerati }} 100. Di eonseguenza e logieo supporre ehe gli arehivipontifici, nel eorso degli anni, si siano sempre piiI arrieehitidi simili materiali, determinando il forn1arsi di veri e propria«dossier patristiei}}. Onorio avrebbe potuto rieorrere a taliraeeolte allorehe si apprestava a eomporre la sua prima lettera,dedueendo di qui i testi agostiniani e leoniani ehe aobiamovisto influenzare il suo diseorso, oppure avrebbe potuto rivolgersi ai florilegi editi, 0 aneora a quelle opere ehe, piiI 0 menoesplieitamente, avevano riproposto il pensiero dei grandi autorideI passato.
Per forn1ulare un'ipotesi di qualehe eonsistenza non ciresta ehe ripereorrere la produzione letteraria dei ss. V-VII, neltentativo di rintraeeiare un eventuale tramite fra le letteredeI nostro autore e la tradizione teologiea individuata alla basedi esse.
Come sopra aeeennato, negli anni sueeessivi al Caleedonese,il mondo latino si mostro aneor meno sensibile ehe in preeedenza alle questioni eristologiehe ehe appassionavano l'Oriente. Lecause d'un tale atteggiamento furono moltepliei e non e questala sede per esaminarle, va eomunque rieordato ehe taluni ambienti, per ragioni storieo-politiehe, non eondivisero la generaleindifferenza ma, al contrario, si iInpegnarono a vario livelloe eon diverso titolo nel dibattito teologieo. PiiJ. eoinvolti furono ovviamente eoloro ehe gravitavano intorno aRoma edin partieolar modo i pontefiei, direttamente ehiamati in causada imperatori e patriarehi bizantini. Se eonsiderialTIO la lungalista di papi fra Leone ed Onorio, possiamo eonstatare ehemolti di essi si trovarono nella neeessit80 di prendere una posizione in merito ai problemi teologiei sollevati nelle provineeorientali. Seorrendo in un rapide esan1e i doeumenti raeeoltidal Denzinger 101, emerge eon ehiarezza la eoerenza eon eui ilsoglio pontifieio (al di 180 deH'ambigua posizione di Vigilio) tenne fede aHa propria seelta in favore di uno stretto ealeedonesimo. Riehiami al eoneilio ed al Tomus appaiono eon signifieativa frequenza e la eristologia di Leone domina le diverse
100 Cfr. TD 9, 8 ss. (la sillage e edita in TD 9, 34-43 e ACa 11/4,119-131).
101 H. Denzinger-A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, Rama231965, pp. 117-165. - - - - - - - - -L- _
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 609
professioni di fede, eio nonostante non troviamo riferimenti allequestioni affrontate da Onorio, ne elen1enti ehe possano eostituire un preeedente per le soluzioni da lui proposte riguardoai problemi dell'energeia e della volonta. Neppure la famosaformula d'Ormisda, eon la quale si rieompose 10 seisma aea..eiano, offre aleun appiglio in proposito. E' sembrato quindiopportuno estendere l'esame all'insieme della produzione epistolare dei singoli pontefiei, eosl eome essa ci viene restituitadalle edizioni attualmente in uso. 11 risultato ottenuto e statopero identieo al preeedente: anehe qui si e potuto notare uncontinuo rieorrere di riehiami a Leone e Caleedonia 102, manulla ehe potesse aiutarei nella nostra rieerea. Rivelatosi vanoquesto seeondo tentativo, ci siamo rivolti a trattati teologieieon1posti in ambiente romano 0 anehe in ambienti diversi, maehe sempre mostrassero interesse per problemi vieini 0 in qual..ehe misura rieondueibili a quelli eonsiderati da Onorio. Aiutatitalvolta dagli indiei delle edizioni eritiehe, talaltra affidandoeiad una veloee lettura diretta, abbiamo ripereorso testi della letteratura antimonofisita 103, opere di polen1iea antiariana 104, iltrattato De duabus naturis di Gelasio 1 105, il De mysterio s.
102 Diamo qui una breve lista di tali riferimenti ehe ha per oggettola eorrispondenza pontifieia indirizzata in Griente, 0 relativa a questioniteologiehe eonnesse eon l'Oriente: Simplieio in PL 58, 39 D, 42 D, 43-44,46 B, 56 B, 57 B; Feliee 111 in PL 58, 895 D, 896 D, 900 C, 901 Al: 903 AB,907 A, 919 B, 921 AB, 929 D, 930 C, 931 AC, 951 A, 953 BC, 954 A, 973 A,975 D, 978 B; Gelasio I in PL 59, 16 D, 17 A, 24 AB, 41, 66 A, 67 BD, 68 D,69 Be, 72 B, 87 D, 92 A, 102 C; Ormisda in PL 63, 375 D, 379 A, 380 CD,391 D, 404 A, 418 D, 430 A, 434 B, 461 C, 472 BD, 513 C; Giovanni 11 inPL 66, 22-23; Pelagio I in F.M. Gasso-C.M. BatNe, Pelagii I P., Epistulaequae supersunt, Montserrat 1956, pp. 7, 9, 21, 33, 38, 39; Pelagio 11 in PL72, 708; Gregorio Magno in CCL 140, 32, 157-158, 219, 220, 253, 321, 346-347,351, 370-371, e in CCL 140 A, pp. 520-521, 553, 700-701, 753, 1083.
103 Arnob. confl., PL 53, 239-322; Vigil. Thaps. c. Eutych. PL 62, 95·154; Avit. c. Eutych. haer., MGH, AA 6/2, 15-29; Rustie. c. Aceph., PL 67,1167-1254.
104 Per la letteratura antiariana d'ambiente afrieano: Quodv. c. iud.page arr., CCL 60, 227-258; Quodv. adv. quinque haer., CCL 60, 261-301;Fulg. Rusp. c. Arrian, CCL 91, 71-94; Vigil. Thaps. c. Arrian., PL 62, 155-238;Vigil. Thaps. c. Felicianum, PL 42, 1158-1172; Ps. Vigil. c. Varimadum,CCL 90, 1-34; Libellus fidei catholicae, ACO IV/2, 98; Cereal., c. Maximin.,PL 59, 757-768. In Gallia: Caes. Arel. Breviarium adv. haer., in G. Morin,S. Cesarii opera omnia 11, Maresdous 1942, pp. 182-208; Avit. c. Arrian,MGH, AA 6/2, 1-15.
105 Cfr. E. Sehwartz, Publizistische Sammlungen z. AkacianischenSchisma in Abhandl. d. Bayerische Akad. d. Wissen., Philol.-Hist. kl., NF10, 1934, pp. 85-95.
610 E. ZOCCA
Trinitatis di Cesario d'Arles 106, aleuni seritti in difesa dei treeapitoli 107, I'opera d'un agostiniano eonvinto quale Fulgenziodi Ruspe 108 ed infine la vasta produzione di Gregorio Magno 109,
pontefiee eosl spesso avvieinato al nostro autore.In linea di massima possiamo dire ehe I'esito e stato aneora
una volta negativo, in quanta nessuna di queste opere si prestaad essere indieata eome tramite fra il nostro autore e queipartieolari testi agostiniani e leoniani eui le sue lettere si riehiamavano. Un diseorso aparte merita forse il trattato diGelasio. Questo n10stra diverse affinita eon le lettere di Onorio,partieolarmente per quanta riguarda I'impostazione eristologiea di base: anehe qui puo eogliersi, da un lato un'inequivo~
eabile matriee leoniana espressa in numerosi e trasparenti riehiami al TOlnus, dalI'altro una piu deeisa sottolineatllra delI'unita di persona e quindi un tentativo di eoneiliazione eontalune esigenze monofisite. Non manea neppure un rapido aeeenno al problema delI'energeia (rieonoseimento d'una duplieeeategoria di operazioni - umane e divine - da rieondursiaII'uniea persona deI Dio-uomo), tuttavia siamo aneora lontanidalla problematiea ampiamente svolta dal nostro autore e, deIresto, non eompare aleun riferiInento al v. 94 deI Tomus 110.
Dobbiamo pertanto eoneludere ehe Onorio potrebbe aver lettoil trattato, magari traendo da esso qualehe spunto, ma nonfu eerto questo ehe gli fornl gli elementi eostitutivi della suaargomentazione dottrinaria, ne per quanta riguarda il probleIna delI'energeia, ne tantomeno per quello della volonta.
A questo punto non rimaneva ehe tentare la via degliexcerpta, abbiamo quindi eonsiderato i florilegi latini deI periodo fra il V ed il VII seeolo. Di questi aleuni sono eselusivamente agostiniani:
1) gli Excerpta di Vineenzo di Lerino, prima florilegio agostiniano, eomposto forse einque 0 dieei anni dopo la mortedell'Ipponate e quindi edito negli anni 434-440 (PLS 3, 23-45);
106 Cfr. G. Morin, S. Cesarii opera oml1ia 11, Maresdous 1942, pp.165-180.
107 Facund. defens.; Id., c. Mocianunm; Id., fid., CCL 90 A, 4-398; 401-416; 419-434; Gelasio I, defens., ed. R. Devreesse, Citta deI Vaticano 1932.
108 Cfr. CCL 91-91 A.109 Cfr. CCL 140-144.110 Cfr. Ie pp. 92 ss. dell'edizione citata.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 611
2) 11 Liber sententiaruln ex operibus s. Augustini, di Prospero d'Aquitania, scritto a ROlna ancora nella prin1a meta deIV s. (CCL 68 A, 257-365);
3) le Solutiones, opera anonima, composta in Africa versoil 480-490 (CCL 90, 149-233);
4) i Capitula s. Augustini in urbem Romam transmissa,attribuiti da M. Cappuyns a Giovanni Massenzio, monaco scitaattivo nella prima meta deI VI secolo, ed editi dallo stessostudioso (cfr. M. Cappuyns, L'origine des capitula d'Oranges,in Recherehes de theologie ancienne et medievale 6 [1934] 121·142);
5) gli Excerpta ex operibus s. Augustini di Eugippo com·posti, anch'essi, nella prima meta deI VI s. (CSEL 9);
altri misti:
1) gli Exelnpla sanctorum patrunl di argomento trinitario.Opera di incerta paternita, ma comunemente attribuita a Dionigi il Piccolo e quindi datata verso la prima meta deI s. VI(ACO IVj2, 74-96);
2) infine le Sententiae di Isidoro di Siviglia, nelle qualil'autore, vissuto a cavallo fra VI e VII s., dispiega una tripliceteologia - dogmatica, spirituale e morale - d'ispirazione agostiniana sia diretta che indiretta (PL 83, 537·738).
Di proposito abbiamo escluso dal nostro elenco quei Verbaseniorum che costituiscono i libri V-VI (PL 73, 851-1024) delleVitae Patrum poiche, dato l'argomento, non potevano interessarci in questa sede. Ad ogni n10do, anche fra le opere citate,e stato impossibile rintracciare precedenti validi per il nostroautore. Solo i capp. VI-VII degli Excerpta di Vincenzo presen·tano qualche affinita con Onorio, dipendendo anch'essi dalcap. VIII deI c. s. Arrian. di Agostino. La parentela fra i duesembra perb limitarsi a quest'unico dato, poiche un esame piilattento rivela che il legame di Onorio con Ia sua fonte e ditipo diverso e piu stretto rispetto a quello deI Lerinese 111.
111 Cfr. Vincent. Ler. Excerpta, 7·8, PLS 3, 33-37. Per Onorio cfr.supra.
612 E. ZüCCA
Neanche quest'ultimo gruppo di opere offre quindi alcunasoluzione al nostro problema. L'ultima ipotesi possibile sembra coSI rimanere quella concernente gli archivi pontifici, maprima di affrontare un cammino tanto incerto converra farealcune considerazioni.
La rapida carrellata storico-Ietteraria qui proposta ci sembra aver dimostrato quanta e eome l'eredita di Agostino, Leonee Caleedonia fosse rimasta viva nel eorso dei seeoli. 11 riehiamoa queste autorita si mantenne eoerente e continuo, mentre 1atradizione non presentava ancora una effettiva sclerotizzazione.La presenza di citazioni sempre nuove tratte dalle opere piildiverse testimonia che la gran parte della produzione agostiniana e leoniana era aneora fruibile per il teologo ed il polemista. In ogni momento di crisi i pontefiei eonsiderarono naturale ed ovvio ricorrere a queste autorita indiseusse: Simplicioinviava esemplari. delle lettere di Leone ad Aeacio, Giovanni 11esibiva una piccola collezione di excerpta nella sua ep. 3 adSenatores e Pelagio I richiamava sia Agostino (definito probatissimus Ecclesiae doctor) che Leone in difesa dei tre capitoli 112. Gli esempi potrebbero moltipliearsi.
La pratica di rivolgersi al passato, e ad un certo passatoin particolare, era dunque variamente attestata nello stessoambiente in cui visse ed opera il nostro pontefice. Egli inoltrefu ehiaramente solleeitato in tale direzione dal suo interloeutore,il quale da un lato eitava Leone e Ca1eedonia, dall'altro produeeva una serie di testimonianze patristiche a sostegno dellapropria tesi. Di conseguenza niente di piil logieo per Onorio chericorrere ad alcune autorita, ormai «eonsaerate», dell'Oeeidente ed in partieolare a quel suo predecessore ehe n era divenuto quasi sinonimo stesso de11'ortodossia cristologiea. Continuando una politica ormai tradizionale, egli si rivolse cosi aLeone ed ai suoi scritti. Con questi, secondo ogni verosimiglianza, ebbe un rapporto diretto, attingendoli probabilmentedalla ricca biblioteea pontificia. Diverse testimonianze permettono infatti di eredere ehe tali scritti siano stati conservatifino ai suoi tempi e che percia fossero faeihl1.ente reperibili
112 Cfr. Simplicio, ep. 4 ad Zenonen1 e 6 ad Acacium, PL 58, 39 D,43-44; Giovanni 11, ep. 3 ad Senatores, PL 66, 21-24; Pelagio I, defens.,ed. Devreesse, pp. 3, 22, 35, 51, 64, 67, 69 (passi delle lettere: 13-14, 14-15,53-54).
613I ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE
~er un pontefice ehe desiderasse eonsultarli. Non possiamoroggi sapere se Onorio rieorse personalmente agli originali 0
Inon affido piuttosto una rieerea preliminare al suo segretario.11 testo non fornisee aleun suggerimento in proposito. Sembrapero eerto, in base all'esame fin qui eondotto, ehe il suo rapporto eon Leone non subi la mediazione di autori diversi ° diapere note.
Nel easo di Agostino la prospettiva potrebbe essere inveeeleggermente eorretta. L'uso di florilegi agostiniani, eome abbialTIO visto, era gia veeehio di eirea due seeoli, e l'opera dell'lpponate, per la sua stessa mole, non era affatto eosi maneggevole eome quella di Leone. E' quindi leeito supporre ehe gliarehivi pontifiei possedessero raeeolte di excerpta suddiviseper temi, e fra queste ipotizzarne una d'argomento antiariano,date le eondizioni storiehe dei tempi, e tutt'altro ehe inverosimile. Si puo eosi immaginare ehe il nostro autore attingessedi n quei testi ehe abbianlo visto influenzare la sua eostruzione dottrinaria e ehe, eome si rieordera, appartenevano tuttiad opere di polemiea antiariana.
Si potra notare ehe purtroppo siamo aneora nel eampodelle ipotesi ed e pertanto iInpossibile trarre eonelusioni assolutamente eerte. Rin1ane pero il fatto ehe Onorio, nella suaimpostazione eristologiea di base, si mantenne fedele allalinea seguita dalla lunga serie dei suoi predeeessori, adottandoriguardo ai problemi dell'energeia edella volonta soluzioni sueproprie ehe non trovavano riseontro nella preeedente produzione letteraria a earattere teologieo, ma risalivano a quelle medesime autorita ehe l'Oeeidente eonsidero sempre valide edattuali.
Col1clusioni.
L'esame fin qui eondotto ha eonsentito d'aecertare la presenza d'uno stretto rapporto fra Onorio e la tradizione oeeidentale, rilevando altresi una dipendenza speeifiea da Agostino eLeone propria in quei punti ehe, all'interno delle due lettere,apparivano dottrinariamente eontroversi. Letto in questa lueeil linguaggio deI pontefiee, eosi spesso eonsiderato oseuro eeonfuso 113, riaequista una sua perspieuita, laseiando trasparirele linee d'un pensiero eoerente e pienamente ortodosso.
113 Cfr. Hefele-Leclercq, ap. eit., p. 383; E. Amman, art. eit., p. 103.
614 E. ZOCCA
Una simile ricostruzione ha offerto d'altronde la possibilita di puntualizzare l'incidenza effettiva di certi influssi ritenutispesso determinanti; ci riferiamo in particolare a Sergio ed aquella sua specifica impostazione dottrinaria ehe, seeondo aleuni, Onorio avrebbe accettato supinamente. In realta eib eheil pontefice raccolse, e sinceralnente eondivise, fu solo un intento irenieo ehe 10 portava a cercare un terreno d'incontrocon quell'interloeutore orientale deI quale non poteva e, soprattutto non voleva, abbraceiare incondizionatamente Ia causa.Se infatti approvb il doppio rifiuto (l'abolizione di entrarrlbele formule: una 0 due energie) non ne condivise pienamentele motivazioni, mentre, per quanta riguarda il problenla dellavolonta, la sua risposta si poneva come una correzione precisaed approfondita dell'argomentazione di Sergio. Onorio eertoavrebbe potuto essere piu rigorosa ed esplicito nelle sue definizioni di fede, tuttavia bisogna considerare ehe oggi siamoinfluenzati dal successivo sviluppo degli avvenimenti, mentremanca una conoscenza diretta ed integrale dei suoi scritti 114.
Non puo ritenersi un caso ehe l'Occidente si sia schierato, alIora, in favore deI pontefice accogliendone la eondanna solo dopo lunga esitazione, in senso limitato e specifico 115. Indubbiamente la euria romana aveva tutto l'interesse nel difendere laInemoria d'un papa, ma ipotizzare ehe 10 stesso ambiente pontificio avesse provocato la perdita degli originali, appare francamente eccessivo 116. Allo stesso mado risulta poco attendibilel'ipotesi ehe Sergio stentasse a diffandere le due lettere preve-
114 Perduti gli originali, ci rinlangono le due lettere (la prima eompleta e la seconda franlmentaria) solo in traduzione greca. Di questetraduzioni solo quella della prima lettera fu verificata sull'originale mentre la seconda non rlcevette alcun controllo (cfr. Mansi XI, 545 E-548 A;580-581; e P. Conte, Primalo papale, pp. 15-16 n. 14 e p. 83).
I1S La condanna venne accolta in Occidente sotto il pontificato diLeone 11, il quale la illtese nei terrnini seguenti: «non si sforzb di mantenere pura questa apostolica tradizione ed inveee, eon il suo profano aceondiscendere, permise ehe l'intemerata Chiesa Romana venisse macchiata» (cfr. Mansi, XI, 733). Per questo punto ed in generale sull'atteggiamento favorevole dell'Occidente H. Grisar, op. eit., pp. 385-426. Diparere diverso G. Kreuzer (ap. eit., pp. 228 ss.) che interpreta la eondanna di Leone in senso pieno. Ancora sulla medesima condanna cfr. P.Conte, Primato papale, pp. 89 S.
116 Cfr. G. Kreuzer, op. eil., p. 228.
ONORIO I E LA TRADIZIONE OCCIDENTALE 615
dendone le gravi eonseguenze 117. Riterremmo piuttosto ehe taleesitazione fosse dovuta a motivazioni aftatto diverse; il patriarca infatti dovette eomprendere ehe le sue speranze erano statedisattese ed il sospirato appoggio di Roma, non era e non sarebbe giunto 118. Si pub in definitiva affermare ehe l'influenzadi Sergio fu solo marginale ed esterna; la sua lettera solleeitbil papa a sottolineare quanta piu possibile l'unita di personain Cristo, ma non pote distoglierlo da una adesione di fondoa quei prineipi sui quali si era sempre basata 1a eristologiaoeeidentale. Onorio mostrava infatti tanti e tali riehiami aquesta tradizione ehe non e possibile sostenere per lui unaderivazione signifieativa da fonti diverse. Se poi, nei suoi seritti,potevano trovarsi aspetti presenti anehe in autori della tradizione orientale, eib era dovuto all'influsso ehe questa, speeulativamente assai rieea, esereitb sempre sulla piu statiea teologialatina, si trattava perb d'un influsso mediato ehe, nei casi quiesaminati, passava per Agostino e Leone.
Bisogna pertanto eoncludere ehe la matriee autentica deIpensiero di Onorio fu la cristologia oeeidentale. Se i eontemporanei avessero eompiuto 10 sforzo sineero di eogliere il nessoehe legava il pontefiee a quegli stessi autori sulla cui base fucondannato, eerto non avrebbero dato una interpretazione tan4
to arbitraria della sua dottrina, ma forse in un'epoea in cui ledispute teologiche si condueevano piu sulle parole ehe sui contenuti, anehe un sinlile sforzo sarebbe risultato vano.
ELENA ZOCCA
Piazza Randanini, 3300186 - Rama
117 Cfr. F. Carcione, op. eil., pp. 63-64.118 Sulla richiesta dell'appoggio romano cfr. Mansi XI, 537b.



























































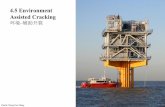



![Il pensiero filosofico occidentale e la morte [Western Philosophy on Death]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322a0bb63847156ac06b685/il-pensiero-filosofico-occidentale-e-la-morte-western-philosophy-on-death.jpg)


