Πολλοί κατά θάλασσαν επεσέπλεον: quando merci e idee dei Greci...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Πολλοί κατά θάλασσαν επεσέπλεον: quando merci e idee dei Greci...
X Convegno di StudiViaggio in Sicilia.Racconti, segni e città ritrovateAuditorium della Biblioteca Comunale “L.Scarabelli”Caltanissetta, 10-11 maggio 2013
Organizzato da SiciliAntica, sede di Caltanissetta
Con il patrocinio di:Soprintendenza BB.CC.AA. di CaltanissettaProvincia Regionale di Caltanissetta, Assessorato alla CulturaCittà di Caltanissetta, Assessorato alla Cultura
Con il contributo di:Camera di Commercio di CaltanissettaBanca di Credito Cooperativo “San Michele” di Caltanissetta e PietraperziaAssociazione Duciezio, F.lli Alessi - Mazzarino, Unicredit, Impresa Venniro Calogero, Mi.Lo. di Milazzo e Lomonaco s.n.c.
Comitato organizzatore:Massimo Arnone, Lillo Cammarata, Silvana Chiara, Marina Congiu, Michelangelo Lacagnina, Calogero Miccichè, Sergio Milazzo,Simona Modeo, Luigi Santagati
Redazione atti:Simona Modeo, Marina Congiu, Calogero Micciché, Silvana Chiara, Sergio Milazzo
Segreteria organizzativa:Silvana Chiara, Stefania D’Angelo, Salvatore Difrancesco,Sergio Milazzo, Federica Spinelli
Si ringraziano inoltre:Salvatore Sciascia EditoreIstituto Professionale Alberghiero di CaltanissettaL’angolo dell’Avventura di Caltanissetta’A ferabio. Mercatino equosolidaleSplokay di Antonio Talluto, studio di grafica
Il presente volume è stato pubblicato con il contributo della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno
Viaggio in SiciliaRacconti, segni e città ritrovate
Atti del X Convegno di Studi
a cura diMarina Congiu
Calogero MiccichéSimona Modeo
con la collaborazione diSilvana Chiara e Sergio Milazzo
SALVATORE SCIASCIA EDITORE
SiciliAnticaSede di Caltanissetta
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA©
Copyright 2014 by Salvatore Sciascia Editore s.a.s.Caltanissetta-Roma
ISBN 978-88-8241-441-2
Stampato in Italia / Printed in Italy
In copertina:Cartolina che riproduce la foce del fiume Gela sulla quale compare la firma di Saverio Cavallari.
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon:quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello.
di Katia Perna*
“In molti arrivarono dal mare”. L’efficace espressione di Tucidide1 racchiu-de in poche parole una storia, quella dei coloni Greci giunti in Sicilia, iniziatacon un viaggio di uomini e realizzatasi attraverso un altro viaggio, quello di og-getti, idee e conoscenze, la cui diffusione rappresenta la mappa dell’incontro,ora pacifico ora violento, tra popoli e visioni del mondo diverse. Degli effetti di quel viaggio, il santuario di Polizzello (Fig. 1), centro sicano
che si affacciava sulla valle del fiume Platani, ha permesso di cogliere, come inun’istantanea, un’immagine cristallizzata, e di leggerne, con tutte le difficoltàdel caso, le implicazioni. Il santuario cominciò a vivere nell’VIII sec. a.C.2 con la costruzione di un
muro di temenos e di due edifici circolari, che si impiantarono su preesistentiambienti squadrati: l’edificio E3, nella parte centrale della spianata, e l’edificioC4 più a Sud. Essi, di notevoli dimensioni e dotati di un grande focolare cen-trale, erano sede di rituali di tipo collettivo, basati prevalentemente sulla con-sumazione di carni animali e sulla successiva deposizione dei resti di pasto e de-gli oggetti utilizzati nel corso della cerimonia5. Il primo nucleo del santuario di Polizzello, quindi, si connotava come tipi-
camente indigeno, sia nella scelta delle forme architettoniche, con il ritornoconsapevole al modulo costruttivo delle capanne dell’Età del Bronzo, sia nellascelta di pratiche che ponevano l’accento sulla dimensione agricolo-pastoraledella comunità6.Con il VII sec., l’area del santuario fu riorganizzata e le attività rituali si co-
dificarono secondo formule rinnovate. In questa fase, infatti, mutarono tantol’impianto architettonico dell’area sacra, quanto la composizione delle offerte
159
* Università degli studi di Catania.1 Thuc. VI, 2,6.2 La Montagna di Polizzello, dove sorge il santuario, è stata recentemente oggetto di tre cam-
pagne sistematiche di scavo (Panvini-Guzzone-Palermo 2009), ma era stata già indagata all’iniziodel secolo da R. Carta, collaboratore di P. Orsi, e negli anni ’80 dalla Soprintendenza BB.CC.AA.di Caltanissetta, sotto la direzione di E. De Miro. Per una storia degli studi: Panvini 2009.
3 Pappalardo 2009.4 Perna 2009, pp. 188-179.5 Pappalardo 2009, pp. 241, 243; Palermo 2009, p. 303.6 Albanese Procelli 2003, pp. 180-181.
votive. Furono costruiti due nuovi edifici circolari, di diametro inferiore rispet-to ai precedenti: il sacello D7 e il sacello A8; accanto a questo, fu eretta un’al-tra struttura circolare, il sacello B9.L’ampliamento dell’area sacra corrispose con la parcellizzazione delle atti-
vità in più edifici e coincise con l’adozione di una nuova semantica dell’offertavotiva, ora affidata alla deposizione, accanto a ceramiche di produzione indi-gena, di ceramica e oggetti di ornamento di tipo greco.Quest’ultima categoria di materiali, a giudicare dal numero di esemplari, è
quella che più attrasse gli indigeni di Polizzello nel loro primo contatto con iGreci o che fu considerata più adatta a essere dedicata nel santuario. Nei sacelli di questa fase, infatti, la ceramica greca è rappresentata solo da due
kotyliskoi corinzi10, databili nella seconda metà del VII sec. a.C., deposti nel sa-cello A. Assai più numerosi, invece, gli oggetti di ornamento in ambra, osso, avo-rio e metallo, appartenenti a tipologie ben note nei santuari greci. Numerosi era-no i vaghi di collana: quelli in osso e avorio, di forma globulare, cilindrica o ovoi-de, erano solitamente dotati di collarino (Fig. 2, a, c); altri, di forma amigdaloi-de, presentavano una superficie striata (Fig. 2, d). Oltre ad essere utilizzati comeelementi di collana, alcuni di essi decoravano l’ardiglione delle fibule (Fig. 2, b)o fungevano, quando erano forati soltanto ad un’estremità, da fermi di fibula. Unpendente eburneo in forma di volatile, dedicato nel sacello A, è l’unico vago zoo-morfo pertinente a questa fase; esso è stato ricondotto al gusto levantino, masembra appartenere allo stesso ambiente produttivo di altri oggetti trovati a Po-lizzello, come potrebbe suggerire la resa dell’occhio mediante l’impressione di uncerchiello11 (Fig. 2, e). Allo stesso ambiente è stato riportato anche un vago tri-lobato in pasta vitrea con inserzioni in bianco (Fig. 3, a), rinvenuto nell’area delsacello B; pur avendo origini fenicie, esso fa parte di una classe ampiamente dif-fusa in Grecia, in particolare a Rodi12, e prodotta anche nelle botteghe greche13.
160
Katia Perna
7 Perna 2009, pp. 189-233.8 Tanasi 2009, pp. 9-33.9 Tanasi 2009, pp. 45-46.10 Perna 2012, pp. 633-634, fig. 3e. La ceramica di tipo greco rinvenuta sull’acropoli di Po-
lizzello è stata già presentata in via preliminare (Perna 2012) ed è, allo stato attuale, in corso distudio da parte della sottoscritta, insieme con gli oggetti di ornamento personale.
11 Per il confronto con il mondo levantino si veda Palermo-Tanasi 2005, pp. 95-96. La stes-sa decorazione compare, per esempio, su due testine in avorio e su un pendente pitecoide, per-tinenti alla fase successiva, di cui si tratterà più avanti.
12 Si vedano, per esempio, i tanti esemplari presenti nella stipe del tempio di Athena, a Lin-dos (Blinkenberg 1931, p. 94, tav. 10) e in quello di Athena a Jalysos (Martelli 1988, p. 110). ARodi, piuttosto che all’area euboica, secondo la Martelli, si dovrebbe guardare per leggere lamappa di distribuzione di alcuni orientalia, come questi, nel Mediterraneo (Martelli 1991, pp.1050-1053). A proposito della presenza di oggetti di importazione orientale in Sicilia si vedaGuzzardi 1991.
13 Un vago di questo tipo è stato rinvenuto all’interno di una struttura di mattoni interpre-tata come forno ad Eretria (Touchais - Huber - Philippe-Touchais 2001, p. 973, fig. 193).
Ad un tipo di origine egizia, altrettanto diffuso in Grecia e in Magna Grecia, apartire dal VII sec.14, appartiene un anello con castone inciso (Fig. 3, d), rinve-nuto nel sacello D, il cui motivo è, purtroppo, scarsamente leggibile.Tra i vaghi, quelli in ambra costituivano il gruppo più cospicuo; essi erano
spesso associati a vaghi in pasta vitrea. Tra questi ultimi spicca un vago discoi-dale di colore azzurro-verde15 (Fig. 3, b), mentre tra le ambre un pendente (Fig.3, c) rinvenuto nel sacello D, appartiene a un tipo facilmente riconoscibile, co-sì come accade per molti vaghi in osso e avorio, nelle elaborate collane indossa-te dalle figure di divinità femminile rappresentate nella coroplastica16. Data lararità di questo materiale tanto in Grecia quanto in Sicilia17, l’elevato numero diambre, diverse centinaia, a Polizzello, appare sorprendente e induce a guardareoltre le più vicine colonie greche per individuare il canale di accesso del centrosicano a materiali di questo tipo, assai più diffusi nell’Italia centro-meridionale.La deposizione di questa grande quantità di oggetti allogeni nel santuario di
Polizzello testimonia non solo l’esistenza di una forte interazione commerciale e/opolitica con le genti elleniche, ma anche un cambiamento radicale nell’azione ri-tuale, ora non più incentrata esclusivamente sul “sacrificio del pasto”, ma declina-ta in più edifici e in diversi modi e sostanziata da una partecipazione al rito che, aldi là dei momenti collettivi, trovava nella dedica, verosimilmente personale, di og-getti pregiati un nuovo canale di contatto con la divinità. Azioni di questo tipo rac-contano da un lato l’esistenza di una nuova rete di relazioni, che favorirono unalenta e graduale penetrazione dell’elemento greco nel cuore della Sicania; dall’al-tro, un incremento della ricchezza e l’emergere di alcuni gruppi all’interno del cor-po sociale, ma anche un’accresciuta importanza della sfera del sacro nella defini-zione dei rapporti e dei ruoli sociali, ulteriormente sottolineata dall’esigua presen-za, quando non dall’assenza, di materiali importati nelle tombe18.
161
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon: quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello
14 Sull’origine e lo sviluppo del tipo si vedano: Boardman in Tocra I, p. 158; Boardman 1967.Anelli di questo tipo sono stati trovati a Perachora (Perachora I, p. 179 tav. 79, nn. 34, 37); nel-l’Heraion di Argo (Waldstein 1905, p. 250, tav. 89), ad Egina (Aegina, tav. 116, n. 47); a Olinto(Robinson 1941, pp. 149-150, tav. xxvii, n. 475); a Tocra (Tocra I, tav. 104, n. 23); nella necropo-li di Taranto (Lo Porto 1959-1960, complesso n. 65, fig. 110c); nel Santuario del Timpone dellaMotta a Francavilla Marittima (Papadopoulos 2003, p. 74, n. 195).
15 Il vago, proveniente dall’area del sacello B, trova preciso confronto con alcuni esemplaririnvenuti nell’Artemision di Efeso (Hogart 1908, p. 208, tav. XLV, nn. 28 e 36) e nell’Heraion diPerachora (Perachora II, p. 519, tav. 194, G12-13).
16 Si veda, per esempio l’elemento centrale della collana indossata da una divinità in tronoda Monte Bubbonia (Panvini 1998, p. 254, VI.48).
17 L’analisi delle ambre rinvenute a Polizzello, attualmente in corso, potrà contribuire a ri-costruire il flusso commerciale nel quale erano inserite.
18 Gli oggetti “esotici” provenienti dalle tombe sono, infatti, pochissimi: una coppa ionicadalla tomba 5; una coppa ionica dalla tomba 2, strato 1; due coppe ioniche dalla tomba 25, stra-ti 2-3; un vago in osso dalla tomba 25, strato 4-5; otto scarabei di tipo egizio e due placchette inosso dalla tomba 25, strato 5 (De Miro 1988, pp. 35-41, tavv. 13-16; 1991, pp. 609-616; Panvini2003, pp. 210-234).
È nella sfera conservativa del sacro, infatti, che si concretizzò nei decennisuccessivi un rapporto sempre più intenso tra indigeni e Greci. All’inizio del VIsec. l’area sacra fu ulteriormente ristrutturata: l’edificio A fu dismesso, per effet-to della ricostruzione del sacello B, che vi si addossò strutturalmente19; nell’areasud-occidentale, il sacello D fu monumentalizzato attraverso la giustapposizio-ne di un vano rettangolare, similmente a quanto avveniva nello stesso periodo aSabucina20. Nel corso di questa fase, anche al sacello B fu annesso un vano, madi fattura assai diversa, a “forcipe”, una forma architettonica vetusta, attestata,per esempio, a Mokarta nella tarda Età del Bronzo21. Infine, sul sacello C fu in-
162
Katia Perna
Fig. 1. Polizzello. Pianta del santuario
19 Tanasi 2009, pp. 36-103, 116.20 Mollo Mezzena 1993, p. 143, con bibliografia precedente.21 Per il significato di una tale scelta architettonica si veda Palermo 2009, p. 300.
163
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon: quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello
Fig. 2. Polizzello. Oggetti in osso e avorio dal sacello A. Seconda metà del VII sec. a.C.
Fig. 3. Polizzello. Oggetti in pasta vitrea, ambra e bronzo dai sacelli B (a-b) e D (c-d). Secondametà del VII sec. a.C.
stallata una struttura rettangolare, l’edificio G, articolata in più vani22.Alla varietà architettonica corrispose anche una differenziazione sul piano
delle offerte votive, a testimonianza di una specializzazione delle attività di cul-to che sembra diretta conseguenza di una maggiore complessità sociale e di unpiù articolato rapporto con la cultura greca.Nel sacello D, accanto alla comparsa del modulo rettangolare, il mutamen-
to fu essenzialmente rappresentato dalla deposizione di alcuni oggetti partico-larmente preziosi e dalla maggiore presenza, accanto a vasi indigeni di formachiusa, oinochoai soprattutto, di coppe, alcune deposte in posizione capovolta.Quasi assente la ceramica greca, rappresentata esclusivamente da una kylix tar-do-corinzia, deposta nel corpo principale del sacello. Tra gli oggetti di orna-mento, invece, comparvero in questa fase una fibula d’argento23, che nello stes-so materiale riproduce i fermi e i vaghi, alcuni anelli digitali in bronzo, elemen-ti di rivestimento di fibula in osso (Fig. 4, a), del tipo attestato nei santuari gre-ci24, numerosi vaghi di collana in ambra, osso e pasta vitrea, fermi di fibula(Fig. 4, d-e) e un vago zoomorfo (Fig. 4, f). Due lamine in bronzo lavorate asbalzo (Fig. 4, b), deposte sulla banchina interna al sacello, potrebbero esserepertinenti, per dimensioni e forma, a un diadema25. Dello stesso contesto de-posizionale faceva parte anche un intarsio in avorio e ambra (Fig. 4, c), che ri-chiama esemplari provenienti dall’Artemision di Efeso26 e che era probabil-mente parte di uno scrigno ligneo.Nel vano rettangolare, altre deposizioni: elementi di rivestimento e dischi
di fibula (Fig. 5, a, c), vaghi in ambra e in osso e distanziatori per collana(Fig. 5, b), tutti oggetti ampiamente attestati nel mondo greco27. Tra questi
164
Katia Perna
22 Perna 2009, pp. 179-188.23 La fibula, pubblicata in De Miro 1988, p. 33, tav. XII, 4, è illustrata anche in Guzzone
2006, p. 277, n. 110.24 Si vedano, per esempio, gli esemplari di Perachora (Perachora II, pp. 439-441, tav. 187, A
239-264), Sparta (Dawkins 1929, p. 198, tav. 82, a-k), Argo (Waldstein 1905, p. 353, tav. 140);Francavilla Marittima (Stoop 1974-1976, p. 148, tavv. 69, 2a, e 70, 8).
25 La lamina assomiglia dal punto di vista tecnico a quelle rinvenute in diversi centri indige-ni (per esempio, Colle Madore e Terravecchia), ma le dimensioni non consentono di equiparar-la a queste da un punto di vista funzionale. Più pertinente il confronto con un esemplare daMontagna dei Cavalli (Vassallo 1993, p. 132, n. 173), interpretato, con qualche dubbio, come undiadema, e con quelli provenienti dai santuari greci di Perachora (Perachora I, p. 181, tav. 81, 2-4), Sparta (Dawkins 1929, p. 199, tav. 85, n, x, p.) e Argo (Waldstein 1905, pp. 266-267, tav. 99).
26 Hogarth 1908, pp. 195-196, tav. 40.27 Degli elementi di rivestimento di fibula si è detto sopra; per i distanziatori di collana si ve-
da: Palermo 1981, p. 141, n. 311 con bibliografia. Esemplari di dischi singoli applicabili a fibu-le provengono da Sparta (Dawkins 1929, pp. 226-227, tav. 136, 1); Perachora (Perachora II, p.437, tavv. 185-186); Itaca (Robertson 1948, p. 116, tav. 47, c17-18); Siracusa (Orsi 1918, coll.590-593, 182-183) e Selinunte (Gabrici 1927, coll. 361-363, fig. 155d). Alcuni siti siciliani - Sira-cusa (Orsi 1918, coll. 499, 591, figg. 90, 181), Imera (Himera I, p. 89, tav. 33, 4) e Monte Poliz-zo (Tusa 2005, p. 543, fig. 16) - hanno restituito dischi simili, ma facenti parte di un tipo più ela-borato, quello della spectacle fibula.
anche alcuni pendenti zoomorfi in avorio, uno in forma di scimmia (Fig. 5,d) e uno in forma di animale accovacciato (Fig. 5, e), probabilmente un arie-te; quest’ultimo era stato adagiato sopra il frammento di un vaso di produ-zione indigena, assai più antico28. Pendenti in forma di ariete accovacciatosono attestati in diversi contesti votivi di area greca e siceliota29; il tipo pite-coide, che riprende iconografie assai più antiche30, è noto da diversi conte-sti greci sia votivi sia funerari31. Nello stesso periodo, nell’edificio rettangolare sopra il sacello C furono de-
dicati oggetti simili. Tra questi, un’ansa in avorio (Fig. 5, f) decorata con cer-chielli impressi e dotata di fori per il fissaggio, richiama alcuni oggetti rinvenu-ti a Perachora ed Efeso e variamente interpretati32.Assai più articolata la serie di offerte nel sacello B, dove 17 deposizioni si
snodavano intorno ad un piccolo altare sul quale era posta la statuina fittile diun guerriero itifallico. Le più rilevanti erano rappresentate da una panoplia -comprendente un elmo di tipo cretese, due delfini bronzei, che costituivanol’episema di uno scudo, e diverse lance- e da un cospicuo numero di vasi gre-ci. Essi appartenevano a forme tipiche del set simposiaco o atte a libare ed era-no deposti secondo un preciso schema: accanto all’altare c’erano due crateri acolonnette corinzi, posti accanto a due crateri indigeni che ne imitavano la for-ma e la decorazione; davanti all’altare, una settantina di coppe greche e indige-ne erano state deposte, le une sopra le altre, in posizione capovolta; nell’ordi-ne, kylikes tardo-corinzie con fregi animalistici coprivano uno strato di coppeioniche dei tipi B1, A2, B2 e B3, a loro volta deposte sopra uno strato di cop-pe di produzione indigena. Phialai mesomphaloi33 e paterette e oinochoai indi-gene, poste a breve distanza, completavano la serie. Alcune coppe indigene
165
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon: quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello
28 L’uso di un vaso antico in un livello deposizionale contemporaneo a quello del sacello Dè attestato nel sacello B: Tanasi 2009, p. 45.
29 Pendenti in forma di ariete accovacciato sono stati rinvenuti, per esempio, a Sparta (Daw-kins 1929, pp. 230-234, tavv. 148-149), Perachora (Perachora II, pp. 407-410, tav. 174), Itaca (Ro-bertson 1948, p. 115, tav. 48, c6-7) ed Efeso (Hogarth 1908, pp. 163-164, tav. 26, 1). Altri esem-plari provengono dal santuario di Francavilla Marittima (Stoop 1974-1976, p. 145, tav. 69, 1).Un ariete accovacciato, di fattura assai diversa rispetto a quelli rinvenuti a Polizzello, provienedal sito di Montagnola di Marineo (Spatafora 2000, p. 908, tav. 173, 2).
30 Si veda per esempio l’esemplare rinvenuto nella Tomba di Isopata a Cnosso (Evans 1906,p. 152, fig. 131:a).
31 Pendenti eburnei in forma di scimmia sono attestati ad Efeso (Hogarth 1908, p. 181, tav.30, 8), a Itaca (Robertson 1948, p. 115, tav. 48, c1), a Pitecussa (Buchner-Ridgway 1993, p. 565,n. 571, tavv. 168, 176), ma anche in area etrusca (Mastrocinque 1991, p. 70, figg. 15-16), dove ilmateriale utilizzato è, tuttavia, prevalentemente l’ambra. L’esemplare più simile al nostro è quel-lo proveniente dall’Artemision di Sparta (Dawkins 1929, p. 240, tav. 169, 3)
32 L’esemplare trovato nell’Heraion di Perachora è stato interpretato come manico di unacithara (Perachora II, p. 445, tav. 188); quelli di Efeso, come anse di pugnali (Hogarth 1908, p.195, tav. 39, 1-5)
33 Perna 2012, pp. 631-635.
166
Katia Perna
Fig. 4. Polizzello. Oggetti in ambra, osso, avorio e bronzo dal sacello D. Prima metà del VI sec.a.C.
Fig. 5. Polizzello. Oggetti in osso e avorio dal vano rettangolare del sacello D (a-e) e dall’edifi-cio G (f). Prima metà del VI sec. a.C.
contenevano al loro interno, in forma miniaturizzata, i simboli tipici della reli-giosità sicana, quali la capanna o i bovini.Per quanto non numerosi come nel sacello D, anche nel sacello B rientra-
vano tra le offerte diversi oggetti in osso, avorio e ambra, alcuni dei quali ricon-ducono ancora una volta ai contesti santuariali greci. È il caso, per esempio, dioggetti in osso, oblunghi, appuntiti a un’estremità e appiattiti in quella oppo-sta (Fig. 6, a); descritti in genere come stili, sulla base dei confronti con le raf-figurazioni vascolari, essi sono stati interpretati anche come spilloni o spatoleper cosmetici34. Un oggetto simile faceva parte del carico trasportato dalla na-ve di età arcaica affondata davanti alle coste di Gela35. Un pendente in osso diforma trapezoidale (Fig. 6, b), rinvenuto nel piazzale a Sud del sacello B36, ri-chiama, invece, un esemplare deposto nel tempio di Artemis Orthia a Sparta,la cui interpretazione è incerta37.Non trovano invece confronto, a mia conoscenza, due oggetti composti da
un’anima in ferro rivestita da elementi in avorio, che sulla parte superiore so-no intagliati a rappresentare due volti femminili (Fig. 6, c). La resa dei dettaglidel volto richiama i pendenti zoomorfi precedentemente descritti, con gli oc-chi resi mediante cerchielli con puntino centrale, caratteristica che Dario Pa-lermo riconduce a una probabile produzione indigena38. Una coppia di testefemminili, di dimensioni simili a queste, ma molto diverse dal punto di visto ti-pologico, provengono dall’Artemision di Efeso39. Volti umani erano intagliati, insieme con uno animale, anche su un oggetto
in ambra, trovato nel piazzale a Sud del sacello B (Fig. 6, d). Anche in questocaso, l’oggetto richiama contesti extra-isolani. Oggetti di ambra intagliata, at-testati in Grecia, sebbene raramente, erano assai diffusi nell’Italia centro-meri-dionale, dove le officine artigiane sembra avessero grande esperienza nella la-vorazione di questo materiale40. Nonostante le evidenti differenze tra il sacello B e il sacello D, due oggetti
li mettono in rapporto. Anche nel sacello B, infatti, era deposto un oggetto li-gneo di cui rimane l’intarsio in avorio e ambra (Fig. 7). Rispetto al precedente,questo è di fattura assai più pregiata e richiama immediatamente gli intarsi do-cumentati sulle gambe di klinai e troni41; non sono stati rinvenuti, tuttavia, in
167
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon: quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello
34 Per l’interpretazione e la distribuzione del tipo in Grecia: Perachora II, pp. 445-446, tav. 189. 35 Panvini 2001, p. 62, con bibliografia precedente. Stili, differenti da quelli rinvenuti a Po-
lizzello, sono attestati anche nell’Athenaion di Siracusa (Orsi 1918, col. 604, fig. 200).36 Tanasi 2009, pp. 93-103.37 Dawkins 1929, p. 241, tav. 171, 1a-c.38 Palermo-Tanasi 2005, p. 99.39 Le testine sono illustrate in Mastrocinque 1991, tav. 2.2.40 Sulla diffusione, sulla produzione e sul commercio dell’ambra in età arcaica si veda Ma-
strocinque 1991, pp. 65-88.41 Il confronto con gli elementi decorativi realizzati su klinai e troni e testimoniati, oltre che
sul piano iconografico, anche dal rinvenimento di alcuni esemplari in contesti funerari, era stato
un contesto che sembra non aver subito alcuna manipolazione, elementi perti-nenti alla decorazione dell’altra gamba e della faccia orizzontale di mobili delgenere, né chiodi per fissare gli intarsi su una superficie verticale o fori per illoro alloggiamento sulle lastrine. Un intarsio simile, conservato assai peggio diquello rinvenuto a Polizzello, è stato trovato nel “thesauros” sottostante all’edi-ficio quadrato nell’Heraion del Sele, databile tra il VI e il V sec. a.C.42. La Zan-cani Montuoro ne ipotizza la produzione occidentale43 e lo attribuisce a un og-getto di dimensioni contenute, quale una cassetta, escludendone la pertinenzaa mobili di dimensioni maggiori. La cassetta lignea, che si presta bene a conte-nere oggetti d’ornamento, era spesso associata alle nozze44. La presenza di cas-sette intarsiate nei sacelli B e D di Polizzello, dunque, data l’alta concentrazio-ne di oggetti legati alla sfera femminile, non sorprenderebbe. Alla stessa sfera, peraltro, potrebbe riportare la presenza, nei due sacelli, di
un altro oggetto attestato nel “thesauros” dell’Heraion del Sele: la cosiddetta“chiave di tempio”. A questa categoria sono, infatti, ascrivibili due oggetti in ferro (Fig. 8), a se-
zione quadrata e piegati ad angolo retto, noti appunto, già nella letteratura an-tiquaria, come “chiavi di tempio”, perché rappresentati in alcune pitture vasco-lari nelle mani di sacerdotesse della dea Atena e della dea Artemide, alla qualeuna chiave proveniente dal santuario di Lusoi è esplicitamente dedicata45. Del-le sacerdotesse le chiavi erano, anzi, elemento distintivo46. Che si tratti di chia-vi funzionali è dimostrato, ancora una volta, dalla pittura vascolare47 e dal lo-ro ritrovamento in corrispondenza degli stipiti di alcuni edifici sacri48, ma la lo-ro dedica, spesso in numero cospicuo, in contesti votivi di divinità chiaramen-te connesse con la sfera delle nozze e del parto49 ne ha da tempo acclarato an-
168
Katia Perna
già proposto dalla sottoscritta in occasione della Giornata di Studio “Aspetti della religiosità edei culti della Sikania nel quadro del Mediterraneo” (Mussomeli, 28 settembre 2007). Recente-mente, in favore dell’identificazione dell’esemplare rinvenuto a Polizzello con un elemento dikline si è espresso A. Naso (Naso 2007, pp. 26-28) che, a supporto della sua tesi ricorda la pre-senza tra le offerte deposte nel sacello di una figura umana distesa su un lettuccio (De Miro1988, p. 33, tav. 10, 5).
42 Zancani Montuoro 1965-1966, pp. 164-165, tav. XLVI b-c.43 A proposito del ruolo giocato dalle officine italiche nella produzione di intarsi in ambra
e avorio e degli impulsi ricevuti dalle officine greco-orientali si veda Naso 2007, pp. 30-32.44 Cassette e scrigni sono una presenza costante nelle scene nuziali: Lissarague 1995, pp. 98-100.45 Si vedano, per esempio, le voci “Sera”, pp. 1241-1248, e “Sacerdos”, pp. 939-940, in Da-
remberg-Saglio 1918.46 Per le raffigurazioni, su vasi e rilievi, del tipo della kleidouchos: Connelly 2007, pp. 92-104.47 Si veda un’hydria di Berlino, in Beazley 1956, n. 1083, 4.48 Così per esempio nel tempio arcaico di Campora S. Giovanni, in territorio di Temesa (La
Torre 2002, p. 304).49 Per una sintesi dei significati simbolici rivestiti dalle chiavi di tempio e per un elenco dei
principali luoghi di rinvenimento delle stesse, tra i quali i santuari di Olimpia e Argo, si vedano:Zancani Montuoro 1965-1966, pp. 152-158; La Torre 2002, pp. 303-304.
che la funzione votiva, confermata, anche in età più tarda, dalla notizia ripor-tata da P. Festo a proposito della dedica di chiavi da parte delle donne, in se-gno di ringraziamento alla dea per aver accordato loro un parto felice50. Assenti in Sicilia, chiavi di tempio sono attestate anche in santuari indigeni
della Magna Grecia e in alcune tombe femminili enotrie51.
Gli interrogativi che il crescente affluire, tra VII e VI sec., di oggetti dei Gre-ci a Polizzello pone sono tanti. Il più immediato riguarda certamente il luogo diprovenienza degli oggetti, la colonia o le colonie, insomma, con cui Polizzelloebbe un rapporto così intenso. In Sicilia, questi oggetti sono presenti solo nel-l’area siracusana, dove gli esemplari sono tuttavia di una qualità assai maggiorerispetto a quelli di Polizzello, e nella cuspide nord-occidentale. Quasi assenti in-vece a Gela, che pure fu certamente uno degli scali della rotta meridionale se-guita dalle navi greche e levantine. Le analisi dei materiali, ceramici e non, con-sentiranno di chiarire meglio questo aspetto e di capire se, come sembra, alcu-ni oggetti possano essere ricondotti a una produzione indigena. Per il momen-to, è all’area imerese che diversi elementi hanno portato in questi anni a guar-dare52, anche se la complessità del santuario di Polizzello costringe a tenere inconsiderazione la possibile esistenza di relazioni più ampie, che possano rende-re ragione dell’interessante concentrazione, nel centro indigeno, di offerte simi-li quelle dei principali santuari della Grecia e della Magna Grecia.Il secondo interrogativo riguarda il valore votivo degli oggetti e porta con
sé la ricerca di una definizione della divinità, degli offerenti, del loro genere,
169
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon: quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello
Fig. 6. Polizzello. Oggetti in osso, avorio e ambra dal sacello B (a, c) e dal piazzale a Sud di esso(b, d). Prima metà del VI sec. a.C.
50 Lindsay 1913, pp. 39-56.51 Sul rapporto tra la dedica delle chiavi nei templi della Magna Grecia e la frequenza degli
stessi da parte di donne indigene si veda Barbanera 2005, pp. 366-367, 375.52 Palermo 2008, pp. 264, 267.
del loro status, della loro organizzazione sociale. La complessa architettura delsacro espressa a Polizzello rispecchia, infatti, una società in cui la gestione del-le attività religiose divenne centrale e fu profondamente influenzata dall’incon-tro con le popolazioni elleniche. Dei diversi esiti prodotti da tale incontro i sacelli B e D sono in qualche mo-
do paradigmatici. Nel sacello D, sin dal suo impianto, le attività di culto si ca-ratterizzarono come essenzialmente connesse al mondo femminile e basate sul-la dedica di oggetti di ornamento personale: collane, bracciali, anelli e spille.Nel VI secolo le offerte si fecero più preziose, ma erano ancora tutte ricondu-cibili alla sfera muliebre, in qualche caso (si pensi appunto alla cassetta ligneae alla chiave) più specificamente riferibili alla sfera delle nozze e del parto53.
170
Katia Perna
53 Sulla caratterizzazione femminile del culto nella regione sicana, si veda Palermo c.d.s., do-ve si propone anche l’identificazione delle due testine femminili eburnee rinvenute nel sacello Bcon tali divinità.
Fig. 7. Polizzello. Intarsio in avorio e ambra dal sacello B. Prima metà del VI sec. a.C.
Fig. 8. Polizzello. Chiave di tempio dal sacello B. Prima metà del VI sec. a.C.
La qualità e le modalità dell’offerta erano quelle tipiche dei santuari dedi-cati alle divinità femminili dei Greci, le stesse in onore delle quali i coloni eri-gevano santuari nelle zone di “confine” con il mondo indigeno, affidando loroil compito legittimante di segnalare la presenza greca sul territorio.Più complessa la natura del culto nell’edificio B, dove diversi aspetti sem-
brano coesistere, ma dove comparvero elementi di netta discontinuità rispettoal passato e agli altri edifici dell’acropoli. Primo tra tutti, il riferimento esplici-to all’elemento maschile, ampiamente rappresentato sul piano dell’offerta (fi-gurine di uomini offerenti in bronzo provengono da quest’area) e fortementeaccentuato dalla presenza della panoplia e del guerriero itifallico; in secondoluogo, l’adozione di una pratica, quella legata all’uso dei vasi tipici del simpo-sio, che, sebbene non possiamo leggerne le peculiarità locali54, rappresenta unagrande novità e il segno di un nuovo e più intenso rapporto tra Greci e indige-ni; in terzo luogo, la presenza di oggetti come le testine femminili in avorio, lacassetta intarsiata e le chiavi di tempio, che sembrano riproporre, in un conte-sto rituale differente, alcune pratiche connesse all’universo femminile e attesta-te nel sacello D. La presenza di offerte tanto ricche legate alla sfera militare e l’adozione di
pratiche allogene, come quella legata alla consumazione di bevande, indicanoche il sacello B era il luogo deputato per celebrazioni dal carattere probabil-mente elitario che coinvolgevano gruppi diversi, per genere o per status, daquelli che frequentavano il sacello D, e che probabilmente traevano il loro po-tere proprio dalla gestione dei rapporti con le popolazioni elleniche. Nel mondo greco arcaico, la sfera militare non era esclusa dalle competen-
ze delle divinità femminili che proteggevano e accompagnavano le diverse fasidella vita delle donne; la coesistenza di aspetti maschili e femminili nel sacelloB, tuttavia, riporta più suggestivamente all’ipotesi dell’innesto di un culto eroi-co55 in un sacello dedicato a una o più divinità femminili, ipotesi che potreb-be trovare un’eco, come Dario Palermo ha più volte sottolineato, nella testimo-nianza plutarchea della deposizione dell’elmo del cretese Merione e delle lan-ce di Odisseo nel tempio delle Matéres, le dee venerate dai Sicani ad Engyon.
È evidente che, quale che fu la natura dei rapporti che legarono i Sicani diPolizzello con i nuovi coloni, l’arrivo dei Greci rappresentò per il centro, co-me per tutto il mondo sicano, lo spartiacque tra due dimensioni: quella conser-vativa, un po’ marginale e profondamente ancorata a solide tradizioni cultura-li, e quella ricettiva che proiettò i centri indigeni nello scenario mediterraneo,
171
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon: quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello
54 Per quanto il rito simposiaco sia ipotizzabile, ci sfugge la conoscenza della bevanda con-tenuta nei crateri, che non necessariamente doveva essere vino, la cui natura è fondamentale percomprendere il genere di attori coinvolti nelle celebrazioni, che non devono essere pensati co-me esclusivamente uomini (Ismaelli 2011, pp. 217-218, con bibliografia).
55 Palermo 2009, pp. 309-310.
in una fase di grande trasformazione politica. Di questa fase Polizzello fu unimportante attore e intessé con il mondo greco una serie di relazioni che ne de-terminarono l’incredibile crescita economica e ne definirono lo status all’inter-no della regione sicana.Gli esiti di questo processo furono molteplici e non possono essere liquida-
ti tout court come fenomeni di acculturazione. A Polizzello, infatti, il rapportotra tradizione indigena e cultura greca fu dialettico, come dimostra non solo lascelta di architetture tradizionali, comune a tanti siti, ma anche la reiterazionee la reinvenzione di simboli tipici della realtà sicana, contemporanea all’adozio-ne di nuove pratiche, e la consapevolezza con cui oggetti tradizionali e alloge-ni furono deposti nei sacelli. Più che di acculturazione, pur senza negare il fascino esercitato dalla cultu-
ra greca sulla popolazione sicana, si potrebbe parlare di un processo osmotico,favorito probabilmente proprio dalla scelta di un santuario come luogo di in-terazione politica e sociale. Lì fu possibile, forse, il sincretismo tra le divinitàfemminili greche e quelle sicane, anch’esse, secondo le fonti, femminili56. E lìl’accresciuta intensità dei rapporti con il mondo greco si tradusse, come DarioPalermo ha ipotizzato, nell’adozione di un comune progenitore, Odisseo, alquale, nel sacello B, oscillando tra tradizione e innovazione, sarebbe stato tri-butato un culto.Fu questo, tuttavia, l’ultimo atto di “pacifico” rapporto tra i Greci e gli in-
digeni di Polizzello, che cadde sotto i colpi della spregiudicata politica espan-sionistica delle stesse genti che ne avevano determinato la forte ascesa. Quan-do l’area del santuario fu rioccupata, il centro era ormai profondamente elle-nizzato.Con i Greci, i Sicani fecero forse comuni libagioni, dei loro gioielli omag-
giarono le loro divinità, ma dalla loro potenza militare furono annichiliti. E for-se, ancora una volta, fu Odisseo, l’eroe viaggiatore, ad assistere alla distruzionedi chi dei Greci aveva accolto i doni.
172
Katia Perna
56 Parisi Presicce 1985, p. 73; Albanese Procelli 2003, pp. 215-216; Palermo c.d.s.
BIBLIOGRAFIA
Aegina= E.R. Fiechter- H. Thiersch - A. Furtwangler (a cura di), Aegina. DasHeiligtum der Aphaia, Munchen 1906.
Albanese Procelli 2003= R.M. Albanese Procelli, Sicani, Siculi, Elimi. Forme diidentità, modi di contatto e processi di trasformazione, Milano 2003.
Barbanera 2006= M. Barbanera, Altre presenze. “Stranieri” nei luoghi di cultoin Magna Grecia, in A. Naso (a cura di), Stranieri e non cittadini nei santua-ri greci, Atti del convegno internazionale, Firenze 2006, pp. 359-395.
Beazley 1956= L.D. Beazley, Attic Black-Figure Vase Painters, Oxford 1956.Blinkerberg 1931= Chr. Blinkerberg, Lindos. Fouilles de l’acropole 1902-1914.Le Petit objets, Berlin 1931.
Boardman 1967= J. Boardman, Archaic Finger Rings, in AntK 10, 1, 1967, pp.3-31.
Buchner-Ridgway 1993= G. Buchner- D. Ridgway, Pithekoussai I. Le Necropo-li: tombe 1-723, Città di Castello 1993.
Connelly 2007= J.B. Connelly, Portrait of a Priestess. Woman and Ritual in An-cient Greece, Canada 2007.
Daremberg-Saglio 1918= Ch. Daremberg - M.E. Saglio, Dictionnaire des anti-quités greques et romaines, Paris 1918.
Dawkins 1929= R.M. Dawkins, The Sanctuary of Arthemis Orthia at Sparta,London 1929.
De Miro 1988= E. De Miro, Polizzello, centro della Sikania, in QuadMess,1988, pp. 25-42.
De Miro 1991= E. De Miro, Eredità egeo-micenee e alto arcaismo in Sicilia, in LaTransizione dal Miceneo all’Alto Arcaismo. Dal palazzo alla città, Atti del Con-vegno Internazionale (Roma, 14-19 marzo 1988), Roma 1991, pp. 593-617.
Evans 1906= A.J. Evans, The Prehistoric Tombs of Knossos, London 1906.Gabrici 1927= E. Gabrici, Il santuario della Malophoros a Selinunte, in Mo-nAnt 32, coll. 6-420.
Guzzardi 1991= L. Guzzardi, Importazioni dal Vicino Oriente in Sicilia fino al-l’età orientalizzante, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenicie Punici (Roma, 9-14 novembre 1987), vol. III, Roma 1991, pp. 941-954.
Guzzone 2006 = C. Guzzone (a cura di), Sikania. Tesori archeologici della Sici-lia centro-meridionale (secoli XIII-VI a.C.). Catalogo della mostra (Wol-fsburg-Hamburg, ottobre 2005-marzo 2006), Catania 2006. 173
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon: quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello
Himera I= A. Adriani- N. Bonacasa- C.A. Di Stefano- E. Joly- M. T. Manni Pi-raino- G. Schmiedt- A. Tusa Cutroni (a cura di), Himera I. Campagne di sca-vo 1963-1965, Roma 1970.
Hogarth 1908= D.G. Hogart, Excavations at Ephesus. The archaic Artemisia,London 1908.
Ismaelli 2011= T. Ismaelli, Archeologia del culto a Gela. Il santuario del PredioSola, Bari 2011.
La Torre 2002= G. La Torre, Un tempio arcaico nel territorio dell’antica Teme-sa, Città di Castello 2002.
Lissarague 1995= F. Lissarague, Women, Boxes, Containers: Some Signs andMetaphors, in E.D. Reeder (a cura di), Pandora. Women in Classical Greece,Princeton 1995, pp. 91-101.
Lindsay 1913 = W.M. Lindsay ed., Sexti Pompei Festi. De verborum significatuquae supersunt cum Pauli epitome, Leipzig 1913.
Lo Porto 1959-1960= F.G. Lo Porto, Ceramica arcaica dalla Necropoli di Taran-to, in ASAtene 37-38, 1959-1960, pp. 7-230.
Martelli 1988= M. Martelli, La stipe votiva dell’Athenaion di Jalysos: un primobilancio, in S. Dietz - I. Papachristodoulou (a cura di), Archaeology in theDodecanese, Copenaghen 1988, pp. 104-120.
Martelli 1991= M. Martelli, I Fenici e la questione orientalizzante in Italia, inAtti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Roma, 9-14novembre 1987), vol. III, Roma 1991, pp. 1049-1072.
Mastrocinque 1991= A. Mastrocinque, L’ambra e l’Eridano, Este 1991.Mollo Mezzena 1993= R. Mollo Mezzena, Sabucina, recenti scavi nell’area forile mura. Risultati e problematiche, in Storia e Archeologia della Media e Bas-sa Valle dell’Himera, Atti del convegno- III giornata di studi sull’archeolo-gia licatese, I convegno sull’archeologia nissena (Licata, 30 maggio 1987),Palermo 1993, pp. 137-181.
Naso 2007= A. Naso, Klinai lignee intarsiate dalla Ionia all’Europa centrale, inRM 113, 2007, pp. 9-34.
Orsi 1918= P. Orsi, Gli scavi intorno all’Athenaion di Siracusa, in MonAnt 25,1918, coll. 353-754.
Palermo 1981= D. Palermo, Polizzello, in Contributi alla conoscenza dell’Etàdel Ferro in Sicilia. Monte Finocchito e Polizzello, CronA 20, Palermo 1981,pp. 103-147.
Palermo 2008= D. Palermo, Doni votivi e aspetti del culto nel santuario indige-no della Montagna di Polizzello, in G. Greco - C. Gasparri (a cura di), Do-ni agli dei. Il sistema dei doni votivi nei santuari, Atti del Seminario di Stu-di (Napoli, 21 aprile 2006), Quaderni del Centro Studi Magna Grecia, 6,Pozzuoli 2008.
Palermo 2009= D. Palermo, L’acropoli di Polizzello fra l’Età del Bronzo e il VIsecolo a.C.: problemi e prospettive, in Panvini-Guzzone-Palermo 2009, pp.297-313.174
Katia Perna
Palermo c.d.s= D. Palermo, Prima di Demetra. Divinità femminili della Siciliaindigena, in La donna e il sacro. Dee, maghe, sacerdotesse, sante, Atti delConvegno Internazionale di Studi (Palermo, 12-14 novembre 2009), in cor-so di stampa.
Palermo-Tanasi 2005= D. Palermo - D. Tanasi, Diodoro a Polizzello, in C. Mic-cichè- S. Modeo -L. Santagati (a cura di), Diodoro Siculo e la Sicilia indige-na, Atti del convegno di Studi (Caltanissetta, 21-22 maggio 2005), Caltanis-setta 2006, pp. 89-102.
Panvini 1998= R. Panvini (a cura di), Gela. Il Museo archeologico. Catalogo,Gela 1998.
Panvini 2001= R. Panvini, La nave greca arcaica di Gela, Caltanissetta 2001.Panvini 2003= R. Panvini (a cura di), Caltanissetta. Il Museo archeologico. Ca-talogo, Caltanissetta 2003.
Panvini 2009= R. Panvini, Storia degli studi e della ricerca archeologica a Poliz-zello, in Panvini-Guzzone-Palermo 2009, pp. 5-8.
Panvini-Guzzone-Palermo 2009 = R. Panvini- C. Guzzone - D. Palermo (a cu-ra di), Polizzello. Scavi del 2004 nell’area del santuario arcaico dell’acropoli,Viterbo 2009.
Papadopoulos 2003= J.K. Papadopoulos, La dea di Sibari e il santuario ritrova-to. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima. II.1,the Archaic Votive Metal Objects, BdA, vol. spec., Roma 2003.
Pappalardo 2009= E. Pappalardo, Il settore centrale, in Panvini-Guzzone-Pa-lermo 2009, pp. 123-175.
Parisi Presicce 1985= C. Parisi Presicce, L’importanza di Hera nelle spedizionicoloniali, in ArchCl 37, 1985, pp. 44-83.
Perachora I= Payne H. et alii, Perachora I. The Sanctuary of Hera Achraia andLimenia. Architecture, Bronzes, Terracottas, Oxford 1940.
Perachora II = H. Payne- T.J. Dunbabin, Perachora II. The Sanctuary of HeraAchraia and Limenia. Pottery, Ivories, Scarabs and other objects, Oxford1962.
Perna 2009= K. Perna, Il settore sud-occidentale, in Panvini-Guzzone-Palermo2009, pp. 177-246.
Perna 2012= K. Perna, Ceramiche di tipo greco dall’acropoli di Polizzello, in R.Panvini -L. Sole (a cura di), La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiai al 480 a.C.Atti del Convegno Internazionale (Caltanissetta 27-29 marzo 2008), Calta-nissetta 2012, pp. 629-642.
Robertson 1948= M. Robertson, Excavations in Itaca V: the Geometric and Lat-er Finds from Aetos, in BSA 43, 1948, pp. 1-124.
Robinson 1941= D.M. Robinson, Excavations at Olynthus. Part X. Metal andMinor Miscellaneous Finds. An Original Contribution to Greek Life, Lon-don-Baltimore-Oxford 1941.
Spatafora 2000= F. Spatafora, Indigeni, Punici e Greci in età arcaica e tardo-ar-caica sulla Montagnola di Marineo e nella valle dell’Eleuterio, in Atti delle 175
Polloi, kata, Qa,lassan evpese,pleon: quando merci e idee dei Greci arrivarono a Polizzello
Terze Giornate Internazionali di Studi sull’area elima (Gibellina-Erice-Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997), Pisa-Gibellina 2000, pp. 895-918.
Stoop 1974-1976= M. W. Stoop, Francavilla Marittima. Acropoli sulla Motta, inAtti e Memorie della Società della Magna Grecia, XV-XVII, 1974-1976, pp.141-155.
Tanasi 2009= D. Tanasi, Il settore settentrionale dell’acropoli, in Panvini-Guz-zone-Palermo 2009, pp. 9-121.
Tocra I = J. Boardman- J. Hayes, Excavations at Tocra. The Archaic Deposit I,Oxford 1966.
Touchais - Huber - Philippe Touchais 2001= G. Touchais- S. Huber -A. Phi-lippe Touchais, Chronique des fouilles et découvertes archéologiques enGrèce en 2000, in BCH 125, 2, 2001, pp. 779-1046.
Tusa 2005= S. Tusa, Fenici, Indigeni ed Elimi alla luce delle nuove scoperte, inA. Spanò Giamellaro (a cura di), Atti del V Congresso Internazionale diStudi Fenici e Punici (Marsala-Palermo, 2-8 ottobre 2000), Palermo 2005,pp. 527-549.
Vassallo 1993= S. Vassallo et Al., Montagna dei Cavalli, in AA.VV., Di terra interra. Nuove scoperte archeologiche nella provincia di Palermo, Palermo1993.
Waldstein 1905= C. Waldstein ed., The Argive Haereum, Cambridge 1905.Zancani Montuoro 1965-1966= P. Zancani Montuoro, Chiavi, in ZancaniMontuoro et Al., L’edificio quadrato nello Heraion alla foce del Sele, inAMSGM VI-VII, 1965-1966, pp. 23-195.
176
Katia Perna
Progetto grafico e impaginazioneSplokay di Antonio Talluto
Finito di stampareper conto dell’Editore Salvatore Sciascia
nel mese di maggio 2014





































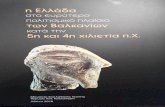

![Monni, S. (2013) “ Oltre il velo di Maya: il ruolo delle idee e delle Istituzioni” [in Italian].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63225731050768990e0fd043/monni-s-2013-oltre-il-velo-di-maya-il-ruolo-delle-idee-e-delle-istituzioni.jpg)




