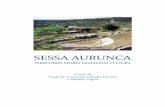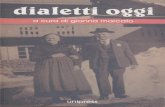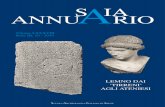Né toscani né romani: per una prima caratterizzazione dei dialetti dell’area viterbese
-
Upload
uniromatre -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Né toscani né romani: per una prima caratterizzazione dei dialetti dell’area viterbese
4 Indice
Prima edizione: maggio 2015
ISBN 978 88 6787 383 8
© 2015 cleup sc“Coop. Libraria Editrice Università di Padova”via G. Belzoni 118/3 – Padova (tel. 049 8753496)www.cleup.itwww.facebook.com/cleup
Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento,totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresele copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.
Impaginazione e grafica di copertina: Patrizia Cecilian
In copertina: fotografia di Tommaso Politi
Comitato di lettura
Giovanni Ruffino (Università di Palermo)Salvatore Trovato (Università di Catania)Antonietta Dettori (Università di Cagliari)Mariselda Tessarolo (Università di Padova)Gianna Marcato (Università di Padova)
7Indice
Indice
presentazione
Dialetto, tra identità strutturali e testualità 13 Gianna Marcato
ambiti del comunicare, scelte di repertorio e dialetto
Colloquialità e dialetto nella Palermo d’oggi 23 Francesco ScaglioneTestualità, storicità della lingua, dialetto: il parlato nell’ambito 35del lavoro in area trevigiana Michele DonàGrado di vitalità della varietà alloglotta di Guardia Piemontese (CS) 43 Irene MicaliIl dialetto fra i giovani del Duemila. Usi, giudizi e dichiarazioni 51 Immacolata TempestaPerché gli adulti si rivolgono ai bambini in italiano? 59 Mariselda Tessarolo - Eleonora BordonDalla Cripta dei Capuleti alla Cesa del Liram. 67Analisi di una lettera d’amore in Piemontese, datata 1609 Tullio TelmonLettere bellunesi del primo Novecento 79 Loredana CorràDialetto in versi: tra funzione poetica e funzione comunicativa 89 Elvira AssenzaDialettalità e romanzo popolare: I Beati Paoli di Luigi Natoli 101 Mariella Giuliano
8 Indice
Il dialetto “a un soldo”. Identità popolare nella letteratura catanese 109di inizio Novecento Daria MottaLa funzione del dialetto nella narrativa di Amara Lakhous 117 Marco GargiuloDialetti e delitti. Scelte stilistiche e aperture dialettali nel poliziesco 125contemporaneo Rosaria SardoSul romanesco del teatro di Giggi Zanazzo (1860-1911) 133 Claudio GiovanardiLo schiavonesco a Venezia: tra parodia e realtà linguistica 141 Alberto GiudiciL’italiano regionalizzato de La grande guerra di Monicelli (1959) 149 Gabriella AlfieriL’italiano fuori di Toscana nei film di Pieraccioni: «mi piaceva 161che si sentissero anche tutti i dialetti d’Italia» Stefania IannizzottoLe Bellas mariposas volano al cinema: analisi linguistica del film 169di Salvatore Mereu Myriam MereuLingua e dialetto nel cinema comico contemporaneo: 177tra Checco Zalone e Ficarra e Picone Milena RomanoVarietà di italiano e varietà di dialetto nel varietà televisivo 185 Giovanna AlfonzettiIl dialetto nelle fiction televisive: un confronto tra la scrittura 195delle sceneggiature e il parlato degli attori Ilaria MingioniMastro-don Gesualdo: dal parlato scritto sdialettalizzato al parlato 203trasmesso iperveristico Elisabetta MantegnaI dialetti urbani tra nuovi usi e nuovi modelli di dialettalità: 211le parodie siciliane di Peppa Pig Giuseppe Paternostro - Roberto SottileDopo Faber. Usi e riusi del dialetto cantato a Genova e in Liguria 223(1984- 2014) Lorenzo Coveri
9Indice
Tra scritto e cantato: le canzoni in occitano dei Lou Dalfin 235 Paolo Benedetto Mas - Silvia GiordanoIl dialetto e i proverbi in area perugina 243 Antonio Batinti - Ornero Fillanti Al post del dialetto. Posizione, funzioni, caratteristiche del dialetto 251trasmesso attraverso il computer e altri media nella Svizzera italiana Matteo Casoni - Giovanna CeccarelliAlias ma non troppo: Roma manifesta nei nicknames di una chatline 267 Andrea VivianiFenomenologia di un fake. Riflessioni sull’uso del dialetto napoletano 275per dare vita in rete a un personaggio di fantasia Vera GhenoBiglietti prego! In viaggio nella realtà dialettale attraverso 285il Repertorio italiano-dialetti (RID) della Svizzera italiana Nicola ArigoniIl Repertorio Italiano-Dialetti (RID): genesi e struttura 293 Dafne GenasciUso e funzioni delle varietà linguistiche nel mondo linguistico arabo. 301Impatto della Rete Sociale Jihad Al-Shuaibi
sistematicità dei dialetti, permeabilità dei confini ed eteronomia
Riflessioni su fenomeni sintattici e fonetici in area campano-lucana 311 Patrizia Del PuenteOsservazioni morfologiche su una parlata lucana 323 Carminella ScarfielloParlare dall’alto: la deissi verticale in Val Germanasca 329 Aline PonsStoria di uno shibboleth in area pedemontana 337 Alberto GhiaNé toscani né romani: per una caratterizzazione dei dialetti 345dell’area viterbese Miriam Di CarloCultismi nel siciliano 353 Salvatore C. TrovatoAspetti dell’interferenza tra italiano e siciliano in epoca medievale 359 Iride Valenti
10 Indice
Il siciliano a contatto con il toscano/italiano. Un’analisi a margine 367del Vocabolario Siciliano Angela CastiglionePercezione dell’italiano regionale 377 Carlotta D’Addario
dialettalità, fonti scritte, trascrizioni e codifiche
La trasmissione scritta di oralità e dialettalità: il caso del latino 387 Elena TriantafillisDi gergo e di paraletteratura: l’importanza delle fonti scritte 399per la documentazione gergale Antonietta DettoriIl sonetto Paduanus del codice Colombino: riflessioni sul nome 407 Maleosse Paola BarbieratoAntroponomastica popolare e geografia linguistica. 415Un incontro possibile Giovanni RuffinoLa toponomastica ufficiale scritta e la toponomastica nella tradizione 421dialettale orale Maria Teresa VigoloLa città “nominata”: odonimi popolari e ufficiali a Salemi 429 Marina Castiglione - Marianna TrovatoUn caso tutto veneziano: il dialetto e la battaglia dei nizioleti 439 Gianna MarcatoLingua romana in scrittura italiana: problemi (orto)grafici 449(e non solo) del romanesco dal parlato allo scritto Paolo D’AchilleDal parlato allo scritto: riflessioni sulla trascrizione dell’oralità 461in area campana Elda De SantisIl vocalismo di Piazza Armerina nel parlato e nello scritto 469 Rita Pina AbbamonteFonologia e grafia del dialetto di San Valentino in Abruzzo citeriore 477 Diana Passino - Diego PescariniRiflessi della codifica del gallego sul parlato 483 Maria Montes
345Né toscani né romani: per una caratterizzazione dei dialetti dell’area viterbese
Né toscani né romani: per una caratterizzazione dei dialetti dell’area viterbese
Miriam Di Carlo
Il mio intervento intende trattare i dialetti della Tuscia, ovvero della provincia di Viterbo, premettendo che la penuria di spazio non permette di poter approfondire la situazione linguistica di detta area, data la sua com-plessità e natura frastagliata. Mio intento è stato quello di considerare un unico tratto, l’anafonesi, fenomeno squisitamente fiorentino, divenuto poi caratteristico dell’italiano standard e gradualmente accolto in vari dialetti non toscani (come il romanesco), e di verificarne la diffusione tra i comuni della provincia viterbese per constatare quali siano state le forze linguisti-che che hanno agito su quest’area, incastonata tra la Toscana, l’Umbria, e le provincie laziali di Rieti e soprattutto di Roma.
La quasi totale assenza di studi scientifici sui dialetti dei comuni del viterbese (Vignuzzi, 1994, 1995, 1997, 2010; Petroselli, 1983, 1986, 1999, 2009; Avolio, 2010; Giannelli - Magnanini - Pacini, 2002; Melillo, 1970, e in diacronia Bianconi, 1962; Palermo, 1997; Sgrilli, 2003) ha reso ancora più complessa la ricerca, di cui si auspica un prosieguo che dia conto delle specificità di questa “zona d’ombra”. Nelle linee fondamentali, la storia e la geografia di questo territorio ne mostrano la peculiarità: il sostrato etrusco non uniforme, alternato a quello falisco per la zona di Civita Castellana; le vie consolari romane1; nel Medioevo, momento florido per Viterbo, la via Francigena2, la sede papale fino al 1281 e i rapporti con i centri umbri di
1 Dipanandosi dalla capitale passando proprio dalla Tuscia, la connettevano con i centri più importanti dell’Italia centrale e settentrionale (l’Aurelia, la Flaminia, la Cassia, la Clodia e l’Amerina)
2 Ovvero il percorso dei pellegrini che dall’Europa settentrionale arrivava a Roma; passava per Siena e nel tratto da Viterbo ricalcava in toto l’antico basolato della via Cassia,
346 Miriam Di Carlo
Orvieto e Perugia (già dal periodo etrusco), così come con quelli toscani di Siena e Arezzo. Dal punto di vista della morfologia del territorio, dato imprescindibile è sicuramente la presenza dei complessi dei monti Cimi-ni e Volsini, sulle cui pendici si arroccano paesi dalla natura molto con-servativa, incrementata dalla fitta copertura boschiva che li circonda (già Tito Livio denunciava l’impraticabilità e oscurità della Silva Cimina3). La scarsa densità di popolazione per alcuni centri (basti pensare al comune di Tessennano con 366 abitanti4), spesso adagiati su speroni di roccia isolati e in atavica inimicizia l’uno contro l’altro, ha reso la situazione ancora più ostica e oscura.
Passando alla caratterizzazione dialettologica dell’area, Vignuzzi (1995: 151-152) ha definito questi dialetti para- o peri- mediani: egli ipotizza una deviazione dell’isoglossa Roma-Ancona che passerebbe per Perugia, lam-birebbe il versante meridionale del Monte Amiata e arriverebbe nella Ma-remma meridionale, frammentando ulteriormente la stessa Tuscia (v. anche Vignuzzi, 2010).
Il fenomeno dell’anafonesi (su cui v. almeno Castellani, 1980 e Rohlfs, 1966) si dimostra particolarmente funzionale per comprendere quanto, in prima istanza Firenze con al seguito tutti i dialetti toscani e poi Roma (il cui dialetto, nella sua prima fase, non prevedeva affatto tale fenomeno), grazie al suo ruolo di catalizzatore dell’esperienza linguistica fiorentina, abbiano agito sull’area, dove l’assenza del tratto è divenuta elemento portatore del concetto di conservatività e rispetto dell’identità dei dialetti della Tuscia. Come è noto, l’anafonesi (o innalzamento condizionato) prevede la chiu-sura di timbri vocalici per influenza del consonantismo seguente. Diversi studi, in particolare quello di Giannelli (1976) sui dialetti toscani, hanno individuato nel fenomeno dell’anafonesi una natura prettamente fiorentina. Che poi esso si sia diffuso a macchia d’olio sul territorio toscano è indub-bio, ma sicuramente ci furono resistenze, soprattutto per quanto riguarda Arezzo e i dialetti confinanti con il Lazio (per lucchese e pistoiese rimando a Giannelli, 1976 e Franceschini, 1991). Come si è accennato, ha accolto il tratto anche il romanesco, dove le ultime forme non anafonetiche risalgono al primo Novecento: il vocabolario di Ravaro (1994) oscilla tra forme ana-fonetiche e non, attestando quanto ancora il Belli preferisse le forme ogna, onto e simili, rigettando la norma fiorentina.
contribuendo così a incrementare quel flusso di persone, merci, lingue e saperi che resero detto territorio vitale ma anche magmatico.
3 Ab urbe condita, IX, 36.4 Dato ISTAT 31-12-2012.
347Né toscani né romani: per una caratterizzazione dei dialetti dell’area viterbese
Per la mia ricerca, condotta, in chiave sincronica, ho fatto tesoro degli atlanti linguistici: i punti AIS (603 Acquapendente; 612 Montefiscone; 630 Tarquinia; 632 Ronciglione; 633 Sant’Oreste5) e i punti ALI (608 Montefia-scone; 607 Cellere; 617 Montalto di Castro; 618 Monteromano; 619 Vetral-la; 620 Viterbo nella frazione di Bagnaia). Altre fonti dalle quali ho attinto sono: vocabolari locali, dai più scientificamente compilati (come quelli di Petroselli) a quelli più amatoriali, glossari, lemmari di ogni genere, raccolte di poesie, racconti e testi teatrali in dialetto, raccolte di motti, modi di dire, blasoni popolari, le interviste di Petroselli (1974-1983). Ho infine condotto io stessa alcune inchieste sul campo, per ottenere una copertura soddisfa-cente per l’intera provincia.
Quali sono le parole ormai entrate nei dialetti della Tuscia nella forma italiana? Anzitutto tinca, miglio e tiglio: essi sono sempre segnalati nei vocabo-lari in virtù del consonantismo e non del vocalismo difforme dalla norma tijjo, mijjo. Così come pure consiglio (eccezion fatta per Bolsena, dove c’è consejjo con il significato di ‘collegio di persone’). Il caso di tigna poi è essenziale per capire quanto l’assenza e la presenza di anafonesi abbia spesso un valore se-mantico. Tigna è presente (eccezion fatta per Canepina) nella forma anafone-tica, quindi tigna, sia nel significato di ‘calandra del grano (Calandra granaria L.)’ e ‘tignola dei panni; tarma (Tricophagatapetzella L.)’, sia in quello, traslato, di ‘cocciutaggine, testardaggine’, che ha generato il verbo intignà ‘intestardir-si’. Ora, il problema risiede proprio nel fatto che, data la palatalizzazione di intingo in intigno, l’assenza di anafonesi in ’ntégno, ‘intingo’ appunto, segna la differenza di significato tra i due verbi: fenomeno questo tipico del viterbese ed estraneo al romanesco, in cui si hanno due forme anafonetiche coincidenti: intigno nel romanesco significa tanto ‘mi impunto’(da intignà) quanto ‘intin-go’ (da intigne, che invece nei dialetti viterbesi è ’ntegne). Il discorso è legger-mente diverso per la coppia spigne ‘spingere’ e spegne ‘spegnere’: a Roma i verbi sono diversi perché spingere presenta l’anafonesi, che consente la distin-zione semantica; nel viterbese invece di spigne si ha spegne, il che avrebbe pro-dotto la stessa omonimia rilevata a Roma per intigne. A questo punto i dialetti della Tuscia hanno risposto in maniera originale a tale confusione evitando spegne e usando stégne (probabilmente derivato dal lat. EXTINGUERE); quin-di non spento ma sténto. I fenomeni descritti coinvolgono l’intera provincia, con solo qualche oscillazione tra forme anafonetiche e non in alcuni comuni: la prevalenza netta della forma con anafonesi si ha ad Orte, comune meglio
5 Sebbene Sant’Oreste, dal punto amministrativo, non faccia parte della provincia di Viterbo ma di quella di Roma, ormai diversi studi tra i quali spicca Avolio (2010) sono concordi nel considerare linguisticamente tale comune, un tassello del mosaico della Tuscia.
348 Miriam Di Carlo
collegato con Roma e Firenze grazie alla linea ferroviaria. Quindi Orte rappre-senta un punto di contatto forte con il romanesco e con il fiorentino, mentre il resto della provincia risulta più conservativo, con qualche oscillazione nella Marem ma laziale, che, vuoi per l’andamento pianeggiante del territorio, vuoi per l’Aurelia, vuoi per il turismo e per una linea ferroviaria più agevole di quella Roma-Viterbo, appare meno propensa all’introversione che caratterizza l’entroterra. Anche in alcune parole in cui Roma dimostra l’avvicinamento al tipo anafonetico fiorentino, i dialetti del viterbese si protendono poco verso i modelli linguistici limitrofi, preferendo ancorarsi a un senso campanilistico, indice di un’identità da preservare. Una di queste parole è lingua con tutti i suoi derivati: nei vocabolari romaneschi, a partire da quello del Chiappini (1933) si ha sempre la forma fiorentina (mentre, Micheli nel 1767 scriveva Povesie in lengua romanesca). Invece tutti i comuni del viterbese si compatta-no attestando la forma lengua con tutti i suoi derivati: lenguacciuto, lenguata, lengua longa, lengua biforcuta, lengua d’oro, lengua de cane, il verbo sdelenguà, lengua che taja e che cuce ‘maldicente’. Vi sono però alcune oscillazioni per quanto riguarda i composti e i derivati, sintomo che l’anafonesi pian piano penetra. Lo stesso dicasi per mungere, che nei vocabolari romaneschi viene ri-portato, nella forma con anafonesi (mugne) anche con il significato di ‘spillare soldi’. In questo caso il senso di appartenenza a una comunità contadina fa sì che il dato linguistico si concili con la praticità della vita quotidiana: la mun-gitura è una pratica ormai estranea alla popolazione di Roma, mentre rimane vitale nelle zone rurali. Mungere nel viterbese non presenta mai l’anafonesi ma è sempre nella forma mogne: in questo caso il fenomeno coinvolge tutti i comuni che rifiutano il modello fiorentino-italiano-romano. Mogne, mónto, mognitura, vacca mongana rimangono come patrimonio linguistico tecnico e specialistico. Stessa specificità di significato per soléngo attestato in tal forma in tutta l’area e che indicherebbe il cinghiale, proprio per il carattere solita-rio di tal animale che caratterizza i boschi viterbesi. Questo significato non è presente in romanesco e, ancora una volta, i dialetti della Tuscia appaiono conservativi nella loro originalità primigenia. Lo stesso dicasi per gramigna, sempre presente nella forma dialettale gramegna; là dove questa voce non è registrata, risulta sostituita da un sinonimo botanico quale gramiccia, pre-sente anche nei vocabolari romaneschi. A tal proposito è bene sottolineare che sono tutti i comuni arroccati sui Cimini6 a presentare, come nel romane-sco, gramiccia rifiutando gramégna.
6 Comuni presso cui nel ’600-’700 furono dislocate alcune stamperie romane (il pen-siero va subito a Ronciglione), e in cui la famiglia dei Farnese fu non poco influente (basti pensare a Palazzo Farnese a Caprarola).
349Né toscani né romani: per una caratterizzazione dei dialetti dell’area viterbese
I casi analizzati finora riguardano quelle parole in cui l’anafonesi è en-trata nel romanesco dimostrando l’impermeabilità della Tuscia viterbese, la quale attesta come ancora vitale la forma non anafonetica. Vi sono poi parole non anafonetiche anch’esse, ancora lemmatizzate dai vocabolari ro-maneschi, che quindi allargano la zona dialettale della Tuscia verso la pro-vincia di Roma. Esse sono7: longo, sponga ‘spugna’, ma soprattutto ossogna (assugna), fongo, ogna ovvero ‘unghia’ e ogne/ogna ‘ungere’. Tralasciando longo e sponga, mi soffermerei anzitutto su ossogna. Ossogna, ‘grasso del maiale usato per ungere o fare sapone, sugna’, è presente senza anafone-si nei vocabolari romaneschi ma nella forma assogna, attestata ancora una volta nei comuni cimini. Fongo è ben radicato sul territorio mentre fungo è attestato solo ad Acquapendente, il comune incastonato proprio tra Tosca-na ed Umbria, mentre alcune oscillazioni si registrano a Orte e a Civita Ca-stellana, ovvero sempre in quell’area falisco-tiberina separata dal resto della provincia dalla linea di Rohlfs: fonghi boni (cioè edibili) e fonghi pazzi (cioè velenosi). La vitalità di fongo si può desumere dalla copiosità dei composti e derivati: fongole, fongara, fongarolo, fongatura, fongo riccio e il detto scappà fora come le fonghe cioè ‘arrivare inaspettatamente’ o ‘parlare in maniera inopportuna’. Ogna ‘unghia’ anche ha una buona copertura. L’omonimia al plurale con ogne ‘ungere’ ha fatto sì che molte di più siano le oscillazioni e ancora maggiori le attestazioni con anafonesi del tipo ugna (Aquapenden-te, ma anche Montalto sulla costa e Oriolo Romano sulla tratta ferroviaria Roma-Viterbo). Sempre di più poi ogna si è specializzato nel significato di ‘zoccolo della mucca o del cavallo’, lasciando a ugna il significato di ‘unghia umana’. Da parte sua ogne ‘ungere’ con il participio onto denota una forte vitalità e produttività: ciò non si evince solo in panonto ‘pane ingrassato con la salsiccia o la pancetta’ e battilonto ‘tagliere o asse per battere il lardo’ quanto anche nei verbi ontare, ontolare e nei participi ontato, ontolato. Dare un’ontolata significa appunto ‘ungere’.
In definitiva, confrontando questi dati, piuttosto significativi, con altri più di difficile interpretazione, si può affermare che la Tuscia conosce la propria roccaforte del dialetto proprio nel capoluogo e in tutti i comuni che gravitano attorno ad esso (Montefiascone, Blera e Vetralla principalmen-te), ritenendolo paradigma anche dal punto di vista linguistico. A questa area conservativa va aggiunta quella dei comuni cimini, abbarbicati sulle pendici dei monti Fogliano e Cimino, circondati da vegetazione spesso im-penetrabile, che hanno però risentito dell’influsso del romanesco durante il
7 Va però considerata la tendenza all’iperdialettizzazione delle fonti analizzate dai collettori romaneschi, che si rifanno principalmente all’uso belliano.
350 Miriam Di Carlo
’600-’700. L’area falisco-tiberina rimane la più problematica: ha come pun-to di riferimento Civita Castellana (il secondo comune della provincia dopo Viterbo) e ha una serie di paesi satellite, presenta esiti incerti ma sembra orientarsi verso la norma letteraria, sicuramente su mediazione di Roma, anche per il forte pendolarismo con la capitale. La subarea maremmana è più atta ad accogliere l’elemento esterno, meglio se supportato dal prestigio linguistico: come si è detto, il territorio pianeggiante e la via Aurelia rendo-no i dialetti indigeni più suscettibili al fascino della Toscana e lo dimostrano le oscillazioni degli esiti. I comuni più a nord, nella area volsinia, sui monti Volsini e attorno al lago di Bolsena, eccezion fatta per Montefiascone, che avvicinerei più a Viterbo, rimangono particolarmente soggetti ai dialetti to-scani, nonostante la compressione su spinta di Orvieto a est.
Non è possibile tracciare una vera e propria isoglossa del fenomeno dell’assenza di anafonesi in quest’area, per il semplice fatto che la linea si avvilupperebbe su se stessa delineando una entità linguistica circoscritta e circolare o si trascinerebbe parallelamente alla linea indicata da Vignuzzi. Il processo ormai avviato sembra quello di progressiva diffusione del tratto nell’intera area; per il momento, tuttavia, l’assenza di anafonesi costituisce ancora un indice di dialettalità che differenzia il viterbese dalla Toscana fiorentina e da Roma.
Bibliografia
Avolio, F. (2010), “I dialetti laziali”. In Istituto dell’Enciclopedia Treccani (2010), ad vocem.
Bianconi, S. (1962), “Ricerche sul dialetto d’Orvieto e Viterbo nel Medioevo”. Stu-di linguistici italiani, III: 23-78
Castellani, A. (1980), Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1946-1976). Roma, Salerno Editrice.
Franceschini, F. (1991), “Note sull’anafonesi in Toscana occidentale”. In Atti del primo Convegno della Società internazionale di linguistica e filologia italiana (Siena, 28-31 marzo 1989). Torino, Rosenberg & Sellier, vol. 1 (Tra Rinasci-mento e strutture attuali): 259-272.
Giannelli, L. (1976), Toscana. Pisa, Pacini Editore.
Giannelli, L. - Magnanini, M. - Pacini, B. (2002), “Le dinamiche linguistiche al confine tra Toscana e Lazio: conservazione, innovazione e ristrutturazione”. Rivista Italiana di Dialettologia, XXVI: 49-72.
351Né toscani né romani: per una caratterizzazione dei dialetti dell’area viterbese
Melillo, M. (1970), “Confini linguistici tra l’Alto Lazio e l’Umbria”. In Ugolini, F.A. (ed.), I dialetti dell’Italia mediana con particolare riguardo alla regione um-bra. Atti del V Convegno di studi umbri. Gubbio, 28 maggio-1 giugno 1967, Centro di Studi Umbri, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli stu-di di Perugia: 491-542
Palermo, M. (1994), Il carteggio vaianese (1537-39). Un contributo allo studio della lingua d’uso nel Cinquecento. Firenze, Accademia della Crusca.
Petroselli, F. (1974-1983), La vite: il lessico del vignaiolo nelle parlate della Tuscia viterbese, 2 voll. Göteborg, Romanica Gothoburgensia.
Petroselli, F. (1986), Blasoni popolari della provincia di Viterbo. Viterbo, Cultura Subalterna.
Petroselli, F. (1999), “Aspetti dell’indagine onomastica in area alto laziale”. In Fio-rini, A. - Galli, L., Comunità e dialetto: giornata di studi sul tema: la storia della lingua in prospettiva interdisciplinare. La ricerca nell’Alto Lazio e in aree limitrofe. Canepina, 8 giugno 1996, Museo delle Tradizioni popolari, Viterbo, Cultura Subalterna: 23-46.
Petroselli, F. (2009), Il lessico dialettale viterbese nelle testimonianza di Emilio Mag-gini. Viterbo, Quatrini Editore.
Petroselli, F. (2010), Vocabolario del dialetto di Blera. Viterbo, Quatrini Edizioni.
Rohlfs, G. (1966), Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fone-tica. Torino, Piccola Biblioteca Einaudi.
Vignuzzi, U. (1994), “Il volgare nell’Italia mediana”. In Serianni, L. - Trifone, P. (eds.), Storia della lingua italiana: le altre lingue. Torino, Einaudi: 329-372.
Vignuzzi, U. (1995), “Marche, Umbrien, Lazio”. In Holtus, G. - Metzeltin, M. - Schmitt, C. (eds.), Lexicon der Romanistischen Linguistik II. Tubinga, Nie-meyer: 151-169.
Vignuzzi, U. (1997), “Lazio, Umbria and the Marche”. In Maiden, M. - Parry, M. (eds.), The dialects of Italy. London, Routledge: 311-320.