The Other September 11th: El Mercurio Media Coverage After the Chilean Coup
Mercurio a Firenze: da Lastricati a Giambologna
Transcript of Mercurio a Firenze: da Lastricati a Giambologna
Ricerche di storia dell!arte
Rivista quadrimestrale / anno 2013
109
Culture visive e pratiche sinestetiche fra simbolismo e avanguardie
ISSN 0392-7202
! "#,$$
1092013
Il prossimo numero, della serie “Arti visive”, a cura di Giovanna Capitelli, sarà doppio e sarà dedicato a I pittori in catacomba. Sul revival paleocristiano !a Cinque e Seicento e nella Roma dell"Ottocento
Ricerche di storia dell%arte
Poste Italiane Spa & Spedizione in abbonamento postale & D
.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004, n. 46) art. 1, comm
a 1, Aut. GIPA
/C/RM
/006/2010
Ricerche di storia dell!arte
109
Culture visive e pratiche sinestetiche fra simbolismo e avanguardie
• Editoriale 4
!"#$!% &"'"()$)"Memoria e attualità dell!antico nel Prométhée di Gustave Moreau 5
*+)$'" #$)",!$Bistol". Scultura come visione 18
"))" *"--").$Edward Gordon Craig e Firenze.«#e whole city is a stage mounted with scenes of lo$eliness» 31 "&%//")!,+ )$(,+Nuo$i documenti per i Balli plastici di Fortunato Depero. Lo spettacolo, la fortuna critica e una nota su Edward Gordon Craig 43 $&",$" /'0$"11$)$I fotomontaggi immaginisti di Vinicio Paladini tra pittura, teatro e cinema 54
• Fuori tema
/.%1")+ 2$%,(3$!$Mercurio a Firenze: da Lastricati a Giambologna 67
4&#",+ ,%'$+ *$,, )+%*$ '$)%&&$Arte, feste e fuochi.La cattedrale di Siviglia e i giochi pirotecnici nella seconda metà del XVII secolo 87
• Summaries 98
67
Nel 1978 Marco Spallanzani pubblicò un arti-colo in cui erano puntualmente ricostruite le vi-cende di un importante bronzo rinascimentale, il Mercurio di Zanobi Lastricati, oggi alla Walters Art Gallery di Baltimora (!g. 7). Lo studioso rese noti i documenti di pagamento per l"opera da parte di Lorenzo Ridol!, il primo dei quali reca la data 3 settembre 1549 e recita: «a pro-vixione d"un Mercurio di bronxo ci fa, la quale à preso a farcci in termine per da oggi a un anno»1. Poiché il bronzo era giudicato una replica da una statua antica, oggi alla Galleria degli U#zi (!g. 1), che si riteneva giunta da Roma non prima del 15502, Spallanzani anticipò al 1549 il termine ante quem per l"arrivo a Firenze di quel marmo3. Anche se si trattava di uno scarto di appena un anno, che poteva sembrare trascurabile, quello spostamento cronologico non era a$atto facile da dimostrare, poiché una fonte cinquecentesca riferiva che l"opera era stata donata al duca Cosi-mo I da Giulio III (1550-1555)4. In realtà oggi è certo che il trasferimento della statua da Roma a Firenze avvenne solo nel 1560, all"epoca di Pio IV5, ma molti dubbi rimangono comunque circa i suoi restauri di epoca rinascimentale.
La storia della fortuna del Mercurio del Bel-vedere potrebbe intrecciarsi con quella di un bronzetto ra#gurante Mercurio di Jacopo Alari Bonacolsi, detto l"Antico, il cui esemplare più antico è documentato nel 1587 nelle collezioni
medicee (!g. 4). La replica bronzea rinascimen-tale del Mercurio del Bel!edere conservata alla National Gallery of Washington (!g. 6) è a sua volta generalmente identi!cata con quella già nel cortile di palazzo Montalvo a Firenze6, mentre un"altra, oggi nel castello di Fontainebleau (!g. 15), è piuttosto problematica: attestata in Fran-cia a partire almeno dal 1585, non è però ricon-ducibile con certezza al gruppo di bronzi fusi ne-gli anni %uaranta da Francesco Primaticcio per conto di Francesco I7. Le vicende della fortuna moderna del Mercurio del Bel!edere e, soprattut-to, le ragioni alla base di questa notevolissima fortuna non sono ancora state davvero indaga-te dalla critica ed è così sfuggito da una parte il probabile rapporto tra il clamoroso successo ri-scosso a Firenze dal Mercurio del Bel!edere e il bronzo oggi a Fontainebleau, e dall"altra quello praticamente certo con la commissione, da parte di Cosimo I, di un piccolo Mercurio a Willem van Tetrode (Firenze, Museo Nazionale del Bar-gello) (!g. 10) e di un altro a grandezza naturale a Giambologna, che fu inviato a Massimiliano II d"Asburgo. Identi!cabile con la scultura oggi in collezione privata in Svezia (!g. 12), il Mer-curio donato all"imperatore con ogni probabilità precedette, non seguì, quello da ricondurre alla committenza di Pier Donato Cesi, sempre di Giambologna, del Museo Civico di Bologna (!g. 13).
Stefano Pierguidi
Mercurio a Firenze: da Lastricati a Giambologna
&'()*+',+
68
Materiali
Il primo a menzionare il Mercurio degli U#zi (!g. 1) è il tedesco Johannes Fichard, che lo se-gnala nel Cortile del Belvedere alla data 15368. A quell"epoca il marmo doveva già essere stato restaurato: l"originale antico certamente non raf-!gurava il dio greco, bensì solo un giovane sulla cui testa venne messo un petaso, il tipico copri-capo alato di Mercurio9. Nell"elenco delle statue
antiche pubblicato in appendice alla seconda edizione delle Vite di Giorgio Vasari (Firenze, 1568) l"opera sarebbe stata infatti così descritta: «Un giovanetto ignudo fatto per un Mercurio, il quale era già in Belvedere di Roma»10. L"espres-sione -fatto per. sottolineava proprio la presenza di un restauro, che aveva trasformato quel gio-vane in un Mercurio11. Il petaso compare già nei due disegni che Francisco de Hollanda trasse da quella statua intorno al 1538-40, nel corso del suo soggiorno romano (Biblioteca dell"Escorial, manoscritto delle Antigualhas) (!g. 2). Il Mercu-rio fu l"unica delle sculture nel Cortile del Belve-dere a cui l"artista portoghese dedicò due disegni e, poiché in uno di questi il dio è ra#gurato privo delle mani, è stata avanzata l"ipotesi che la statua venisse restaurata proprio sotto gli occhi di Fran-cisco de Hollanda12. L"opera con ogni probabi-lità era stata rinvenuta dopo il 1527, anno a cui risalgono le Antiquitates Urbis di Andrea Fulvio che, pur descrivendo piuttosto puntualmente le statue allora nel Cortile del Belvedere, non men-ziona il Mercurio13. Di#cile, però, stabilire se la statua fosse giunta in Vaticano al tempo di Cle-mente VII o di Paolo III: nell"atto di vendita ad Ottavio Farnese di alcuni suo bronzi, nel 1575, Guglielmo della Porta così si sarebbe riferito alla copia monumentale da lui realizzata del Mercu-rio: «simile a quello che era in Belvedere al tem-po de la fe. me. di Paolo III»14. Poiché, come ve-dremo, la scultura antica era ancora in Vaticano al tempo del ponti!cato di Giulio III, della Porta forse intendeva a$ermare che sotto Paolo III la statua era arrivata nel Cortile del Belvedere, ma è anche possibile che lo scultore intendesse solo menzionare la «felice memoria» del ponte!ce Farnese, nonno dell"Ottavio con cui stava con-cludendo la vendita.
Scrivendo tra luglio e agosto del 1536, Fichard speci!cava che alla Venere, appena giunta in Va-ticano, era stato restaurato un piede: si trattava di una notizia davvero fresca, poiché nel mag-gio precedente erano state pagate le pitture del «nicchio dove ha da stare la Venere che donò il R.do Governatore di Roma a Sua Santità»15. La Venere, prima di essere collocata nel Cortile, era stata subito reintegrata del piede mancante, ed è davvero di#cile che alla statua oggi agli U#zi, prima del 1536, fosse stato aggiunto il petaso per trasformarla in un Mercurio senza che si prov-vedesse contemporaneamente al reintegro delle mani, come si vede nel secondo dei due disegni di Francisco de Hollanda. Certo è che gli attri-buti che il Mercurio del Bel!edere reca oggi nelle due mani non potevano essere più sorprendenti, tanto che non sono stati ancora identi!cati con
1. Mercurio del Bel!edere, Firenze, Galleria degli U#zi.
69
Materiali
certezza16. Anche il fatto che non ci rimangano altri fogli del portoghese che mostrino le statue del Belvedere prive dei restauri è in qualche modo signi!cativo: sembrerebbe che l"artista avesse, di fantasia, cercato di riprodurre l"opera senza quel-le strane integrazioni17. L"altro disegno di Fran-cisco de Hollanda mostra il dio nell"aspetto che ha ancora oggi, con due piccoli cilindri tronchi nelle mani: si volle in questo modo sottolineare lo status di statua antica dell"opera, rinvenuta in condizioni frammentarie, suggerendo la presen-za di un caduceo e di un /auto rotti?18 Nel 1704, descrivendo la già citata copia bronzea di Gu-glielmo della Porta in Palazzo Farnese come se si trattasse dell"originale, Paolo Alessandro Ma$ei avrebbe però scritto: «La principale osservazio-ne, che dobbiamo fare in questa nostra statua, si è del volume, o sia foglio, che porta nella destra, per il quale non pare, che cada in dubbio, che lo scultore abbia voluto rappresentare in questo marmo Mercurio per Dio dell"eloquenza, e delle lettere»19. L"ingegnosa interpretazione dell"an-tiquario, magari suggerita, almeno da quanto si può dedurre dall"incisione pubblicata nella Rac-colta di statue antiche e moderne di Ma$ei (!g. 3), dall"aspetto più irregolare del suddetto cilin-dro nella già citata copia cinquecentesca opera di della Porta20, non era del tutto peregrina. Certo un messaggio scritto non era un attributo tipico di Mercurio, che in mano generalmente poteva avere, oltre al caduceo o al /auto, anche una bor-sa21, ma un bronzetto seicentesco, la cui inven-zione è in qualche modo legata a quel modello antico22, mostra Mercurio proprio con un foglio simile in mano (!g. 11).
Ad ogni modo le ragioni che, prima del 1540, suggerirono di mettere in mano al Mercurio del Bel!edere quegli attributi così sorprendenti ri-mangono poco chiare. %uando nel 1549-1550 Ulisse Aldrovandi vide la statua «in una loggia coverta più a dentro» e non nel Cortile del Bel-vedere vero e proprio, lo descrisse così: «un Mer-curio intiero bellissimo, con occhi, che pare che guardino, e sta poggiato col braccio dritto sopra un tronco di albero di marmo, et ha un cappello in testa»23. Si trattava di una descrizione certa-mente precisa, ma Aldrovandi, che pure prestava la massima attenzione agli attributi delle divinità ra#gurate, rinunciò a menzionare i due piccoli oggetti nelle mani di Mercurio. Nonostante le grandi lodi tributategli dall"Aldrovandi, a quel-la data la statua evidentemente non godeva della stessa fama di altre antichità radunate nel Corti-le del Belvedere, quali il Laocoonte, l"Apollo del Bel!edere, la cosiddetta Cleopatra o le due grandi statue del Tigri e dell"Eu"ate: non si spieghereb-be altrimenti il suo allontanamento dal Cortile che aveva avuto luogo fra il 1536 e il 1549. Forse anche per questa ragione Cosimo I, nel 1560, sa-rebbe riuscito ad ottenerla in dono da Pio IV24.
Il 21 luglio 1549 Donato Giannotti, segreta-rio del cardinale Niccolò Ridol!, che risiedeva a Roma, scriveva da Bagnaia a Lorenzo Ridol!, fratello del cardinale, allora impegnato nei lavori di ristrutturazione del palazzo di famiglia a Fi-renze, informandolo dell"arrivo a Bagnaia di una cassa contenente due sculture: «La cassa dentro-vi il putto di marmo, et il Mercurio, comparse a salvamento»25. Nel 1978 Spallanzani identi!cò quel Mercurio non meglio speci!cato con il mo-
2. Francisco de Hollanda, Mercurio del Bel-vedere, Escorial, Biblioteca, manoscritto delle Antigualhas.
70
Materiali
dello per il Mercurio bronzeo di Zanobi Lastri-cati, già nel cortile di palazzo Ridol! a Firenze e oggi a Baltimora (!g. 7), per il quale lo scultore avrebbe ricevuto il primo pagamento il 3 settem-bre di quello stesso 1549: «a provixione d"un Mercurio di bronxo ci fa, la quale à preso a farcci in termine per da oggi a un anno»26. Secondo lo studioso, Lorenzo avrebbe inviato al fratello quel modello a#nché fosse approvato, prima che Lastricati a Firenze si mettesse al lavoro sulla sta-tua da fondere. In realtà quel supposto modello, o calco, avrebbe dovuto viaggiare da Roma a Fi-
renze e non viceversa, visto che la statua antica era a quell"epoca ancora a Roma: forse la cassa era in realtà giunta a Bagnaia e, da lì, avrebbe proseguito per la Toscana. Giannotti, quindi, avrebbe informato Lorenzo del suo prossimo ar-rivo a Firenze, dove egli l"attendeva per fornire a Lastricati il modello su cui lavorare. Nella lettera si speci!cava che il putto era di marmo, mentre non si diceva nulla in merito al Mercurio, che quindi poteva davvero essere un semplice calco in gesso da una statua antica.
Se, come già detto, il Mercurio non era una del-le statue più celebri del Cortile del Belvedere, ci si dovrebbe domandare per quale ragione il car-dinale Niccolò Ridol! scegliesse proprio quella come modello per una replica in bronzo da collo-care nel cortile del palazzo !orentino del fratel-lo. È possibile che l"interesse per quella scultura fosse dettato dal confronto con il perduto Mer-curio antico che Aldrovandi vide nella raccolta romana di statue antiche del cardinale. «In casa del Signore Lorenzo Ridol!», l"erudito e natura-lista bolognese descrisse numerose «statue, e te-ste bellissime, che erano de la felice memoria del Reverendiss. Cardinale Ridol! suo fratello»27. Ad aprire l"elenco, in una posizione che doveva essere stata attentamente calcolata, erano due ra#gurazioni, entrambe perdute, del dio greco: «Vi è prima un Mercurio intiero ignudo col suo cappello in testa. Vi è un"altro Mercurio ignu-do intiero pure col cappello alato in testa: ha ne la mano sinistra una cetra, e sta poggiato ad un tronco. %uesta è bella statua, ma è moderna»28. In tutto il lungo trattato dell"Aldrovandi, in cui sono descritte o comunque menzionate centina-ia di statue e busti antichi, sono pochissime le opere moderne citate29. Se si escludono quelle di Michelangelo30, Aldrovandi non riconobbe la mano di nessuno scultore contemporaneo e il perduto Mercurio in casa Ridol! è forse in asso-luto l"unica scultura, che possiamo immaginare a grandezza più o meno naturale, a essere indicata come «moderna»: si trattava, per l"autore, di una «bella statua», la cui commissione era pro-babilmente da leggere in rapporto al Mercurio antico a cui era stata accostata. Come già detto, Aldrovandi è straordinariamente preciso nell"in-dicazione degli attributi delle statue ed è davvero signi!cativo che il Mercurio antico di casa Ri-dol! fosse, secondo l"autore, connotato solo dal cappello in testa, proprio come quello del Belve-dere: si trattava con ogni probabilità di una sta-tua simile, che era stata restaurata secondo quel modello prestigioso. Si noti infatti che per Al-drovandi il Mercurio del Bel!edere «sta poggiato col braccio dritto sopra un tronco di albero di
3. Mercurio, da Paolo Alessandro Ma$ei, Raccolta di statue an-tiche e moderne, Roma 1704.
71
Materiali
marmo» e quello moderno in casa Ridol! «sta poggiato ad un tronco»; per quello antico in casa Ridol!, invece, Aldrovandi non citava nes-sun tronco a cui la !gura si sarebbe appoggiata. Non è un caso, allora, che nel bronzo di Lastri-cati non ci sia nessun albero o bastone a o$rire un sostegno al dio greco: questo particolare, dav-vero sorprendente, non è mai stato sottolineato dalla critica. È probabile che la scultura oggi a Baltimora fosse una replica del Mercurio Ridol!, non di quello del Belvedere, anche se il primo a sua volta poteva essere stato restaurato seguendo il modello più celebre. La statua oggi a Baltimora avrebbe solo dovuto anticipare l"arrivo a Firen-ze dell"intera collezione di antichità radunata dal cardinale Ridol! a Roma31, come Giannotti aveva assicurato a Lorenzo già alcuni anni prima, invitandolo al contempo a non sollecitarne il tra-sferimento, in una lettera da Venezia del 4 feb-braio 1545: «Le anticaglie del cardinale sanza dubio sono destinate a cotesta casa; ma quando questa destinatione si condurrà ad e$etto, non vi so io già dire. Et voi conforterei a non haver tanta fretta, o almeno a non la dimostrare»32.
La collezione Ridol! era ricca soprattutto di busti-ritratto romani, ai quali si erano andati ad aggiungere quelli all"antica di Ludovico Lombar-di, alcuni dei quali commissionati anche dall"e-rede del cardinale, Lorenzo Ridol!33. Ad ogni modo la replica bronzea realizzata nel 1549-50 e collocata nel cortile di palazzo Ridol! dovette avere una certa risonanza a Firenze e magari an-che un peso nel suscitare l"interesse di Cosimo I verso il Mercurio del Bel!edere. In qualche modo però si trattò di una vicenda senz"altro anomala: il cardinale Ridol! era infatti uno dei più acerri-mi nemici del duca di Firenze, tanto che la sua morte nel 1550, nel corso del conclave che portò all"elezione di Giulio III, ma che avrebbe anche potuto incoronare lo stesso Niccolò, venne da alcuni attribuita ai sicari di Cosimo I34. E non si dimentichi che il Bruto di Michelangelo, che celebrava il tirannicida Lorenzino de" Medici, era stato iniziato proprio per il cardinale Ridol-! nel 1546, forse su commissione di Giannotti, prima di !nire, paradossalmente, nelle collezioni medicee nel 159035. Lorenzo, peraltro, forse non aveva rapporti di#cili con Cosimo I, se Cellini intorno al 1550 cercò di avviare le trattative per l"acquisto della collezione di antichità del cardi-nale Ridol! per conto del duca36.
Nel 1560 Cosimo I si recò a Roma e a quel viaggio si lega il primo, decisivo incremento alle collezioni di antichità dei Medici a Firen-ze. Pur forte del vincolo di parentela (peraltro non stretto) che lo legava al neoeletto ponte!ce,
il duca di#cilmente sarebbe riuscito a portare via dal Vaticano opere ormai celeberrime come la cosiddetta Cleopatra o il Torso del Bel!edere,
4. L"Antico, Mercurio, Firenze, Museo Nazionale del Bargello.
72
Materiali
per non parlare dell"Apollo del Bel!edere o del Laocoonte37. Oltre al Mercurio Cosimo riuscì però ad assicurarsi anche il colossale gruppo mutilo dell"Ercole e Anteo, documentato nel cortile di Palazzo Pitti a partire già dal 156838. Il primo studioso moderno a riportare la notizia del passaggio del Mercurio da Roma a Firenze fu Adolf Michaelis nel suo fondamentale articolo sulla storia del Cortile del Belvedere, del 1890: il grande archeologo pubblicò le postille a un esemplare della seconda edizione de Le antichi-tà de la città di Roma di Lucio Mauro, in cui era contenuto il trattato sulle statue di Aldrovandi (Roma, 1559), già nella Biblioteca di Augusta e oggi nella Staatsbibliothek di Monaco. Le note del cosiddetto Anonimo Asburgense sono data-bili post 1560, proprio perché l"autore non vide nel Cortile del Belvedere neanche l"Ercole e An-teo39. Del Mercurio l#Anonimo scriveva: «Tran-slatus est Florentiam Iulio 3. P. M.»40. La notizia è sempre stata ritenuta a#dabile, anche in virtù degli ottimi rapporti tra Giulio III e Cosimo I, ma la critica non ha mai sottolineato come l"A-nonimo ignorasse completamente i doni di Pio IV al duca di Toscana, del 1560: accanto alla de-scrizione dell"Aldrovandi del gruppo frammen-tario dell"Ercole e Anteo egli annotava solo che l"opera non era più lì41.
Sempre nel 1890, in realtà, era stata pubblicata una lettera del 4 gennaio 1561 di Galeazzo Cusa-no all"imperatore Massimiliano II che permette-va di spostare in avanti l"anno del trasferimento della statua a Firenze; solo nel 1993, però, Ber-trand Jestaz ha riportato all"attenzione degli stu-di questo importante documento: «A Romani non è sodisfatto punto che sua eccellenza [Cosi-mo I] ha portato via di Roma una gran quantità di statove di marmo e molt"altre antichaglie delle più belle che vi fossero, et il papa gli ha donate tutte quelle che haveva racolte per mandar alla maestà catolica et di più gli ha dato un Mercu-rio che era in Belvedere di marmoro et un gran pillo di serpentino, cose rarissime che vagliano un tesoro»42. Cusano, quindi, citava esplicita-mente il Mercurio e non il colossale frammento dell"Ercole e Anteo, che godeva di grande fama ed era nel Cortile del Belvedere !n dal 150343. Da una parte l"opera, gravemente mutila, non poteva stare alla pari con il Laocoonte o l"Apollo del Bel!edere, ritrovati quasi integri e in seguito restaurati, né poteva godere della medesima stra-ordinaria celebrità del Torso del Bel!edere, che Michelangelo in persona aveva lodato ed era già stato esplicitamente citato nelle Vite di Giorgio Vasari (Firenze, 1550) tra le opere maggiori del Cortile44. Dall"altra parte non si può negare che
il frammento con Ercole e Anteo fosse comunque un pezzo d"eccezione, ancora nel Cortile vero e proprio, non nella loggia del Mercurio o nel giar-dino segreto, al tempo della visita di Aldrovandi nel 1549-50: non si può insomma escludere la possibilità che, se Cosimo l"avesse davvero volu-to, egli non sarebbe riuscito a portar via dal Bel-vedere un pezzo anche di maggiore reputazione rispetto al Mercurio e all"Ercole e Anteo, come ad esempio, una delle due statue ra#guranti Venere.
La lettera di Cusano sopra riportata, inoltre, at-testa del malcontento che serpeggiò a Roma per quel generoso regalo. È insomma probabile che il duca chiedesse al ponte!ce due opere il cui sog-getto gli era particolarmente caro.
Il tema di Ercole, come è noto, aveva sempre avuto enorme fortuna a Firenze, e in particolare presso i Medici: qui basti ricordare le tre perdute Storie di Ercole, eseguite da Antonio e Piero del Pollaiolo per Cosimo il Vecchio intorno al 1460 e con!scate dalla Signoria nel 1494-94, e soprat-tutto il colosso di Baccio Bandinelli con Ercole e Caco, inaugurato in piazza della Signoria nel 1534, così intimamente legato al ritorno dei Me-dici a Firenze dopo la Seconda Repubblica da di-venire subito bersaglio di critiche feroci45. Sulla fortuna di Mercurio nella Firenze nel Cinque-cento la prima opera signi!cativa da ricordare è un piccolo bronzo ra#gurante il dio greco, ope-ra di Giovanni Francesco Rustici (Cambridge, Fitzwilliam Museum), che era stato collocato in cima alla fontana del giardino posteriore di pa-lazzo Medici intorno al 151546; negli stessi anni, Bandinelli aveva eseguito un altro Mercurio in marmo, forse in sostituzione del David bronzeo di Donatello, anch"esso con!scato nel 1494-95, per il cortile del medesimo palazzo di via Lar-ga47. Sul rapporto privilegiato tra l"immagine politica di Cosimo I e la !gura di Mercurio si è so$ermata Sonja Brinck in un libro del 198748, in particolare richiamando l"attenzione su al-cuni passi dei Ragionamenti di Vasari (Firenze, 1588) in merito al Mercurio su una delle pareti e alla cosiddetta Virtù mercuriale sul so#tto della Sala degli Elementi in Palazzo Vecchio (1555-57 circa) (!g. 8)49. Com"è noto, i Ragionamen-ti non possono essere considerati il programma iconogra!co dei vari cicli vasariani di Palazzo Vecchio, poiché l"autore vi riversò a posteriori una serie di signi!cati, certamente non previsti al momento della realizzazione di quelle pitture50. Le due !gure che qui interessano, però, non po-tevano avere un valore allegorico diverso rispetto a quello riportato nel testo del 1588: esse furono inserite proprio in rapporto al legame che si era instaurato tra la politica di Cosimo I e le qualità
74
Materiali
senz"altro più simile al bronzetto dell"Antico56. Tuttavia la scultura oggi negli Stati Uniti, sulla quale le prime notizie che abbiamo risalgono alla seconda metà del Settecento, di#cilmente può essere davvero considerata il modello del Mercu-rio del Bonacolsi: è più probabile che si tratti di un pezzo antico, restaurato tenendo presente sia il bronzetto dell"Antico sia il Mercurio del Bel-vedere, la cui celebrità crebbe costantemente nel corso dei secoli57. Acquistato nel 1926 o 1927 da William Randolph Hearst a un"asta inglese, il Mercurio Bateman era così descritto nel cata-logo di vendita: «Roman marble statue, holding a scroll in his right hand and resting his arm on drapery thrown over a column». Una replica di John Cheere a Kedleston Hall, in Inghilter-ra, mostra la medesima !gura con un messaggio nella mano destra: quest"intervento di restauro è stato rimosso dall"originale del ,'0&'58. Anche la testa del Mercurio Bateman, però, l"unico ele-mento a connotare la statua come una ra#gura-zione del dio greco, non è pertinente: in origine doveva infatti trattarsi, proprio come il Mercurio del Bel!edere, della semplice !gura di un gio-vane appoggiato ad una colonna o ad un tron-co, secondo una tipica soluzione di ascendenza prassitelica59. Il messaggio che recava nella mano destra rimanda inequivocabilmente al Mercurio del Bel!edere, mentre la posizione delle gambe e soprattutto la testa a quello dell"Antico: in nes-sun precedente greco o romano, infatti, il dio ha la testa alata e, contemporaneamente, indossa il suo tipico copricapo, privo però delle alette, così come si vede nel bronzetto del Bargello e nel Mercurio Bateman60. È probabile insomma che il marmo antico, rinvenuto verosimilmente nel corso del Settecento, fosse stato restaurato te-nendo presenti quei modelli ormai celebri.
Il problema della fonte del Bonacolsi rima-ne quindi sostanzialmente aperto. %uasi tutti i bronzetti dell"Antico, com"è noto, riproducono opere celebri che l"artista aveva potuto studiare nel corso dei suoi soggiorni giovanili a Roma, scalati negli ultimi anni del %uattrocento61. Il Mercurio sembra invece una creazione originale dell"artista, che si rifece a diversi modelli classi-ci senza copiarne pedissequamente nessuno62. Il Mercurio dell"Antico era un"invenzione senz"al-tro sui generis: il dio era infatti connotato solo dalle ali in testa, non avendo in mano nessuno dei suoi attributi classici. In seguito Isabella d"Este avrebbe commissionato allo scultore una replica di quell"invenzione a cui sarebbe stata aggiunta la !gura di Cupido, ai piedi del dio, in modo da avere un gruppo di carattere narrativo, ovvero: «Un Mercurio che insegna a leggere a
Cupido». %uest"esemplare, privo peraltro pro-prio di quel Cupido, andato perduto, è oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna ed ispirò probabilmente l"Educazione di Cupido di Cor-reggio, oggi alla National Gallery di Londra (1523-25 circa)63. Ann Hersey Allison ha datato l"esemplare del Bargello al 1505-1511 circa, ri-tenendolo frutto di una commissione di uno dei più importanti protettori dell"artista, il vescovo Ludovico Gonzaga64. %uello che occorre sottolineare qui è che il
Mercurio oggi al Bargello è l"unico bronzetto dell"Antico documentato nelle collezioni me-dicee e forse non si tratta di una coincidenza: è possibile che l"acquisto di quel pezzo risalisse a Cosimo I. La replica del Mercurio del Bel!edere oggi a Washington (!g. 6), con il bastone al po-sto del tronco d"albero, se davvero fosse di pro-venienza !orentina e medicea, potrebbe essere stata realizzata tenendo presente anche il model-lo dell"Antico. Sembra più probabile, però, che il bronzo della National Gallery of Art sia iden-ti!cabile con quello di provenienza farnesiana. Come già detto, anche il Mercurio di della Porta si appoggiava ad un bastone, non ad un tronco di albero, e a proposito di quell"esemplare è impor-tante ricordare che nella collezione di antichità Farnese sistemata negli orti del Palatino era una statua di Mercurio che, grazie alla descrizione dell"inventario del 1646 (Un Mercurio in piedi con una borsa nella mano sinistra et un pezzo di bastone nella destra) e soprattutto alla sua ri-
8. Giorgio Vasari, Virtù mercuriale, Palazzo Vecchio, Sala degli Ele-menti, so#tto.
75
Materiali
produzione in una incisione del Settecento (!g. 9), sappiamo che ra#gurava il dio con il braccio appoggiato sopra un bastone del tutto simile65. Jestaz ha respinto la possibile identi!cazione del Mercurio di Washington con quello già Farnese per la di$erente forma della base, per la presenza di una lucertola alla base del bastone nella sta-tua, non ra#gurata nella stampa di Ma$ei, e per il pro!lo troppo regolare dello strano oggetto che tiene in mano il dio nel bronzo americano66. Si tratta, a ben vedere, di tre di$erenze davvero minime, che potrebbero essere imputabili a una traduzione a stampa non fedelissima nei con-fronti dell"originale: molto più signi!cativa è la sostituzione, sia nel bronzo che nell"incisione, del tronco d"albero con il bastone. L"altra replica bronzea dal Mercurio del Bel!edere, quella oggi a Fontainebleau (!g. 15), presenta il tronco d"al-bero come l"originale. Della Porta, è vero, proba-bilmente ricevette da Pio IV, intorno al 1560, la commissione di quel gruppo di repliche dall"an-tico poi vendute a Ottavio Farnese, ma poiché non risulta che nessuna di quelle opere fosse e$ettivamente pagata dal ponte!ce, è possibile che non tutte fossero state già fuse negli anni Sessanta: della Porta avrebbe potuto realizzare il Mercurio Farnese solo molto più tardi, in vista della vendita poi conclusa nel 1575, con quella modi!ca che avvicinava l"opera alla statua anti-ca collocata nel 1646 negli Orti sul Palatino67. Ancora nel Cinquecento, bronzi monumentali come quello di Washington erano pezzi eccezio-nali e poiché è di#cile indicare un"altra prove-nienza per quella statua68, l"ipotesi più probabile rimane quella che si tratti dell"esemplare già in palazzo Farnese.
Nel 1561 le truppe medicee entrarono a Pi-tigliano, ponendo !ne alla Signoria degli Orsi-ni. Nel dicembre del 1562 Cosimo I scriveva a Giovanni Francesco Orsini comunicandogli che il famoso studiolo che suo padre Nicola aveva commissionato allo scultore !ammingo Willem van Tetrode era giunto a Firenze, vero e proprio bottino di guerra69. Già il 19 febbraio 1564, in un"altra lettera su cui sempre Jestaz ha riportato l"attenzione, Galeazzo Cusano informava Massi-miliano II che il duca aveva richiamato presso di sé Tetrode e un altro scultore oltramontano di cui ignoriamo il nome, per terminare il suddetto stu-diolo: «Il quale [Cosimo] havendo detto alli due maestri Alemani, che li !nirono il raro studiolo, che faceva far in Pitigliano il signor conte Ni-cola per donarlo alla maestà vostra [...] Com"ho detto, detto studiolo capitato in mano al duca, operò che li medesimi maestri che l"havevano fatto al conte Nicola si contentarono d"andar
a Firenze a !nirlo»70. Il vanto di quel prezioso mobile, andato perduto, erano i numerosi bron-zetti che Tetrode e il suo collaboratore avevano tratto dai maggiori capolavori antichi conservati a Roma. Alcuni di questi bronzetti si conserva-no ancora al Bargello e a questi è stato associato anche il Mercurio moderno (!g. 10) che Tetrode eseguì come una sorta di omaggio al suo maestro Cellini, accanto al quale aveva lavorato a Firenze nel 1549-50: si trattava infatti di una variazione sul tema del Mercurio bronzeo collocato in una delle nicchie del piedistallo del Perseo (1545-1554; Firenze, Loggia della Signoria)71. Poiché, quindi, il Mercurio di Tetrode non era una re-plica dall"antico e, sia per soggetto sia per com-posizione, era legato unicamente a Firenze e alla committenza di Cosimo I, è ragionevole pensa-re che esso venisse realizzato nel 1563, quando, secondo la testimonianza di Cusano, lo scultore aveva !nito lo studiolo per conto del duca72. Se il Mercurio di Cellini era còlto nell"atto di librarsi in volo, quello di Tetrode era al contrario ra#gu-rato in quello di atterrare73. Purtroppo l"esempla-re del Bargello, sulla cui completa autogra!a di Tetrode è stato peraltro sollevato un dubbio da parte di Jestaz74, non conserva gli attributi nel-le due mani: nella destra, in basso, il dio poteva tenere il caduceo (come avrebbe fatto quello suc-cessivo di Giambologna), ma non è chiaro cosa avesse in quella sinistra alzata: in alcune versio-ni più tarde, come una della Frick Collection di New York, egli ha nella mano destra la testa de-capitata di Argo e nella sinistra una spada; anche in un esemplare del Rijksmuseum di Amsterdam la posizione della mano alzata, sebbene priva di attributo, sembra nell"atto di reggere qualcosa di pesante, probabilmente proprio una testa de-capitata75. Tetrode avrebbe cioè reso omaggio al suo maestro rifacendosi anche all"iconogra!a del Perseo con la testa della Medusa. Tuttavia in una replica seicentesca di Caspar von Turkelsteyn (Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum) (!g. 11), egli ha nella mano alzata un messaggio su un foglio arrotolato76, proprio l"attributo che secondo Ma$ei aveva in mano il Mercurio antico giunto a Firenze nel 1560, un altro precedente a cui Tetrode poteva guardare. Il Mercurio del !ammingo poteva inoltre essere accostato, in un classico confronto fra antichi e moderni, al Mer-curio dell"Antico, a quell"epoca probabilmen-te già nelle mani di Cosimo I: il primo, con un braccio alzato, era alto 44,5 cm, il secondo 38.
In quello stesso giro di anni, com"è ben noto, Giambologna eseguiva la prima delle numerose versioni del Mercurio, certamente la sua inven-zione più celebre e fortunata. Di quello che,
76
Materiali
verosimilmente, doveva essere l"esemplare più antico, parlano sia Vasari, sia Ra$aello Borghi-ni. Il primo, nel 1568, ricordava tra le opere del !ammingo «un Mercurio in atto di volare, mol-to ingegnoso, reggendosi tutto sopra una gamba et in punta di piè, che è stata mandata all"impe-ratore Massimiliano come cosa che certo è ra-rissima»77. Borghini, nel 1584, avrebbe aggiun-to qualche particolare: «In questo medesimo tempo [quando eseguiva la Fontana del Nettuno a Bologna] fece un Mercurio di bronzo grande come un fanciullo di 15 anni, il quale insieme con una historia di bronzo, et una !gurina pur di metallo fu mandata all"Imperadore»78.
Al Kunsthistorisches Museum di Vienna si conserva solo un Mercurio di 62,7 cm di altezza, impossibile da identi!care con quello «grande» descritto da Borghini79. %uest"esemplare è mol-to più slanciato rispetto a quello del Museo Civi-co di Bologna, di cm 56,2 (!g. 13)80 e, al pari di altri conservati a Dresda e a Napoli, è da conside-rarsi verosimilmente più tardo, successivo alla se-conda versione in grande di quella invenzione, il bronzo realizzato prima del 1580 per la fontana del giardino di villa Medici a Roma, conservato oggi al Bargello (170 cm)81. Già nella monogra-!a di Dhanens, del 1956, in ragione dell"analisi stilistica dell"opera e del documentato soggior-no bolognese dell"artista, il Mercurio del Museo Civico era datato al 1563-64 e quello inviato a Massimiliano II, allora ritenuto perduto, al 1564-6582. Nel 1985, però, Lars-Olof Larsson ha reso noto un grande bronzo di 185 cm, conser-vato in una collezione privata svedese (!g. 12), che ra#gura Mercurio secondo la classica inven-zione giambolognesca e stilisticamente è certo più vicino all"esemplare di Bologna che non agli altri già citati, sebbene lo studioso ne attribuisse la paternità al giovane Adriaen de Vries83. Due anni dopo Charles Avery, nella sua monogra!a sullo scultore !ammingo, identi!cava per pri-mo il bronzo svedese con quello inviato a Mas-similiano II citato sia da Vasari sia da Borghini, continuando però a riconoscere una possibile, leggera precedenza cronologica all"esemplare di Bologna84. Nel 1988 Richard Tuttle pubblicava un manoscritto di Pier Donato Cesi, vescovo di Narni e governatore di Bologna, datato dallo stu-dioso a cavallo tra 1564 e 1565, in cui era descrit-to un Mercurio che il prelato avrebbe commissio-nato a Giambologna85. In un convegno del 1990 Irving Lavin, senza tener conto delle conclusioni di Avery e del bronzo svedese, sottolineava le dif-ferenze tra il Mercurio bolognese e le successive redazioni, riconoscendo nel primo la perfetta ra#gurazione di quello descritto da Cesi nel
suddetto manoscritto, ovvero «un"immagine in bronzo di Mercurio che scende dal Cielo», qual-cosa di ben diverso dalla tensione verso l"alto espressa dagli esemplari più tardi e più noti86. La critica si è da allora sostanzialmente assestata su queste posizioni: Giambologna avrebbe realizza-to un modelletto del suo primo Mercurio per il Cesi, nel 1563 (al più tardi nel 1564), eseguen-do subito dopo quello oggi in Svezia, inviato nel 1564-65 a Massimiliano II87. Jestaz, in realtà, ha ri!utato l"identi!cazione dell"esemplare citato da Vasari e Borghini con il bronzo svedese, poi-ché secondo lui non sarebbe possibile conciliare la descrizione de Il Riposo, in cui si parla di un «un fanciullo di 15 anni», con una scultura alta ben 185 cm88. Il passo di Borghini, però, non deve essere preso troppo alla lettera: si potreb-be ipotizzare, prima di tutto, che egli intendes-se dire che il bronzo inviato all"imperatore era «grande» e che ra#gurava il dio «come un fan-ciullo di 15 anni». Inoltre, se è vero che l"autore conosceva molto bene Giambologna, di cui era amico, non si deve dimenticare che quell"opera aveva lasciato Firenze da circa vent"anni ed è pos-sibile che Borghini non ne ricordasse esattamen-te le dimensioni, riducendole nel ricordo.
A sostenere l"identi!cazione del bronzo svede-se con quello inviato a Massimiliano II è l"analisi delle piccole, ma signi!cative varianti rispetto agli altri esemplari, analisi che suggerisce di an-ticiparne la datazione rispetto al Mercurio di Bo-logna. Se questo, com"è sempre stato detto, non rivolge con decisione la testa verso l"alto, secondo quella soluzione attestata dai bronzetti più tardi di Vienna, Dresda e Napoli, è vero, però, che non guarda neanche verso il basso, come fa invece quello svedese. Da questo punto di vista, non c"è dubbio che il percorso evolutivo dell"invenzione giambolegnesca sembrerebbe condurre dall"e-semplare di collezione privata, attraverso la tap-pa intermedia di quello bolognese, verso gli esiti più maturi e slanciati delle piccole versioni tarde e di quella monumentale di villa Medici a Roma. Non c"è infatti nessun elemento che permetta di datare incontrovertibilmente il Mercurio del Museo Civico di Bologna prima di quello invia-to a Massimiliano II. Nel manoscritto di Cesi già citato sono descritte due opere scultoree che non vennero poi realizzate, il già citato Mercurio, che doveva essere collocato nel cortile del palaz-zo dell"Archiginnasio, e una statua del ponte!ce allora regnante, Pio IV, che sarebbe stata posta di fronte al medesimo palazzo. I documenti re-lativi alla complessa e laboriosa realizzazione della Fontana del Nettuno di Giambologna, già pubblicati da Gramberg nel 1936, menzionava-
77
Materiali
no infatti più volte un modello «della statua di nostro signore» che l"artista aveva portato per-sonalmente a Roma, insieme a quello dello stesso Nettuno, a#nché fosse approvato89.
Il 16 agosto 1563 Francesco I rispondeva po-sitivamente a Cesi, che gli chiedeva di manda-re a Bologna il giovane e promettente artista !ammingo90. Appena quattro giorni dopo, il 20 agosto, Giambologna !rmava il contratto per la realizzazione della fontana, impegnandosi a por-tare a termine l"impresa in dieci mesi91: i Medici avrebbero dovuto riavere lo scultore a Firenze per l"inizio dell"estate 1564. I lavori però non proce-dettero così velocemente e nel gennaio del 1565 Giambologna, certamente pressato da Francesco de" Medici che lo voleva indietro a#nché pren-desse parte ai preparativi dei grandiosi festeg-giamenti per il suo imminente matrimonio con Giovanna d"Austria (annunciato u#cialmente il 21 marzo 1565 e celebrato il successivo 15 dicem-bre), lasciò il cantiere senza che la fontana fosse stata ultimata. A Bologna si sapeva bene che l"ar-tista non si sarebbe assentato per poche settimane e il 23 gennaio, giorno in cui Cesi terminava il proprio mandato in qualità di governatore della città92, fu quindi stilato un preciso stato d"avanza-mento dei lavori: a quella data restavano da fon-
dere ancora il Nettuno, i quattro putti e le quattro cantoniere; erano state terminate solo le quattro arpie e gli stemmi93. %uello stesso giorno il Cesi scriveva a Francesco annunciando il prossimo ritorno a Firenze di Giambologna e pregando il principe di rimandare presto lo scultore a !nire quanto iniziato94. Nell"aprile del 1566, conclu-sosi il tour de force che aveva impegnato pratica-mente tutti gli artisti e gli artigiani di Firenze per gran parte del 1565, Francesco I permetteva allo scultore di tornare a Bologna95. Cesi aveva conti-nuato a scrivere da Roma al principe e alle auto-rità bolognesi96: sebbene il suo mandato fosse da tempo terminato, egli si adoperava a#nché i la-vori che aveva patrocinato fossero portati a termi-ne. È probabile, infatti, che il prelato contasse sul Senato perché la statua del ponte!ce, il cui mo-dello era già stato approvato a Roma, fosse fusa e collocata sulla piazza. Pio IV era però scomparso nel dicembre del 1565, quando non era stato !r-mato nessun contratto per quell"opera: niente di sorprendente, quindi, che essa non venisse realiz-zata. Il 27 agosto 1566 le autorità bolognesi scri-vevano soddisfatte a Francesco I annunciandogli la !ne dei lavori alla fontana e quindi l"imminen-te rientro di Giambologna a Firenze97: in quattro mesi erano stati fusi il Nettuno, i putti e tutto
9. Giuseppe Panini (inv.), Gli Orti Farne-siani sul Palatino (part.), Roma, Istituto Nazionale per la Gra!ca.
78
Materiali
quanto ancora mancava per terminare l"opera. Il Mercurio che avrebbe dovuto ornare il cortile dell"Archiginnasio, al pari della statua di Pio IV, non fu eseguito da Giambologna; eppure di esso, come già detto, si conserva nel Museo Civico di Bologna un modello bronzeo, peraltro non !ni-to, a di$erenza del modello del Nettuno, sempre nello stesso museo, identi!cabile forse con quello che nel maggio del 1564 era stato portato a Roma (insieme all"altro con la statua di Pio IV che scon-!gge l"eresia) per l"approvazione del ponte!ce98. Poiché del Mercurio bolognese non rimane trac-cia nella ricca documentazione dei lavori condot-ti tra l"agosto del 1563 e il gennaio del 1565, non sembra probabile che esso fosse stato realizzato in quel lasso di tempo a Bologna. Non essendo mai stato rinettato, tanto che conserva ancora la super!cie porosa naturale del bronzo99, si potreb-be ipotizzare che il Mercurio venisse sì realizzato a Bologna nel 1563-64, ma non fosse inviato a Roma per essere presentato al ponte!ce, e anche per questa ragione i documenti tacerebbero della sua esistenza. Sembra però più verosimile credere che l"idea di collocare una !gura di Mercurio in cima a una colonna nel cortile dell"Archiginnasio fosse maturata in Cesi solo al momento di sten-dere il già citato manoscritto, tra il dicembre del 1564 e il gennaio del 1565, e che in seguito il pro-getto non prendesse mai davvero forma concreta, a di$erenza di quello della statua di Pio IV.
A questo punto si deve cercare di stabilire, an-che in assenza di una precisa documentazione, il momento in cui fu realizzato il Mercurio inviato a Massimiliano II. Le trattative per trovare una moglie al primogenito del duca erano iniziate molto presto, e già nel 1560 era fallito l"ambi-zioso tentativo di Cosimo I di imparentarsi di-rettamente con Filippo II di Spagna, ottenendo per il !glio la mano della di lui sorella, la princi-pessa del Portogallo; lo stesso Filippo II, però, si assunse il compito di portare avanti le trattative per concludere il matrimonio con una delle !glie dell"imperatore Ferdinando I. Tra il maggio del 1562 e il settembre del 1563 Francesco de" Me-dici soggiornò a Madrid per stringere i rapporti con la corte di Filippo II100: in quell"occasione è probabile che egli portasse con sé il rilievo in ala-bastro di Giambologna oggi al Prado con France-sco I condotto da Mercurio al cospetto di Fiorenza, databile quindi ante 1562 (!g. 14)101. Il signi!-cato tutto politico di quel rilievo allegorico, che mostrava il giovanissimo principe, ancora imber-be, condotto da Mercurio verso la città che si ap-prestava a governare, è confermato dal fatto che un rilievo in bronzo, secondo Borghini, fu poi inviato a Massimiliano II insieme al grande Mer-
curio: è evidente che questo sia da identi!care con la versione bronzea dell"invenzione del rilie-vo del Prado oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna102. Fin dal 1562, quindi, l"immagine pubblica del principe Francesco, proiettata sullo scenario europeo, veniva associata a Mercurio, in perfetta continuità con quelle che erano state le scelte del padre Cosimo.
Tra le opere di Giambologna, nel 1568 Vasari citava per prima la Fontana di Nettuno; poi ac-canto ad altre sculture già fatte, quali il Bacco
10. Willem van Tetrode, Mercurio, Firenze, Museo Nazionale del Bargello.
79
Materiali
Cortesi (1560-62 circa; Firenze, Museo Nazio-nale del Bargello)103 e il Mercurio inviato all"im-peratore, ricordava quelle non ancora compiute. Borghini, più preciso, scriveva invece che nel «medesimo tempo» in cui aveva realizzato la Fontana di Nettuno, egli aveva anche eseguito il Mercurio inviato Oltralpe. Giambologna doveva averlo realizzato subito dopo il suo rientro a Fi-renze, nei primi mesi del 1565: i doni diploma-tici per l"imperatore non potevano tardare oltre, ed egli era stato richiamato da Bologna proprio
a quello scopo. Di#cile, infatti, ipotizzare che l"artista si allontanasse per molto tempo dal cantiere della Fontana del Nettuno nel corso del 1564, quando la sua presenza a Bologna è docu-mentata con continuità. %uindi, proprio come riportava l"informato Borghini, il Mercurio era stato realizzato nel «medesimo tempo» della Fontana del Nettuno, ovvero dopo che era stato terminato tutto il lavoro preparatorio sui mo-delli, ma prima che fosse stata fusa la !gura prin-cipale. In questo modo si spiegherebbe anche
11. Caspar von Turkelsteyn, Mercurio, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum.
12. Giambologna, Mercurio, Rydboholm (Svezia), collezione privata.
80
Materiali
perché il gruppo di Firenze che sottomette Pisa, commissionato a Giambologna in occasione dei festeggiamenti del dicembre 1565 per fare da pendant al Genio della Vittoria di Michelangelo nel Salone dei Cinquecento, fosse stato realizza-
to in gesso, tanto che la versione in marmo non era ancora terminata nel 1568, come riportato da Vasari: «Ma se insin qui ha fatto molte opere e belle, ne farà molte più per l"avvenire e bellissi-me, avendolo ultimamente fatto il signor Preni-cpe accomodare di stanze in Palazzo, e datoli a fare una statua di braccia 5 d"una Vittoria con un Prigione, che va nella Sala grande dirimpetto a un"altra di mano di Michelagnolo»104.
Sebbene sia possibile che per l"apparato del 1565 non fosse stata commissionata a Giambo-logna una scultura monumentale in marmo, non si può escludere l"ipotesi che l"artista, semplice-mente, non avesse avuto il tempo necessario per realizzarla105. Se le cose andarono così, Giam-bologna eseguì il Mercurio per Massimiliano II quando Cesi aveva già deciso di commissionar-gliene uno per il cortile dell"Archiginnasio e ne riportava la descrizione nel manoscritto oggi all"Ambrosiana. %uesto non signi!ca, però, che l"invenzione dell"opera fosse stata davvero elabo-rata per il governatore di Bologna e replicata per Cosimo I: si trattò semplicemente di una fortui-ta concomitanza di eventi.
Come già detto era il duca di Firenze ad aver legato da tempo la propria immagine pubblica e quella del !glio al dio Mercurio, e questo legame si era in qualche modo consolidato con l"arrivo da Roma del Mercurio già nel Belvedere nel 1560. Inoltre si ricorderà che intorno al 1563 Tetrode aveva eseguito per Cosimo il piccolo Mercurio ispirato al precedente di Cellini per lo studiolo già Orsini, e quello fu senz"altro il precedente più importante cui guardò Giambologna per il Mercurio da inviare all"imperatore. Il dio del bronzetto di Tetrode guarda verso il basso e la sua posa suggerisce chiaramente che si tratta di una ra#gurazione di Mercurio còlto nel momento in cui dal cielo scende sulla terra. Allo stesso modo il grande Mercurio della collezione privata svede-se ha la testa rivolta verso il basso e, sebbene sia in una posizione completamente diversa (è la sua gamba sinistra a poggiare in terra, non la destra), è chiaro che non è nell"atto di librarsi verso l"alto (come era nel precedente di Cellini, in cui Mer-curio rivolgeva la testa al cielo). Giambologna, in-somma, si rifece forse all"invenzione recentissima di Tetrode: il suo Mercurio, sia iconogra!camente sia compositivamente, era un"opera legata prima di tutto alla Firenze di Cosimo I. Lo scultore do-vette anche tenere a mente la medaglia che Leone Leoni aveva eseguito proprio per Massimiliano II nel 1551 circa, sul verso della quale era l"immagi-ne di Mercurio in volo sopra la terra106.
Tuttle nel 1988 chiamò in causa un altro prece-dente, che legava l"invenzione giambolognesca al
13. Giambologna, Mercurio, Bologna, Museo Civico Medie-vale.
81
Materiali
contesto dell"Archiginnasio: si trattava della marca tipogra!ca dell"editore Giovanni Rossi che, dopo aver lavorato a Venezia, nel 1559 si era trasferito nella città felsinea, lavorando anche per l"univer-sità. Come nella medaglia di Leoni, la marca di Rossi mostrava Mercurio in volo accompagnato dal motto 0'),1 2)&+3343 '5 ',(1, ovvero «mandato dall"alto del Cielo», che certo si lega-va bene all"immagine del dio greco concepita da Giambologna107. Ma anche il Mercurio di Tetrode, che evidentemente non aveva nulla a che fare con quella marca tipogra!ca, era «mandato dall"alto del Cielo». Giovanni Rossi aveva adottato l"im-magine di Mercurio in volo come sua marca già al tempo in cui operava a Venezia, né egli era l"unico editore al servizio dell"università di Bologna: dif-!cile, in fondo, vedere un rapporto di dipendenza troppo stretto tra quell"immagine e il progetto di erigere una statua ra#gurante il dio greco nel cor-tile dell"Archiginnasio. Si potrebbe al contrario ipotizzare che Giambologna chiedesse congedo dal suo committente bolognese, il governatore del-la città, informandolo dell"impegno che lo atten-deva a Firenze – la realizzazione di una grande sta-
tua bronzea di Mercurio da inviare all"imperatore Massimiliano – e che questa circostanza suggerisse a Cesi un"altra opera che lo scultore avrebbe potu-to eseguire una volta che fosse tornato a Bologna. In fondo, a ben vedere, non era certo la !gura di Mercurio quella che sarebbe stato più immediato associare al cortile di un"università: scelte più ov-vie erano Minerva, dea della sapienza, o Apollo, protettore delle arti. %uando Giambologna tornò a Bologna nel 1566 per terminare la Fontana del Nettuno, portò con sé, o magari realizzò sul posto, il modello bronzeo oggi al Museo Civico di Bolo-gna, con il Mercurio che non guardava più verso il basso, ma di fronte a sé, anticipando le successive versioni della medesima invenzione, sempre più proiettate verso l"alto. Egli però non rinettò il mo-dello, né rimosse il nucleo o eseguì il caduceo, poi-ché presto sfumò il progetto di fondere sia quello sia la statua di Pio IV.
Da quanto detto !n qui si comprende bene come il Mercurio giunto da Roma fosse l"opera più prestigiosa delle collezioni medicee d"anti-chità, e non è un caso che nell"antiquarium alle-stito da Bartolomeo Ammannati in palazzo Pitti
14. Giambologna, Francesco I condotto da Mercurio al cospetto di Fiorenza, Madrid, Prado.
82
Materiali
intorno al 1561-62108, nelle cui nicchie era sta-ta collocata una serie di sculture descritte in un elenco pubblicato nella seconda edizione delle Vite di Vasari (1568), vi fosse non solo quel Mer-curio, di cui si sottolineava la provenienza dal Cortile del Belvedere, ma anche una copia bron-zea dello stesso109. È stata avanzata l"ipotesi che Cosimo I donasse poi quella replica ad Antonio Montalvo, il coppiere che aveva preso il posto di Sforza Almeni. Nel cortile di palazzo Montalvo a Firenze, infatti, !no all"inizio del Novecento era un Mercurio bronzeo che poteva esservi stato collocato subito dopo i lavori di costruzione del palazzo stesso, diretti dall"Ammannati a partire dal 1568, e che è stato poi ipoteticamente iden-ti!cato con quello oggi a Washington (!g. 6)110. Ma sarebbe altrettanto plausibile, forse più pro-babile, identi!care la replica bronzea già in pa-lazzo Pitti con quella oggi a Fontainebleau (!g. 15), assolutamente fedele all"originale (senza, cioè, la sostituzione del tronco con il bastone): si sarebbe cioè potuto trattare di un dono diplo-matico di Cosimo I a Caterina de" Medici111. Se all"imperatore Massimiliano il duca aveva mandato un"invenzione moderna, opera dello scultore più dotato della Firenze di quegli anni, non sarebbe certo sorprendente che egli avesse spedito invece una copia dal Mercurio già del Belvedere alla corte di Francia, dove certo sapeva che si conservava la più importante collezione di repliche bronzee dall"antico mai messa insieme nel Cinquecento: quella voluta da Francesco I e realizzata a partire dai calchi che Francesco Pri-maticcio aveva tratto nel 1544 dalle sculture più note di Roma, in particolare proprio da quelle del Cortile del Belvedere112. Cosimo da una par-te avrebbe spedito ancora una volta l"immagine del dio al quale amava essere associato e dall"altra avrebbe sottolineato come a Firenze si conserva-va una scultura un tempo in quel celebrato giar-dino romano, la prma che mai avesse lasciato il Cortile del Belvedere113.
Stefano PierguidiSapienza Università di Roma
15. Mercurio, Fontainebleau, Musée National du Château.
83
Materiali
NOTE
1. M. Spallanzani, $e courtyard of Palazzo Torna-buoni-Ridol% and Zanobi Lastricati#s bronze Mercury, in «6e Journal of the Walters Art Gallery», XXXVII, 1978, pp. 7-21 (Ciano Campagni, che !rmò l"opera in-sieme a Lastricati, probabilmente non intervenne in pri-ma persona nell"esecuzione del bronzo, cfr. ivi, p. 15); cfr. anche N. Penny, in A. Radcli$e, N. Penny, eds., Art of the Renaissance bronze 1500-1650: the Robert H. Smith col-lection, London 2004, pp. 36-40, n. 4.
2. G.A. Mansuelli, Galleria degli U&zi: le sculture, Roma, 1958-1961, I, pp. 50-51, n. 27.
3. Spallanzani, $e courtyard of Palazzo Tornabuoni-Ri-dol%, cit., p. 15.
4. Ancora recentemente è stata avanzata l"ipotesi, del tutto infondata, che la soluzione al problema fosse da ri-cercare nel diverso stile di datazione in uso a Firenze e a Roma, cfr. A. M. Gáldy, Cosimo I de# Medici as collector: antiquities and archaeology in sixteenth-century Florence, Newcastle, 2009, pp. 418-419, n. 76.
5. Cfr. in"a, nota 42.6. F. Haskell, N. Penny, Taste and the Antique: the Lure
of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven 1981, p. 266; J. Ozone, S.G. Sturman, Technical in!estigation of the Mellon Venus and Bacchus and a Faun, in P. Motture, ed., Large bronzes in the Renaissance («Studies in the History of Art», 64), atti del convegno, New Haven, 2003, pp. 209-210.
7. J. Cox-Rearick, $e Collection of Francis I: Royal Treasures, Antwerp, 1995, pp. 353-353, cat. X-6.
8. J.S. Ackerman, $e Cortile del Bel!edere, Città del Vaticano, 1954, p. 147, n. 7; sulle descrizioni antiche del Cortile del Belvedere cfr. anche K. Wren Christian, Empire without end: antiquities collections in Renaissance Rome, c. 1350-1527, New Haven, 2010, pp. 265-275.
9. Mansuelli, Galleria degli U&zi, cit., p. 50.10. G. Vasari, Le vite de# più eccellenti pittori, scultori e
architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di R. Bettarini, commento secolare di P. Barocchi, Firenze, 1966-1994, VI, p. 544; Collezionismo mediceo e storia ar-tistica, I, Da Cosimo I a Cosimo II, 1540-1621, a cura di P. Barocchi, G. Gaeta Bertelà, Firenze, 2002, p. 230.
11. C. Riebesell, Sulla genesi delle gallerie di antichità nell#Italia del Cinquecento, in C. Strunck, E. Kieven, eds., Europäische Galeriebauten - Galleries in a comparative European persepective (1400-1800), atti del convegno (Roma), Monaco, 2010, p. 201.
12. S. Deswarte-Rosa, Francisco de Holanda et le Corti-le di Bel!edere, in M. Winner, B. Andreae, eds., Il Cortile delle Statue: der Statuenhof des Bel!edere im Vatikan, atti del convegno, Mainz, 1998, pp. 406-407.
13. Ackerman, $e Cortile del Bel!edere, cit., p. 146, n. 5. B. Agosti (Intorno alla «Vita» gio!iana di Ra'aello, in Prospettiva», 110/111, 2003, p. 60, nota 53) ha avanzato l"ipotesi che il Mercurio oggi agli U#zi possa essere iden-
ti!cato con quello che, secondo quanto riportato da Pao-lo Giovio in una lettera del 1534-35, sarebbe stato ancora nelle Logge di Leone X e avrebbe fornito il modello per il Mercurio ra$aellesco che compare nel Banchetto degli dèi della Loggia di Psiche alla Farnesina (1518 circa). La statua, quindi, sarebbe stata rinvenuta molti anni prima e, dopo essere stata a lungo esposta nelle Logge, sarebbe stata trasferita nel Cortile del Belvedere poco prima della visita a Roma di Fichard. In realtà, però, la posizione delle gam-be del Mercurio degli U#zi è completamente diversa da quella del Mercurio negli a$reschi della Farnesina, vicina invece al modello che, secondo Giovanni Pietro Bellori, avrebbe ispirato Ra$aello, il cosiddetto Antinoo Farnese.
14. W. Gramberg, Die Düsseldorfer Skizzenbücher des Guglielmo della Porta, 2 voll., Berlin 1964, I, p. 107; B. Jestaz, Copies d#antiques au palais Farnèse: les fontes de Guglielmo della Porta, in «Mélanges de l"École Française de Rome. Italie et Méditerranée», CV, 1993, p. 47. Sulla copia di della Porta cfr. in"a note 20, 66-68, 104.
15. Ackerman, $e Cortile del Bel!edere, cit., pp. 63 e 158, doc. 34.
16. Mansuelli, Galleria degli U&zi, cit., p. 50; Haskell, Penny, Taste and the Antique, cit., p. 267.
17. Il disegno potrebbe addirittura essere testimonianza di quello che sarebbe da considerarsi come un rarissimo, forse il primo in assoluto, intervento di de-restauro. Pochi anni prima dell"arrivo di Francisco de Hollanda a Roma il dio greco sarebbe stato restaurato una prima volta: nella mano destra sarebbe stato il classico caduceo, o un /auto, mentre la sinistra poteva essere appoggiata al !anco, in quella che doveva essere la posizione originaria del giova-ne poi restaurato come Mercurio; secondo questa ipotesi al 1538-40, poi, sarebbe databile il secondo intervento te-stimoniato dai disegni dell"artista portoghese. Sul restau-ro dell"antico nel Rinascimento cfr. soprattutto O. Rossi Pinelli, Chirurgia della memoria: scultura antica e restauri storici, in Memoria dell#antico nell#arte italiana, a cura di S. Settis, Torino, 1984-1986, III, in particolare pp. 181-195.
18. L"ipotesi non sembra molto probabile, ma a questo proposito si pensi alla vicenda del Bacco di Michelangelo già in casa Galli a Roma (Firenze, Museo Nazionale del Bargello), cfr. K. Wren Christian, Michelangelo#s Bacchus and «Forgeries» in Renaissance Collections of Ancient Sculpture, in C.C. Mattusch, A.A. Donohue, A. Brauer, eds., Common ground. Archeology, Art, Science and Hu-manities, atti del convegno, Oxford, 2006, in particolare p. 254.
19. P.A. Ma$ei, Raccolta di statue antiche e moderne, Roma, 1704, col. 56.
20. Sull"identi!cazione di quell"esemplare cfr. note 66-68.21. Si vedano, ad esempio, le statue già nella collezione
di villa Medici, cfr. C. Gasparri, scheda in A. Cecchi, C. Gasparri, Le collezioni del cardinale Ferdinando: i dipinti e le sculture (La Villa Médicis, 4), Roma, 2009, pp. 138-140; cfr. anche G. Siebert, Hermes, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, V/1, Zürich, 1990, pp. 285-387.
84
Materiali
22. Cfr. nota 76.23. U. Aldrovandi, Delle statue antiche, che per tutta
Roma, in diuersi luoghi et case si veggono, in L. Mauro, Le antichità de la città di Roma, Roma, 1556, p. 121.
24 Su questo punto cfr. anche in"a, note 43-44.25. D. Giannotti, Lettere, in «Giornale Storico degli Ar-
chivi Toscani», VII, 1863, p. 238.26. Spallanzani, $e courtyard of Palazzo Tornabuo-
ni-Ridol%, cit., pp. 13 e 19, doc. 5.27. Aldrovandi, Delle statue antiche, cit., p. 292.28. Ibid.29. J.-R. Gaborit, Le cupidon de Manhattan: un Mi-
chel-Ange retrouvé?, Paris, 2000, p. 9; D. Pegazzano, La collezione di antichità di Bindo Alto!iti, in A. Chong, D. Pegazzano, D. Zikos, a cura di, Ritratto di un banchiere del Rinascimento. Bindo Alto!iti tra Ra'aello e Cellini, catalo-go della mostra, Milano, 2004, p. 355.
30. D. Gallo, Ulisse Aldro!andi, «Le statue di Roma» e i marmi romani, in «Mélanges de l"École Française de Rome. Italie et Méditerranée», CIV, 1992, pp. 485-486.
31. Sulla collezione del cardinale Ridol! cfr. anche C. Elam, Art in the service of liberty: Battista della Palla, art agent for Francis I, in «I Tatti Studies», V, 1993, pp. 54-55.
32. Giannotti, Lettere, cit., p. 223.33. A. Boström, Ludo!ico Lombardo and the taste for the
all’antica bust in mid-sixteenth-century Florence and Rome, in Motture, ed., Large bronzes, cit., pp. 166-168.
34. G. Costa, Michelangelo alle corti di Niccolò Ridol% e Cosimo I, Roma, 2009, pp. 50-52.
35. M. Hirst, Michelangelo and his %rst biographers, in «Proceedings of the British Academy», LXXXXIV, 1997, pp. 78-80; D. Zikos, Il busto di Bindo Alto!iti realizzato da Ben!enuto Cellini e i suoi antecedenti, in Chong, Pegazzano, Zikos, a cura di,Ritratto di un banchiere, cit., pp. 144-145.
36. Zikos, Il busto di Bindo Alto!iti, cit., pp. 137-138.37. La fama del Laocoonte e dell"Apollo del Bel!edere è
tanto ampia da non essere necessario rimandare ad una bibliogra!a speci!ca; per la Cleopatra, in realtà un"Arian-na, cfr. P. Pray Bober, R. Rubinstein, Renaissance artists & antique sculpture: a handbook of sources (London, 1986), London, 2010, pp. 125-126, n 79; per il Torso del Bel!e-dere cfr. nota 44.
38. Vasari, Le vite, cit., VI, p. 544.39. A. Michaelis, Geschichte des Statuenhofes im vatican-
ischen Bel!edere, in «Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts», V, 1890, pp. 7 e 44, nota 169.
40. Ivi, p. 39, nota 142.41. Ivi, p. 40, nota 14942. H. von Voltelini, Urkunden und Regesten aus dem
K.U.K. Haus-, Hof-, und Staats-Archiv in Wien, in «Jahr-buch der Sammlungen», XI, 1890, p. LXXV, n. 6510; Jes-taz, Copies d#antiques, cit., p. 15, nota 17.
43. Pray Bober, Rubinstein, Renaissance artists, cit., pp. 188-189, n. 137.
44. Ivi, pp. 181-184, n. 132; Vasari, Le vite de# più eccel-lenti pittori, cit., IV, p. 7.
45. Sulla fortuna della !gura di Ercole a Firenze (e sul-la sua associazione a quella di David) cfr. almeno M.M. Donato, Hercules and David in the early decoration of the Palazzo Vecchio: manuscript evidence, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», LIV, 1991, pp. 83-98, in particolare pp. 83-90 e F. Caglioti, Donatello e i Medici: storia del David e della Giuditta, Firenze, 2000, passim, in particolare pp. 246 e 262; sulle Storie di Ercole dei Pollaiolo cfr. A. Wright, $e Pollaiuolo brothers: the Arts of Florence and Rome, New Haven, 2005, pp. 75-86; sulle satire rivolte contro l"Ercole e Caco di Bandinelli cfr. da ultimo G. Masi, Le statue parlanti del cavaliere e altri prodigi pasquineschi %orentini (Bandinelli, Cellini, Miche-langelo), in C. Damianaki, P. Procaccioli, A. Romano,a cura di, Ex marmore: pasquini, pasquinisti, pasquinate nell#Europa moderna, atti del convegno, Manziana, 2006, in particolare pp. 230-234 (con bibliogra!a precedente).
46. Ph. Sénéchal, Gio!an Francesco Rustici: 1475-1554; un sculpteur de la Renaissance entre Florence et Paris, Paris, 2007, pp. 98-102 e 196-198, n. 17.
47. M. Bormand, scheda in F. Viatte, M. Bormand, V. Delieuvin, Baccio Bandinelli: dessins, sculpture, peinture (Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, In!entaire géné-ral des dessins italiens, 9), Paris, 2011, pp. 280-282, S1; S. Pierguidi, Il Mercurio di Bandinelli al Louvre: una scultu-ra per il cortile di palazzo Medici a Firenze, in «Arte Do-cumento», XXVIII, 2012, pp. 122-129.
48. La studiosa tedesca ha anche discusso altre opere citate nel presente articolo, dal Mercurio del Bel!edere al Mercurio di Lastricati, !no a quello di Giambologna (S. Brink, Mercurius Mediceus: Studien zur panegyrischen Verwendung der Merkurgestalt im Florenz des 16. Ja-hrhunderts, Worms, 1987, pp. 63-64 e 91-95), ma il suo libro non è stato preso adeguatamente in considerazione dalla critica successiva.
49. Brinck, Mercurius Mediceus, cit., pp. 50-51 e 65.50. Su questo tema cfr. in particolare lo studio di E.
McGrath, Il senso nostro: the Medici allegory applied to Va-sari#s mythological "escoes in the Palazzo Vecchio, in G.C. Garfagnini, a cura di, Giorgio Vasari tra decorazione am-bientale e storiogra%a artistica, atti del convegno, Firenze, 1985, pp. 117-134.
51. Brinck, Mercurius Mediceus, cit. pp. 49-69.52. G. Vasari, Le Opere, a cura di G. Milanesi, Firenze
1906, VIII, Ragionamenti (Firenze, 1588), p. 25; Brinck, Mercurius Mediceus, cit., pp. 50-51.
53. E. Allegri, A. Cecchi, Palazzo Vecchio e i Medici: gui-da storica, Firenze, 1980, p. 65.
54. Cfr. nota 67.55. Collezionismo mediceo, cit., p. 331.56. P. Zanker, Klassizistische Statuen, Mainz, 1974, p.
54, n. 6.57. Haskell, Penny, Taste and the Antique, cit., p. 266.58. M.L. Levko$, Hearst and the Antique, in «Apol-
lo», CLXVIII/558, 2008, pp. 57-58 (per la replica di Kedleston Hall, cfr. A. Hersey Allison, $e Bronzes of Pier
85
Materiali
85
Jacopo Alari-Bonacolsi, called Antico, in «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien», LXXXIX/XC, 1993/1994, p. 174, nota 705).
59. Zanker, Klassizistische Statuen, cit., pp. 54-55.60. Siebert, Hermes, cit., pp. 285-387.61. Allison, $e Bronzes of Pier Jacopo Alari-Bonacolsi,
cit., pp. 38-39.62. Ivi, pp. 51 e 59.63. Ivi, pp. 177-178, n. 22b.64. Ivi, pp 172-176, n. 22a.65. L. Sensi, La collezione archeologica, in Gli Orti farne-
siani sul Palatino, atti del convegno, Roma, 1990, p. 390, !g. 35; B. Jestaz, L#in!entaire du Palais et des propriétés Farnèse à Rome en 1644 (Le Palais Farnèse, 3, III), Rome 1994, p. 201, n. 4896; per la citazione del perduto bronzo di della Porta cfr. Jestaz, L#in!entaire du Palais, cit., p. 187, 4526: «Una statua di bronzo d"un Mercurio poco più pic-cola del naturale, con piedistallo di noce intagliato».
66. Jestaz, Copies d#antiques, cit., p. 20.67. Sulla vicenda della vendita a Ottavio Farnese cfr.
prima di tutto C. Riebesell, Die Sammlung des Kardinal Alessandro Farnese: ein «studio» für Künstler und Ge-lehrte, Weinheim, 1989, p. 54. Jestaz (Copies d#antiques, cit., pp. 15-17) ha ricollegato i bronzi poi venduti a Ot-tavio Farnese a un pagamento a della Porta del 10 giugno 1564: Sudi 3 di moneta a frate Guglielmo del Piombo cont.i a Mercurio suo servitore per pagarne tre banche larghe e doi scabelletti per posarvi sopra otto historie del-la vita di Gesù Cristo, cinque teste et 4 statue di metallo fatte per lui in Belvedere d"ordine di N. S. et poste nelle (s)tantie nove, cfr. ibidem, p. 15, nota 19. C. Riebesell (Guglielmo della Porta, in Palazzo Farnese: dalle collezio-ni rinascimentali ad ambasciata di Francia, catalogo del-la mostra a cura di F. Buranelli, Firenze, 2010, pp. 259 e 261, nota 39) ha fatto però notare che in quel documento si menziona anche la serie con le Storie di Cristo che non vennero poi fuse: secondo la studiosa, quindi, quei bron-zi non sarebbero stati commissionati, ma solo o$erti in vendita al ponte!ce. È e$ettivamente di#cile che della Porta si imbarcasse in un"impresa simile se non in seguito ad una commissione, ma il pagamento del 1564, relativo solo ai basamenti, non attesta l"avvenuta fusione di quelle statue, che infatti non furono acquistate da Pio IV prima della sua morte. Probabile, allora, che lo scultore avesse realizzato i calchi, e magari anche qualcuno dei bronzi, senza però portare a termine il lavoro entro il 1565: in caso contrario le statue sarebbero approdate in Vaticano. Il Mercurio, quindi, potrebbe essere stato fuso solo molto più tardi, al momento della stipula della vendita a Otta-vio Farnese.
68. Cfr. note 6 e 110.69. B. Jestaz, A propos de Willem van Tetrode, alias Gu-
glielmo Fiammingo, in «Revue de l"art», 148, 2005, p. 13, nota 9.
70. Voltelini, Urkunden und Regesten, cit., pp. LXXXI-II, n. 6544; Jestaz, A propos de Willem van Tetrode, cit., p. 12.
71. Sui bronzetti dello studiolo Orsini cfr. soprattut-to A.M. Massinelli, a cura di, Bronzetti e anticaglie dalla guardaroba di Cosimo I, catalogo della mostra, Firenze, 1991, pp. 80-100; A. Giannotti, Precisazioni e aggiunte per il «%ammingo» Willem Tetrode, in «Prospettiva», 95-96, 1999, pp. 173-176; Willem van Tetrode, sculptor (c. 1525-1580) = Guglielmo Fiammingo scultore, catalogo della mostra a cura di F. Scholten, Zwolle, 2003; Jestaz, A propos de Willem van Tetrode, cit.
72. C. Avery (Giambologna: la scultura, Firenze, 1987, p. 125) ritiene comunque più probabile che il Mercurio arrivasse a Firenze nel 1562 con gli altri bronzetti; M. Leithe-Jasper (Il Mercurio !olante. Il problema della %gura serpentinata, in Giambologna: gli dei, gli eroi, catalogo del-la mostra a cura di B. Paolozzi Strozzi, D. Zikos, Firenze, 2006, p. 255) pensa sia stato realizzato proprio a Firenze, ma tende ad escludere un"in/uenza diretta di quella sta-tuetta su Giambologna.
73. Al Mercurio di Tetrode si rifece Giovanni Stradano per un"incisione del 1587, cfr. A. Baroni, scheda in Ma-gni%cenza alla corte dei Medici: arte a Firenze alla %ne del Cinquecento, catalogo della mostra, Milano, 1997, p. 282, n. 228.
74. Jestaz, A propos de Willem van Tetrode, cit., p. 9.75. Willem van Tetrode, sculptor, cit., p. 34.76. Ivi, p. 67.77. Vasari, cit., VI, pp. 248-249.78. R. Borghini, Il Riposo, Firenze, 1584, pp. 586-587.79. M. Leithe-Jasper, scheda in Giambologna, cit., pp.
261-263, cat. 54.80. W. Cupperi, scheda in Giambologna, cit., p. 258,
cat. 52.81. M.G. Vaccari, scheda in Giambologna, cit., p. 208,
cat. 57.82. E. Dhanens, Jean Boulogne: Gio!anni Bologna
Fiammingo Douai 1529-Florence 1608. Bijdrage tot de studie van de kunstbetrekkingen tussen het graafschap Vlaanderen en Italie, Brussel, 1956, p. 124, cat. XV.
83. L.-O. Larsson, Zwei Frühwerke !on Adrian de Fries, in Netherlandish mannerism, atti del convegno a cura di G. Cavalli-Björkman, Stockholm, 1985, pp. 117-126; D. Diemer, Giambologna in Germania, in Giambologna, cit., p. 107.
84. Avery, Giambologna, cit., pp. 125-127.85. R. Tuttle, Il palazzo dell#Archiginnasio in una rela-
zione inedita di Pier Donato Cesi al cardinale Carlo Borro-meo, in G. Roversi, a cura di, L#Archiginnasio: il palazzo, l#università, la biblioteca, Bologna, 1988, I, pp. 68-85, in particolare pp. 69 e 83-85.
86. I. Lavin, «Bologna è una grande intrecciatura di ere-sie»: il Nettuno di Giambologna al crocevia, in Il luogo ed il ruolo della città di Bologna tra Europa continentale e mediterranea, atti del convegno a cura di G. Perini, Bo-logna, 1992, p. 17.
87. Leithe-Jasper, Mercurio, in Giambologna, cit., pp. 255-257.
86
Materiali
86
88. Jestaz, A propos de Willem van Tetrode, cit., p. 14, nota 29.
89. W. Gramberg, Gio!anni Bologna: eine Untersu-chung über die Werke seiner Wanderjahre (bis 1567), Li-bau, 1936, pp. 97-98; 93-101.
90. Gramberg, Gio!anni Bologna, cit., p. 103.91. Ivi, p. 93.92. R. Tuttle, Piazza Maggiore: studi su Bologna nel
Cinquecento, Venezia, 2001, p. 196.93. Gramberg, Gio!anni Bologna, cit., p. 101.94. Ivi, pp. 103-104.95. Ivi, p. 107.96. Ivi, pp. 105-106. Altre lettere furono inviate da
Bologna a Firenze, nel corso del 1565, dal successore di Cesi alla carica di governatore, il cardinale de Crassi, cfr. S. Eiche, Giambologna#s Neptune fountain in Bologna: newly-disco!ered letters "om 1565, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XXXVIII, 1994, pp. 428-429.
97. Gramberg, Gio!anni Bologna, cit., pp. 107-108.98. A. Bacchi, scheda in Il Michelangelo incognito:
Alessandro Menganti e le arti a Bologna nell#età della Controriforma, catalogo della mostra a cura di A. Bacchi e S. Tumidei, Ferrara, 2002, pp. 113-119, cat. 1; R. Prei-mesberger, scheda in Giambologna, cit., pp. 161-162, cat. 3.
99. W. Cupperi, scheda in Giambologna, cit., p. 258, cat. 52.
100. R. Manno Tolu, scheda in I Medici e l#Europa 1532-1609: la corte il mare i mercanti, catalogo della mostra a cura di C. Ciano (Firenze e la Toscana dei Medi-ci nell#Europa del Cinquecento, IV), Firenze, 1980, p. 46; A. Petrioli, Mostra di disegni vasariani: carri trionfali e costumi per la Genealogia degli Dei (1565), catalogo della mostra, Firenze, 1966, p. 5.
101. Per questo rilievo cfr. T. Mozzati, scheda in Giambologna, cit., p. 232, cat. 36.
102. Ibid.103. D. Heikamp, scheda in Giambologna, cit., pp.
155-156, cat. 1.104. Vasari, Le vite de# più eccellenti pittori, cit., VI, p.
249.
105. P. Motture, scheda in Giambologna, cit., p. 235, cat. 39; cfr. anche T. Mozzati, scheda ivi, pp. 237-238, cat. 41.
106. Su tutti i precedenti del Mercurio di Giambologna cfr. Avery, Giambologna, cit., pp. 124-125.
107. Tuttle, Il palazzo dell#Archiginnasio, cit., pp. 72-73.108. M. Daly Davis, La galleria di sculture antiche di
Cosimo I a Palazzo Pitti, in Le arti del principato mediceo, Firenze, 1980, pp. 31-54.
109. Vasari, Le vite de# più eccellenti pittori, cit., VI, p. 544.
110. G. Gandi, Il Palazzo Ramirez di Montal!o Mat-teucci di Bartolommeo Ammannati, Firenze, 1932, pp. 15 e 18, nota 1; Jestaz, Copies d#antiques, cit., p. 20; cfr. anche nota 6. Su Montalvo cfr. C. Davis, Frescoes by Vasari for Sforza Almeni, «Coppiere» to duke Cosimo I, in «Mit-teilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XXIV, 1980, p. 195, nota 143.
111. Sui rapporti tra Cosimo I e Caterina de" Medici negli anni che avrebbero potuto vedere l"invio di quella statua bronzea in Francia cfr. E. Palandri, Les négocia-tions politiques et religieuses entre la Toscane et la France à l#époque de Cosme I et de Catherine de Médicis (1544-1580) d#après les documents des Archives de l#État à Flo-rence et à Paris, Paris, 1908, pp. 99-108.
112. G. Bresc-Bautier, Parisian casters in the sixteenth century, in Motture, ed., Large bronzes, cit., pp. 98-99; G. Bresc-Bautier e D. Cordellier, Primaticcio e le «antiquail-les exquisses», in D. Cordellier, a cura di, Primaticcio: un bolognese alla corte di Francia, catalogo della mostra, Mi-lano, 2005, pp. 112-114. L’ipotesi di Janet Cox Rearick ($e Collection of Francis I, cit., pp. 353-353, cat. X-6), secondo cui il calco da cui venne tratto il bronzo di Fon-tainebleau sarebbe identifcabile con quello a cui in un do-cumento del 1545 ci si riferisce come ad uno ricavato dalla «statua Antinoi», non è convincente: di#cile, infatti, ipotizzare un errore così grossolano negli attenti registri dei Comptes des batiments.
113. Secondo questa ricostruzione, mancherebbe quin-di all"appello il Mercurio già nel cortile di palazzo Montal-vo, sul cui destino non è possibile avanzare alcuna ipotesi.

























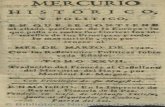








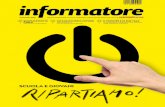





![Nello splendore mediceo. Papa Leone X a Firenze [catalogue entries/schede di catalogo]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631778452b00f6ff440695c8/nello-splendore-mediceo-papa-leone-x-a-firenze-catalogue-entriesschede-di-catalogo.jpg)


