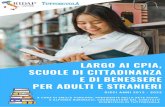Matrimoni mancati. 'Pericolate' e 'gravide occulte' dell'ospizio di Orbatello di Firenze nel XVIII e...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Matrimoni mancati. 'Pericolate' e 'gravide occulte' dell'ospizio di Orbatello di Firenze nel XVIII e...
SIDCSSOCIETÀ ITALIANA DI DEMOGRAFIA STORICA
NUBILI E c-E-LIpIr R A s c E lrn-È-c-o§TRlzlq N E'iSe-c-ot-t xvl-xx):.. MARGARETH LANZINGER E RAFFAELLA SARTI
FORUM
Indice
,.lieth I-anzingel, Ratfaellzr Sarti
casi di studio."
-. :5r'ì Àlc!1lo11'.;,;1;:;!ltri'i. Ld ttotrilineatlltì ne I ntotttts/eri fetnrutnili /ioteutittt
\, .-,:'iit.). il crt.ro dr 5'anta \''e rtlt.and'
. -.: Er ;rr-rgelisti
;,;:!l tr,r Cinque e SeiLettlo
. . i.iolo trlazzonis, ,,pi,ittroli, intliutt/tLi tncttleutl Il caso de/le ortoline
: , -,i,r )"It'rici (lrit-111())
.l-.r Srrrtclri' , ':;1rtili Lttttnctrti.'PericoLotc' a'grdulde ocurltL'' Jcll'r'tsptzir''
' '.t::ilo ,Ji ble ttze nel X\rlll t: XIX stcolo
i., :.iL'r Car,nllo,| :,.;,itr.,ttIr.t c tttascolittit,t. Uotttitti ttÙIt \;ft(tsL!I/ neI tttont/o
';..;,ittr., tJtl Sal e 5€ltecet/1.)
ti
pa-s
.:l()
1l
i1
11
r 1i
9l
.,.rIgareth Lanzinger',.., rctc1età di nubili e calibi?
- .': ()t/ocentct
,.,rsclo D'Ambr:osicl
',:ri lli e ct'libi nt:llo- stn'ttttrta:, .t .\t'ttc t: Otlctcettto
ln rld iqìn t' s tl /111 il ut lltt ttt / iro/cst'
s o c t o - p t oJ'e.\ s i o n tt.l t' d. I Rtr u t tli P u gl i u
1ii
Matrimoni mancati'Pericolate' e'gravide occulte'
dell'ospizio di 0rbatello di Firenzenel XVIII e XIX secolo
LUC]A SANDRI
1,. Premessa. L-assistenza alle gravide e alle partorienti, fuori dal contesto familia-
:: i testimonrata, aFirenze, già dalla fine del XVII secolo nell',ospizio per tagazzr
,::andonati, fondato da San Filippo Neri, in via dei cimatori, e poi, sistematica-
::.:rre, dai primi del XV[i secolo, nell'ospizio di orbatello per donne sole e anzia-
-:. posto in via della Pergola (Carrara t999). Fu l'ospizio di Orbatello, fondato alla
,.- d"1 XIV secolo da un esponente della casata fiorentina degli Alberti per porta-
:= .o1lievo alle vedove e alTe anziane in genere, ad essere investito dal governo gran-
*--:a1e, nel corso de1 Settecento, anche dell'assistenza alle donne incinte. Le giova-
.- jonne, che chiedevano aiuto a1le vecchie ospitate in Orbatello erano tutte, oltre
- --. grayide e più o meno prossime al parto, in situazioni di marginaiità: nubili, pro-
.--,'.,,", adultere o ..rpport" tali. Uno stfano connubio umano dunque quello di
- ::ate11o, dove f isolamento sociale del1e donne, de1le anziane e delle 'incinte', finì
-,=: rrasformarsi da solidarietà di genere in una vera e propria prassi assistenziale
:,:blica, che si tramutò anche in acquisizioni medico-scientifiche a vantaggio di
=::'.ìde e parroriertti.Il progr.rro dell'ostetricia a Firenze, nel XVIII secolo, venne ad inffecciarsi sia
- * ]e uicende cli Orbatello che con quelle del vicino ospedale degli Innocenti,
:-:inaro all'origine a funzioni esclusive di brefotofio. Ne1 1756, ne1l'ambito della
:.1:larrrzzazio.r" d"Uu disciplina chirurgica, fu creata una cattedra specifica di
,:etncia in Santa Maria Nuova, il maggiore ospedale fiorentino, situato a poca
,.s:enzasia da Orbatello che da1 medesimo brefotrofio degli Innocenti. Pochi anni
:::o. ne1 17 (i, proprio in orbatello, il luogo del parto, venne istituita una scuola
--. .u[i"rr. ostet;ich; dela città, abbinata all'accoglienza delle nubili incinte. Nel
---r. l'am-inistrazione di Orbatello, compresa quella del1a scuola per ostetriche,
:::ne affidata dal Granduca agli Innocenti, fitenuto luogo moralmente più conso-
-,: ed ospitare 1e allieve. Da questo momento, come è noto in particolare dagli studi
' -1nna beli nazzi (Belhnazzi 1999) e di Francesca Rampinelli (Rampinelli 1999) , ai
:-'.;li rimancliamo per i necessari approfondimenti, l'ospedale degli Innocentil.:.'eme, con Orbatello, la sede dell'apprendimento ostetrico e del progresso scien-
::co in quest'ambito disciplinare. Furono le gravide illegittime dunque a contri-
:rire. a Éi."nr", a1lo sviluppo de11a conoscenzain campo ostetrico, come pure si
j-.;e alle istituzioni di assisienza (Orbate11o, gli Innocenti) la promozione dell'at-
-.:rzione medico-scientifica alla fisiologia e alla patologia de1 corpo femminile
\e1 1816, Ferdinando III oryanizzò agli Innocenti un a1ffo luogo per partorire'
Lucre Saruonr
creando, nell'ottica della morale del tempo, l'ospizio di Maternità per donne <<one-ste e miserabili», dotato di una propria scuora di ostetricia, riservata, diversamenteda77'altra di Orbatello, alle allieve della campagna e clel circondario amministrativofiorentino. Le donne regoiarmente.porrr.ìi sottoposero alle visite e ai parto nelnuovo ospizio, per <<servir di soggetto alla scuola>> e usufruire del compenso previ-sto (Bellinazzi I999,l8). Nel 1861, i due ospizi, queilo per le ,gravide
occulte, diorbatello e quello per le 'donne povere e oneste', à le rirpettiue Lrol. di ostetricia(.di città e. di campagna), furono riuniti nel brefotrofio d"gli Irrno..nti. Dal rg77 , adistanza di quasi un secolo da11'a'"wenuta convergenza amministrativa e di luogo agJìInnocenti, scuole e ospizi passarono definitivamente sotto la gestione dell,osieda'legenerale di santa Maria Nuova. Gli anni lg77 -Lglg possono Àsere assunri, a segui-to di tale awenimento, come data d'ingresso, a Firenze, deila pratica dell,osteliciain ospedalel.
11 progresso scientifico era dunque definitivamenre passato in quest,ambitodjsciplinare dai luoghi dell'assistenza a quelli preposti ,Jlu ,ur^e a1la sperimenta-zione. Di contro, su1 piano assistenziale, il consoiidarsi di una prassi di assistenzapubblica, awiò ai primi del Novecento un aiuto sisrematico u1L iugurrc madri, fina-Tizzato al riconoscimento dei figli (Sandri 2OO2b,42-4j).
Le memorie documentarie relative all'assistenza alle 'gravide occulte,, ricevutenell'ospizio di orbatello, sono conservate, oltre .h. p..io l,Archivio di Stato diFirenze, in quello del brefotrofio, oggi Istituto d.gii Irrnocenti. Lindagine, chesegue, è stata condotta su queste memorie allo scopo di portare alia l,rle, per i1xvi[ e il XIX secolo, un aspetto della marginalità femminile non ancora sufri-cientemente invesrigaro dagli storici: quello delle nubili incinte, 1e
,pericolare,, le
'gravide occuite'. Per il settecento, il periodo analizzato.op." gii anni dal 7756 al17 66 e segue 1a fondazione, avvenuta nel 71 56, in Santa Mària
"Nuova, della catte-
dra di ostetricia el'af{idamento deil'incarico di insegnamerro , òi,rr"ppe Vespa,personaggio autorevole in quest'ambito, cui fu affidato anche quello nella scuolaper ostetriche di orbatello (Bdlinazzi 1999,36-37). per l,ottocàto, la ricerca si èTimitata a-ll'assunzione dei dati per gli anni lg39 e rg45,ad alcuni decenni di distan_za cioè dalf istituzione, agli Innocenti, dell'osp izio diMaternità per le donne ,one_
ste e miserabili', allo scopo di verificare se fosse intervenuta unai.,alche modifica-zione nell'assistenza alle'gravide occu-lte', arle nubili cioè, che.orìdn.rrrrurro, pur_torire nell'ospizio distaccato di Orbatello.
, una campionaturakmitata,dunque, quella presentata per i due secoli, partico-larmente quel1a per il XÌX_secolo, .h. hu p..-esso però di scoprire, restituendoglivoce e dignità, uno stuolo di donne, io avanzato stat; di gravid,anza,provenienti perla maggior parte da fuori città, da aree rura-li e povere, con un unico proble-r, pr.-torire fuori dall'ambito familiare, di lavoro lrei caso delle serve) ed àchssare, insie_me all'evenro, anche i propri neonati. sgravatesi nel luogo della carità ma anche deldisonore, le donne, in genere, ripartono dopo brevI, brevissime permanenze.Alcune, tuttavia, non reggono alf impatto de1 iuogo, al tauma del partorire trae.stranei, lontano dai paesi di origine, e trovano ir coraggio di ripartire col loro far-dello prima deli'evenro del parto. In questo .uro ir io.Ji"rti.ro .i è ignoto.
72
Matrìmoni mancati
Tale studio, in ultimo, segue, assumendone i risultati a confronto, due altri pre-cedenti lavori, che hanno avuto per oggetto, in un caso, le vicende delle rovatelleJell'ospedale degli Innocenti, vittime, nel1a prima metà dei Settecento, di violenzer-.iche, sessuali e morali (Sandri 2002a)2 e, nell'alto, quelle delle 'balie di casa', le::ubili cioè, assunte come nutrici, ra XVII e XIX secolo, nel brefotrofio fiorentino,jopo aver partorito da 'occulte' in alffi ospizi della Toscana, e madri, talvolta, dei:ambini abbandonati agli Innocenti (Sandri 2002b). Que1lo de1la mobilità, meglio.:rebbe dire dello scambio da un ospedale all'altro de1l'area toscana, de1le nubili:rcinte in procinto di partorire, è un dato accertato: si partoriva lontano dai luoghi:r origine e, ugualmente, si chiedeva poi (sino quasi alla fine del XVIII secolo) di-ssere prese in servizio come balie, lontano dal luogo del parto, che non sempre
:.-rirlcideva con i1 luogo dell'abbandono dei bambini. Una strategia complessa,
:rcettata di buon grado dai brefotrofì sempre carenti di nurici, pronte, in casa, a
::r fronte ai bisogni dei piccoli appena accolti. Le madri nubili, è vero, accresceva-
.-!r i-l numero dei trovatelli ma erano indispensabili per il loro sostentamento, dato
--:re raramente una donna sposata avrebbe accettato di ricoprite i1 ruolo di 'balia di:esa' in un brefotrofio. Ragione questa che giustifica di per sé, insieme ad una mino-:. incidenza dei costi di allattamento, 1a secolare abitudine dei brefotrofi di inviare, -rovatelli a balia presso i1 domicilio delle donne. Un fenomeno, inoltre, quel1o
::Llo spostamento de1le nutrici nubili, strettamente collegato a quello del mercato:=1 latte, regolato dall'offerta e da1la domanda di balie. Se 1'offerta dipendeva dal1a
-r:esenza di madri povere, sposate o nubili che fossero, 1a domanda era determina-
:: sia dalie istituzioni assistenziali che dai privati, desiderosi di inviare il più presto
:..ssibile i propri figli a balia fuori casa (Sandri 7991 e 2002b,22-26). Erano i sala-
:-- dei privati, più alti di quelli corrisposti dagli ospedali, a togliere, se mai, nel giroj: poco tempo (due, tre mesi), madri e nutrici ai piccoli tovatelli ed era 1a donna::osata, e non la nubile, 1a balia più ambita dal1e ricche famiglie toscane.
È così che 1e gravidanze, seguite a eventi traumatici, come la violenza, le mancate
:.omesse di matrimonio, f impossibilità di costituire una famigLia regolare, linivano:rr avere tuttavia ritorni econornici, che andavano oltre i1 tornaconto personaie, coin-'.'..lgendo istituzioni, intermediari e famiglie d'origine, che dopo aver scacciato la figlia:-:bi.1e hcinta se ne riappropriavano come produttrice di reddito familiare. Del resto
:oco altro era possibile fare, i processi per inadempienza della promessa matrirlo-::ale erano diminuiti già dal XVII secolo, sia nel foro religioso arcivescovile che in:-uei1o civile e la prova dello stupro, nei casi interessanti la ruota criminale, era quasi
:::rpossibile da fornire (Alessi 1995,238; Lombardi 2001,319 326).
Qualcosa si è cercato allora di comprendere, anche su ciò che stàvà à monte del-
-'irrivo nell'ospizio de11e gravide, con una breve indagine, condotta tra le carte
:-ll'Archivio di Stato di Firenze, nei fondo de1la Magistatura Criminale degli Otto* Balia del Principato, relativamente ad alcune annate del XVIII secolo. Non tutte
-. donne vittime di abusi però rimanevano incinte, solo poche sporgevano querela,
:.--isuna otteneva giust izia.
Le donne che troviamo a sgravarsi in Orbatello non divennero quasi mai spose
::l padre del bambino che portavano in grembo e non ebbero da lui altro risarcimen-
73
Lucre Sntoni
to - ma solo nei casi in cui si sospettava un evento pregresso di violenza - che il paga-mento delie spese del parto. Diversamente, più o meno a1la stessa epoca, quasi tutte le'nocentine' violate (Sandri 2002a) o andarono spose o ebbero la dote. Per ognuna diloro l'ospedale intentò un processo criminale, sporgendo querela alla Magistraturadegii Otto. I- ospedale dunque risultava alla fine protettivo nei confronti del1e proprieassistite e le trovatelle potevano sperare in risarcimenti moral.i ed economici.
Ancora differente è il quadro nella prima metà dell'Ottocento. La tutela de11e
donne, relativamente all'onore e alf integrità sessuale, appare principalmente affi-data all.a comunità religiosa di appartenenza, a7 popolo, alla parrocchia, alla fami-glia. Si rafforza, in particolare, in quest'ambito, la figura del parroco, invesrito, orapiù che mai, della tutela delle donne e dell'appuramenro della loro responsabilitànel compimento del male (sandri 2001, 17i-ll]). Lo scavo psicologico proseguenelJ'ospizio, dove le giovani sono attentamente osservare per ricosiruirne il profilointeriore, metterne a nudo l'anima, comunque essa si manifesti.
Lo studio che segue è infine l'epilogo di un via vai, tta ospizi e ospedali, didonne disperate: violentate, 'castigate', gravide, puerpere col perto gonfio di latte,offerto, a partire dil 1191, almeno a Firenze, obbligatoriamente al brefouofio,luogo di accoglienza, ormai da quest'epoca, dei bambini partoriti in orbatello(Sandri 2002b,29).
2. Prima dell'ospizio: querete e suppliche a[[a Magistratura degti Otto ne[[aprima metà det XVIII secolo. Prima di presentare I'analisi dei dati, ricavati dai regi-stri di ammissione delle gravide occulte, entrate in Orbatello ta 1l ll55 e tl 17 66, èforse di qualche interesse fornire il risultato di una breve indagine svolta, per ilprimo Settecento) su una campionatura di testimonianze, conservate pressoI'Archivio di Stato di Firenze, prodotte a seguito di ricorsi (1e querele), inoltràti allaMagisffatura degli Otto, cioè la corte criminale toscana, cui veniva rimessa, ancorain quest'epoca, la risoluzione di violenze sessuali e rotture di maffimonio con gravedanno, anche economico, di promessi sposi e relative famiglie. A seguire sono stareesaminate anche le suppliche al Granduca, prodotte su tale materia e da questirimandate, per la risoluzione, a7 cancelliere in carica della predetta Magistraturadegli Otto. Sono state proprio 1e suppliche, consukate per la prima metà del seco-1o, ad offrire una messe di notizie olremodo illuminanti sulla mentalità oltre chesulla normativa del tempo in materia di sessualità.
La Magisttatuta degli otto era una costante interlocutrice, tra l'altro, anche perle violenze denunciate dalle 'nocentine', querelante l'ospedale (sandri 2oo2a, 19),cui, come si è detto, a partire dal tlls spetta anche la sovrintendenza sugli affaridelle 'occulte', 1e ospiti di Orbatello. La ricerca, non esaustiva e cronologicamentelimitata alla prima metà del Settecento, non ha dato la possibilità di rintracciare unqualche collegamento col brefotrofio, che pure fu autore di varie querele e nonpoche suppliche in questa prima metà del secoio, per via delle violenze perperratealle ffovatelle e neppure ha dato risultati circa altri eventi relativi alle 'gravide occul-te'in genere. È stuto possibile però ricavare, nonostante che si tratti di una tipolo-gia documentaria, per così dire, di parte, specialmente le suppliche, informazioni
74
Matrimoni mancati
utiÌi per una migliore comprensione in genere delle caratteristiche che in quest'e-poca aveva il fenomeno de11a violenza sessuale, perperata a danno del1e donne e
de11a sua portata sociale. Un'indagine collaterale dunque, che ha aggiunto spessore*11e figure femminili, gravitanti intorno all'ospizio di Orbatello e di cui ci occupe-remo nei paragrafi successivi.
Lindagine su11e suppliche, rimesse alla Magistratura degli Otto ma indinzzate alCranduca. ha dato risulrati inreressanfi e quarrtitativamente rappresentarivi specieper g1i anni ffa 1l 17 07 e I ll 13 ; i ricorsi al Granduca paiono infatti diminuire, via'.ia che ci si ar,,vicina alla metà del secolo, che è poi l'epoca in cui Orbatello svilup-?a la sua attività assistenziale. Le opportunità di assistenza per le donne, cherumentano con 1'ar,.vento dei Lorena, sembrano essere, dlfatti, insieme alla cancel-,':zione dei castighi per le giovani disonorate, venuri meno già dal 1723, conlaxorte di Cosimo (Sandri 2002a,)2-33),la ragione più plausibile del1a rarefazionea tali iniziative, promosse da vittime, rei e relative famiglier.
Per il primo Settecento colpisce anzitutto la severità delle condanne, applicate.i-lle pratiche sessuali in genere, non necessariamente di natura violenta. E il caso diiue giovani che, sorpresi ne1 1706 ad amoreggiare e condannati per questo, rrovic-i:o a supplicare il Granduca di liberarli dalla condanna pecuniaria, che ha avuto,.-ome effetto, il ritardo, <<con grave danno>> morale ed economico, del loro matri-ronio. A11a supplica il Granduca fa rispondere: <<seguendo il matrimonio non si
nolestino più» (ASFi, 2419,4). <<Fare all'amore di sera>> è ancora i1 motivo, il 12-gosto de1 1107 , di una condanna ai danni di un supplicante, che sceglie come lineaJ difesa l'ammissione, non scevra da una certa meraviglia per la pena subita, della.ua colpevolezza, dovuta. come 1ui stesso ammette, all'essere totalmente «ignaroje1la legge>> (ASFi,2480, a. 1107). Un bacio, strappato conforza e con offesa, èrocora la causa, 1,24 giugno del 1707, della pena di un giovane a cinque anni di;aÌera. Il supplicante, questa volta, è il padre de1 condannato, che vede rifiutarejalla controparte un matrimonio riparatore nonostante l'offerta, a suo dire vantag-iosa, di un domicilio, i1 suo, per i due giovani (ASFi, 2480, a. 7107').
In alcuni casi tuttavia le pene ci sembrano, per quanto ci è dato capire e avuto:rguardo alla sensibilità e mentalità dell'epoca in materia sessuale, commisurate alle.-tiese. LinsoTenza e la prepotenza di un giovane, perpetrata ai danni di una rugaz-ze nei confronti de1la quale si era precedentemente vantato «di poterle fare qualsiasi,:Éronto affine d'averla in spos»>, è punita con una severa sentenza, cui segue la.upplica deil'ottobre del 1707 , che libera i1 colpevole dalla condanna pecuniaria ma:ron dal precetto di stare ail,alarga dalla fanciulla offesa (ASFi,2480, a.7101).Un'.'ero e proprio tentativo di stupro, severamente punito, emerge ancora dal1a sup-:lica di un altro reo, che, nel 7713, è accusato di aver inseguita, gettata a tera e per-sino pestata una ragazza di cui si era invaghito senza speranza (ASFi, 2488,54).Controversa è, invece, 1a risposta data dai Granduca al ricorso, inoltrato da una:erta Maria, condannata, è lei la rea questa rrolta, perché colpevole, paradossal-:lente, di aver subito nei 1705 uno stupro incestuoso, da Amedeo, suo cognato.r-ondannata pesantemente a tre anni di reclusione nel carcere fiorentino delle5irche, dopo ben 2) mesitrascorsi in prigione, la ragazza, un'orfana di 22 anni, che
75
LUCIA SANDRI
vive di elemosine, si appella infine alla clemenza del Granduca. <<Dicasi il grado diparentela>> è la risposta perentoria del principe, suo malgrado cosretto, come pare,
ad esprimersi circa 1a rimozione del supposto impedimento, il grado di parentelaappunto, al marirnonio riparatore (ASFi, 2480,250).
La supplica del reo, 10 stupratore, è quasi sempre tesa a dimostrare la disonestàdella fanciulla deflorata e f inutilità de1la condanna, perniciosa afamiiari innocen-ti, quelli del colpevole, abbandonati, a suo dire, ad un destino di povertà e di soli-tudine. L'uomo condannato evidenzia cioè, in genere, la sua funzione di sostegnofamiliare, la sua utilità sociale opposta alf inutilità de1la controparte, 1a vittima.Antonio Francesco Lotti di Campi, condannato per stupro con sentenza del 26 giu-gno 171), si rivolge al Granduca per l'arbitrarietà, a suo ar,viso, de1 giudizio subito.Domenica, la fanciulla stuprata, si è infatti comunque maritata e i1 <<povero giova-ne>>, il <<malfattore>>, desidera rimpatriare per sostenere la vecchia madre e duesorelle ancora fanciulle. Dopo aver prodotto falsi testimoni, che avevano testimo-niato a suo favore circa la pretesa disonestà del1a fanciulla, il Lotti, che aveva peròconfessato dopo mezz'ora di corda (di tortura cioè), era stato infine condannato allapena pecuniaria di 100 scudi, più altre 500 lire e un anno di confino a Pisa e
Livorno, pena altrimenti tramutabile in cinque anni di gaiera (ASFi,2488, 13, 170,l0B). Una punizione dunque esemplare. Più fortunato un certo Domenico diZanobi Magherini di Montignano, anche lui autore di stupro, che si vede ritirare laquerela e rilasciare quietanza da parte di Maria Teresa Masi, la vittima, e del padredi lei Michele . La ragazza infatti si sposa il 2J dicembre 17 l3 con un certo Tommasodi Domenico Bongi e, probabilmente, usufruisce di una dote riparatrice (ASFi,
2488, 336) . Sempre in quest'anno , l, l713 , nel mese di luglio, roviamo altri due casi
significativi per 1a posizione assunta da11e ragazze, le vittime, che si appellano per-ché venga fatta più equamente giustizia. Giulia di Angelo Giuliani di Barga ricorrecontro la sentenza data, a seguito della deflorazione da lei subita e denunciata, per-ché non era stato sentito un testimone chiave contro 1o stupratore, <<solito delin-quente in simil delittil>, i1 quale aveva invece prodotto, da parte sua, vari restimonia suo favore (ASFi,2488, 4).Poca equità è denunciata anche da Maria AntoniaSalvadori, deflorata da Lionigi Piazza di Soiana, <<persona potente e facoltosarr, 1a
quale, proprio per <da prepotenza del1a parte>>, invoca, <<genuflessa>>, i1 Granduca<<perché teme di restare a di sotto>> e teme, principalmente, <<1o scapito della suareputatione e (di quella della) famiglia>>.MatiaAntonia chiede coraggiosamente cheil processo sia addirittura spostato dal1a corte di Lari alla Magistratura degli Ottodalla quale si attende, evidentemente, maggiore giustizia (ASFi,2,{88,2).
Alla metà del secolo 1e donne oppongono ancora nuove strategie di resistenza.È il.rro di Maria Maddalena, stuprata nel1142 da un certo Giovanni Durante diSanta Croce su11'Arno. Condannato in contumacia a cinque anni di galera e a spo-sare o dotare la giovane, il reo si vede negare da1la medesima vittima qualsiasi quie-tanza, che gLi faccia avere f indulto. Maria Maddalena rifiuta infatti il risarcimentodelia dote, nonostante che sia definita miserabile e viva questuando (ASFi, 2525,117). Caterina di Scarperia, a sua volta, non esita a denunciare e pretendere il risar-cimento da Giuseppe da Barberino di Mugello, che l'aveva oltaggiata per strada
76
Matrimoni mancati
con atti illeciti e insolenze. Trascorsi otto mesi in esfio e pagata la pena, ottenuta,in questo caso, la quietanza dalla suddett a Cateina, Giuseppe chiede la grazia peril rimanente della pena da scontare (ASFi, 2525 , 2).
Gravissima e con modalità di svolgimento differenti dalle precedenti è invece lavicenda toccata, infine, in sorte ad Agata, come sappiamo dalla querela, da leicomunque presentata alla Magistratura degli Otto. Condotta con I'inganno a Collein un'osteria I'antivigilia della Pasqua del 1750 e violentata da più uomini, Agatache dimostra, a detta dei rei, 26 anni, essendo <<di giusta statura>> ma che in realtàne ha solo 20, viene ingannata con la promessa di un lavoro. Uuomo che f ingannaper primo, sparge la voce in paese che <<c'era tal femmino> disponibile nell'osteria.A niente vale la <<resistenza e rossore>> di Agata che, a seguito della violenza collet-tiva, resta gravida (ASFi, 1179, L).
È la gravidanza infatti che induce le nubili più frequentemente alla decisionedella querela, per via dell'obbligo della pubblica dichiarazione del loro stato, entra-a in vigore dd lT ll (Alessi 1995, 2)l; Di Bello, Meringolo 1997 , 2)), a seguitoddla normativa a tutela del bambino e al fine di reprimere l'infanticidio, punitoJl'epoca con la pena di morte. Riguardo all'infanticidio, tra le suppliche analizzate
crxnpare proprio quella relativ a ad una donna di ormai 52 anni, esiliatasi volonta-thmente da ben 27 anni, dopo una condanna in contumacia per l'uccisione del neo-
oeto. Il corpo del bambino non era mai stato rirovato. Condannata dapprima aila
1ma della forca e poi a tre anni di carcere, ora, siamo nel 1713,la donna, ormai inaà e <<aggravata di mùattie e mendicando il vitto>>, chiede al Granduca \a grazia di
1frer rientrare in Toscana. Nonostante i2l anni di esilio e la vita raminga,le vienerrcora intimato di tenersi lontana dallo Stato per almeno altri due anni (ASFi,2488,
ffi).Lo stesso ospedale degli Innocenti aveva avuto a che fare con episodi simili a
orico delle sue assistite ma la decisione del priore era stata quella della protezione
ddle giovani infanticide anziché quella della denuncia alle autorità competenti
§mdd 2oo2a,)L).Dalle violenze alle querele, alle suppliche per avere giustizia. Dall'obbligo della
&uncia di eventuali gravidanze, alle visite ostetriche per l'invio all'ospizio delleculte e da qui all'ospedale degli abbandonati. Era questo il destino riservato arlte delle donne oggetto di violenze sessuali nel corso del Settecento, una disgra-
dt dopo l'ùtra, che le avrebbe segnate per I'intera esistenza. Ecco il perché deidei padri a che la giustizia intervenisse severamente a tenere lontano i giova-
innamorati troppo audaci. Ecco il perché dello sdegno di Maria Maddalena, la
te, che rifiuta una dote che non le avrebbe reso l'onore, né consentito,il suo stato sociale, alcuna offerta, accettabile, di matrimonio. Ecco, infine, il
della vergogna di Agata, la ventenne di Colle, caduta ingenuamente neleffimero, trasformatosi in un incubo lungo due notti, di un lavoro che la
lei la'femmina', dai nemici di sempre: lafamigha, il vicinato, il paese.
le 'pericolate' di 0rbatello alta metà del XVIII secolo. Nel Libro attenente'Azieruda delle donne pericolate di Orbatello (AOIFi, s.97 ,9), il primo relativo alle
imonianze tramandateci sulle nubili, le'pericolate' accolte nell'ospizio, e tenuto
77
Lucrl Slruoni
dai due deputati imperiali Giovanni Battista Scadatti e Lorenzo Mancini, le regi-strazioni dei ricoverivanno dal 25 luglio 7155 sino al dicembre dell,anno 17g0. Ditali scritture ne è stata anahzzatauna cospicua campionatura sino a tuttoll 1166.
La fonte esaminata non consente di elaborare dati schiettamente demograficicome la provenienza, l'età, il mestiere, che compariranno invece) come u.d..mo,nei regisffi oftocenteschi; rumavia, per quanro si è potuto, si è cercato di dar rilievoagli aspetti qualitativi in essa contenuti,
"sp.imenii la moclalità, anzi, più propria-
mente, la dinamica dei ricoveri. Il risultato è stato 1o scaturire di nuovi p"..oÀi dirìcerca, per seguire 1e donne, fagocitate da un flusso inarrestabile di arrvenimenti(i'invio all'ospizio, il parto, 7a partenza), spaurite, consegnate, rnaneggiate e, infine,ricondotte in famiglia, più frequentemenre 'acconciarel di nuovo, iel caso delleserve, ne1le case dei padroni.
Riguardo al numero delle gravide accolte, se la media annuale si aggira intornoai 46 ingressi su un totale di 505 in poco più di dieci anni, si nora però un aumen-to di ricoverate proprio nelle annate successive a quella della creazione della catte-dra di osteffi cia, tl 71 5 6, e a quelia, l ll 63, della fondazione della scuola delie allie_ve ostetriche. Dalle 16, l8 donne per anno, accolte nel 1756 e ancora nel 1757. nel1758 si arriva infami a contarne, significativamente, 49, numero massimo c1i presen_ze annuali riscontrato per tutto l'arco cronologico consiclerato e che caratterizzaanche il 1760 e, nuovamenre in modo significativo, 11 1766, tre anni dopo cioè lafondazione della scuola.
L accoglimento sistematico del1e gravide in Orbatello, come si evince da1 crono-logico del registro, inizia proprio l'anno precedenre a quello della fonclazione del,f ir-rsegnamento ostefico e sembra volto proprio a programmare la preparazione dimateriale umano da st,diare. Non stupisce d.,nqre làumento, ,oi., ,ii".r.to, d"1numero de11e nubili accolte, certo invogliate da una maggiore organizrazione me6i_c_o-sanitaria del luogo, al'valorata dalla presenza di ,ràdici e st,,denti e da quellade1le allieve della scuola di osteticia. Lapprendistato cle11e allieve includeva, infat-ti, presumibiìmente, lo svolgimento di un'attività ir-rfermieristica a vantaggio dellericoverate, a sostituzione parziale o totale de1 volontariato, prestato sino ad alloradalle anziane, anch'esse ospitate in orbatello. Da)1'apprezzamento del valore stret_tamente numerico dei dati, si è passati, come si è anticipato, ad un,analisi qualitati_va dei medesimi, È sernbrato significativo, anzitutto, comprendere le circostanze,che influivano sulla decisione deile donne di recarsi all,osoiziospizio e anahzzarele moda-lità dei ricoveri. chi inviava le 'incinte' all'ospizio? chi pror,vedeva a<l accompa_g rr arle?
_ Relativamente alle persone che inviarono e/o accompagnarono le nostre ,gra'i-cle', solo per 11 9'A del totale non è dato sapere né chi te ulo-pugnò, né tantome-no chi prorruide a segnalarne l'urgenza del ricovero in orbatello. Solo p., cinque cli1oro, poco più de11'1%, si disse che vennero <<cla per sé». per la quasi totalità deicasi abbian-ro invece norizie, il più delle volte alternative, su chi le inviò e accompa_gnò al luogo del parto. Per 11 55'% circa del totale delle 'incinte' accolte, pari a 279casi su 505, siamo a conoscenza dei mandanti, enti o persone, che garantirono lorol'assistenza nell'ospizio. 11 19% di esse fu inviato du i..ronrggi ch"e si fecero iden_
Matrìmoni mancati
' -..lre per nome e cosnome, senza specificafe percì la natura del leganc intrzrtte-,(r coll 1a gravida, coinvolti. loro malgrado, neile pratiche di accettazione clc1lernc. Lr particolarc, 11 1l% de1le giovani fu in'iaro a orbatello dr per.sonlggi
.--iit zrl t'nonclo religioso: curati, priori, abati. r,escovi, er,.idcntemente sensibilizzzrti
'.iltito di denunce, conlidenze, esplicite richicste cli aiuto, se non responsabili essi' -..i ir.r prin-ra persona in qualchc caso di gravidanza. per il 10%, f invio è farto risa--. tllvece alf interessan-iento c1i clipendenti (scrivani, camarlinghi, meclici, cerusici,- .r:rici) dellc istituzioni ospedalicre cittadine (l'ospeclale di Bonifazio, di Sar-rta
,.:'rl Nuova), compresa que1la n'reclesima clcgii Innocenti.Relativan'rente agli invii sollecitati da persc»ra1e medico, è signifìcativo che cssi:-cnrino specialmcnte a ptrrtire dal 7762,l'trnno che precedc la fondazic»re uffl-
.,,.- clel-la scuola di ostetricia. Tra i medici che roviamo a raccomanclarc il ricove-::llc giovani nell'ospizio clelle'occulte', compare trall Il 62 c il 17(16, a|pcno ip
: '.casior-li, il nome di Cìiuseppc vespa, docente c <<unico teorico)>, a Firenzc,- ,r nrateria ostcffica (Bellinezzi 799c), 30. Una presenza signilicativa, dunclue,-,-.r clei mcdici tra i I'r'ranclanti, cl-rc caratterizza una loro professiona]ità, r,ia yia
-lciir.rita in quest'anrlrito. la curi scena era stata sino acl allora gestita cla presenze: ::rinili. La perizia osretrica. prima aflìclata allc dor-rne, pare divcnire ora una pre--.,,ila clei rrcdico chirurgo, col progrcdire cle11a conoscenza anatomico-ltisiologi-r.1 corpo ièmminile (Pastore 791)3,66).I meclici, come i curari e i rcligi6si in
--ir'r. sembrano, infine, anche i deposirari dclla fiducia delle 'incinte'e dei lorcr.i;rri. Per il 6%, c1cl1a mcdesin'ra campionarura, la sollecitazione al ricor.cro - è il
, .lelle ser",e pro\renne dal padrone; per iI 29'" I'iniziativa spctto a1l'Auclitore, --:ic. i1 rappresentante cioè della N'Iagistratula civilc, cui forse è da aggiurgcre uir
:.lccot.nandato da t'ron mcglio iclentilicati cancellieri (clella corte criminurle. ciyi-. rcligiosa). Solo l'19l., ti in,,.iato dalla Nlagistratura Criminalc degli otto. Una
-::r tu inrriata, evidentemclrte per Ia giovane cttì, dalla Nlagistrattrra dci pupilli e.,-;ra. infine, clal Bargello, la polizia go\rcrnatira.']uasi mai i mandanti coincidevano con gli accolllpagnatori r,cri e pr-opri, colo-
-.,.rc che si prender.ano cli persona la briga di recare le clonnc a1l'ospizig. Tr-rttayia.- r1 i8% clclle 505 'incinte' accoke, pari a ben 292 casi, risulra caratterizzaro da
, ..icca ucsse c1i notizic relatirre a chi le accompzrgnò, parenti stretti i1l maggio---ì -. ancora Lina \/olte, sebbene più raramcr]tc, p615e,rn*gi in r.elazione col
..:lele dellc clonne. 11 ricovero pare rispondere in molti di questi casi a iniziative-. -jrri. private, finalizzate al ricovero cleìlc gravicle nell'immincnza clel par:te, Bcn-- n. infatti, iu accontp2ìgnetto nell'ospizio su iniziatir,a clei par:enti, con sna
. -tictante predon-rinanza di rapprescntanti del sesso maschile: padri anzirutto er,rtclli, cugini, zii c, persino, cognati. Poche, rispetto a tale inrraclenza maschile ,
: .:-rdri. 1e sore[1e, le zie, ie cognate (fig. 1. AOIIri. s..17, 9).T.r1c attriLrr-rzione strettamente fnmiliar:e del1'acconlpagnamento delle grar,icle'.prizio ci conferma probabilmcnte, pcr qrrest'epoca, 1'osservanza clclla crrllabo--rne richiesta, per 1egge, a1le famiglie clal prin"ro decennio clel secolo ai tìni della
- rrrlazione rli grar,iclanza, onde prevenire aborti e infanticidi.IÌ t'estante 1(r,99lo circa del1e meclesirne'incinte'è accompagnato da ul.r casisti-
79
Fig. T. Incinte dell'ospizio di c)rbatello lat 17)j at 1766 secondo chi le accompagna
LUCIA SANDRI
cognatat%
sorelh /) "/o
paclrone -1%
/'
I
cuginofratellcr
10%,I
padre210
ca umana varia, sempre al maschi,le, fatta di servitori, padroni e personaggi in qual-che modo legati alle donne, tutti solleciti a farle ricoverare per liberarsi di un com-pito ingrato ma alla fine, come ci sembra di capire, non inusuale né per loro, né perle gravide. L'accompagnamento di persona di molte delle donne e i sostenimentodelle spese fa pensare infatti ad un loro intimo coinvolgimento ne1le vicende clellenostre nubili. È d,rn.1t,e un universo maschile quello che (ieri come oggi?) pareappropriarsi nonostante tutto del compito di accompagnare le donne a partorire.
Se niente è possibile sapere, inoltre, cofi esattezza, circa 1o stato anagrafico cle1le'incinte', tuttavia il riferimento al nome dei padre, anziché de1 marito, ci fa inten-dere come ci si trovi di fronte, effettivamente, ad una quasi generale totalità di nubili, tra cui molte orfane. Ci sono poi un certo numero di vedove e alcune donne mari,tate, le 'pericolate'per eccellenza, 1e adultere.
Nonostante che nessuna annotazione indichi in quest'epoca, il XVIII secoio, lostato sociale (possidente, miserabile) e l'occupazione abituale delle donne accolte.tuttavia ci è sembrato in qualche modo indicativo rilevare per ciascuna di loro iltempo di permanen za ne7\'ospizio, dove era obbligatorio il pagamento di una rettagiornaliera. Alf ingresso dovevano essere pagate, infatti, 1g lire, di cui quattro anda-vano alla levatrice <<per 1a rilevarura del parto», una lira e Jieci soldi ai'ospizio perun mese di permanenza, pari ad un soldo al giorno. Un soldo e otto denari rl gio,no era iìncora.l'onorario, quotidilrro deila levetrice, tenulJ a una presenza giornaliera; le restanti 10 lire, circa, erano per i'alimentazione «della donna g.uuidrr.Per ogni mese in più si chiedevano inolrre 14 lire al mese.
Relativamente ai tempi di permanenza nell'ospizio delle 'incinte' e delle puer-pere, è soÌo a partire daltlsl che viene indicata, oltre a1la data di arrivo e dipn.
80
maclrealtri12%
Matrimoni mancati
r tr:t. 2ìnc1le quella del parto. Dallc date così clifferenziatc. si er,ince che le grayide-l sir:ngerrano necesscliarnrnte, corrc prsq,sclerra la normatir.a r,igentc in quest'e-.r. allo scadere degli otto mesi clalf ir-rizio della grar.,iclanza (Alcssi 7.).)5,2391 , maìro prima e, frequentemente. anche di soli quattro, cinque rnesi. In questi casi
,:.orre\,,rl1o nna buona parte deL-la gravidanza ad C)rbatelio.Relativarlente poi ai tempi di pcrl.ìlanenza (arrir.o, parro, parrenzur), si pgssono
.::-r'c ancora altre notizie significatirre. Tra le clonne in ar,zrnzato stato di grar,iclan---he restano ir-r C)rbatello meno cli Lrn nresc, talr,olta pochigiorni (in un caso addi-
..-Lrrl Lln giorno, que11o del parto) 1a schiacciante maggioranza è rappresentata,,,.- incinte' rìccompagnate da paclri e tratclli, quasi si tr,ìttiìsse cli una sorta cli ope. rìne coercitiva ai clzrnni de1le ragazze, afficlata agìi uomirri di casa. con una certa
:istcnte prevalenzzr clei primi, i ;raclri, sui secondi, i fratelii. .A secuire, le brer,,i: :ìlirr'le1-lze risuardano anche, comc ci paìre questa r.olta piìr logico, lc gior,ani
--.Ìi rccorlpagnate cla1 padrone, probabilmcnte il 'reo', e cluelle inviate daile yarie.,-.srlarure criminali e cirrili, casi, quest'ultimi, snscotibili di uno spiccato inter.es-, , risptrrmio clelle spese cli parto.
L.r maggior parte deile giovani incinte. tutavia, rimanc in genere neil'ospizio tra, t.lanza, parto e pucrperio. da uno a trc mesi. a conlermare la lealtlì cli r-rpa
r.r c1i arrivi in avanzato stato di grar,idanza. Tuttavia. come si è detto sopra. alcu-: llììiì1ìgo1lo oltre tre, sir-ro a cinque tr-iesi. Tale mrrggiolc pernlJnellz2ì nel1'ospizicr
..ol'tì r-rna volta legata, anziché a1 puerperio. all'attesa, alie fasi iniziali croè de1la
- r.1anza. Sono qucsti i casi che tcstimoniano un'originc socialc piir elct,ata. doye,, raguarclia dell'onore, clei rei e clel loro casato, non certo delle erar,i{e, andar.a-,ìcemente tutelata, allontananclo le giovani il piir precocemcnre possibile clai- :sti irrmiliari e di lavoro. N1aria Angiola, venuta da Nlontevarchi, accompagna--:.ti cocchierc di casa Bartolini, presumibilmente una serr,a. è Lln c2ìso cmblerla-
- '\rrivata i1 22 febbraio 1758, partorisce il 26 agosto e parre ll 22 dellnese slrc--:.1r.p. per compiessìr'i sette mesi di ricovero. ln qucsto caso la donna crrr gitlrte
.prizio nella fase iniziale, inrorno ai tre mcsi di gra'idanza (AOtFi. s.97,9, c.1n casi del gcnere si restar,zr nell'ospizio cli regol:r per oltrc cinque sir-ro. talr.ol-
,, scrte, otto nresi e più a giustiticare, corne si è cletto, l'appartencnza non delle-r!'1ra dei'rei', i padroni, a ccti cli unrì certa lcvatura sociale. Si può dire inoltre. in qencre, anche nel caso c1i lunghe pennancnze, dorrute a precoci ricor,cri. 1e
:rc poi non si trzìftenessero oltre i1 conrpin-rento c1i un mese di puerperio. Non-'.'rrmo se i bambini in questi, cotre nclla gelrcralità dci casi cli abbandono, fos-
, intr.ttecliatamentc recati al r,icino brcfotrofio o restassero con 1a madre..,-che r.olta 1e puerperc, nla non era un ar,r,enimcnto frcquentc ancorrr in quc-
::'ilclr (vi sono r-rìcno cli una diecina cli casi), passa\/ano spontancarnente ac1
, :rre ncl hreforrolio come .<balie di casa». Lobbligo all'allattarrcnto dcglr' r,:ti da parte clellc madri nLrbili di Orbatcllo, si perfeziona, infatti, conre abbia-
.Ì.cennato nella premcssa, alla line dcl Settecento, entrando in r,igore obbliiirtmenre clal 1791.
r qrlasi totalità clei familiari e clei padroni provr,idc a salclare totalmente le-:: t nel caso clel pasalrclrto effettuato dai paclroni ciò ci è sembratc, c()urprova
81
Lucre Snnlnr
re la loro responsabilità per quanto riguarda l,ingravidamento delle giovani. per le'incinre' accoke su segnalazione di canceilieri, auditori . "ffi.i;ii vari, ra spesa fusostenuta dalla magistratura che le aveva inviate mentre le clonne giunte <<cìa per
s6>, prowidero al p.agamento di tasca propria. Ciò nonostante venivano accolteanche donne prive di qualsiasi garante É.ro,, po.h. andavano via senza saldare ilconto' Il parto, del resto, non era evento da potersi procrastinare a saldo awenuto.Su un totale generale di r05 ingressi, i parti f,r.ono u* +ÀJ f-i a 2i9 maschi e219 femmine, ta cui soio due furono i parii gemellari (due _ur.hi e due femmine).c)tto de1le altre donne furono dichiaraie 'non grar.i.le, e nove partlrono senza par_torire, portare via dai congiunri, in qualche caso proprio fr-rggite. soro due a.u. gio
vani incinte (poche, avuto riguardo ar1'epoca , uL'ulru,,,oiiai,a p.,,;;;.i";;;rono di parto. Solo sette neonati, qr,rattro maschi. t." f"--irr.,?.r.orro detti ,natimorti' e tutti i rimanenti furono dichiarati sani a1la nascira. Un caso eccezionale èrappresentato da Francesca, dalle <<Terine c7'Arezzo>>, che partorì il 15 gennaio del77 64 una bambina mostruosa che morì dopo essere statabattezzata. <<Ladetta crea-tura la feci consegnare», scrive il deputato cli orbaterlo ".iri;;;; di Santa MariaNuovo>, presumibilmente srudenti ìi medicina in artesa ai -ri..i.r" umano dastudiare; a Santa Maria.Nuova venne portata anche la madre (AOIFi, s. 47,9, c.70)' Le fonti tuttavia, talvolta, ampliant il q,adro deile informazioni, soro per rredelle 'incinte' di questo periodo si trattò di ,rna seconcra gravrd.aLnza, soro in duecasi si trattò di portatrici di handicap: <<scema e storpiata>>in un caso, <<srorpiata»nell'altro.
..Relativamente agli eventi marurati in tempi brevi, durante il periodo c1i degenzanell'ospizio, sappiamo che una defle 'occurìe' riuscì u ,poru.j ,"uir.i;;i;;;enffò alle convertite. ci è or,-viamente ignota la sorte ,o..r,u
" ,r,r. le rimanentipuerpere dopo 1a pafienza dail'ospizio. Ad undare sposa fu Anna Maria Francesca,una trovarella, condofta a orbatero daila soprabaria degri t,-,rro..rr,i, per ra quale si
,' l*1rl.r' «fu sposata avanti di partorire . u-ds via» (AoJÉi, s. g7 , g,.. r4). Diu.nu,u
:.1,,1,:::rrsa..ad Anna Maria Francesca fu risparmiara dunquc Ia i.ergogua delparto nell ospizio nlentre 1o sposo di sicuro ne risparmiò 1" .p"r.. un caso embie_matlco, questo appena citato, che testimonia ta r'artro, nr.o.u una vo-[ta, quanto
fossero più tutelate. in simili frangenti, le giovani istituzionarizz^te, perlazione diricerca dei reo da parte deil'ospedale, che non le tante nubili a .".rririo in casa d,al-tri o le povere contadine. per cherubina, infine, -"nd",; ;li;i;. dar priore diSanta Felicita nel luglio delri56 e partita dopo ben dieci -.rr, iirg * aggio 1757 edivenuta nradre di un bambino, si seppe che «entrò ner monastero dere convertiteper vestirsi monaca conversa» (AOIFi, s. 9l , 9, c. )0).
4' Le 'gravide occulte' ne[[a prima metà dett'Ottocento. Nel Regzslro deye clonrteincinte c'cculte del Regio conseruatorio cÌi orbatello cli Firenze doti';;ro igig a tuttol'anno 1812 (AoIFi, 9168-9169), come nel Registro i"ii" )rri*tote ner R.Cr"tnseruatorio di orbatcr.ro tncominclato t'r prtmo gennaio 1g45 (f,g11:i, s. 47, 1r), icui dati, relativamente ai soli anni 1gr9 e 1b4r, ,or'ro stati presi a campione per que-st'epoca, appare evidente come orbatello continr_ri nd .rr... un.o.o il luogo del
Matrimoni mancati
r,rrto clelle'gravide occulte', opposto percì ora a qucllo clelle partorienti 'trtisera':ili c orrestc'. clal 181(r ilccoltc, come si è trnticipato. r-rell'()spizio di N'Iatcrnità de1
:.rt-totrofio. I1 secor.rrlo clei cllrc registri offi'e, in particolare, la possrbilità tli con-
iLrrre un'indagine ir-r el)oc2r posteriore irlf introdrrzionc rlelLe rcgistrtrzioni clello
:irrro civile e cluttqtte c()n Lln corfcdo di notizic più ricco da1 punto cli l'ista ana-
r r,rfico.I registri ()ttocentcschi prcsi in csame, rliversat'ner.rtc <lalle sclitttrlc clel X\1lI
:rcolo. prescntatc r-rcl paragrafo pleccclcnte, ci offrono clati srrscettibili a rilei'are la
:rit,r.cnienza. il n.restiere c I'età rlelle donnc, dancloci 1'opporttrnitaì cli forrt.rr-rlarc, itt
J.1llchc caso conferr.t'lirrc, importanti consiclerazioni utili arl illtrstrarc rtltcriornretl-:; lc r icerrJe elre le r irlcr,r Pr()titg()nistc.
Veclianro arlzitutto i rlati rclativi iilla prcscnza nurncrica tlelle clontte ncll'os1-rizio
::.lle dtre aurlate caulpiolle. (lorlitrcilntlo dal primo clci dtre registli, r'isulta conrc,
:--:l 18lc). I'ospizio avcssc accolto l(r9 clonnc, qr-rasi qtraclrttplicrttc rispctto alle -17
-:,.-rmr chc abbianro tr()\,ilt() esscle assistitc i-ìllnttaltllente alla ntetà clel sccolo ltrccc--:r-1tc e pali acl una r.ncclia cli arlivi cli 1{ rlc,nnc al nrese. Ilspctto alla plovcrricrrzir,
- ;')",, ,'1r,,,r. csscrc di ftroli Iìircnze nlcrltre il 11"/,, l-ra utt'origit'tc cittetclilì4. Itl tluc--: Lrltin.ra pcrcentualc vi ò complcso tr.lttavia ttr-r 7'){, rli 'incirtte'rcsitler.rri in cittrt nr,t
-1r origine cli ltrori Iiilcnze (fig. 2, AOIFi. 9168 91(r9). Urr tlato, qttcst'ttltit.t.ro,
- ,:ttìrrtrrto anche clalla c(ìspicLra rrppartcllcnzir rlelle donnc alla categol'ia clcllc scrvc
. .lclle caurcliclc, rcsirler.rti in città nla l)rovcnienti ill Srrtn prtrtu, colrlc è rroto. tltt- -,,ri e chc assorbon <> il )6"/,, clel totale clci tttestieri intlicati.
Rclativanrcnte al rncstielc clunque, a scguirc q'ot.ì.ìpaiot.lo le lavorar.rti .lcl ntoncltr
.::'icolo. coutarline, blaccirrnti, lrigirrnali pcr il i2'11,, ivi c<ttttpt'esc,rlculre,.tt'cc-
-..iirrlcrr. le arlclcttc cioò,rlla lavorazione clclla pagli:r, it.t t'tttt'ncro non tttolto cot.tsi-
.:.-ntc c l)er clLteslo assinrilrrtc, pcr questa aìllnitta. alle lavolatl'ici aglictllc.jLlall'pcnte sollo statc collsidcrate insiemc. rr c()stitLlirc Llrl r.nlico scrt()fe, qtrello clcl
:.,:'1o tessile, le «ltilatorer, lc <<tcssitorc>> e le incannatrici cli scta che, cot-t qtralchc
,-,:rrr ivi conìpresa, raggiungono l->en 11 25')1r, clcl totalc. (ìarzorre e bottcgrric.
' .:.2. Itttitt/t'rlt'll'Osp/:to tli Orbttalln ttcl 1X)'). src())t(l() ld protrtti?t/ilt
Fircnzcl+9 (,
Firenze con pror eniertza
tla iìrori1'l;
-.,n Fircnzc{9";
83
LUCIA SANDRI
anch'esse considerate un'unica categoria, sono il 6% delle donne, mentre un'altrapercentuale minima, il 7%, accoglie altri disparati mestieri tra cui una cantante e
una <<vaganterr, una donna cioè senza dimora e senza sostentamento alcuno, mentresono solo 2, pari all'fÀ circa, le casalinghe risconrrate ra le giovani incinte.
Relativamente all'età delle donne a1 momento del parto (fig. l, AOIFI, 916891.69),11dato che emerge per quest'epoca è che, per la maggior parre di esse, taleevento, i1 primo presumibilmente del1a loro vita feconda, accade nella fascia di etàtrai2l ei25 anni compiuti, pari a1 $'/. del totaie. Seguono le giovanttrai26 e
Fig.3. Incinte dell'Ospizio di Orbatello nel 1839, secondo I'età
i 30 anni (.31%). Le ragazze tra i 18 e i 20 anni compiuti raggiungono soltanto il107o, mentre 11 7% è relativo a quelle trai)1. e i 15 e 11 5%, infine, a1le donneoltre i 15 anni.
Un dato, questo dell'età, oltremodo inreressante in qr:anto si rileva che ia classede1le 'gravide occulte', al loro ingresso ne11'ospizio, individuata come nurnerica-nrente più consistente, è proprio quella tra i21 ei25 anni di età, la medesima fasciacui appartenevano, ne1 XVIII secolo, 1e 'nocentine' oggetto di violenza sessuale(Sandri 2002a,26). Non so1o, anche per le balie nubili in servizio ne1l'ospedale traSette e Ottocento, l'età a-l servizio coincide con que1la delle giorrani tovatelle violentate e delle nostre partorienti nubili di Orbatello, 1e medesime obbligate a pas-sare, da11a fine del Settecento, appunto, al servizio dell'ospedale come nutrici inter-ne (Sandri 2002b,34,40 11). Un'età, questa ttai27 ei25 annt, a rischio dunque diviolenze, come ci informa anche Sara Matthervs Grieco, che individua, nelSettecento, proprio per Ie serve, che rappresentano, come si è detto, una delle cate-gorie di mestiere tra 1e più numerose delle nostre gravide, una concentrazione dicasi di r,iolenza proprio intorno a1 venticinquesimo anno di età (Matthews Grieco1997, 89). Età, che va a coincidere, sia per la seconda metà del XVIII secolo che,ancora, per la prirna metà dell'Ottocento, con quella al matimonio per le donne ingenere, innalzatasi nel corso dei secoli sino a collocarsi addirittura, tra XVIII e XIX,proprio intorno ai 25 -26 anni di età (Barbagli 1981, 505 -520). Maria Fubini Leuzzi,
piu dr 35
5_qi, \n.l. meno di 20
. 10"À
26-303t,'/"
21-2513%
Matrimoni mancati
da parte sua, ci conferma tale fenomeno, rilevando per il XVIII secolo, un innalza-mento dell'età al godimento delle doti granducali, elargite in Toscana a7).e ragazzepovere (Fubini Leuzzi 1999, 232, 238).
un periodo della vita dunque, que1lo tra i 2l e i 25 annt, c^ratterizzato per Iesiovani nubili da una recrudescenza di casi di stupri, di gravidanze illegittime, chesfociano di rado in matrimoni riparatori e, più frequentemente, nei pagamento dellespese de1 parto e de1 puerperio. Paradossalmente, dunque, ma ci pare un risultatoimportante, l'età al mamimonio, biologica e culturale, è anche quel1a deil'abuso osupposto tale. G1i studi condotti sinora non ci consentono di affermare che si trat-tasse di vere e proprie strategie messe in atto per arrivare al matrimonio, dato che èdjfficile capire quanta consapevolezza di ciò esistesse a livello individuale e sociale.Ciò nonostante si tratta di un fenomeno riscontrato, tra XVIII e XIX secolo, indiversi contesti sociali (città, campagna, istituzioni assistenziali, ceti agricoli e arti-eiani), con risultati - la celebrazione o meno dei matrimoni riparatori - di volta in',-olta differenti, perché strettamente dipendenti dalla normativa giuridica e dallecongiunture economiche e culturaii delle varie epoche interessate.
Ormai totalmente 'depenalizzata 1a seduzione', la tutela è risffetta a1la violenzacarnale, tuttavia, come si è detto, di difficile prova. Orbatello serve solo a nascon-dere la coruzione deile <<inhoneste», a difesa della società degli onesti con la reclu-sicrne, l'occultamento delle gravide nubili e dei loro figli (Alessi 1995,24».È-tamaturazione di tali concetti che porterà, tra Settecento e Ottocento, anche a]la con-:rotazione del brefoffofio degli Innocenti come luogo di accoglienza dei soli figliCella colpa, a fronte di una tradizione secolare di luogo di assistenza dei poveri, obe-:ati da troppe nascite, prima che degli iJlegittimi.
venendo ai dati raccolti per il 1845, essi permetrono di rilevare anzirurro uneumento contenuto delle ricoverate, passate da una media di quattordici a quella dicirca diciotto partorienti al-mese per un totale di 220 donne ammesse neli'arco diuna sola annata.
Relativamente a1 mesriere, sebbene siano rrascorsi pochi anni, il quadro de1 1g45rresenta invece un significativo ribaltamento risperto alle posizioni del 1819. I1)i% delle'occulte', corrispondente alla percentuale più alta di gravide apparte-nenti a1la stessa categoria di mestiere, è ora rappresentato non più dalle sen,e, comepochi anni prima ma dal1e contadine, dette anche 'pigionali', 'opranti' e incluseooche pecoraie. Considerate a parte, questa volta, dato i1 loro nume ro abbastanzaconsistente le 'trecciaiole', aggiungono, da parte 1oro, un aTtro 9"/, al totale del1econtadine (44%) . 11 secondo posto, con 11 i\,A , speua ora alle donne occupate ne1:amo tessile, 'filatore', 'tessitore', comprese le sarte, le 'cucitore' e qualche caLzet-:aia. Serve e cameriere, seguono, infine, al terzo posto a coprire 11 22% del totaletig. 4, AOIFi, s. 4J,17).
Contadine e donne occupate nel ramo tessile, specialmente 'filatore' e 'tessito-le', vanno parzialmente a sostituire dunque, nel 1845, fra le nostre gravide diorbatello, 1e serve e le cameriere che erano al primo posto solo pochi anni prima e:he erano state una costante anche per tutto il XVIII secolo. Nonostante i1 ritardoeel1o sviluppo industriale, denunciato per il nostro paese in genere in questo perio-
85
LUCIA SANORI
altri3%-
11.1.
,/ 3tl,
seNe e cameflerer- 30%
contadine-,34%
lncannatllct c strle2t%
Fig. 4. lncinte dell'Ospizio di Orbatello nal 18$, sacondo il mestiere
do storico e quindi anche de11a Toscana nello specilico (Romano 1986, 109), tutta-via la cospicua presenza di 'filatore' e 'tessitore', benché non si sappia il luogo disvolgimento del lavoro (domicilio de11e donne o opificio), sta ad indicare che, alme-no in questo settore, il tessile, appunto, qualcosa si stava muovendo grazie allamancldopera femminile. Appare inoltre evidente, come dimosfa 1a crescita dellegravide di estrazione contadina, 1e più numerose delle assistite di Orbatello, comela manodopera femminile, meno specializzata e più a basso costo, sia assorbita, inquest'epoca, prevalentemente, dal mondo agricolo. Una costante che caratterizzeràancora la prima metà de1 Novecento (Ulivieri 1999, )02-301).
Riguardo ail'età de11e nostre assistite, se la maggior parte delle tagazze, quasi il40% del totale, è sempre rappresentato, in quest'anno, il 18,{5, da que11e trat21 e
t25 anni compiuti, scendono aID% quelle tra i26 ei30 anni, mentre cresce la per-centuale di quelle trai 1'7 (1'età più bassa riscontratatta le nostre gravide) e i 20anni, che raggiungono ora la media ragguardevole del 2ltÀ. Rimangono invariateinvece, per 117"A,Ie gravide comprese trai37 e i J5 anni, come pure è confermata1a percentuale del 5% di quelle oltre i J5 anni di età. Si pr-rò allora dire che l'au-mento tra Ie nosre gravide delle ragazze de1 mondo agricolo, travagliato in questaprima metà de1 secolo da un forte aumento della popolazione e da un crescenteimmiserimento (Faccini 1986, 105) è forse la causa, in quest'epoca, oltre che di ungenerale innalzamento del numero cleÌle 'occulte', di un abbassamento de11'età allaloro prima, o supposta tale, maternità illegittima.
A seguire, varia anche il quadro deile provenienze, che vede un aulnento anco-ra più consistente, la quasi totalità, di 'incinte' provenienti da lìori città, dalla cam-pagna appunto, il luogo di residenza delle contadine. I maggiori rischi di abuso,corsi da1le giovani al lavoro nei carnpi o a guardia di greggi, si riflettono nelle gra-vidanze illegittirne, in aumento in generaie già dal Settecento, come pure aumentain conseguenza di ciò anche il numero dei bambini abbandonati aIle istituzioni assi-
stenziali, che vedono triplicare quasi la loro presenza contata ora, in pieno XIX
Matrimoni mancatl
i
I
:.colo. in alcunc mrgliaia cli abbancloni ar-rfiuaLi (DellaPcruta 1986' 1](r)' si è cletto
.:iir r,olte. infatti, come il lenonteno delle'gravide occulte', fossc intimamente lega
u p". più versi a qucllo dell'abbandono e come lc madri nubili passasstro, sir put'c
.'.ii-*i periocli, .1"1 ...,r-rr".r,,rtorio clcl parto all'ospcdale dci trovatelli cotle rrutri
-: e nradri c1i abbanclonati (Sandri 2002b,29)'- -1". qu"rr'epoca. i1 18,{i,1e fonti ci fo|niscono:ìlrcora la possibilitzì di considc-
:.,.e f inrcrr,allo tr, 1" clata clell'acccrtazione e quella .lel parto. Se 1c gravidc povere
..,.,.rn essere accolte nell'ospizro cli Maternità a sette mesi di Qravitlanza con.r-
. ..ìi.'i.:i".i-rte'nt,bili.rrir,^r',o ad Orbatello tra i sctte e i nove nresi di gra'idan-
-.. i.rlt.fi, ornri n.ll'lrrr,rriuenzzr clcl parto, il giorno stesso' Appare teruinato' dun
: .... r.isperto a qualrro |ilevato ne1 se.o1o prececlcntc, i1 XVIII. I'ut/1tzzo dell'ospi
- 1..". ,-r"r..),-rd"." i lunghi n-resi di un,r graviclanza indesiderata ll parto dclle nubi-
,..\.i.n" cli regola ,r-r..,r, in Orbateilo, mentfe 1'Ospizio di Maternità.acquista pialr
^..-,u i^n], grlzie alla lrequenza cle11c spose povefe, assistite dallc'allievc del cir'-
- . J,tr.io. Tuttavia, .or]. ,i è r,isto, in .orà di patologic gravi e complicazioni, le gio-- ::- ,ì\-evano ora piir che nrai libcro accesso in Santa N{aria Nuova Ttrtto cicì ci fa
.rJerc cor]]c la scena del parto fosse ulteriorn-rente Variata, dal pur-rto di Yista
._.:rtitico-logistico, a r".o,rdn dello stato di saltrte cÌellc partorienti, fino a soprtr-
::-r,ìre. per importanza, lo stato anagralico sociale delle rlonr-ie, chc tallta partc
- .-,,.t inYece avuto in passato r-rella prassi assistenziale cli ger-ret'c' Le gravide nubili
:-:r,.r Colrtullque ancora sottoposte arl uua yigile attenziolle, testl ad inquaclrarìe
. , , il profilo ,lel .nn-,por,rro"nto. La fr-rtura partot'ientc doveva dimostrale , come
- . . pe ricoLut"' n,.,',In".re nell'os1-riziit nel settecento, cli conoscerc 1a clotffina cri
, ::,-ì. telterc Lln comportamento eciificante, eset'nplare e, specialmente, clare segrli
_ -=_.ìrù r-okrntà di ravveclimcnto. È ciò che fece subito dopo aver partorito la sua
:,:.:ina. clementina, una casalinga cli 26 anni, di Santa Marin in cìratlo cii Arezzo'
l. :::l uiugno clel 184i, «irassò r"r"1 Riri.o Cappor-ri>r, dctto deile Con'ertite a redi-
-::i. .Lrllle l'ìlonaczì cotl\rersa (AOIFi' s '17, 17)
. :esistro delie grat,idc del conserr,atorio del l8l5 dà anche ir.rdicazioni sullo
,- :isico clelle dorrne, ma solo ne1 caso cl-re si tratti ctln er''idenza di portatrici di
-.. .'.n. .imbecilli,, sordclnrute, mtrtilatc (una donna è prir,a di un llraccio) e le
. : :tìLrre in questo perioclo sopl'aval-ìzeoo per numelo le restauli infelici Lo stato
, . , :':rlrirà psiclrica À s.,p1,or,.i'1e, è r'itcnuto il peggiore pe r 'ia
clelf impossibilità
-.-,.rrione delle inf"rrrìe. Per Maria Rosa, una contadina di trcnta anrri di Sarl
-1 rtr I Scopeto, tliaclre c1i trn bambino partorito nel settcrnbre de1 1845, defini
- - :r.cille'. ci si rtrmmaricò che.,non f,-t possibile trccostarla ai sacratìenti» tanto
-: - .-io ne fu inlirrnrato i1 parroco» (AOIFi, s..17, 17). Sempre pel quest'epoca,
, :iizia clei par:ti (pochi per la r,crità, trattandosi di ulra tl]aggioranza di par:ti
- - ,:-.- cesarej,.,.nn i.r-roslio'> o genericamer-rte «laboriosi>>' come scrtlo per trolte
.-. .'.,];o.re. Intlltre è p,",".,t.'anche la descrizione del sesso e rlel1o stato c1i
-. : ].l barlbini: Settin]ini, genrelli, nzrti nrorti' 11 9 gennaio clel ,45' Lr.risa cli 28
_..iitora' clel popoio cli san Felice in prazza, <<subì 1'operazione cesarea e dopo
' - *..:rorì, (AC)IFI ,s11 ,11 )'Agata, cli J2 anni' serva a Prato' «subìl'operazicr-
.: _: j:rnagliii, escgr-rita clal sig. prot. N[oLfìni» il 1'novetlble dcl 18'15 (AOI]ri,
87
L!crA SANDRI
s.17,17). Ne1 18,17, un'annata non considerata nclla presente campionatura, al fincdella elaborazione dci dati, si ebbe la nascita, che segnaliamo, cli ,,un fero mostruo-so, battezzato sotto condizione>>. Anche in qucsto caso colne nel precedente de17764,si fattava di un piccolo essere di sesso femminile, inviato ancora una yolta afornire materia cli studio nel vicino ospedale di Santa Nlaria Nuova (AoIFi, s. 47,17). In gencrale, rutta\ria, i parti ehbero esiro positivo e pari a 121 maschi e a ll3fetlmine; solo quattro maschi e due lcmmine furono rcgistrati come nati morti. Ladifferenza riscontrata, infine, tra il totale degÌi ingressi c il totale dei parti (circa unadiecina) è dorruta alla dimissionc delle donne prima cle1l'evento finìle delÌa gravi-danza (passate ad altri ospedali o conservatori) o non gravide.
Rigunrdo alla sorte de11e gior,ani, maturata ancl're in questo caso prinla clella par.-tenza dall'os1'rizio, sappizrmo che trc sole delle nostre 'gravide occ-ulte' per l,anno18:15 convolarono a nozze subito dopo il parto: Teresa, una trecciaiolacli24 anni diNlontespertoli; Candicla, Lrna conta.lina di diciannovc anni cli pratovechio diCasentino, rnarirarasi proprio rrclla chiesa di orbateilo e Annunziata, cli l4 anni,serva in San Lor:enzo a Fircnze, anch'essa originaria de1 Casentino (AOIFi, s. 47,17).La sorte di tutte le altre, una volta uscite dal1'ospizio, ci è nuovamenre oscura.
5. Riflessioni conclusive. A1la metà c]el Settecento, 1'assisrcnzzr a1le donne in situa-zioni di marginalit:ì, gravide illegittime, puerpere, madri fuori clal matr.imonio ospose miserabili, si tradr-rce in arnbiti di intervento politico, sanirario, giudiziario.normativo e, in collegamento con le maggiori istituzioni ospedaliere cittadine,anche di progresso medico-scientifico. La riconduzione all'orcline e alla jisciplinadel gencre fernminile, mediante 1'occultamcnto delle gravidanze e 1'abbandono ,1eifigli ai brefotrofi, si rnanifesta così nel lungo perioclo in un ritorno pgsitiyo a van-taggio delle donne sresse e de1la loro prole. È 1, donr* gra,ida, che pian pianoacquista spessore. Lospizio, l'ospedaie, i1 breforofio diver-igono di diritto i1 iuogoc1i accogJienza delle 'incinte' in stato di necessità. Cacciate clalie proprie famiglìe,dalle case dei padroni, messe sulla srradzì per la vergogna e l'inutilità à"1 1c,.o sàto,le gravicle tro\rano fìnalmentc porte aperte ad accoglierle e mani pronte acl aiutar:lenel travaglio del parto. Se gli ospizi per ie 'incinre' sono allestiti già nel corso de]Seicento, è sicuramente nel Settecento che si assiste alla proliferazione, in Italia efuori, di tale tipologia assistenziale . Lospizio per le gravicll ò inteso ancora come i1h-rogo della pre'enzione di aborti e infanticidi ma diviene, specialmente, quellodella istittrzior',.Tizzaztone cleìi'aiuto aile 'incinte', poi madri illegittime.
Lanalisi dci dati sull'età de11e gravide a1 momenro de1 parto, nelìe epoche con-siderate, ci porta ad altre considerazioni. Si è già detto di comc 1a fascia di età, chene include Ia maggior parte, cioè qr-rella ra i 2l e i 25 anni, pari a1 3"1, al.1gl9 e al)9'% al 1E'1), coincida con quella delle balie di casa, madri nubili venure cla fuoriad allattare, tra Settecenro e ottocento, all'ospedale iiorentino. ci troviamo dunquedi frontc, per Je due epochc, almcno in area toscana - ma esiste una coincidenza dirisultati sin-iiii anche per altre regioni - ad una percentlrale non inclilferente c1i
donne, tutte presumibiln'rente alla loro prima gravidanza, clivcnute madri prima delmatrimonio. Un risultato, che ci 1à intendere come la massiccia istttttzionalizzazio-
88
i\.4atrimonì mancati
ne delle gravide nei rrari ospizi per 'incinte' illegittime, fta Settecento e Ottocento,
divenga, oltre che 1a connotazione assistenziale delle varie città toscane e de11a peni-
sola in genere, la risposta acl r:n fenorleno sociale di considerevoìi proporzioni. Una
percentuale non indifferente di grovani donne arriva clifatti all'età de1 matrimonio
dopo una, talvolta più gravidanze illegittirle, che vanno ad aumentare 1a percen-
tuale dei trovatelli, mentre diminuiscono, tra Settecento e Ottocento, i nati alf in-
terno del matrimonio in genere. I concepimenti prenuziali continuano ad aun-renta-
re ancora nei prin-ri decenni del Novecento e sono tanto più frequenti quanto più
basso è il livello economico delle famiglie, specialmente diffusi tra i lavoratori del
mondo agricolo. I primogeniti concepiti fuori da1 matrimonio raggiungono in aicu-
ne regioni addirittura tl 1oul,, percentuale destinata a dimilruire con f ilitroduzione,
ir questo secolo, degli anticoncezionali (Barbagli 1984, 187).
È un dato di latto, inoltre, che con l'Ottocento i piccoli abbandonati amivino al
brefotrofio, direttamente e prevalentemente, dagli ospizi de1le 'gravide occulte'. Ed
è rale specifica riconduzione sette-ottocentesca de1 trovatello, ia principale respon-
sabile de1la sua moderna connotazione di illegittimo. La dichi:irazione obbligatoria
Ji gravidanza e l'accoglicnza delle 'incinte' nubili negli ospizi, insieme all'aumento
li bambini abbandonati nei brefotrofi, confermano poi la funzione di regolazione
.ociale ancorché econonica, assunta ovunque dalle istituzioni assistenziali, nelle
-poc1're suddette. Nel Sette-C)ttocento, si argina ancora, come già ne1 Seicento, 1'e-
:rarginazione in ogni sua forma (povertà, malattia, illegittimità, coulportamenti:er-ianti e persino abusi) rinchiudendo, serrando, istituzionalizzando e f istituzione
:i per sé, qualsiasi tipo di istituzione, di pubblica so\rvenzione e di carità, diviene
:elf inlmaginario collettivo (o realmente?) luogo aberrante e aberrato.
Occorrerà ancora molto tempo, infine, pef compfendere che il benessere de1la
iisrante si concretizza ne1 benessere del bambino, che l'aiuto dato a1la madre per
:llevarlo, sarà il viatico per il riconoscimento del figlio, che il riscatto sociale, infi-:e. de1 neonato, futuro uomo e donna, passa attfaverso la rinuncia della madre all'a
rLrnimato e 1'accettazione de1la sua maternità illegittima.Lincoraggiamento alle madri nubili al riconoscin'rento dei figli sarà difatti mate'
::-r della nuova normativa del XX secolo, che si esplicherà nei sussidi a1le madri con
=-i aiuti domiciliari, ad evitare l'istituzionalizzazrone dei bambini.LOttocento è dunque il secolo de11a codificazione de1la sperimentazione sette-
:.nresca, assistenziale e scientifica. I1 parto del1e donne diviene ambito privilegiato
:: studio sia per 1e allieve della scuola di ostetricia che per i r.neclici. Tuttavia 1a com-
:onenre moralistico-religiosa de11'eruento nascita continua a prevalere su que11a psi-
i-.logico-terapeutica e, persino, patologica. Parti gemellari o mostruosi o semplice-
::ente laboriosi sono visti corle 1a manifestazione del giudizio divino. La sofferen-
:.: del parto è ancora una necessaria e giusta espiazione. La frequentazione dei
il.-ramentj è imposta per aiutale le'incinte' prinra e 1e puerpere poi, a ritrovare 1'e-
::ilibrio, perduto in concepimenti illegittimi, in relaziolri dor,e f infatuazione amo-
:-ìsi.ì certo aveva prevalso sulla legittirnità de11a procreazione. Giulia Di Bello sotto-
--lea come nel corso de1l'Ottocento si affermi un progrcssivo arteggiamento di
-::olleranza nei riguardi della maternità fuori dal matrjn'ronio. La maternità è con-
89
LUcIA SANDRI
siderata-possibile solo per le coniugate, in una famiglia legittima, ia sola cui potevanoessere affidati «ideali educativi e finalità socialf> (Di Bello, Meringolo l99l ,39).
È .o-rrnq,r. in questo secolo che si dà modo di emergere ,[à dorrrr" in stato digravidanza atrraverso le 'incinte' iliegittime. Di quest'ultime, in particolare, si dàrisalto a1 profilo sociale, all'età, a1 mestiere, dando rilievo al loro essere inserite,nonostante tutto, in un processo economico-familiare e poi in un progetto di ,recu_
pero' sociale. Sicuramente è il secolo dell'attenzione rawicinata ala tàcnica ostetri-ca e delf ingresso delle gravide in genere in ospedaJe per partorire senza rischio efavorire, come già le 'gravide occulre', 1o studio di casistiche utili alla disciplinamedica in ascesa.
Matrimoni mancati, infine, quelli toccati in sorte a1la sragrande maggioranza clelledonne entrate rn orbatello a partorire a1le due epoche .orrrid".ut., ufÌìrrr.ut" du .,r,universo di uomini tuttavia mai dichiaratamente 'rei', quasi mai possibili sposi.
I Ringrazio Angellca Vitiello per 1e indicazionilornitemi sulf istituzione dell'Ospizio diMaternità e l'annessa scuola di ostetricia.2 Si tratta di uno studio condotto sul regisrointitolato Fanciulle delinquentì dat Uf)l at1742 (AOIFi, s. 46, 2'), utilizzato anche daGiorgia Alessi, che considera le trovatelle, vit-time di stupro e poi gravide, il prototipo della'gravida occulta' toscana di quesro periodo
Riferimenti archivistici
AOIFiASFi
Riferimenti bibtiografici
G. Alessi 1995, Le grauidanTe illegittime e ildisagio dei giuristi (secc. XWLXIX), in G.Fiume (a cura di), Madri. Storia di un ruolos ociale, Marsito, Venezia, 221 -245.
Firenze, Archivio Ospedale InnocentiFirenze, Archivio di Stato di Firenze
(Alessi 1995). In realtà le trovatelle gravide chepartoriscono in Orbatello tra le 'occulte', sonomolto poche. Tale fonte è stata studiata ancheda Daniela Lombardi, con una speciale atten-zione alle rrovalelle invirre a servizio luor.i(Lombardi, Reggiani 1990).J Cfr. anche, per i severi prowedlmenti presinei confronti delle tag,azze disonoiate,Matthews Grieco 1997. 89.
260,308,336)
M. Barbagli 7984, Sotto lo stesso tetto.Mutamenti della famiglia in ltalia dal XV alXX secolo,Il Mulino, Bologna.
A. Bellinazzi 1999, Ld scuola di ostetricia diFirenze fra Setteceflto e C)ttocento. Obiettitti erisultati di un progetto politico, in La nascita
AOIFi, Ospizio di Orbatelio, s. 46,2AOIFi, Ospizio di Orbatello, s. 47, 9AOIFi, Ospizio di Orbatello, s. 47, 1jAOIFi, Ospizio di Orbatello, s. 97, 9AOIFi, Ospizio di Orbatello, 9168-9169
ASFi, 1179 (Otto di Guardia e Balia del principato, 1179, fasc. 1)ASFi,2479 (Otto di Guardia e Balia del principato, 2479, {asc. 4)ASFi, 2480 (Otto di Guardia e Balia del principato, 2480,fasc. 250)ASFi, 24BB (Ofio di Guardia e Balia del principaro, 24g8, fasc. 2, 4, B, jAASF1, 2525 (Otto di Guardia e Balia de1 principato, 2525, fasc. 2', 1'11)'
Matrimoni mancati
..ii.itrlr.r e de//'ctstetricitt trtt X\,'ltI e XXf ,, , -,.. -ftrlu, t | ,. ,,. ,.1.1,,1.ì6 qsn
:-:zione di (1.A. Corsilli e L. Sandri,:::ino cli Den'roglatìa Storjca», l0l11,
,:-r l'lc)!), I lurtghi dellLt nltjtetilità d.rcrr. Xljll fXl , in Ltt. nttscita dello
..: t' t:lt'/l ostetrtcid trtt X\.'III c XX .reco,,1/t,,r', t I n,.,.1., 11,, .,,,,
':::,)it? i1 C.A. Corsirti e L. Sdndri,::ino di Dernografì:r Stor-ica», 10,/11,
- ., Ì)crrrta I.)86, Malaltio e sctcicttì, tn...,!lì sociehì ftoliond, yol. 15, ll mctti
: ':.i:rortdle c // 1t18. Teti, À{ilano, 127
::;llo. P ,\lcringolo lc).)1 . Il rifiuto della,:.:,ì.. l'tnfautictltlio /u ltd/itt tlal/'Otto. .6,.11 t1,t'1t1. f r.. li5ir.
-::ri 198(r, L'tgrtcoltlrn dll ltl .5 ttl l t j9,,:.i Jell,t sctcictà ito/tdntr, vd. 7t, Il
,.:itto t/0ti(.)il(.tle ( il i8lt, Teti, À,,lilano,
t :.':rr Leuzzi 79.)9, 'Cotdurrt, o o/tor(. .
:..:',i. ttta/riruottict e ttssistt,n:tt dorale d:.. j,t Ettì Mor/t:nnt. Olschki, Fircnze.
::-rrrcli 2001, Nlatritroni dt autico reguttt,,I.l :,iro. Boiogna.
::rlrarcli. f. Reggiani 1c)90, Da dssi.ttttl Lt
: Ctrcui/i dt rec/uttlilutto tlt,lle: serue: ;, s o /e t) s ti t u:,io n i tt s s t s tc n zi n /i (F i re n za-,,,. .\I tt-X\tilI secolo), inS. Cavaciocchi
-.rra di), [,a tlonno te //'ecctnomh, sccc.-- i\71I, Le Monnier, Firenze. 101-l19.'.i.rrthen,s Glieco I9c)7 (l9c)lt), Corpa,- ::,, ,. sessuulilì, in G. Dubv e A,{. Penor
, l.r ,lir'. Ji,, Jt,,tì,r 1,i1, ,1,,,,,,, ,.,,:.;,,ttta. ), Drtl Ritastinteilto dll'L:/à...i.,td. a cura cli N. Zemon Davis e A.
:ri.. Larerza, Roma Bar-i, 5l-9(r...rirrc 199J, Tra wet/icina c diritto. Taoria
c.prdssi dcllt perizid raedltLt nella Bologntt delSt,it-ctttct. in À{.L. Retr.i. A_ pastorc ia curacll).Ldrte di gudrirc. ilspcttt delh prry''cssionetttetJittr tt'tt tr'ladir.:,cuo ccl EItì contcntporataa,Clueb, Bologna. 5i-73,Rrrnpinelli lo')(). \i,,,7, Ji S,,t.ri. ,,1,1,,1 ,1,,1.
;r,ll, r,lozro,ti J,ll, , llt,,, J,ll.r \.ttul ! !/. lIt'utttrit:t lellct Speda/e degli Iunoct:nti (1i171877), in La ua.rct/l del/tL pe,ltlatrid e Jell'rr-sleh'icia tra XYIIT t: XX sct:o/o (a l:irant ealtror-t'). Un scltinorict con introduzjonc di(1.4. Corsinr c L. Sandri. «Bollrttino diDerrogralìa Stolica>>, )0/)1. 1)f i/.O.
R. Ror.nano 1986, [.'industrta italirrnt dd//ctre.ttdilrazlone a//'unttà, rn Storta tlalltt societtìitaha/tn, r,t'i. 75, Il tttouittttttr.r naztr.trtle c rllE4.t, Tcti, N{ilano, l]L) 126.
L. Sandri l9c)1. Baliatico mcrcendrio c abbantJo-uo tlei banbini alle istttuztc»ti trs.ristetzialt; unmede.tittct disagio sott,t/e?. in G. N{uzzarelli. pGaletti, B. Andreolli (a cura cli), Donrrt, c lat,oro xt,ll'ltalt)o mt'tlicule, Roscmbcrg & Sellicr,Tonno.105-126.
L. Sanciri 2001, fu t,tol.enzo e 'buottd crediltt'.trouotelli tt Firettze e in Toscdntt (srcc. Xl,I-X\rlII). jn E. Becchi, A. Scnreraro (iì curad.|,, Art:h iL,i d' i nfa t zt o. P t,r u rt d s t ort o grt l)atlclld pritna e/zi, La Nuova Italia, Firenzc,Ih)-tò)
L. Sandri 20(12a. Dtt d.rsts/itc d trttuitte. Lt,'Nocc'tttine' tra X\II c X\1ll scccth. tr G. DaÀ,Iolin (a cLrra di), F'ornte th os.risttn:a tnItalid dttl X\/ dl XX sccolo, Forurl, Udine.2)-)9.
L. Sandri 20O2b,l[erutto dcl htte e liglt ttbbttndonati ncgli ospeldlt tostttni dal tardoNlcdioct:ct ai girn"ni nostri. in À. Dadà (a cura<li\, Bahe da latte . Istittr:iuti tt.rsis/en:.tdli t:prit,a/t, Nlorgena Edizioni, Firenzc. I7 .1(r.
S. Ulivieri 1999 (a cura ili). Lt: btuttbiue rtellds trrriu t/e ll' ethcdzion e, Latt.;za, Roma-Bari.
91