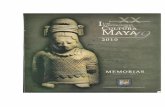Le in Toscana tra XVI e XIX secolo: il caso degli Innocenti di Firenze in Trovatelli e balie in...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le in Toscana tra XVI e XIX secolo: il caso degli Innocenti di Firenze in Trovatelli e balie in...
TROVATELLI E BALIE IN ITALIA
SECC, XVI-XIX
o curo di
GIOVANNA DA MOTIN
,NFANZTA ABBANDoNtfl??^?'i?38l,i,ro,u ('ECC xvr-xrx)Bori,20-21moggio 1993
Cqcucci Editore - Bori - 1994
INDICE
Introduzione
PARTE PRIMA
Le caratteristiche demografiche e sociali
LUCA CALZOLACaratteristiche demografiche e modalità di abbandono de-
gli esposti all'Ospedale di S. Maria della Misericordia di
Perugia nei secoli XVI e XVII
CLAUDIO SCHIAVONIIl problema del baliatico nel brefotrofio dell'Archiospedale
di Santo Spirito in Saxia di Roma tra'500 ed'800
AURORA AI.{GELIBalie ed esposti: percorsi di vita. Imola nei secoli XVII e XIX
LUIGI TITTARELLI - FRANCESCO TOMASSINII projetti dell'Ospedale Beata Lucia di Narni dal 1738 al 1859
CASIMIRA GRANDIIl baliatico esterno nel <<Piano di generale regolazione del
Pio Ospitale detla Pietà» di Venezia del 1791
pag. )
» 11
>> 73
» 109
>> 157
» 215
GIOVANNA DA MOLINGli esposti e le loro balie all'Annunziata di Napolinell'C)ttocento pag.253
PAOLA NOTARIO<<Esposti>> e <<abbandonati>> nel Piemonte della Restaurazione:l'Opera di Maternità di Torino » 301
EUGENIO SONNINOBaliatico e modalità di dimissione degli esposti nello Statopontificio agli inizi dell'Ottocento
ANTONIA PASIDentro e fuori l'ospizio: l'infanzia abbandonata nella Paviaottocentesca
CRISTINA POZZAL'infanzia abbandonata in una zona risicola del secondoOttocento: il brefotrofio di Vercelli
PIER PAOLO YTAZZO - MARIA BORTOLOTTOANDREA ZANOTTOPenuria di balie e mortalità degli esposti a Firenze, 1840-1920.Note di una ricerca
PARTE SECONDA
Le fonti archivistiche e letterarie
ANGELO SEMERAROL'esposizione nella storia dell'infanzia
LUCIA SANDzuLe <<scritture del baliatico» in Toscana tra XVI e XIX secolo:il caso degli Innocenti di Firenze
664
>> 325
>> 347
>> 393
>> 4lg
>> 457
,> 4Jl
LIDIA FERSUOCHTipologia delle fonti sul baliatico dell'Istituto Santa Mariadella Pietà di Venezia dal secolo XVII alla caduta dellaRepubblica pag. 491
WANDA DE NUNZIO SCHILARDIL' infanzia abbandonata nel romanzo sociale dell, Ottocento(Ranieri, Mastriani, Serao) >> 52j
SILVANA RAFFAELEFonti, dinamiche demografiche e aspetti sociali dell'infan-zia abbandonata nell'Intendenza di Catania (sec. XX) » 553
FRANCA COSMAITipologia delle fonti sul baliatico dell'Istituto SantaMaria della Pietà di Venezia dalla seconda dominazioneaustriaca al 1866 » 603
GIORGIETTA BONFIGLIO DOSIOGli archivi dell'assistenza agli <<esposti>> nel Veneto >> 62j
ff_<
LUCIA SANDRI
Le «scritture del baliatico» inToscanatraWl e XIX secolo:
il caso degli Innocenti di Firenze
Intento del lavoro è stato quelio di cogliere le caratte_ristiche della produzione di scritture relative all'abbandono deibambini in Toscana nel corso dei secoli. Il perpetuarsi o ilvariare dei sistemi di scriffura ne1 lungo periodo è infatti ancheespressione di equivalenti stabilità o mutamenti della mentali-tà, della normativa, quest'ultima sviluppatasi specialmente inepoca a noi molto vicina, nei confronti dell,infanzia in gene_rale e di quella assistita dagli ospedali per trovatelli nel par-ticolare. La constatazione poi, specie per alcune epochestoriche, dell'utilizzo in Toscana di un medesimo modello discritture <<dell'abbandono>>, ci conferma anche nell'idea dellapresenza di una comune sensibilità nei confronti di un feno-meno intensamente sentito e a carico esclusivo ormai, già daltardo Medioevo, di enti assistenziali urbani, cui facevano capoampie zone del territorio regionale.
L'indagine portata su alcuni archivi delle principali cittàtoscane ha dato risultati inediti per la quantità, l'originalità el'antichità delle scritture prodotte nei secori dalle amministra-zioni ospedaliere a seguito dell'accoglimento dei trovatellir.
Trattandosi, poi, di una quasi totalità - l,unica ecce_
zione è quella fiorentina - di istituzioni dedite, taivolta sino
al XIX secolo, ad attività poliassistenziali,la documentazionepervenutaci comprende, in molti casi, oltre a quella dei get-tatelli, anche quella degli infermi ricoverati.
Sono stati consultati, oltre a quello fiorentino dell,Isti_tuto degli Innocenti
- che conserva anche le scritture di altri
)
r-E <<scRn-ìruRE DEL BALiATtco>> rN Tosc,qr,q rna, XVI r. XIX sEcot-o
ospedali cittadini più antichi nonché quelle dell'ospedale per
trovatelli di San Gimignano - gli archivi di Prato, Pistoia,
Lucca, Pisa, Siena, Arezzo e Cofiona.Un primo risultato, come si è accennato, è stata la ca-
ratteristica dominante, rispetto ad altre regioni, dell'antichitàdelle memorie toscane pervenuteci in materia di abbandono.
Arezzo, Lucca, Prato e Firenze -
quest'ultima però limita-tamente al fondo del più antico ospedale di San Gallo, riunitoa quello degli Innocenti nel corso del '400
- conservanoinfatti i registri dei trovatelli dal '300, '400 e, pressocché
ininterrottamente, sino al XIX-XX secolo2. Le scritture con-
servate negli ospedali di Pistoia, Pisa, Cortona e Siena, piùtarde e, forse, come sappiamo per quello della Scala di Siena,
andate soggette a maggiori dispersioni nel tempo, ci permet-
tono tuttavia anch'esse di risalire al XVII se non al XVI se-
colo; solamente Pistoia conserva le scritture dei gettatelli a
partire dal Settecentor.
La memoria dell'attività assistenziale è generalmente
legata in Toscana e altrove - almeno sino a quando non si
sviluppa un progresso nell'attività medico-scientifica e una
spiccata sensibilità all'assistenza sanitaria - quasi unica-
mente alla contabilità e all'amministrazione degli assistiti, per
cui le scritture dei bambini e quelle degli infermi vanno lette,
dal XV al XVIII secolo, con una valenza quasi esclusivamentecontabile, redatte cioè in vista del probabile futuro rimborsodelle spese di baliatico, in un caso, e per gli effetti personali
che l'istituzione di diritto veniva ad ereditare dopo la mortedei ricoverati, nell'altroa. Da qui, l'utilizzo dell'espressione«fonti del baliatico>> per indicare genericamente tutte le scrit-ture riferite all'abbandono dei bambini, sia per la natura
prevalentemente contabile, come si è detto, di esse, sia per lamotivazione principale, quella del baliatico appunto - specie
per i legittimi - del loro affìdamento alle istituzioni ospe-
daliere5.
472
LE <<ScRITTURE DEL BALrATtco» rN ToscnN,.r,'r'n,r XVI r,t XIX sr,t,or ,,
L'analisi di quelle che possiamo indicare arr.rpiarrrcrrlccome scritture del <<baliatico>>, ha dato modo di constirtiu'c.dunque, come in area toscana, per il '300, il '400 e, di solito,per tutto iI '500 e oltre, come vedremo, venisse utilizzato unmodello unico per questo tipo di registrazioni.
Tale sistema di scrittura, tradizionalmente seguito intutta la Toscana e in maniera molto uniforme sino a tutto ilXVI secolo, consisteva, nel particolare, nell' annotazione su diun unico registro e sulla medesima carta, una per ogni bam-bino, sia del momento dell'ingresso e quindi delle notizieattinenti al trovatello e al modo in cui era stato abbandonato,che di quello successivo dell'affìdamento alla balia, o meglio,specie per il '400 e il '500, al marito di lei il <<balio>>, colquale, avvenivano di norma i patteggiamenti per il salario dacomispondere per I'allattamento o lo svezzamento. Ogni cartadel registro veniva in questo ntodo intestata ad un bambinosempre diverso, cui era aperto il conto personale del suo ba,liatico.
Il nome clel barnbino infatti veniva ben evidenziato sulmargine sinislro o al centro della carta, subito dopo seguiva ladescrizione del modo del suo abbandono, con f indicazionedel giorno, dell'ora, del luogo del ritrovamento, delle suecaratteristiche fisiche (età, sesso, stato di salute) e dei segniche lo accompagnavano dalle fasce, ai messaggi, agli oggettidi riconoscimento, i più vari. Seguiva f indicazione della baliacui lo si affidava, con la precisazione del suo stato di co-niugata, il popolo, la parrocchia di appartenenza e, princi-palmente, il salario mensile stabilito. A capo ogni volta, comeper ogni altra scrittura contabile, venivano i pagamenti, nel
Quattrocento e nel Cinquecento ancora in denaro o in natura,a seconda dei luoghi e dei casi6.
Nelle istituzioni più grandi, dotate di complesse ammi-nistrazioni contabili e patrimoniali, le spese del baliatico fi-nivano per confluire in partite complessive, nei cosiddetti libriMaestri o Mastri i cui conti cumulativi concorrevano poi alla
413
LE <<scRrrruRE DtsL tsAt-lATtco>> tN Tosca,NR rne XVI e XIX sECoLo
formazione dei bilanci annuali. Valga per tutti l'esempio, ma
è la stessa cosa anche a Firenze, di Siena, dove nel XVI se-
colo, nei registri delti Libri a ricogliare e bilanci, compare in
dare e in avere il conto intestato ai «baliatici di figli e figliedi nostra casa>>, che in effetti esprimeva il totale delle spese
sostenute per i baliaticiT.È sicuramente una mentalità prevalentemente comrner-
ciale quella che anima dunque per tutto il '300, il '400 e buona
parte del '500 il modo della tenuta dei registri toscani per
trovatelli. Le scritture erano redatte, del resto non a caso, dai
camarlinghi, spesso i medesimi rettori, e poi da appositi <<scri-
vani dei fanciulli», anch'essi, come è probabile, con una
formazione contabile, anzi giuridico-contabile, visto che retto-
ri e camarlinghi erano anche, almeno nel XV e nel XVI se-
colo, i rappresentanti legali dell'istituzione.Alla direzione degli ospedali tardomedievali erano
chiamati del resto gli esponenti del mondo commerciale e
imprenditoriale dell'epoca, basti pensare al caso dell'ospedale
degli Innocenti di Firenze, governato e posto sotto la tutela
giuridico-amministrativa, sino al XVIII secolo, dell'Arte della
Seta8. Il ricorso a professionisti estranei all'istituzione, ingenere dei notai, avveniva solo in occasione di specifiche
necessità e, solo più tardi, I'aumento dell'attività e dei patri-
moni determinò il bisogno di distinguere e delegare le variemansioni pur restando il priore o chi per lui il rappresentante
legale dell'ente in genere. In aggiunta a ciò, la medesima
prassi della descrizione dei bambini al loro ingresso inospedale -
effettuata pure per gli infermi adulti, là dove
esisteva anche un'attività di assistenza sanitaria - altro non
era che la stesura di un documento ufficiale, attestante 10
svolgimento dei fatti e con una valenza prevalentemente le-
gale per il futuro del piccolo abbandonato. L'esposizionestessa era difatti, di per sé, per la perdita di identità che ne
conseguiva, un evento giuridico di notevole rilevanza. AdArezzo, nel fondo dell'ospedale di S. Maria del Ponte, è
414
I r .,s( rìr'r'r'lrrìr, r)r,r. rìAr.t^'r'r<tt>> tn TcisCnN^ T'RA XVI E X[X sgcolo
, r,ils('rviÌto, rnollo significativamente a questo riguardo, un re-rr:,trr tlci barnbini abbandonati dei primi del XIV secolo, redattorrr lrrtirro tla un notaio, che applicò alle scritture dell'abbzurdonon()n ir cuso, i formulari tipici dell'attività giuridico-notarilee.
'lLrttavia -
per ritornare alle caratteristiche, meglio sa-
rr'lrlrc rlire alle complicazioni, del modello regionale di scrit-lrrrc tli questo tipo in uso in Toscana
- ad una simile strut-
trrrirzione: descrizione dell'abbandono, conteggi del baliatico,lo spazio di una carta finiva col risultare, alla lunga, alquantorrrsulllciente, specie nel caso che il bambino portasse a ter-rninc l'intero ciclo (allattamento e svezzamento) e ancor più se
rli capitava (ma era quasi d'obbligo) di cambiare più balie,t oslringendo lo scrivano ad occupare sempre più spazio colripctere più volte il formulario contrattuale della consegna a
rìuove balie. Per questo motivo, nel corso degli anni si verificarl liequente rimando, all'interno del medesimo registro o intlLrelli immediatamente successivi, di partite intestate allo:ilesso bambino e non sempre viene indicato, come utile col-lcgamento, il numero d'ingresso, comparso, tra l'altro, a
contraddistinguere i fanciulli solo nel corso del XVI secolo,
ntentre per I'avanti tulto era affidato alla ricerca della scelta dinomi sempre diversi e quanto mai fantasiosi. Il più delle voltelo scrivano si limitava infatti a indicare il nome del bambinoseguito da un rimando ad una carta precedente con la dicitura«levato da>> o <<posto inclietro» e altre simili espressioni.
In Toscana, specie nel corso del '500, la confusione a
questo riguardo è grande. Persino a Firenze, nell'ospedaledegli Innocenti, i conti dei trovatelli si soprammettono e si
susseguono nel disordine più generale , specie tra il 1526 e il1588, anni che vedono, tra l'altro, la dispersione accidentale dialcuni dei registri originalir0. A Lucca, tanto per esemplificareun disagio comune, che poteva acuirsi localmente, le difficoltàaumentano nel tempo per I'abitudine - rilevata per certiperiodi del resto anche a Firenze
- a registrare i pagamentialle balie su due colonne nella medesima cartarr.
415
LE <<SCRITTURE DEL BALIATICO>> IN TOSCANA TRA XVI E XIX SECOLO
La predetta descrizione del bambino poi, in apertura ai
conti relativi al baliatico, agli Innocenti di Firenze avveniva,
come supponiamo avvenisse, in genere, in tutte Ie maggiori
istituzioni, dotate di un servizio di balie interne, sulla base del
resoconto fatto a voce o per iscritto proprio da quest'ultime. Ibambini infatti erano in genere accolti alf interno dell'istitu-
zione dalle balie - negli ospedali con attività poliassisten-
ziale anche dalf infermiera - ed era la balia più anziana la
persona incancata di annotare, su una sorta di brogliaccio, Ie
prime impressioni avute al momento del ritiro del bambino
dalla pila o dalla ruota, a seconda delle epoche, quando non
fosse consegnato a lei personalmente. A Siena, nell'ospedale
della Scala, l'addetta al ricevimento dei bambini era la co-
siddetta, significativamente, <<padrona delle balie>>l2.
Le balie fiorentine hanno lasciato di questa attività, una
preziosa testimonianza, costituita da piccoli registri adattr ad
essere contenuti nelle tasche o nelle pieghe delle vesti delle
donne, documento, tra l'altro, eccezionale di un mondo tutto
femminile, sicuramente poco conosciuto e catatterrzzato dal-
l'uso di un linguaggio, come appare dai medesimi libretti, di
marcata impronta dialettale, quotidiana e familiarel3. Le im-
pressioni, i giudizi insindacabili, formulati dalle balie a se-
guito della loro consumata esperienza, rigtardavano, partico-
larmente le caratteristiche fisiche dei bambini: l'età, lo stato di
salute o meglio f identificazione del tipo della trasctratezza
soffertala.
È con la fine del XVI, se non nel corso del XVII secolo
che, per ovviare alla più o meno intensa ma generale confu-
sione dei registri, che abbiamo sin qui definito di tipo tradizio-
nale, destinati cioè a risolvere, lo ripetiamo, in un'unica so-
luzione, e la memoria degli abbandoni e Ia contabilità dei
baliatici, che si prowide, sia pure diversamente da luogo a
luogo, a distinguere due serie di registri: quelli dei conti delle
balie, e quelli destinati più propriamente alla memoria della
modalità degli abbandoni.
476
ì
LE <<scRrrruRg DEL BALrATrco>> rN ToscaNa rna XVI s XIX srcolo
Il Seicento si presenta, infatti, per questi enti come unsecolo di cambiamenti notevoli, dal punto di vista dell'am-ministrazione, banco di prova dell'interpretaz\one e dell'ap-plicazione della nascente volontà dello Stato Regionale. LaToscana è infatti interessata a quest'epoca da un vasto mo-vimento teso all'accentramento dei diversi poteri, che si evi-denzia, anche e specialmente, nel controllo dell'amministra-zione di istituzioni di questo tipo, ospedaliere, assistenziali ingenere, dotate di patrimoni considerevoli. Le medesime sop-pressioni e successive riunioni, operate già dal '500, sono ilsegno di una forte volontà riformatrice e accentratrice.
In quest'ottica, di un progresso continuo teso a tessere lemaglie del futuro Stato Regionale, al cui interno certol'estensione fondiaria degli enormi patrimoni ospedalieri -basti pensare a quello della Scala di Siena e a quello degliInnocenti di Firenze - creava ampie zone di autonomia e diintemrzione al potere mediceo, si pone a nostro avviso la ri-levazione dei cambiamenti amministrativi degli ospedali ingenere e di quelli per trovatelli, che qui particolarmente in-teressano.
È dunque sicuramente, ancora una volta, una necessità dicontrollo contabile-amministrativo, ancor prima che una ma-turazione di sensibilità nei confronti dell'infanzia abbando-nata, quella che portò, nella seconda metà del '500 e ancor piùnel corso del'600, le direzioni degli enti ospedalieri toscani adistinguere, sia pure diversamente da luogo a luogo, la <<me-
moria>> delle esposizioni dalla contabilità degli allattamenti e
degli svezzamenti. Gli ospedali di Santa Maria del Ponte diArezzo e quello della Misericordia e Dolce di Prato, operaro-no una subitanea e netta distinzione tra le due tipologie discritture, memorialistiche e contabili. Le istituzioni assisten-ziali di Firenze, Siena, Pisa e Cortona, preferirono inveceaffiancare una più precisa contabllizzazione dei salari e deibaliatici, all'antico sistema di registrazione, che venne co-munque affidato da quest'epoca ad un formulario stereotipato
471
LE <<scRIT"TURE DEL BALIATICo>> IN Tosc,qNe rn,q. XVI s XIX sECoLo
a sottolinearne la caratteristica di scrittura unicamente destina-
ta ormai all'assolvimento di una prassi ufficiale.
A quest'epoca dunque conteggi e pagamenti si risolsero
dappertutto - purffoppo le serie contabili sono le più sotto-
poste, a torto, nel tempo, a massicci scarti archivistici - in
scritture specifiche, variamente articolate e, talvolta, come
vedremo per Firenze, d'impianto del tutto originale. Unica
eccezione l'ospedale di San Luca di Lucca, che pare perpe-
tuare sino ad epoca moderna la complicata e però tradizionale
registrazione, quasi ad esprimere una sorta di impotenza ad
arginare un fenomeno, la cui entità fiaccava evidentemente a
Lucca ogni tentativo di ordine e regolatezza-
I1 mantenimento, di una medesima forma di scritture
degli esposti in Toscana, sino al XVI secolo e poi, con carat-
teristiche ancora ben riconoscibili, fino all'800 sembra testi-
moniare allora la propagazione e il perdurare di un <<sapere>>
amministrativo che è presumibile si trasmettesse nell'avvi-
cendarsi stesso dei medesimi rettori, dei camarlinghi, chiamati
al comando dell'ente, come sappiamo per cerlo avvenisse
nell'area fiorentina e senese, tra gli ospedali dipendenti da
quello della Scala di Siena, caratterrzzato da una notevole
espansione di «filiali» oltre i confini cittadinir5' Ma anche
altrove sappiamo vigesse ugualmente la medesima consuetu-
dine, dettata dalla necessità di salvaguardare tali enti da ogni
possibile malversazione. ciò specialmente nel XVII e XVIIIsecolo, allorchè pare chiudersi la parentesi dei rettori laici a
beneficio quasi esclusivo di personalità di spicco del mondo
religioso, abati, canonici, e pievani, assistiti però, data la nota
incompetenza dei religiosi in campo amministrativo, nuova-
mente da camarlinghi e scrivani di volta in volta diversi, ma
con provate esperienze contabili, quasi un manipolo di pro-
fessionisti itineranti, paragonabili per certi aspetti agli antichi
giudici e notai chiamati al seguito dei podestà.
A Firenze, per ritornare alle modificazioni intervenute
all'apparato delle scritture tra XVI e XVIII secolo, la specia-
478
LE <<scRrrruRE DEL BALrATrco>> rN TosceNe rne XVI s XIX sECoLo
lizzazione assistenziale dell'istituzione - l'ospedale degliInnocenti era unicamente destinato all'allevamento degliesposti - produsse un'attenzione dilatata e per certi versiinnovativa dell'amministrazione dei baliatici. Già a partire dal1615, in concomitanza dunque dei predetti controlli, praticatidall'autorità aI potere, di cui la medesima Arte della Seta,
patrona dell'ospedale era comunque organo rappresentante, siprodusse la serie nominata Riscontri del baliatico, dovegiornalmente venivano annotati tutti i pagamenti a beneficiodelle balie estemet6.
Tale prassi rispondeva però anche ad esigenze di ordinepratico differente, derivanti da un sensibile aumento delleesposizioni, verificatosi generalmente e non solo a livelloregionale, nel corso della seconda metà del Cinquecento.Sempre agli Innocenti di Firenze, per esemplificare, dai 771
esposti degli anni 1535-37, si era passati, quasi un raddoppio,ai 1.516 delle annate 1596-98, come sappiamo dal rendicontopresentato al L599 da Bemardino di Carlo Masini, l'alloranotaio e cancelliere de11'ospedale'7. Il Masini fece seguiredifatti alla documentazione una supplica accorata, rivolta alGranduca dove si precisava la necessità di aiuti «per il grannumero di bambini», <<portati dal 1590 in qua e che del con-tinuo>>, aggiunge, vi venivano recati, tanto che era stato a suo
dire, <<necessarissimo non solo accrescere numero di balie mali salari» di queller8.
A1 carico dei nuovi arrivati, si aggiungeva poi quellodelle fanciulle e delle donne rimaste in casa, che si andavano«multiplicando e crescendo», tanto da aver indotto, già nel1550, il priore di quel tempo, a rivolgersi al medesimogranduca perché <<facessi un editto, che nessuno bambino Ie-gittimo potessi venire allo spedale>>le. Tutto ciò a dimostra-zione di come il problema delle bambine e donne rimaste a
carico delf istituzione si identificasse macroscopicamente conl'abbandono dei legittimi, cui la ruota, entrata in uso già dalXVI secolo, non era stata un bastevole deterrente2O.
479
I,IJ <iS('RI'I"fI.]RL1 DEL BAI-,IATICO>) IN TOSC,qN,q TNA XVI B XIX SECOIO
Tale coincidenza, tra l'aumento dei legittimi abbandonati
e quello delle fanciulle rimaste a carico dell'istituzione, appare
ancora più esplicitamente ai primi del '600 a Lucca, dove ilgià nominato ospedale di San Luca, è costretto ad adottare
provvedimenti del tutto singolari e gravemente emarginanti
nei confronti delle bambine. A partire dal 1610, venne vietato
intatti ancora più drasticamente l'abbandono dei bambini le-
gittimi <<al portone>>, cioè al di fuori della ruota, come co-
munemente avveniva per t ragazzi già grandi, disponendo tra
l'altro sì la restituzione dei pochi maschi ma la registrazione
su un libro a parte per le femmine, delle quali non era pos-
sibile, per il gran numero, in alcun modo, <<liberarsi>>. Tale
distinta registrazione veniva a discriminare così ulteriormente
le trovatelle, visto che «quelle figliuole, descritte a detto li-bro>>, erano poi destinate a non <<havere alchuno favore e dota
dallo hospitale>>, cosa che però finiva col rivolgersi contro
l'istituzione medesima, visto che in questo modo si rendeva
ancora più difficile la loro sistemazione, tanto da deciderè in
seguito di concedere lo stesso una dote alle legittime, sia pure
di 50 anzichè di 65 scudi come di consueto''. È a Lucca,
inoltre, che i registri dei gettatelli detti, originalmente, Libridei bambori, aumentano notevolmente di dimensione, per ilgrande numero di fanciulli abbandonati proprio tra la fine del
XVI e il XVII secolo, epoca in cui compare, di regola,
ovunque, il solo accoglimento dei bambini appena nati.
Sebbene in teoria, infatti, solo gli illegittimi avrebbero
dovuto correre il rischio di essere abbandonati <<di nascita>>,
tuttavia, come è noto, sia la ruota che le disposizioni ulte-
riormente tese a rnortificare l'esposizione dei legittimi, non
ottennero altro risultato che quello dell'abbassamento dell'età
all'esposizione stessa di quest'ultimi, fenomeno che resterà
generalmente invariato per tutta I'epoca tnodema22.
Se l'aumento delle esposizioni, il carico dei legittimi,specie delle femmine, avevano determinato già alla fine del
XVI e ancor più nel corso del XVII, variazioni sensibili, come
480
r.rì {<scRr't"rURIi Dur- BALrAl rco» ti',t TosCnNA frìA XVI il XIX sr(,()t ()
.;r i'visto, a livello del sistema di scritture destinate all,inlirr-zirr abbandonata in Toscana,
- ampliando il settore contabile,olir rìettamente distinto, per riassumere, dalla stesura dellerlcscrizioni, che abbiamo definito veri e propri verbali dell,in-lrrxluzione
- bisognerà però aspettare il XVIII secolo pers I ornare final mente l' attenzione dall' area econom ico-contabil evcrso quella più specificamente assistenziale e sanitaria.
Dal 1145 la Toscana era difatti sotto l'influenza partico-liumente illuminata del governo lorenese, sicuramente inten-zionato ancor più del precedente ad una azione di controllo marrrrche, data I'epoca, a quella di sperimentazione, individuazione,r:ampionatura dell'enorme e sconosciuta folla degli esposti.
L'impossibilità di seguire le fasi di vita e il desrino deglicsposti era risultata chiara, infatti, dappertutto, già nel corsorlel '600 con la generale denuncia a livello delle varie istitu-zioni regionali, dell'insufficienza delle ispezioni, clelle visiteoperate nel corso della durata del baliatico ai bambini dati ahalia fuori, i più sottoposti al rischio della scomparsa. A prato,rr metà del '600, per ritornare alla viva voce delle fonti scritte,(ìiorgio Landi, scrivano dell'ospedale della Misericordia eI)olce, doveva ammettere con ramtnarico che, nonostante levisite da lui fatte nel corso del 1656 alla ricerca di molti deitlovatelli affidati ai bali, <<non si era potuto avere notizia dir;uello era stato di loro>>23.
Se una maggiore puntualità nei controlli, viene messatlr:nque in atto generalmente nel corso del XVIII secolo, è aIiirenze che, nella seconda metà del'700. si ha modo di veri-licare la sperimentazione di una rilevazione tutta particolare,t;uella dei Giornali del Baliatico, incentrata sulle variazioniciornaliere - fanciulli entrati, dati a balia, restituiti, deceduti,plrrtiti, maritate, ecc.
- dell'elemento umano, oggetto dell'as-sistcnza e unica attività dell'ente: gli esposti, ancora una volta,:,irr lrure in lennini di esistenza in vita, contabllizzati dall,am-n r irr istrazione2a.
481
I,t1 (<SCRI,-ì'L]RE DE' BALIATICO>> IN TOSCENN TNA' XVI E XIX SECOI'
]
Alla fine del '700, all'ingerenza secolare dell'Arte della I
Seta si andava sostituendo di fatto sempre di più nella dire- ]
zione dell'ospedale fiorentino degli Innocenti, quella grandu- !
cale, nella persona di Leopoldo II Asburgo Lorena, molto J
impegnato tra l'aItro, proprio nella riorgantzzazione dell'as-
sistenza ospedaliera, mediante soppressioni e successive
concentrazioni25. Non solo, in questi anni è nominato commis-
sario degli Innocenti, 1'abate Giovanni Neri, braccio destro del
medesimo Leopoldo nell' indagine da lui voluta proprio sullo
stato dell'assistenza ospedaliera in Toscana26. Eletto commis-
sario nel 1766, è proprio dal 1761 che varia sensibilmente
nell'ospedale fiorentino, il sistema di scritture dedicato ai
trovatelli lì ricoverati.L'aggiustamento amministrativo voluto da Giovanni
Neri, avvenne su due fronti: quello contabile, relativo ai pa-
gamenti alle balie e quello, fino ad allora il più trascurato, del
conteggio dell'esistenza in vita dei piccoli abbandonati, me-
diante l'approntamento di tabelle riassuntive mensili, siste-
mate all'intemo dei medesimi Giornali del baliatico e addi-
rittura di tabelle giomaliere, redatte dall'allora scrivano
Francesco Mariani. In questo modo il commissario di nomina
granducale, cioè il suddetto abate, riusciva ad avere «sì gior-
nalmente che mensualmente il numero certo dei pagamenti e
delle creature esistenti o nello spedale o fuori di esso, per
potere alla fine dell'anno avere uno stato certo del pagamento
del baliatico ed esistenza delle creature, il che era stato tentato
altre volte inutilmente per la varietà giomaliera», per dirla con
le sue stesse parole, di cui «soffriva l'ospedale>>27. Si alludeva
in questo caso certamente al continuo, quotidiano via vai di
balie che venivano a prendere o a riportare i bambini del-
l'ospedale. Superfluo dire che nessun altro ospedale del
granducato riporta per il XVIII secolo una tale varietà e accu-
ratezza di rilevazioni destinate ai trovatelli. Gli lnnocenti
rappresentano, infatti, in questi anni l'efficienza amministrati-
va lorenese, mai come in questo periodo i bambini appaiono
482
LL, <<scRrrruRE DEt_ BAt_tATrco>> rN ToscRn,q.r.n,,r. XVI n XIX sl«,or,rr
( rrrati e seguiti. Sono anche gli anni che vedono l,impegnorlcll'ente spostarsi pian piano verso il campo più propriamentesirnitario che assistenziale. A questo scopo non si esita a tenereeontatti e a scambiare esperienze sull'allevamento deglicsposti a livello europeo.
La direzione degli Innocenti accoglie difatti di buongrado in questi anni le notizie dei regolamenti che sonoadottati in simili istituzioni a Londra e, nel 1162, aniva ilprimo resoconto, da Vienna, questa volta, sull,allattamentoartificiale degli esposti. Anzi giunge in quest'anno notizia dicome si <<alimentano gli infanti con l'acqua invece che collatte>>, e ciò tramite una «pallottolina a sfera di legno», con un«sifone a guisa di cannello d'imbuto da1 quale si fa gemerecon I'aiuto o forza del bambino, che succhia I'acqua, appli-cando un cenciolino al luogo dove deve applicare i labbri»28.La notizia era sl.ata trasmessa con l'entusiasmo del ricercatoredal medico fìglinese Pallucci, che aveva studiato chirurgia aFirenze, al Santa Maria Nuova e poi da qui era passato aParigi e da lì ancora a Vienna, <<cerusico>>, questa volta, nellalÌuniglia imperiale2e. Ma Firenze e gli Innocenti non eranoirncora pronti a simili sperimentazioni e a memoria dei posteri,si volle sottolineare che i «professori di medicina, tutte lel)crsone savie e più d'ogni altro i ministri dello spedale dilrirenze, furono di sentimento che per infinite ragioni mairrndasse usato tal metodo>>, aggiungendo che nella medesimaVienna, tale sistema si «costumava rarissime volte e solotluando alla rnadre mancava il latte ed al padre i denari perlrovare altra nutrice>>3o. Lo scandalo insomma fu tale che sir ilenne addirittura necessario giustificare la conservazionerlclla lettera del Pallucci che, si disse, essere stata archiviatasolo <<per poter dare» con tale memoria <<ancora al medesimo:;istcma la totale disapprovazione>>3r.
Il XIX secolo, dopo la parentesi della dominazione fran-t t'sc, che produsse, tuttavia, non poche modificazioni nelle;rrrrrrinistrazioni di questi enti, si apre invece dedicando un'at-
483
LE <(scRITTURE DEL BALIATICo» IN ToscnNa rn,q. XVI B XIX sECoLo
tenzione particolare all'assistenza dei legittimi o meglio sareb-
be dire alla loro identificazione. Il problema principale del
secolo è infatti la definizione dello stato di legittimo o diillegittimo del bambino abbandonato. Del resto la ricerca della
matemità e della patemità non erano mai state proprio de1
tutto accantonate. Nel primo libro di Balie e bambini, con-
servato agli Innocenti di Firenze già nell'anno 1445, al-l'apertura ufficiale della grande istituzione assistenziale, Lapo
di Pacino, un setaiolo eletto dall'arte alla carica di camarlingo
scriveva: <<Questo libro è dello spedale degli Innocienti ...
dove si scriveranno tutti i fanciugli e fanciulle recati a questo
spedale chon tutti quelle chose che' detti fanciulli arecheranno
e cho' sengni saranno mandati el dì e 1'ora e milesimo a punto
e se sarannobattezzati o no, il nome del padre se ci sarà detto
e simile el nome e soprannome el popolo di chi l'arecherà...>>32.
La verbalizzazione stessa del modo dell'abbandono, che
abbiamo notato per tutte le epoche, era arìcorata alla speranza
di una futura richiesta del bambino da parte dei genitori.
Dappertutto, poi, il moltiplicarsi degli abbandoni dei bambini
alle istituzioni ospedaliere, a partire dalla fine del XVI, per
tutto il XVII sino al XVIII secolo, ancor prima dunque della
legge di soppressione delie <<ruote>> del 1875, aveva reso or-
mai chiaro che la gran parte degli abbandonati avesse alle
spalle una famiglia o comunque una qualche possibilità direinserimento in un nucleo familiare. A Siena, l'ospedale della
Scala, oberato oltre misura dal numero dei bambini abbando-
nati, rendeva possibile già dal 1J83, accertamenti e controllitesi alla ricerca del padre e quindi alla legittimazione dei bam-
bini, come testimonia la serie documentaria prodottasi, a parlire
da quest'epoca e dedicata alla restituzione degli esposti33.
A dir la verità, ad eccezione di quello florentino, gli ospedali
toscani per frovatelli, operano già nella prima metà dell''800,alcuni significativamente già durante il periodo francese e
altri, a seguire, in piena restaurazione lorenese, una distinzione
tra le scritture destinate ai legittimi e quelle riservate agli il-
484
r,ri «scRrrruRE DEL BALrATrco>> rN ToscaN.q. rna XVI e XIX sECoLo
lcgittimi. È così per l'Ospedale di S. Maria della Misericordiarli Cortona, che agisce in questo senso già dal 1807, per quellorli S. Maria del Ponte di Arezzo, dal 1816, per quello della§cala di Siena, dal 1820 e dal 1825 per quello della Miseri-cordia e Dolce di Prato. A Firenze e a Pistoia tale distinzionecomparirà nettamente, a Pistoia, solo all'indomani dell'abo-lizione della ruota, e a Firenze, in concomitanza della leggedel 1890, disciplinante, come è noto, le Istituzioni pubblichedi Assistenza e Beneficienza c:ui quella degli Innocenti era oraassimilata.
È la normativa statale dunque che, in modo meno blandoche nel passato, avoca a sé il controllo delle istituzioni assi-stenziali, disciplinandone l'attività sino ad improntare, le-gandolo ad una rigida normativa, il sistema amministrativo.Ancora una volta infatti tale distinzione tra legittimi e illegit-timi è da ricollegare alla motivazione economica al costo cioèdei medesimi da ripartire, a seconda dei casi, tra i vari poteriamministrativi pubblici.
Già ne1 1818, infatti, le istruzioni granducali relativeall'assistenza dei trovatelli prevedevano che tale servizio fosseda effettuarsi solo nei confronti degli itlegittimi introdottinella ruota e per i legittimi orfani di padre o con madre im-possibilitata ad allattare3a. Sempre a questa data era stata sta-lrilita anche l'età massima di assistenza da effettlarsi nei con-fionti dei maschi, sino ai 14 anni e nei confronti delle fem-mine che, salvo diverse consuetudini, sarebbero rimaste sinoai 18 anni.
In conclusione, l'angolazione proposta in questa sede, diuna ampia visione cioè dello sviluppo dell'organizzazioneclelle scritture del <<baliatico>> toscane nel tempo, se ci ha datoragione della presenza specie per i secoli XV-XVI, di un unicornodello regionale di scritture del «baliatico>>, corrispondentescnza dubbio ad una medesima sensibilità nei confronti del-I'infanzia abbandonata e ad una medesima concezione giuridi-c:o-contabile del problema dell'abbandono, ci ha però anche
485
r.E <<scRITT'uRE, DEL BALlATlco>> IN Tosc,q.N,q r«a XVI g XIX sECoLo
confeflnato nelf idea che a partire dal XVI sino al XIX secolo,
è il lento ma inesorabile cammino verso la formazione di uno
stato regionale prima e unitario poi, che disciplina tali isti-
tuzioni sino a modificame anche i sistemi di scrittura'
LaletturaditalimodificheofflespuntopelvalutareI'influenza governativa sulle diverse istituzioni e, di riflesso,
sulla loro attività, sulla mentalità e sensibilità nei confronti del
fenomeno dell'abbanclono e delf infanzia in genere' Riguardo
al primo punto la ricchezza del patrimonio rappresentò, come
fu per gli Innocenti cli Firenze, motivo di ingerenza ma anche'
dai,altra parte, di autonoma resistenza sino quasi alla soglia
del XX secolo. Riguardo al secondo, alle variazioni cioè della
sensibilità nei conlronti clei bambini abbandonati, col 7927
I'Istituto dovetle sottostare, nuovamente, sotto il profilo della
tenuta clelle scritture dei bambini, ad ulteriori modificazioni,
tese a stabilire l'inemente il grado di emarginazione dei
barnbini lì ricovcrati al iine puramente economico, ancora' di
un'equa redistribuzione clelle spese per il loro allevamento. se
nel corso del XVIII e ancor più del XIX secolo, infatti, era
stata comunemente accettata ormai, al momento dell'ingresso,
la distinzione tra bambini di genitori conosciuti o legittimi e
bambinidi<<genitoriincogniti»,aseguitodellaleggedell'Smaggiodel|gTT,unadelleprimedelventenniofascista,siprodusseunaquantomaidifficiledistinzionetragliesposti-òra tutti indistintamente illegittimi -
che vennero segnati su
registri diversi a seconda dell'epoca del riconoscimento da
p*t" d"11" madri. I libri degli Esposti riconoscirzli furono così
quelli dedicati ai bambini riconosciuti dalla madre sino dalla
nascita, a carico in questo caso <lell'ente provinciale. Tutti gli
altri, per i quali il riconoscimento non era avvenuto o tardava
a venire, erano registrati nei libri degli Esposti illegittimi e
rimanevano a carico dell'ospedale3s. Si era così creata una
gerarchia dell' emarginazlone.
Lastoriadellasensibilitàaibambiniabbandonatiappareallora ripetersi nei secoli, sia pure infine in un'ottica stravolta,
486
! ,,:ir'r{lt'r'l |Rtr r)rrr . B^r.l^il(r)), tN'lì)s('ANA't tì^ XVI t XIX st,(1)t ()
,r ( ()rr(l() rrnir irnrr.rutabilc costantc: il carico cconolnico tlcll,,rlr:rtit'o. Ma la cuntabilità dcl baliatico insieme erlla lncntoriulrrrrirliclr dcll'abbandono, erano anche le costanti della mc-rrroliir scritla del «sistema assistenziale toscano per trovatelli,lt'llc origini».
Nrrt tr
I Si noti ad esempio la maggiore antichità e perpetuità delle fonti dellr.rlr;rtico loscane, rispetto a quelle venete, presentate da Giorgetta Bonfigliol rosio. (i1r orch.ivi dell'assistenza agli nesposti» nel Veneto in questo medesirnor olUntc.
' Il lbndo dell'ospedale di S. Maria del Ponte di Arezzo (secoli XIV-XIX), r orrscrvato presso l'Archivio di Stato di Arezzo, da qui in avanti A.S.A.; illontLr rlclì'ospedale della Misericordia e del Dolce di Prato (secoli XIV-XIX), ,rtlrurhncnte presente nella sezione distaccata dell'Archivio di Stato di Firenzerrr l'r;rlo, d'ora in poi 4.S.tr.P.; il fondo dell'ospedale di San luca di Lucca (XV-\l\ sccolo) è depositato presso l'Archivio di Stato di Lucca, d'ora in poi\ S.1,.; pcr Firenze si tratta invece di fondi (secoli XN-XV per l'ospedale di'i,rrr ( iullo e XV-XX per quello degli Innocenti) ancora depositati nella sedei,r,'rìiìr-iiì dell'Archivio dell'Ospedale di S. Maria degli Innocenti, per sempli-, rl.r A.O.l.F.
' l-c scritture dell'ospedale del Ceppo di Pistoia (secoli XVIII-XIX) sono, orr,,r'rvirtc presso l'Archivio di Stato di Pistoia, d'ora in avanti A.S.P.T.; a Pisarl lorrlo tlegli ospedali Riuniti (secoli XVIII-XIX) tra cui anche quello deitr,r'rrrclli é presente nell'Archivio di Stato di Pisa, che sarà indicato per sem-;,1r, rt;r A.S.P., riservando la sigla A.S.S. all'Archivio dell'ospedale di S. Maria,[ ll:r Sclla di Siena (relativamente ai trovatelli dal XVI al XIX secolo) de-p,r:,rt:rlo appunto nell'Alchivio di Stato di Siena. Per Cortona, infine, il fondo,lrll'Ospcdale di S. Maria della Misericordia è presente presso l'Archivio Sto-rrr o rlel Comune di Cortona, d'ora in avanti A.S.C.C. A questo proposito,rrnl'rrzio i colleghi, archivisti e studiosi, che si sono prodigati, lacilitando i'','rr,Lrp,lti rli studio nei diversi fondi documentari. In particolare ringrazio larloll ss:r Malina Brogi di Lucca, la dott.ssa Antonella Moriani di Arezzo e il,lott llr-rrno Cìianluca di Cortona.
r('lì.. a proposito delle fonti ospedaliere in genere e per la memoria,',.,r'n/i;rlnrerìlL: contabile degli inf'ermi, L. Sandri, Stranieri e Jorestieri nellaI ttr'n r' tlr'l Qutttlnx'cn.to a.ttrayerso i libri di ricordi. e di entrata e uscito degli',tt,r',l,tli r ittrttlini,h Forestieri e stranieri nclle città basso-medievali, Atti del1,, urr;ri() Irrlcrnazionale di Studio Bagno a Ripoli (Firenze) 4-8 giugno 1984,lrrr rrz. lr)fil{, pp. 149-l6l e anche Ospedali e utenti dell'assistenza nella Fi-t,t r tlt l)u(ttlto((nl(),in Lu società del bisogno. Povertà e assistenza nellal',t,,trr,r ntt'tlì('r(tl('. a cura tli Ciuliano Pinto, Firenze 1989, pp. 6l-100. Per
487
r.E <<scRrrruRE DEL BALTATICo>> lN ToscaN,q. rna XVI s XIX secoI-o
1'epoca modema si cfr. anche L'Archivio dell' ospedale di San Giovanni di Diodi Firenze (1604-1890), lnventario, a cura di Lucia Sandri, Cemusco sul Na-viglio 1991, pag. 17.
s Sull'allattamento come principale motivazione di abbandono per i le-
gittinri nella società tardomedievale, cfr. L. Sandri, Baliatico mercenario e ab-
bandono dei bambini alle istituzioni assistenziali: unmedesimo disogio sociale?,
in Donne e lavoro nell'ltalia medievale, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli,Paola Galetti, Bruno Andreolli, Torino 1991, pp. 93-104. Per I'epoca moderna,
cfr. W- Hunecke, I trovatelli di Milano, Bambini esposti e Jàmiglie espositrici, dalXVll al XIX secolo, Bologna 1989, speciahnente alle pp. 219 e ss.
6 Per questo tipo di scritture del baliatico, che prevale totalmente inToscana tra XIV e XVI secolo, rimando per la ricchezza delle fonti e lo svilup-po del sistema di scritture a L. Sandri, L'ospedale di S. Maria della Scala d.i
S. Gimignano nel Quatlrocento. Con.tribu.to alla storia dell'infanzia abbando'nata, Firenze 1982.
7 A.S.S., Ospedale cli S. Maria della Scala, Libro a ric:ogliare e bi.lanci,(1592-1595) n. 539, c. 176.
8 Per questo argolncnto rimando al mio contributo, La Sestione dell'as-sistenza nella Firenze dal '100: il ruolo delle arti, in La Toscana al tempo diLorenzo il MogniJicrt. Politica, economia, cultura, arte,Fienze, Pisa, Siena, 5-
8 novembre 1992, itt corso di stampa.e A.S.A., Ospcdalc di S. Maria del Ponte, Battesimi, (1314-1322). Sul-
l'attività dell'ospedalc dcl Pontc tli Arezln è in corso uno studio di A. Moriani,Note par lu storia dell'ttspcdula cli S. Mctrio del Ponte di Arezzo, in «Annali
della Fraternita dei ìaici», in via cli slampa.I0 A.O.LF., Balie e bamhini, dal 1526 al 1588.
rr Tale proceduraè ttllizzata già nel '400 ed è ripresa poi anche in epoca
moderna. Si veda A.S.L., Libro de' hambori., (1401-1464), 907. Tale sistema 1o
si litrova anche nel '700 e nell'800, si vedano i nn. 928 e 938 della medesima
serie.12 Cfr. per Siena, Archivio di Stato di Siena, Archivitt dell'ospedale di
Santa Maria della Scala. Inventario, a cura di G. Cantucci e U. Morandi, Roma,
1960, pag. LXV e, specialmente per l'epoca modema il recente lavoro di T.
Bruttini, Madri e .figli nella Siena granducale. L'assistenza dell'ospedale allamaternità e all'inJanzia abbandonata (1765-1860), catalogo delia mostra do-
cumentaria orgaflizzatadal Centro Culturale delle Donne Mara Meoni, Siena 15
dicembre 1984-13 gennaio 191ì5.
r3 Si tratta dell'antica serie iniziata nel 1568 e denominata dal Cherici,archivista della fine del XIX secolo, Slracciaf'ogli, titolazione che, tuttavia era
entrata in uso solo nel 1845. Per 1'avanti, infatti, tale serie era semplicemente
denominata, al pari di quella ufficiale, dove comparivano anche i conti delle
balie,Batie e bambini. Tale serie, sar'à tenuta a partire dal 1617 dal medesimo
scrivano, perdendo quella freschezza di linguaggio notata per l'avanti per dive-nire semplicemente un duplicato delle descrizioni degli abbandoni.
p Tale consuetudine era osservata per esempio nell'ospedale per lrovalel-Ii di San Gimignano, dove, pur mancando un servizio di balie inteme, i bambini
488
tt ,r rrl r rrr lrr r ri \r r\ r( r ),, rN'lì rst ^N^
rr^ XVl t, XlX st( r)t ,()
,l,r[ilr rll {.t].;t,/r,r/lr, l ll l)ilJ
Irlrr' ( rrc rlrr rrr:rrri lt'rrrrrirrli, gcrtr"'r'icrttttcltlc lc sclvigiirli, lt:
.lr l. Srrrrtlrr. l.'rt,:1n'rlllt'tli ,\. Mttril tlt:lltr,\tulrt. ili S. Ginti-Ito
'' l'r'r ll lirrrrir irrtrttrirtislritlivu clcll'ospcdalc clclla Scala di Siena, si
,,rrrlrrrrrliollrll..s;rrrrlrr^ l.'ot1t«lul<,tli S.MuriodeLLuScaladiS.Gimignanocit.,1r.r1' ll"i r' :rnt'lrt', S.l{- lilrslcirr. Allc rtrig,ini deLla.fattoria toscana. L'ospedale della',t,tlrr Llr ,\it'rrtr t'lt ,ttr( lcrrt (mctà'200-metà'400), Firenze 1986, pp.3-4.
r'"1';rlr'scric: chc va clal l6l5 al 1832 è formata da registri tenuti in duplice, r,pirr tlul cirrnur-lingo, l'originale, e dallo «scrivano dei bambini», la copia.
/ ^.O.1.F.,
l,'ilza d'arthittio, XXl, c. 7.N lltitltrn, c. 6.
" A.O.l.F., Filza d'archivia, IX, c. 306.r0 Le esposte adulte finivano poi col rappresentare per questo tipo di
r:;lilrrzioni un problema alquanto spinoso. Giulia Di Bello, Senza nome n.é Ja-ttri,qliu.l bambini abbandonati nell'Ottocento,Firenze 1989, pag. 21 ci paria dit iir pcr Firenze e della clamorosa contestazione delle gettatelle fiorentine controil grlnduca il 16 agosto del 1687, per via delle rnisere condizioni di vita in cui:;opravvivevano alf interno dell'istituzione. Analogo avvenimento anche a Siena,lovc le <<ragazze di casa» alla metà circa del '500 der-runciarono con alffettantark'lcnninazione le loro «pessime condizioni di vita», cfr., G. Piccinni-L. Vigni,ll,lrilelli di assistenza ospedaliera tra Medioctto ed Età Moderna. Quotidianità,ttDtntinistt'u.zione, conflitti nell'os;tadule di Sanla Maria della Scala di Siena, inltr società del bisogno, cit., pp. 130 e ss.
2r A.S.L., Trovatelle ritot'tlul(, L)31), c. 2.:2 Che i'introduzione dclìa rllola e ognì altro provvedimento teso alla
liuritazione dell'abbandono dci legittirni, risultasse alla fine come un incentivo,stuturisce da rnolti studi specil'ici su questo argomento, in quest'occasione miIirnito a citare quelli, relativi a Prato, per il XIX secolo ma con validità, sottorlucsto aspetto anche retroaltiva cli A.M. Maccelli, Gettatelli a Prato nell'Ot-trtt'p11\s, Prato 1988 e, della rreclesima autdce, anche il successivo Bambinirrlthtrndonati a. Prato ntl XIX sacolo: il «segnale» come testimonianza ditrri identità da perderc o tlu ritrovore, rn Enfance abandonnée en Europe, XlV"-\ X' siècle, Roma I 99 I , pp. 8 I -5-836.
'?r A.S.F.P., Osltcdulc tlella Misericordia e del Dolce, Baliatici, (1656-l()60) 1119 G 38, c.51.
2a Si tratta della seric Giornole e Risconlro del Baliatico, che va a so-
stituire la serie più antica del solo Riscontro, ma in un ottica oltremodo qua-litativa più che contabile. Il Barnbino, grazie anche a dei ristretti mensili, potevar'ssere seguito nella lìrsc del Baliatico, cambiamenti di balia compresi, e ne1
pcriodo dell'affidamento ai balii tenutari. Né sono escluse le notizie sulla sortetlci ritornati.
25 Per una sintesi delle riforme ospedaliere in epoca leopoldina si veda,S. Pieri, Aspetti della rilorma ospedaliera inToscana al tempo tl.i. Pi.etro Leo-
ltrtldo,in Stato e Ch.icsa tli .f'ronte al prohlema dell'assistenza, Roma 1982, pp.r5t-15-5.
489
LE <<SCRITTURE DEL BALIATICO>> IN TOSCANA TRA XVI E XIX SECOLO
26 Per I'elezione a commissario di Giovanni Neri, voluta dal medesimoLeopoldo, cfr. A.O.LF., Filza d'Archivio di negozi diversi (1700-1768) n.76,fasc.62.
27 A.O.I.F., Giornale delle creature dal dì primo giugno 1767 a tuttogiugno 1768, s.24, n.225, c. 1,.
28 A.O.I.F., Filza d'Archivio di negozi diversi, n. 76, fasc. 10.2e lbidem, fasc. 10.30 lbidem, fasc. 10.32 lbidem, fasc. 10.32 A.O.I.F., Balie e bambini (1445-1450), c. l.33 Archivio di Stato di Siena, Archivio dell'ospedale di Santa Maria della
Scala, cit., vol. II, pp. 5l-53.3a cfr, A.M. Maccelli, Gettatelti a prato nell'Ottocento cit., pag. 10.
Tuttavia sulle caratteristiche del modo dell'abbandono per l,epoca mòderna especie per l'area fiorentina, si veda G. Di Bello, Senza nome né famiglia cit. perla normativa generale anche G. orefice, Brevi note sulla normativa osped,alieranegli stati preunitari, in Per un itinerario risorgimentale clell'architettura ita-liana, Fienze 1975, pp. 147-179.
35 Se avveniva un riconoscimento tardivo, a distanza di mesi o di anni,erano segnati su registri ancora diversi relativi agli lllegittimi riconosciuti.
490