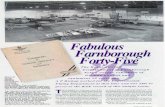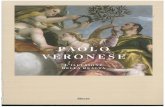L’azione dell’Anppia e della Vvn per il riconoscimento politico, assistenziale e culturale degli...
Transcript of L’azione dell’Anppia e della Vvn per il riconoscimento politico, assistenziale e culturale degli...
Ricerche Storiche anno XLIII, numero 3, settembre-dicembre 2013
Finita la guerra l’Italia e la Germania, che avevano vissuto la comune esperienzadella dittatura fascista ed erano uscite sconfitte dal conflitto bellico, si ritrovarono alconfine tra i blocchi controllati dalle due superpotenze. Le diverse fasi politiche dellaRepubblica italiana e della Repubblica federale tedesca (Rft) influirono profonda-mente sulla vita dell’associazionismo postbellico e il grado di penetrazione nelle rispet-tive società da parte delle associazioni di ex perseguitati dai regimi fu strettamente legatoal quadro politico in cui esse si mossero. Alcune di queste, come l’Associazione nazio-nale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia) e la Vereinigung der Verfolgten desNaziregimes (Vvn) l’associazione dei perseguitati del regime nazista, svolsero un ruoloimportante nel processo di diffusione della memoria dell’antifascismo1 e di riconosci-mento degli ex perseguitati nelle società italiana e tedesca del dopoguerra. In questo sag-gio tenteremo di sviluppare, senza alcuna pretesa di completezza, una riflessione nonsull’associazionismo in generale o sulla storia dell’Anppia e della Vvn2, ma sul loro ruolo
L’AZIONE DELL’ANPPIA E DELLA VVNPER IL RICONOSCIMENTO POLITICO, ASSISTENZIALE E CULTURALE
DEGLI EX PERSEGUITATI DAL FASCISMOE DAL NAZIONALSOCIALISMO (1945-1961)*
* Il saggio è la rielaborazione di un intervento tenuto durante il Convegno Sissco, Cantieri di storiaIV, a Marsala, nel settembre 2007. Desidero ringraziare i colleghi che parteciparono alla discussione, ladottoressa Ulrich del Bundes Archiv di Berlino, la direzione della Vvn, il dott. Alberto Cavaglion e la dot-toressa Simonetta Carolini.
1 Il tema della memoria e delle sue declinazioni è molto vasto. Tra gli studi più significativi citiamoP. Nora,Mémoire collective, in R. Chartier, J. Le Goff, Jacques Revel (a cura di), La nouvelle histoire, Paris,Retz, 1978; P. Jedlowski,Memoria individuale e memoria collettiva, in Nicola Gallerano (a cura di), LaResistenza fra storia e memoria. Atti del Convegno, Milano, Mursia, 1999, pp. 19-30; M. Halbwachs, Lamemoria collettiva, Milano, Unicopli, 2001; P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma delpassato, Bologna, il Mulino, 2004; R. Chiarini, 25 Aprile. La competizione politica sulla memoria, Vene-zia, Marsilio, 2005; F. Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal1945 ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2005; P. Dogliani,Memoria e storia pubblica: Resistenza in Italia e inFrancia, in «Storica», 34, 2006, pp. 73-119; L. Paggi, Una Repubblica senza Pantheon. La politica e lamemoria dell’antifascismo (1945-1978), in Id. (a cura di), La memoria del nazismo nell’Europa di oggi,Firenze, La Nuova Italia, 1997, pp. 247-268; S. Cavazza, La transizione difficile e l’immagine dellaguerra e della resistenza nell’opinione pubblica nell’immediato dopoguerra, in G. Miccoli, G. Neppi Modona,P. Pombeni (a cura di), La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopo-guerra, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 427-464.
2 Sull’Anppia qualche breve cenno in: P. Dogliani, Associazionismo resistenziale nel primo decennio dellarepubblica: politiche ed insediamenti di una memoria, in «Memoria e Ricerca», 10, 1997, pp. 165-185 (poiripubblicato in Miccoli, Neppi Modona, Pombeni (a cura di), La grande cesura, cit., pp. 527-555); P. Ber-tilotti, Contrasti e trasformazioni della memoria dello sterminio in Italia, in M. Flores, S. Levis Sullam,
494 CAMILLA POESIO
informativo, assistenziale-previdenziale e sul loro impegno a livello internazionale, dal-l’immediato dopoguerra al 1961 quando fu stipulato l’accordo bilaterale tra Italia e Rfta favore dei cittadini italiani ex perseguitati dal regime nazista, lo stesso anno in cui ladivisione del mondo in due blocchi fu sanzionata dalla costruzione del Muro di Ber-lino. Tale analisi sarà condotta con un approccio comparato in modo da mettere in lucenon solo le specificità di azione delle due associazioni, ma anche il diverso grado diinfluenza sugli assetti normativi e sulle culture nazionali in relazione al riconosci-mento politico, sociale, culturale, economico delle vittime dei passati regimi.
1. L’Anppia, la Vvn e le politiche di risarcimento
L’Anppia era nata nel 1945, subito dopo la Liberazione, in un contesto politicofluido in cui il grado di violenza privata continuava a essere molto forte anche dopo lafine del conflitto bellico. Fin da subito essa si prefigurò come organizzazione vicina alPartito comunista italiano: era presieduta dal comunista Umberto Terracini e aderì allaFederazione internazionale della Resistenza (Fir) che nacque nel 1951 sotto spinta sovie-tica con l’intento sia di denunciare una presunta involuzione fascista nei paesi occi-dentali (soprattutto nella Rft), sia di elevare l’antifascismo come strumento di legitti-mazione del blocco orientale. Il colore politico dei dirigenti dell’Anppia – comunistie socialisti – condizionò profondamente tanto le scelte dell’associazione quanto l’at-teggiamento della politica governativa nei confronti delle sue iniziative viste come mani-festazioni comuniste.Nel periodo dei governi del Comitato di Liberazione nazionale, dal 1944 alla fine
del 1947, la produzione di provvedimenti legislativi a favore dei risarcimenti e dellereintegrazioni fu abbondante: il r.d.l. 6 gennaio 1944, n. 9, aveva previsto la riassun-zione nella pubblica amministrazione di licenziati per motivi politici; il r.d.l. 20 gen-naio 1944, n. 25, la restituzione dei diritti civili e politici ai perseguitati e l’abrogazionedelle disposizioni di carattere razziale; il r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26, la reintegrazionedei diritti patrimoniali degli ebrei (integrato dal d.d.l. 30 aprile 1945, n. 222 e modi-
M.-A. Matard Bonucci, E. Traverso (a cura di), Storia della Shoah in Italia, vol. 2, Torino, Utet, 2010, pp.59-112; L. BRUNELLI (a cura di), I fondi archivistici Anpi e Anppia di Terni, Perugia, Isuc, 2009. Sono pochii lavori scientifici sulla storia della Vvn, si rimanda a J. Foitzik, Vereinigung der Verfolgten des Naziregi-mes (VVN), in M. Broszat, H. Weber (a cura di), SBZ-Handbuch: Staatliche Verwaltungen, Parteien,gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands1945-1949, München, Oldenbourg Verlag, 1990, pp. 748-759; E. Reuter, D. Hansel, Das kurzeLeben der VVN von 1947 bis 1953. Die Geschichte der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in der sowje-tischen Besatzungszone und in der DDR, Berlin, Edition Ost, 1997. Si veda anche K. Tenner, Zur poli-tich-ideologischen Arbeit der KPD bzw. SED und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) fürdie Entwicklung des antifaschistischen und antiimperialistischen Bewusstsein der werktätigen Massen in dersowjetischen Besatzungszone 1945 bis 1949, Diss. Gesellschaftswiss., Jena, 1984; S. Wierskalla, DieVereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in der Sovjetischen Besatzungszone und Berlin 1945 bis1948, Magisterarbeit, 1994.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 495
ficato dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 31 luglio 1947, n. 801);il d.l.l. 5 maggio 1946, n. 393, la rivendicazione dei beni confiscati e sequestrati ai per-seguitati per motivi razziali sotto la Rsi3.A questa prima stagione di produzione normativa in materia di risarcimento era suc-
ceduta, a partire dal 1948, una fase di stallo percorsa, però, da intensi dibattiti cherispecchiavano le posizioni politiche del Paese e che fecero emergere la difficoltà didistinguere la persecuzione razziale da quella politica. Dal 1948, nel quadro generaledi un anticomunismo di Stato, i governi centristi democristiani seguirono una politicadella memoria volta a frenare l’attività delle associazioni resistenziali ritenute di sini-stra, come l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), l’Anppia, l’Associazionenazionale ex deportati (Aned) privilegiando, invece, quelle di area cattolica e patriot-tica come l’Associazione nazionale ex internati (Anei) e l’Associazione famiglie italianedei martiri caduti per la libertà della patria (Anfim)4. Il 1953 fu un anno di svolta alivello tanto internazionale – la morte di Stalin – quanto nazionale – con l’approvazionedella legge elettorale che prevedeva un largo premio di maggioranza alle coalizioni cheavessero ottenuto il 50,01 per cento dei voti. Di fronte a una prima distensione inter-nazionale e al nuovo assetto politico uscito dalle elezioni del 1953 – che registrò unarretramento della Democrazia cristiana e un avanzamento dei partiti comunista,socialista, monarchico e del Movimento sociale – si manifestò una volontà di strappareil monopolio della memoria della Resistenza alle sinistre. È tenendo conto di questoquadro che si spiega l’approvazione, dopo anni di intensi dibattiti, della legge n. 96 del10 marzo 1955 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e deiloro familiari superstiti. Il provvedimento legislativo in materia di risarcimento concesseai perseguitati politici e ai perseguitati per motivi razziali e alle famiglie di coloro cheerano morti per effetto delle persecuzioni, un assegno vitalizio di benemerenza qualorala causa diretta e immediata delle lesioni riportate fosse stata la detenzione, il confino,violenze e sevizie subite5. Su tale legge e sull’equiparazione nel testo dei perseguitati raz-ziali e politici il dibattito fu aperto anche in seno alle stesse istituzioni ebraiche e in par-
3 Sulle politiche riparatoria in Italia, si rimanda a M. SARFATTI (a cura di), Il ritorno alla vita. Vicendee diritti degli ebrei dopo la seconda guerra mondiale, Firenze, Giuntina, 1998; I. Pavan, Tra indifferenza eoblio. Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia (1938-1970), Firenze, Le Monnier, 2004; G.D’Amico,Quando l’eccezione diventa norma. La reintegrazione degli ebrei nell’Italia postfascista, Torino, Bol-lati Boringhieri, 2006. Si veda anche G. Fubini, La condizione giuridica dell’ebraismo italiano, Torino,Rosenberg & Sellier, 1998; L. Martone, L’infamia dimenticata: l’esproprio dei beni patrimoniali dei cit-tadini ebrei imposto dalle leggi del 1938-1939 e il problema delle restituzioni, in L. Garlati, T. Vettor (a curadi), Il diritto di fronte all’infamia nel diritto: a 70 anni dalle leggi razziali, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 147-162.
4 Cfr. Bertilotti, Contrasti e trasformazioni della memoria dello sterminio in Italia, cit., p. 60; Id., Rico-noscimento, reintegrazione e risarcimento, in «Italia contemporanea», n. 254, 2009, pp. 43-59.
5 Sulla genesi della legge, i passaggi, le applicazioni, sull’efficacia sulla base di quanti perseguitati bene-ficiarono della legge si rimanda a E. Corradini, Il difficile reinserimento degli ebrei: itinerario e applica-zione della legge Terracini n. 96 del 10 marzo 1955, Zamorani, Torino, 2012.
496 CAMILLA POESIO
ticolare tra l’Unione delle comunità israelitiche italiane (Ucii) e la Federazione giova-nile ebraica d’Italia (Fgei). La prima tendeva a sottolineare la specificità della perse-cuzione che avevano subito gli ebrei in quanto tali, la seconda spingeva per inserire lamemoria della deportazione ebraica all’interno della memoria della Resistenza unendola memoria dei deportati per motivi razziali a quella delle vittime “attive”6. Nel 1956furono apportate alcune modifiche come la reversibilità dell’assegno e l’impossibilitàdi cumularlo con un’eventuale pensione di guerra7. Nel 1958 furono previste altredisposizioni8: furono considerati periodi di servizio militare, e quindi utili per riscuo-tere la pensione, periodi prestati in qualità di partigiano, di lavoratore coatto o comeex internato in Germania.L’Anppia svolse un ruolo di primo piano nella promulgazione della legge n. 96: non
a caso, questa prese il nome dal presidente dell’associazione, Umberto Terracini, che nefu il promotore. Due rappresentanti dell’Anppia – Francesco Fausto Nitti, vicepresi-dente dell’associazione e il segretario Lino Zocchi – fecero parte della Commissioneinterministeriale9 incaricata di esaminare le domande volte a conseguire i benefici dilegge10. Ad avere diritto all’assegno vitalizio furono gli antifascisti che, per malattia con-tratta in carcere o al confino o per le violenze subite da parte della polizia o dei fasci-sti, avevano perso almeno il 30% della capacità lavorativa, così come i familiari super-stiti di antifascisti deceduti a causa di persecuzioni. I requisiti richiesti limitarono note-volmente il raggio di applicazione della legge per la quale furono stanziati, nel bilan-cio 1955-1956, solo 100 milioni di lire11.L’Anppia – e in particolare il suo presidente – si impegnarono a fondo per riferire
sui lavori della Commissione ministeriale. Già nell’estate del 1954 «L’Antifascista» –l’organo di stampa mensile su cui era illustrata l’attività dell’associazione – aggiornavasui lavori della I Commissione Permanente del Senato che lavorava sul progetto di legge
6 Cfr. Bertilotti, Contrasti e trasformazioni della memoria dello sterminio in Italia, cit., pp. 74-75.7 Legge 8 novembre 1956, n. 1317, Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente
provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.8 Legge 20 febbraio 1958, n. 55, Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore
dei pensionati dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, soprattutto agli artt.7, 8, 9.
9 La Commissione fu nominata in base all’articolo 8 della stessa legge con decreto del Presidente delConsiglio di concerto coi ministri per l’Interno, la Giustizia e il Tesoro.
10 Nella Commissione erano anche presenti un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere diCorte di appello, un magistrato della Corte dei Conti, un rappresentante della Presidenza del Consiglio,uno dei ministeri dell’Interno, della Giustizia e del Tesoro. Art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 Prov-videnze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti, in G. Abaldo, Laprevidenza sociale. Assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti. Norme generali e settoriali I.N.P.S.,Milano, Pirola, 1971, pp. 1023 sgg. La legge 8 novembre 1956, n. 1317, integrò l’art. 8 della legge 10marzo 1955, n. 96, con l’aggiunta nella Commissione di un «un segretario, senza diritto a voto, scelto trai funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto delPresidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro».
11 F. Focardi, L. Klinkhammer, Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L’accordo glo-bale italo-tedesco del 1961, in «Italia contemporanea», n. 254, 2009, pp. 11-24.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 497
in favore degli ex perseguitati politici antifascisti. Nella seduta del 27 aprile e del 4 mag-gio 1954 la Commissione si era posta in opposizione al ministero del Tesoro, che mani-festava dissenso, e aveva votato il primo articolo, quello più importante, che sanciva eregolava il trattamento di pensione e di risarcimento danni. Scriveva Terracini:
La morte e l’invalidità permanente derivanti, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 25luglio 1943, a cittadini italiani perseguitati a causa delle loro opinioni o dell’attività poli-tica da essi svolta oppure nel periodo dal 1° luglio 1938 al 25 luglio 1943, a cittadiniitaliani perseguitati per la loro razza, in conseguenza di a) sentenze contemplate dall’art.1° del D.D.L. 27 luglio 1944, n. 159; b) la assegnazione al confino di polizia o a casadi lavoro; c) violenze a opera di appartenenti al movimento partito o formazioni mili-tari o paramilitari fasciste o di gruppi e individui operanti in accordo con essi, o di appar-tenenti alle forze di polizia sono equiparate alla morte e alla invalidità permanente, deri-vanti da causa di guerra. Il diritto alla pensione equiparato integralmente alla pensionebase di guerra, è riconosciuto quando risulti che la privazione della libertà personale ola violenza siano state la causa diretta e immediata della morte o della invalidità per-manente. Il nesso di causalità si presume, salvo prova contraria, quando la morte siaavvenuta in carcere o al confino o nelle sedi di polizia12.
L’Anppia richiese la documentazione necessaria per ottenere assegni diretti o rever-sibili ai familiari superstiti e contributi assicurativi assolvendo, dunque, al compito chesi era data di assistere materialmente e moralmente le famiglie dei caduti. La richiestadi risarcimento dei danni ai beni materiali, invece, non fu accolta nemmeno nel pro-getto di legge13.L’Anppia prese contatto con altre associazioni giungendo a redigere una sorta di
carta comune di rivendicazioni14, ma rispetto ad altre associazioni essa si distinse perl’entità dell’impegno: nella zona di Terni, ad esempio, la sua attività di assistenzarisulta molto più costante rispetto a quella svolta dall’Anpi15.La Commissione ministeriale iniziò i lavori nel dicembre del 1956. A maggio del
1957 erano state esaminate circa 1300 pratiche. Coloro ai quali la Commissioneministeriale aveva dato il riconoscimento al beneficio furono poi convocati dai propricomuni di residenza per la consegna del libretto di pensione16. Sebbene non fosse statariconosciuta la persecuzione alle vittime del fascismo colpite prima del 28 ottobre 1922,né i periodi di ammonizione e di vigilanza speciale, né l’attività antifascista – e la con-seguente persecuzione – all’estero, sebbene fossero stati fissati pesanti oneri di provadella dipendenza immediata e diretta delle infermità dalla persecuzione e fosse stata
12 U. Terracini, La Commissione Finanze e Tesoro. La legge in favore dei perseguitati politici antifasci-sti, in «L’antifascista», luglio 1954, p. 1.
13 Ibidem.14Discorso del senatore Terracini al IV Congresso ANPPIA, in «L’Antifascista», novembre 1954, pp. 3-5.15 BRUNELLI (a cura di), I fondi archivistici ANPI e ANPPIA di Terni, cit., p. 38.16 Bilancio e indicazioni. Relazione di dottor Fausto Nitti al Consiglio nazionale dell’Anppia, in «L’An-
tifascista», maggio 1957, p. 5.
498 CAMILLA POESIO
introdotta la condizione del «bisogno economico» per godere dell’assegno vitalizio dibenemerenza, il segretario generale Lino Zocchi a sei anni di distanza dalla promul-gazione della legge poteva affermare che:
La legge comunque, pur ristretta e mutilata, non poteva essere respinta […] E laprova sta nei fatti: hanno ottenuto la pensione oltre 1600 perseguitati politici; circa 5000hanno vista regolata la loro posizione assicurativa in base al disposto dell’art 5; unnumero non indifferente di dipendenti dello Stato, di perseguitati razziali, di ex depor-tati hanno visto in parte riconosciuto il contributo di persecuzione e di martirio pagatiper gli ideali di libertà e di progresso. Potevamo ottenere di più? Può anche darsi. Lalegge comunque è stata interpretata largamente malgrado la mancanza quasi assoluta diprove documentali17.
Anche il presidente Terracini si disse in un certo modo soddisfatto dato il grandesforzo compiuto da parte di alcuni senatori, in particolare Perri, Gianquinto e Parri18.L’Anppia svolse un ruolo importante anche nell’informare, sempre attraverso
«L’Antifascista», i suoi iscritti sull’andamento legislativo delle leggi a favore degli ex per-seguitati e nell’aiutare a evadere le pratiche burocratiche. Se nel novembre 1954 gli asso-ciati erano solo 12.56419, dopo il varo della legge del 10 marzo 1955 l’associazioneacquistò maggiore prestigio e conobbe un aumento di iscritti; ma a pochi mesi dall’e-manazione del testo era la stessa associazione a lamentare un eccessivo appagamento peril successo ottenuto e una conseguente scarsa incisività nel condurre la campagna perlo scioglimento del Msi e la pubblicazione delle liste dell’Ovra, nonché uno sbilan-ciamento nell’azione delle federazioni provinciali, fra cui si distinguevano per impegnoquelle di Firenze, Roma, Venezia, Verona e Ferrara20. Dal febbraio del 1957 «L’Anti-fascista» iniziò a pubblicare regolarmente l’elenco di perseguitati politici antifascisti erazziali ai quali la Commissione riconosceva il diritto ai benefici previsti dalla legge sullabase delle domande presentate. Contemporaneamente iniziò anche una rubrica inti-tolata Risposte in breve alle lettere che arrivavano all’Anppia e che chiedevano chiari-menti sull’attuazione della legge21.
La mia pratica è stata rifiutata perché il Ministero degli Interni non ha fornito i docu-menti che avrebbero potuto comprovare le mie malattie. Che cosa doveva risultare dalmio fascicolo se il medico della colonia di Tremiti non si degnava nemmeno di guardarein faccia taluni confinati? Allora io soffrivo soprattutto di nevastenia [sic!], disturbi all’ap-
17 L. Zocchi, Attività e prospettive dell’Anppia, in Anppia, VI congresso nazionale Roma 14-16 aprile1961, pp. 33-34.
18 Cfr. U. Terracini, Conclusioni del dibattito, in Ivi, p. 48.19Discorso del senatore Terracini al IV Congresso ANPPIA, in «L’Antifascista», novembre 1954, pp. 3-5.20 L. Zocchi, Note sul tesseramento, in «L’Antifascista», maggio 1955, p. 2.21 La commissione P.P. Le deliberazioni concessive votate fino all’8-1-57, in «L’Antifascista», febbraio
1957, p. 4.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 499
parato digerente, reumatismi. Mi si dice che avrei dovuto produrre il certificato del neu-rologo e che non avrei dovuto accettare il giudizio della Commissione medica diPalermo, la quale mi riscontrò un’infermità cardio-vascolare, derivata secondo il giudi-zio della Commissione dall’età. È proprio così? Dove finisce l’esperienza dei medici delConvegno di Mosca, che scientificamente provarono come le malattie più diffuse svi-luppatesi nei campi di concentramento e in carcere sono proprio quelle del sistema car-dio-vascolare22?
E ancora:
Il problema è di fondo; […] le Commissioni mediche e quella stessa esaminatriceagiscono così perché ancorate ad una prassi prodotta da concezioni vecchie e superate.1) Il giudizio delle Commissioni mediche non tiene in alcun conto i certificati deimedici che per anni hanno curato gli ammalati. 2) Si richiedono certificati medici del-l’epoca, senza considerare che spesso i perseguitati politici venivano curati di nascostoda medici che si guardavano bene dal rilasciare certificati per non compromettersi, chele malattie in carcere e al confino erano raramente riconosciute, che molti documentisono andati persi perché sono trascorsi da allora almeno 15 anni, nel migliore dei casi.3) Non vengono riconosciute malattie insorte in un secondo tempo, ma che la scienzamedica ha ormai provato essere conseguenza della vita carceraria. […] promettiamo dipresentare all’Istituto italiano di medicina legale le nostre osservazioni e le nostre pro-poste per un aggiornamento della nostra legislazione pensionistica23.
La rubrica de «L’Antifascista» forniva anche consigli su come farsi accettare richie-ste rifiutate o cercava di agevolare gli associati. A P.P. di Orbetello rispondeva, peresempio:
La tua pratica non è stata ancora discussa, ma valore determinante ha il responsodella Commissione medica; se non ti hanno riconosciuto l’invalidità c’è poco da fare24.
A A.M. di Ancona chiedeva invece il numero di pratica in modo da sollecitarne l’i-struzione25.L’associazione fornì anche informazioni sulle scadenze dei termini per la presenta-
zione delle domande, a chi indirizzarle (ossia alla Direzione generale delle pensioni diguerra-servizio infortunati civili del ministero del Tesoro) e, soprattutto, come com-pilarle26. Il 26 agosto 1955 scadeva il termine di presentazione delle domande volte a
22 Lettera di G.V., in Per un azione rivendicativa. Deficienze di un sistema, in «L’Antifascista», marzo1958, p. 4.
23 Lettera anonima, in Ivi.24 Delibere concessive della Commissione P.P. Terzo elenco, in «L’Antifascista», aprile 1957, p. 5.25 Ibidem.26 Ogni pratica, per essere presa in considerazione dalla commissione, doveva essere accompagnata dal
certificato di stato civile e nazionalità italiana, da informazioni economiche del richiedente, da informa-zioni sull’attività politica svolta (condanne, arresti, espatri, infermità insorte a causa della persecuzione),
500 CAMILLA POESIO
ottenere l’assegno vitalizio con decorrenza dalla data di pubblicazione della legge,ossia il 26 marzo. «L’Antifascista» invitò le federazioni e le sezioni dell’Anppia a rac-cogliere e intensificare attraverso la stampa locale, volantini, assemblee e incontri «lapopolarizzazione delle provvidenze a favore dei perseguitati»27.Furono resi pubblici anche gli errori più comuni commessi nelle richieste in modo
da evitarne in futuro. In alcuni casi l’Anppia riuscì a fornire un aiuto anche a distanzadi molti anni: nel 2002, a un iscritto di Torino, il cui unico reddito era un assegno vita-lizio mensile di 392 euro come riconoscimento di una benemerenza civile per il car-cere che aveva subito durante il regime fascista, l’Inps negò l’assegno sociale sostenendoche quel reddito fosse superiore ai limiti di legge previsti per la concessione dell’asse-gno. Grazie all’intervento del presidente dell’Anppia torinese, l’avvocato Bruno Segre,fu possibile dimostrare che l’assegno agli ex perseguitati aveva carattere risarcitorio e noncostituiva un reddito. La sezione lavoro del tribunale di Torino confermò che l’assegnomensile di benemerenza non era computabile nel calcolo del reddito e condannòl’Inps al pagamento dell’assegno sociale28.Gli eventi tragici del luglio 1960 durante il governo Tambroni e l’avvio della sta-
gione dei governi di centro-sinistra influirono sulle politiche dello Stato nei confrontidelle vittime del nazifascismo. Dopo alcune modifiche apportate nel 196129, nel196730 furono eliminate dall’art. 1 della legge del 1955 due aggettivi di notevoleimportanza: «immediata e diretta» relativi alla causa della perdita delle capacità lavo-rative. In altre parole, non era più richiesta una rigorosa dimostrazione del nesso dicausa-effetto tra persecuzione subita e le lesioni per le quali si faceva domanda di risar-cimento. Fino ad allora, infatti, non pochi richiedenti si erano visti rifiutare la domandadi risarcimento perché non avevano potuto accludere alcuna documentazione cheprovasse gli effetti diretti sulla loro salute del sistema repressivo fascista. Nel 196831furono estesi i benefici della legge Terracini anche a quei perseguitati italiani politici orazziali che, dopo l’entrata in guerra, si erano trovati nei territori posti sotto controllodella Commissione italiana di armistizio con la Francia (Ciaf ).
da informazioni sulla posizione previdenziale per l’assicurazione invalidità e vecchiaia, da un verbale divisita medica redatta dalla commissione medica pensioni di guerra competente per il territorio. Relazionedel vicepresidente Francesco Fausto Nitti al V Congresso nazionale dell’Anppia nell’aprile del 1957, ripor-tata in «L’Antifascista», maggio 1957, p. 5.
27 La legge 10 marzo 1955, in «L’Antifascista», luglio 1955, p. 6.28 Eccezionale importanza di una sentenza a Torino. L’INPS condannato a pagare un assegno sociale a
favore di un perseguitato politico, in «L’antifascista, mensile degli antifascisti di ieri e di oggi », settembre-ottobre 2002, p. 4.
29 Legge 3 aprile 1961, n. 284,Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8novembre 1956, n. 1217, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e deiloro familiari superstiti.
30 Legge del 24 aprile 1967, n. 261, Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitatipolitici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
31 Legge 28 marzo 1968, n. 361, Interpretazione autentica dell’art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96,e dell’art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici antifa-scisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 501
Raggiunta un’intesa fra Dc e Psi, nel 1961 fu approvata la legge del 14 marzo n. 130che allargò i benefici degli ex deportati e internati. Inoltre nel 1961 fu concluso l’ac-cordo bilaterale tra Germania federale e Italia sugli indennizzi ai cittadini italiani per-seguitati per questioni di «razza, fede, ideologia». Dalla legge, però, continuarono arimanere quasi del tutto esclusi gli Internati militari italiani. A differenza della legge del1955, l’Anppia non svolse un ruolo di primo piano per il raggiungimento di questoaccordo, come dimostra, fra l’altro, l’assenza di notizie sul proprio organo di stampa(così come su «L’Unità»). Probabilmente ciò è imputabile anche al fatto che le vittimedel sistema concentrazionario nazista beneficiarie dell’accordo fra Roma e Bonn face-vano parte di altre associazioni come l’Aned, l’Anei e l’Ucii che, invece, svolsero unruolo attivo nelle trattative32.Anche in Germania la vita dell’associazionismo fu condizionata dal contesto poli-
tico generale. Finita la guerra, nelle quattro zone di occupazione e a Berlino, si costi-tuirono dei comitati di ex detenuti politici per dare assistenza alle vittime del nazismoe per favorire il loro reinserimento nella società. Già nell’agosto del 1945 la Vvn (ini-zialmente Vereinigung der politischen Gefangenen und Verfolgten des Nazi- Regimes), perrichiedere la sua ammissione al governo militare americano, si propose di assistere congeneri alimentari, vestiti, alloggi e medicine coloro che erano stati nei campi di con-centramento o in carcere, aiutarli a trovare un lavoro, assistere i loro familiari, fornireassistenza sanitaria e offrire consulenze giuridiche. L’associazione si pose anche l’o-biettivo di aiutare la ricerca degli scomparsi e di avviare la cattura dei responsabili dellepersecuzioni. Dal 20 al 22 luglio 1946, a una conferenza interzonale di ex detenuti poli-tici a Francoforte sul Meno, l’associazione si dette un programma comune; a novem-bre si concluse la costruzione della Vvn nella zona americana, a dicembre nella zonabritannica. In quattro Länder della zona di occupazione sovietica si erano intanto tenutealcune conferenze a livello provinciale e di Land che si erano occupate della questionedell’organizzazione33. Pochi mesi dopo, nel marzo 1947, si costituì la Vvn con un’or-ganizzazione a livello non di Länder, ma di Zone. Alla conferenza parteciparono ses-santotto delegati e sessantadue ospiti provenienti dai ventuno Stati federali delle quat-tro Zone e dalla città di Berlino. Come organo direttivo della Vvn fu eletto un unicoconsiglio tedesco (Gesamtdeutsches Rat), furono nominati poi quattro segretari per cia-scuna Zona e uno per Berlino Ovest34. Due anni dopo i trentatré membri del consi-glio della Vvn si incontrarono di nuovo a Monaco, questa volta come appartenenti adue diversi Stati: il 23 maggio e il 7 ottobre 1949 erano nate rispettivamente la
32 Sull’accordo si rimanda a F. Focardi, L. Klinkhammer, Quale risarcimento alle vittime del nazio-nalsocialismo? L’accordo globale italo-tedesco del 1961, in «Italia contemporanea», 254, 2009, pp. 11-24.
33Die VVN in allen Zonen «Neues Deutschland»,19/12/1946 in Stiftung Archiv der Parteien undMassenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (Sapmo), DY 55/V 278 Vereinigung der Verfolg-ten des Naziregimes in der DDR/ 6/2146 Brill, Dr. Hermann- Louis.
34 Johann Pflüger con sede a Monaco; Karl Raddatz (Kpd-Sed) per Berlino Est; Hans Schwarz perAmburgo; Alphonse Kahn per Ludwigshafen; Hilde Cohn- Löhner per Berlino Ovest.
502 CAMILLA POESIO
Repubblica federale tedesca (Rft) e la Repubblica democratica tedesca (Rdt). Sede degliuffici del Consiglio della Vvn per la Germania ovest fu scelta Francoforte sul Meno esuo primo presidente fu eletto Marcel Frenkel.La divisione del Paese comportò uno sdoppiamento della Vvn. Questa ebbe vita
breve nella Germania orientale perché la Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-SED, il partito comunista al potere, volle strappare il potenziale propagandistico del-l’antifascismo al controllo della Vvn e sciolse nel 1953 l’associazione che fu sostituitadal Komitee der AntifaschistischenWiderstandskämpfer der DDR. Inoltre molti membridella Vvn di origine ebraica avevano dovuto lasciare il paese e rifugiarsi nella Germa-nia ovest per gli atti di violenza antisemita che avevano avuto luogo nella Rdt nei primianni Cinquanta. La diffusione della memoria dell’antifascismo fu allora affidata aorganizzazioni di Stato, come il Nationale Front, la Freie Deutsche Jugend, il ministerodell’Educazione35. Nella Repubblica federale, invece, la Vvn, l’unica associazione uni-taria degli ex combattenti antifascisti della Repubblica Federale tedesca, sopravvisse seb-bene non senza difficoltà. Gran parte dei suoi membri afferivano al Partito comunistaoccidentale (Kpd) e ciò provocò fin dalla nascita dell’associazione duri conflitti poli-tici36. Già alla fine del 1946 il presidente del Partito socialdemocratico delle zone occi-dentali, Kurt Schumacher, aveva definito la Vvn come «la nuova organizzazione dicopertura di propaganda» dei comunisti37. Nel maggio 1948 fu vietato agli iscritti alPartito socialdemocratico di appartenere alla Vvn proprio a causa del consistente pesonell’associazione dei comunisti38. Anche eminenti ex vittime del regime nazista comeEugon Kogon, con posizioni vicine al Partito cristiano democratico (Cdu), lasciaronol’associazione per motivi politici.Nel clima di “democrazia protetta” degli anni Cinquanta, caratterizzata dai tenta-
tivi di arginare la minaccia comunista e le frange dell’estremismo di destra e che portònel 1952 e nel 1956 rispettivamente alle sentenze di interdizione da parte della CorteCostituzionale di Karlsruhe del partito neonazista (Srd) e del partito comunista tede-sco occidentale, si inserì il cosiddetto Erlass Adenauers che colpì anche la Vvn. La leggesul pubblico impiego del 19 settembre 1950 stabilì, cioè, l’incompatibilità di ogni fun-zionario, impiegato, lavoratore del pubblico impiego con l’appartenenza ad alcunimovimenti, organizzazioni, partiti che risultassero una minaccia per il libero e demo-cratico ordinamento statale. Si ritenevano tali la Kommunistische Partei Deutschlands etutte le sue organizzazioni, l’Aktion sozialdemokratische, la Freie Deutsche Jugend (FDJ),la Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, la Vereinigung der Sowjet-freunde, la Srd, laNationale Front, il cosiddetto Schwarze Front. Nel gruppo delle orga-
35 Cfr. Reuter, Hansel, Das kurze Leben der VVN, cit. Si veda anche W.J. Niven, The BuchenwaldChild: Truth, Fiction, and Propaganda, Rochester, Camden House, 2007, p. 62.
36 Cfr. Foitzik, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), cit., p. 75937 Wierskalla,Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in der Sovjetischen Besatzungszone
und Berlin 1945 bis 1948, cit., p. 4.38 Cfr. C. Moisel, Frankreich und die deutsche Kriegsverbrecher. Politik und Praxis der Strafverfolgung
nach dem ZweitenWeltkrieg, Göttingen, Wallstein Verlag, 2004, p. 196.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 503
nizzazioni «contrarie alla costituzione», due gravitanti nel neonazismo e undici nell’a-rea comunista e considerate Tarnorganisationen cioè propaggini di copertura del par-tito comunista, fu inscritta anche la Vvn39. Come parte della Fir, l’Anppia, attraversole federazioni e le sezioni, fece sentire la sua voce contro la minaccia di scioglimentodella consorella associazione tedesca, avviando una campagna di solidarietà che con-sistette in un’azione di informazione circa la politica di riarmo della Germania occi-dentale e la mancata epurazione di ex nazisti nell’amministrazione statale, nella giustiziae nell’esercito40.Sulle politiche di risarcimento in area tedesca, un primo passo era stato fatto tra il
1947 e il 1949 dagli alleati occidentali nelle loro zone di occupazione con la restitu-zione delle proprietà alle vittime del nazismo41. Nella Repubblica federale tedesca lepolitiche di risarcimento ebbero inizio con la cosiddetta Bundesergänzungsgesetz(BErG)42 del 1 ottobre 1953 che aveva validità in tutti i Länder della Repubblica. Lalegge stabilì quali erano i gruppi di persone da indennizzare, i danni da considerare, idiritti al risarcimento e le autorità da preporre. Potevano presentare domanda coloroche fino al 31 dicembre 1952 erano stati residenti nella Germania occidentale o a Ber-lino Ovest, ma finirono per essere esclusi tutti perseguitati stranieri. La legge del 1953fu sostituita tre anni dopo dalla Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der NS-Verfol-gung (cosiddetta Bundesentschädigungsgesetz-BEG)43 del 29 giugno 1956 che estese ilgruppo degli aventi diritto ai reduci, ai profughi e ai fuoriusciti e a coloro che eranostati residenti nei territori appartenenti al Reich al 31 dicembre 1937: ne risultavanopertanto fuori quei civili e militari italiani che erano stati catturati dopo l’8 settembre1943 perché non in possesso della residenza in Germania. Il paragrafo 6 della leggeescluse dai risarcimenti anche coloro che erano stati comunisti nel dopoguerra perchéconsiderati nemici «del libero ordine democratico»: in pratica, fu lasciata fuori largaparte delle vittime della dittatura nazista. La legge, dunque, creò una distinzione fra levittime: furono indennizzati i tedeschi che avevano subito per ragioni politiche e raz-ziali le persecuzioni ma furono lasciati fuori gli zingari e coloro che dopo il maggio1948 erano incappati in una condanna a più di tre anni di detenzione44. La legge nonfu pienamente applicata: la prova della diretta consequenzialità tra le persecuzioni e idanni fu, talvolta, affidata a personale medico ex appartenente al partito nazista, che
39 U. Backes, Politische Extreme: EineWort- Und Begriffsgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart,Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2006, p. 191; R. Gössner, Die vergessenen Justizopfer des kaltenKrieges. Über den unterschidlichen Umgang mit der deutschen Geschichte in Ost undWest, Hamburg, Konk-ret Literatur Verlag, 1994, p. 55.
40 Cfr. L. Zocchi, Attività e prospettive dell’Anppia, cit., pp. 34-35.41 Cfr. R. Ludi, The vectors of Postwar Victim Reparations: Relief, Redress and Memory Politics, in Jour-
nal of Contemporary History, 41, 2006, pp. 421-450; C. Pross, Paying for the Past, Baltimore, Md., TheJohn Hopkins University Press, 1998.
42 BGBl. I S. 1387.43 BGBl. I S. 562.44 Cfr. J. Elster,Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche, Bologna, il Mulino, 2008, p. 251.
504 CAMILLA POESIO
richiedeva rapporti che testimoniassero il nesso immediato fra i sintomi di una malat-tia e le persecuzioni non tenendo conto, invece, che molte malattie avevano avuto unperiodo di latenza asintomatico45. Il 14 settembre 1965 fu varata la cosiddetta Bun-desentschädigungsschlußgesetz (BEG-SG)46 che stabilì una riapertura delle scadenze perla richiesta di rivendicazione al primo soccorso e al risarcimento, il reintegro nelle pre-cedenti posizioni, la possibilità di inoltrare la domanda di risarcimento fino al 31dicembre 1969 per coloro che non erano riusciti a farlo entro il 1 aprile 1958. Nel corsodei decenni la legge subì delle regolamentazioni speciali ma non mutò il suo assetto47.Come l’Anppia, la Vvn svolse un ruolo concreto nell’applicazione delle leggi che
interessavano gli ex perseguitati. Nell’anno di approvazione della BerG, la Vvn diAmburgo si mosse su vasta scala e inoltrò le richieste di danni. Stando alle fontiinterne, la Vvn di Amburgo, fino all’approvazione della prima legge del 1953, sioccupò, in quello stesso anno, di 495.000 richieste di danni di diverso tipo, stampò175.000 copie di testi di leggi e decreti, organizzò circa 500 corsi di insegnamento perconsulenti sociali (Sozialberater). I cosiddetti Sozialpolitische Blätter (“giornali socio-poli-tici”) informarono costantemente gli associati sulle indicazioni e sulle decisioni piùimportanti in materia di legislazione previdenziale. Dal 1953 al marzo 1957 i consu-lenti sociali della Vvn si occuparono di 240.071 richieste di danni, 121.023 richiestedi consulenze, 51.876 sentenze (Vorsprachen) di risarcimento, 231.375 lettere redatte,4.376 informazioni giuridiche. Inoltre furono distribuite migliaia di scritti, testi di leggee decreti a partire dal settembre del 1953. 425 adunanze pubbliche informarono tuttele vittime sulla legislazione previdenziale48. Sebbene si tratti di cifre tratte da fontiinterne, e quindi probabilmente sovrastimate, risulta comunque un intenso impegnodella Vvn sul territorio.Sono, tuttavia, abbastanza evidenti le differenze tra le due associazioni sul piano
della loro reale e effettiva influenza sulle politiche risarcitorie. Portava l’imprinting del-l’Anppia la prima legge italiana che avviò una politica a favore degli ex perseguitati,voluta da Umberto Terracini, senatore comunista, ex detenuto politico, ex confinato,ma, soprattutto, presidente dell’Anppia fino alla sua morte nel 1983. La Vvn nonottenne, invece, un simile riconoscimento con una legge promossa dal suo presidenteo da altri suoi rappresentanti. Del resto, molto diverso era il clima politico in quegli
45 Ivi, pp. 258 sgg.46 BGBl. I S. 1315.47 Entschädigung von NS-Unrecht. Regelungen zurWiedergutmachung, Bundesfinanzministerium (a cura
di), Berlin 2012, il volume è scaricabile dal sito del Ministero delle finanze http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2012-11-08-entschaedigung-ns-unrecht.html; sulle tre leggi cfr. A. Lehmann-Richter, Auf der Suche nach den Grenzen der Wiedergutmachung: die Rechtsprechung zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, BWVVer-lag, 2007, pp. 35 sgg; C. Goschler, Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Natio-nalsozialismus, 1945-1954, München, Oldenburg, 1992.
48 Cfr. Zehn Jahre Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN). IV. Bundeskongress München vom17. bis 19. Mai 1957.Wir leben für das Vermächtnis der Helden des deutschen Volkes, Vvn (a cura di), Stutt-gart, Heimrich, 1957, pp. 25-27.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 505
anni nei due paesi: nella Repubblica federale tedesca, una sentenza della Corte costi-tuzionale federale di Karlsruhe aveva messo al bando il partito comunista nel 1956,mentre in Italia, sebbene l’attività del partito comunista fosse da tempo sottoposta aferrei controlli della polizia anche sulla base del Testo unico di pubblica sicurezza del193149, il Pci aveva mantenuto libertà d’azione politica e nel 1955 era stata approvatauna legge che portava il nome di un comunista, sebbene non un semplice comunistatrattandosi di uno dei “padri” della Costituzione.L’azione della Vvn non risultò comunque priva di risultati. Fu grazie ad essa, per
esempio, che furono allargati gli stretti parametri delle normative risarcitorie: nel1977 Breitenau fu riconosciuto campo di concentramento/luogo di detenzione (Kz-Haftstätte), un riconoscimento che significò, per coloro che avevano conosciuto quelluogo, il diritto a rientrare nelle categoria di ex detenuti: fino ad allora avevano rice-vuto, solo una volta, dei contributi dal fondo per l’assicurazione sociale50.
2. Il ruolo internazionale e transnazionale
L’Anppia e la Vvn si mossero anche a livello internazionale facendo parte, entrambe,della Fir. Dal 5 al 7 luglio 1954 si tenne a Copenaghen la prima conferenza sulle malat-tie contratte dagli ex deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e fasci-sti per fame, astenia, distonie neuro-vegetative, psiconevrosi, tubercolosi, reumatismiarticolari, endocrinopatie, disturbi cardiovascolari, affezioni stomatologiche, ecc. Inquella occasione, a cui parteciparono otto paesi dell’Europa occidentale e due diquella orientale oltre all’Urss, furono proclamati i diritti alle cure, alla rieducazione pro-fessionale e alle pensioni per gli ex deportati, internati e vittime del fascismo. Con laconferenza di Copenaghen fu fornita una sistematizzazione nosografica delle «sindromispeciali da campo di concentramento» o malattie «concentramentali». Il dottoreGuglielmo Perretta, associato dell’Anppia, fu l’inviato de «L’Antifascista» a Copenha-gen: egli riferì che non era stato fatto uno studio metodico sulle condizioni di salutedei deportati e internati e che i pochi provvedimenti legislativi adottati non erano suf-ficienti né rispondenti alle esigenze reali, ma dettati solo da «un imperativo morale assaigenerico». L’Anppia rivolse, dunque, un appello a tutte le associazioni legate ai perse-guitati politici e razziali, ex deportati e internati, per iniziare un lavoro di ricerca e diraccolta dati51. Il riconoscimento scientifico dei danni causati dall’oppressione fascista
49 Cfr. C. Poesio, “Pericolo pubblico” e cultura della prevenzione nell’Italia repubblicana. Il confino dipolizia dal 1945 al 1975, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 92,2012, pp. 542-566.
50 Cfr. D. Krause-Vilmar, Das Konzentrationslager Breitenau. Ein staatliches Schutzhaftlager1933/1934, Marburg, Schüren, 1997, pp. 222 sgg.
51 G. Perretta, Gli insegnamenti della Conferenza di Copenhagen per uno studio sulla patologia degliex deportati, in «L’Antifascista», settembre 1954, p. 4.
506 CAMILLA POESIO
e nazista influì sul piano giuridico-previdenziale in ogni paese. Grazie a uno scambiodettagliato di documentazioni mediche, molti di coloro che avevano resistito ai dueregimi avrebbero potuto vedere riconosciuto il diritto al risarcimento, il diritto all’u-guaglianza di tutti i resistenti senza distinzioni politiche, razziali o religiose52.Sempre nel 1954, a novembre, si tenne a Vienna un Incontro-Festival per celebrare
la Resistenza europea, a cui parteciparono intellettuali, artisti, giornalisti e politici. Trale adesioni italiane si contano quelle dello storico Roberto Battaglia, in veste di excomandante della Divisione “Lunense”, di Umberto Terracini, Pietro Nenni, AugustoMonti, Corrado Bonfantini, Alberto Cianca, Ferruccio Parri, Bianca Ceva, NorbertoBobbio, Tommaso Fiore, Carlo Levi, Fausto Nitti, Renato Guttuso, Luchino Visconti,Cesare Zavattini, il produttore cinematografico Sergio Amidei, Vittorio De Sica,Alcide Cervi, padre dei sette fratelli Cervi, Arrigo Boldrini presidente dell’Anpi,Renata Viganò, partigiana e autrice del romanzo L’Agnese va a morire, Ranuccio Bian-chi Bandinelli, il regista Carlo Lizzani53. Dalla Germania orientale giunsero il ministrodelle Questioni culturali, scrittore e membro del comitato nazionale della Germanialibera, Johannes R. Becher, il segretario di Stato al ministero della Giustizia Heinz Toep-tlitz, il membro della presidenza del comitato dei resistenti antifascisti e vice presidentedella Fir Fritz Beyling, Ottmar Geschke membro della presidenza del comitato dei resi-stenti antifascisti, Wolfgang Langhoff direttore del Deutsches Theater di Berlino eautore di Chant des Marais, gli scrittori Anna Seghers e Arnold Zweig. Dalla Germa-nia occidentale: il pastore Max Rudolf Weber, Siegfried Berliner combattente della Resi-stenza in Francia, Willi Cronauer segretario ministeriale al governo della Baviera e variex detenuti54.L’Incontro-Festival previde varie manifestazioni culturali come esposizioni e proie-
zioni di film, simposi con letterati, artisti, scienziati, religiosi, insegnanti, cineasti, stu-diosi dei diritti dei resistenti, ex deportati in campi di concentramento. Furono alle-
52 Sapmo, DY 57 Komitee des Antifaschistischen Widerstandskamps der DDR/ 265, FIR 1956, “Con-ferenza del consiglio generale della Internationale Föderation der Widerstandkampfer, Parigi 19-22 aprile1956”, Rapporto sull’attività e i compiti della FIR.
53 Archivio dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana (d’ora in poi Isrt), FondoFoscolo Lombardi, b. 18, fasc. 1 Anpi Carteggio 1947-1960, sf. «Rencontre Festival internationale de larésistance» Vienna 24-28 novembre 1954, Comitato promotore italiano.
54 Adesions parvenues jusqu’au 25 september 1954. Numerose furono le adesioni dagli altri paesi: dal-l’Austria (il segretario generale del comitato internazionale di Mauthausen, ex deportato a Auschwitz eMauthausen Heinrich Durmayer, il vice presidente dell’Associazione austriaca dei resistenti e delle vittimedel fascismo – KZ Verband e segretario della FIR Otto Horn), dal Belgio (ad es. il poeta e resistente MarcBraeft, il segretario della Fir Luc Smerhausen, il ministro Eugen Soudan, il segretario della Regionale desPrisoners Politiques de Bruxelles Andrèe Terfve), dalla Spagna (il capo della Resistenza spagnola in Fran-cia Luis Fernandez), dalla Francia (ad es. il pittore Jean Amblard, lo scultore Emmanuel Auriscoste, l’exministro Jean Pierre Bloch, professori universitari ex deportati come Gilbert Dreyfus o Henri Desoille,anziani militari come Paul Maury, capitano di riserva ex responsabile militare del settore sud parigino edeportato a Buchenwald), dall’Urss (Nikolas Tchikalenko, rappresentante dei partigiani dell’UnioneSovietica) e dalla Danimarca, Olanda, Lussemburgo, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia. Cfr. anche L’or-ganizzazione ed il programma, in «L’Antifascista», settembre 1954, p. 4.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 507
stite mostre pittoriche, scultoree, spettacoli musicali e balletti: tutti avevano al centroeventi che mettevano in evidenza l’apporto della Resistenza in ogni cultura nazionale.Ciascun gruppo o categoria propose delle mozioni: gli artisti lanciarono l’idea dicostituire un comitato permanente per la diffusione della letteratura ispirata alla Resi-stenza, per il coordinamento di una bibliografia internazionale della letteratura sul temae per la stesura di un testo popolare di storia della Resistenza internazionale da diffon-dere in tutti i paesi e in particolare nelle scuole e fra i giovani. Il gruppo chiese ancheche fosse conferito un premio internazionale ai diversi rami della cultura e che fosseroorganizzati incontri annuali fra intellettuali europei. La mozione degli insegnanti posel’accento sulla necessità di uno scambio internazionale circa i progressi di studio, i libridi testo e le esperienze pedagogiche, nonché l’introduzione obbligatoria della storia deimovimenti della Resistenza nei programmi di insegnamento. Il gruppo degli artisti etecnici del cinema, presieduto da Zavattini, si impegnò a contrastare forme di censurao minaccia alla libertà di espressione, propose un premio ai migliori film sulla Resi-stenza e lanciò l’idea di un festival di film sul tema in ogni paese55. Nella mozione degliex deportati nel campo di Mauthausen, provenienti da Belgio, Cecoslovacchia, Repub-blica Federale Tedesca, Repubblica Democratica Tedesca, Francia, Italia, Polonia,Urss, Austria fu espressa la volontà di trasformare quel campo in luogo commemora-tivo. Essi dettero la disponibilità al Comitato Internazionale di Mauthausen per orga-nizzare una manifestazione internazionale nel maggio del 1955, a dieci anni dalla libe-razione del campo. Le risoluzioni degli ex deportati di Dachau, Neuengamme,Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen avanzarono proposte di pellegrinaggi inter-nazionali in quei campi.All’incontro di Vienna partecipò anche un gruppo di medici, che espresse soddi-
sfazione per alcuni risultati concreti seguiti alla conferenza medica internazionale diCopenaghen sopra ricordata: in Olanda si era costituito, infatti, un comitato medico-sociale a difesa di quelle vittime cui fino ad allora era stato rifiutato il riconoscimentodi danni postumi alle deportazioni; in Cecoslovacchia la Facoltà di medicina di Pragaera stata incaricata di portare avanti studi specifici; in Francia i medici si erano espressiin favore dell’obbligo di assistenza a tutti i resistenti per aiutarli a ottenere pensioni ecure56.L’anno dopo, dal 22 al 23 ottobre 1955, gli stessi undici paesi radunatisi a Copenha-
gen, si riunirono di nuovo, questa volta a Bruxelles, per una conferenza giuridica. Sia
55 Sul ruolo del cinema come uno dei tanti «laboratori di costruzione dell’immaginario collettivo» dellaResistenza, si rimanda al saggio di A. Ballone, La Resistenza, in M. Isnenghi (a cura di), I luoghi dellamemoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 403-438.
56 Isrt, Fondo Foscolo Lombardi, b. 18, fasc. 1 Anpi Carteggio 1947-1960, sf. «Rencontre Festival inter-nationale de la résistance» Vienna 24-28 novembre 1954, Comitato promotore italiano. Dopo Copenha-gen gli stessi paesi che avevano partecipato, con l’aggiunta della Jugoslavia, si ritrovarono per una secondaconferenza medica internazionale a Mosca dal 25 al 28 giugno 1957. I lavori si incentrarono sulla tera-peutica, sul recupero funzionale e la rieducazione per gli invalidi di guerra, prigionieri politici, partigianie deportati.
508 CAMILLA POESIO
a Copenhagen sia a Bruxelles furono messe a confronto le leggi in vigore in vari paesieuropei. In quell’occasione furono scambiate le conoscenze nel campo dell’assistenzasociale e medica, fu studiata la situazione dei sopravvissuti dal punto di vista medico-sociale e furono valutate le pensioni di invalidità57.Sul piano dell’impegno internazionale è da menzionare l’azione che la Vvn e l’Anp-
pia svolsero nei confronti di alcuni orfani di partigiani e perseguitati. Una strettarelazione, per esempio, si instaurò tra la Vvn e l’Istituto protezione orfani dei patriotiFrancesco Biancotto di Venezia: i membri della Vvn inviarono loro soldi e favorironogli scambi con bambini tedeschi (fig. 1). Insieme alla Fir, la Vvn organizzò viaggi-vacanze nella Repubblica federale tedesca per ragazzi di varie nazionalità e per quellitedeschi in paesi stranieri. Secondo le fonti della Vvn, nel 1955 e nel 1956 più di qua-ranta bambini tedeschi, soprattutto della zona della Ruhr, furono ospiti sulla costaadriatica. La Vvn, insieme alla Fir, rese possibile nel 1955 a centoquindici ragazzi disette nazioni trascorrere 2415 giorni di vacanze nella Repubblica federale tedesca; nel1956 2424 giorni a centouno ragazzi di cinque nazioni e a centoquarantatre bambinitedeschi di passare 3542 giorni di ferie in nove paesi stranieri, per esempio in Franciadove visitarono, nel cimitero di Pére Lachaise a Parigi, la tomba ai caduti francesi dellaResistenza e ai perseguitati francesi morti nei Kz58. Anche l’Anppia cominciò a orga-nizzare dal 1959 viaggi e vacanze all’estero: in occasione del congresso nazionale del1961 il segretario generale, Lino Zocchi, riferì che ogni anno l’associazione mandavacentinaia di ragazzi in Francia, nelle due Germanie e nelle democrazie popolari del-l’Europa orientale59.La questione delle giovani generazioni fu al centro di un altro impegno interna-
zionale dell’associazionismo. Nel novembre del 1959 l’Anppia e la Vvn aderirono a unaconferenza internazionale organizzata dalla Fir che si tenne a Firenze a palazzo MediciRiccardi sede, all’epoca, dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana. Il tema por-tante era il coinvolgimento delle giovani generazioni, che non avevano conosciuto gliorrori dei regimi, per fare della Resistenza il fulcro dell’educazione scolastica. I relatoriproposero tre modalità per diffondere la storia della Resistenza: l’insegnamento nellescuole e in speciali corsi, gruppi di studio, tesi universitarie; la letteratura extrascola-stica; altri mezzi comunicativi come riviste giovanili, teatro, musica, film, radio, tele-visione e dischi60. Alla conferenza intervennero quaranta partecipanti provenienti daBelgio, Bulgaria, Danimarca, Repubblica federale tedesca, Repubblica democraticatedesca, Francia, Grecia, Israele, Jugoslavia, Austria, Polonia, Romania, Ungheria,
57 Sapmo, DY 57 Komitee des Antifaschistischen Widerstandskamps der DDR/ 265, FIR 1956, “Con-ferenza del consiglio generale della Internationale Föderation der Widerstandkampfer, Parigi 19-22 aprile1956”, Rapporto sull’attività e i compiti della FIR.
58 Cfr. Zehn Jahre Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, cit., pp. 23-24.59 Cfr. L. Zocchi, Attività e prospettive dell’Anppia, cit., pp. 25-26.60 Sapmo, DY 57 Komitee des AntifaschistischenWiderstandskamps der DDR/ 273, FIR. Internationale
Historikerkonferenz. Nov 1959.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 509
Unione Sovietica e vari ospiti61. Dalla Repubblica federale giunsero il filologo Arne vonFranque, lo storicoWilhelm Herzog, il pubblicista Kurt Hirsch, Alfred Hausse, lo scrit-tore J. C. Rossaint, il consigliere del gruppo “Die Geschwister Scholl” Walter Wendt.Dalla Repubblica democratica arrivaronoWalter Bartel – ex detenuto di Buchenwald,membro della Sed, ex portavoce del presidente della Ddr Wilhelm Pieck e professoreuniversitario a Berlino – e Heinz Schumann collaboratore del Marx-Engels Institut aBerlino. Dagli altri paesi giunsero direttori di istituti storici, un ministro dell’educa-zione, direttori di musei. Fu la prima occasione in cui educatori e storici si riunironoper discutere se la storia della Resistenza europea potesse rappresentare un valore edu-cativo universale62. Tra gli italiani erano presenti Roberto Battaglia, Eugenio Garin,Carlo Francovich, presidente dell’Istituto della Resistenza in Toscana, Foscolo Lom-bardi, Augusto Monti, Giuseppe Berti, Claudio Pavone, Ferruccio Parri, Umberto Ter-racini, Paolo Spriano, Ferruccio Parri, Raffaele Santi, Nello Traquandi, Carlo Cassola.Se Ettore Tibaldi, all’epoca vicepresidente del Senato, definiva la Resistenza «l’epopeaeroica della guerra partigiana» alla base di una nuova morale che le giovani generazioni,in una visione manichea del futuro, dovevano seguire per «distinguere il bene dalmale»63 e se Ada Gobetti vedeva nell’insegnamento della Resistenza una lezione di vitache doveva essere impartita prima di tutto dalla famiglia64, Battaglia parlò delle diffe-renze di insegnamento nei paesi appartenenti ai due blocchi. Nei programmi scolasticidegli Stati orientali il tema era molto più presente che in quelli occidentali sebbene inquesti ultimi (ad esempio in Italia e Francia) si registrasse una vasta produzione lette-raria sulla Resistenza65. Joseph Cornelius Rossaint (poi presidente della Vvn dal 1961fino alla morte nel 1991) tenne la sua relazione sulla situazione nella Repubblicafederale tedesca denunciando una diminuzione dell’insegnamento sulle persecuzioninaziste e sulla Resistenza. Come esempio egli illustrò la progressiva riduzione delnumero di pagine su quel periodo storico nel conosciuto libro di testo in uso nellescuole della Repubblica federale tedesca, Der Mensch imWandel der Zeiten66: nel 1948ai fratelli Sophie e Hans Scholl erano state dedicate otto pagine, nel 1958 i due nonerano nemmeno menzionati; nel 1949 le pagine sui Kz erano nove, nel 1958 non vene era nessuna; da tre pagine sulla persecuzione degli ebrei nel 1949 si passava a quat-
61 Sapmo, DY 57 Komitee des Antifaschistischen Widerstandskamps der DDR/ 204, InternationaleKonferenz Florenz. Thema: Die Widerstandbewegung und die junge Generation 20.-23. 11. 1959.
62 P. Spriano, I giovani e la Resistenza. Si è aperta a Firenze la conferenza internazionale, in «L’Unità»,21 novembre 1959, p. 3.
63 Ivi, Relazione di Ettore Tibaldi.64 Sapmo, DY 57 Komitee des AntifaschistischenWiderstandskamps der DDR/ 273, FIR. Internationale
Historikerkonferenz. Nov 1959, Reportage di Heinz Schumann in «Die Zeitschrift für Geschichte derungarischen Arbeiterbewegung».
65 Sapmo, DY 57 Komitee des Antifaschistischen Widerstandskamps der DDR/ 204, InternationaleKonferenz Florenz. Thema: Die Widerstandbewegung und die junge Generation 20.-23. 11. 1959,Relazione di Roberto Battaglia.
66 I.M. Bauer, O.H. Müller, Der Mensch imWandel der Zeiten, edito dalla GeorgWestermann Ver-lag, Braunschweig fino al 1964.
510 CAMILLA POESIO
tordici righe nel 195867. Walter Bartel, di contro, esaltò la situazione nella Repubblicademocratica tedesca sostenendo che la Resistenza era stata fatta propria dalle nuovegenerazioni68. Di fatto nella Rdt, come in altre repubbliche popolari, la costruzione diuna memoria resistenziale era utilizzata a scopo politico per legittimare la condotta el’esistenza stessa della Repubblica democratica come paese dell’antifascismo69. Inoltre,contrapponendo le supposte continuità fasciste dei paesi del blocco occidentale alle fon-damenta antifasciste della Rdt, la Sed poteva argomentare che la Repubblica demo-cratica aveva più diritto a essere riconosciuta come la “vera” Germania rispetto allaRepubblica federale.Alla fine della conferenza furono avanzate alcune proposte, tra cui potenziare la rac-
colta di documenti e testimonianze in tutti i paesi; intensificare i rapporti fra accademiee istituti per lo scambio di informazioni e delle ricerche; diffondere i “Quaderni inter-nazionali del movimento della Resistenza” pubblicati dalla Fir. Per quanto riguardava l’e-ducazione delle giovani generazioni, considerate le differenze emerse nei sistemi scola-stici dei singoli paesi, la conferenza propose di immettere nei programmi delle scuole pri-marie la storia della Resistenza; di non limitarsi allo studio delle esperienze resistenzialinazionali, ma di avere uno sguardo d’insieme; di valorizzare nell’insegnamento univer-sitario la storia della Resistenza; di organizzare scambi di universitari; di avviare corsi dipreparazione per gli insegnanti su questi temi. Per la diffusione della storia fuori del-l’ambito scolastico e universitario la conferenza si concentrò su alcune iniziative comeincontri fra ex resistenti e giovani in luoghi simbolo, proiezioni, manifestazioni nei tea-tri, nei cinema e in televisione. L’incontro si chiuse con la richiesta alla Fir di rendere notele opere più importanti edite negli altri paesi; di pubblicare un album fotografico sullaResistenza europea accompagnato da testi esplicativi in tutte le lingue; di stimolare inogni paese la promozione di premi letterari per la letteratura giovanile e di assegnarepremi di riconoscimento internazionale ai vincitori di ogni concorso nazionale70.
3. Riflessioni finali e conclusioni
Quale apporto fornì l’associazionismo al riconoscimento degli ex perseguitati e alladiffusione di una memoria della Resistenza? Con quali risultati? Quali furono le dif-ferenze tra le due associazioni prese in esame? Quali furono i loro rapporti?
67 Sapmo, DY 57 Komitee des AntifaschistischenWiderstandskamps der DDR/ 273, FIR. InternationaleHistorikerkonferenz. Nov 1959, Reportage di Heinz Schumann in «Die Zeitschrift für Geschichte derungarischen Arbeiterbewegung».
68 Ibidem.69 Cfr. C. Goschler, The politics of Restitution for Nazi Victims in Germany West and East (1945-
2000), in «Institute of European Studies», 25, 2003, pp. 1-17, p. 10.70 Sapmo, DY 57 Komitee des Antifaschistischen Widerstandskamps der DDR/ 204, Internationale
Konferenz Florenz. Thema: Die Widerstandbewegung und die junge Generation 20.-23. 11. 1959.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 511
Questo contributo offre alcuni spunti di riflessione e alcune ipotesi di ricerca ed èun primo tentativo di bilancio. Si può affermare che l’associazionismo, di fronte allapluralità delle memorie – quella degli antifascisti segnata da differenze di appartenenzapolitica; quella dei perseguitati per motivi razziali fra cui ebrei, africani, zingari, omo-sessuali; quella dei perseguitati per motivi religiosi, fra cui cattolici, ebrei, testimoni diGeova o fedeli di altre confessioni – si propose di sviluppare una memoria comune. Iltentativo però fallì perché le associazioni non riuscirono a restare super partes rispettoalle diverse correnti politiche. Sia l’Anppia sia la Vvn arrivarono a fare affiggere targhecommemorative, a intitolare strade ai perseguitati, a fare erigere monumenti ai resi-stenti, ma il grado di penetrazione nelle rispettive società fu abbastanza limitato71. Ilmotivo principale risiedette nella loro forte politicizzazione che le portò a escludere unalarga parte di ex perseguitati che non si riconoscevano nei partiti a loro collegati – ilPci per l’Anppia e la Kpd/Sed per la Vvn. Inoltre non riuscirono a trovare un canaledi dialogo con i governi, se non in poche occasioni.L’obiettivo di creare associazioni non settorializzate non fu, dunque, raggiunto: in
Italia nacquero diverse associazioni rappresentanti determinati gruppi che avevano vis-suto specifiche esperienze e afferenti a formazioni politiche distinte. Si è parlato di «fra-zionato associazionismo» tra Anpi, Anppia, Anei, Imi, Aned, Anfim, dovuto tanto«all’ambiguità del nuovo Stato italiano a riconoscerle [le diverse esperienze] e a inte-grarle nel suo corpo costitutivo»72, quanto alla stessa diversità di esperienza nei quadripolitici tra chi la Resistenza l’aveva fatta attivamente (capi partigiani e militari) e chino. Il clima della guerra fredda riuscì a inquinare gli intenti dell’associazionismo e astrumentalizzarli. In Italia, sulla memoria della seconda guerra mondiale e la Resistenzasi aprì un forte conflitto fra le sinistre e i partiti di governo, in particolare la Democraziacristiana che mirava a contestare a comunisti e socialisti il monopolio della Resistenzarivendicando il ruolo che avevano avuto i partigiani «bianchi»73. In rare occasioni lediverse associazioni seppero ricompattarsi, come avvenne per le elezioni del 1953quando l’Anppia, l’Anpi, l’Anei, l’Anrp sottoscrissero un documento in cui chiesero,ai candidati dei partiti usciti dalla Resistenza e concorrenti alle imminenti elezioni, unimpegno al riconoscimento giuridico-previdenziale dei loro associati74.In Germania la divisione in due Stati comportò due approcci diversi alla memoria
della persecuzione e della repressione75. La nazionalizzazione della proprietà privata a
71 Sulla monumentalistica sulla Resistenza cfr. A. Finocchi, I monumenti: luogo e forma della memo-ria, in Gallerano (a cura di), La Resistenza fra storia e memoria, cit., pp. 72-83.
72 Dogliani, Associazionismo resistenziale nel primo decennio della repubblica, cit., p. 166.73 Cfr. Focardi, La guerra della memoria, cit., pp. 25 sgg.74 Il documento è in “Patria Indipendente”, n. 11, 7 giugno 1953. Sull’Anpi oltre al saggio di
Dogliani, Associazionismo resistenziale nel primo decennio della repubblica, cit., si veda anche L. CECCHINI,Per la libertà d’Italia e per l’Italia delle libertà. Profilo storico dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia,vol. I, 1944-1960, Roma, Arti grafiche Jasillo, 1996.
75 I.G. Holtey, Chi definisce ciò che deve essere ricordato? Sulla costruzione della ‘memoria collettiva’ nellaBundesrepublik, in «Novecento», 5, 2001, pp. 53-70.
512 CAMILLA POESIO
est e la concezione capitalista occidentale ebbero delle conseguenze sulla gestionedelle richieste di rimborso. Nei primi anni della Repubblica federale la concezione stessadi vittima non era ben definita: nel 1952 il deputato socialdemocratico Georg AugustZinn poteva affermare che «nonostante la piccola differenza che una parte fu torturatamentre l’altra fu solo ‘sedotta’, vittime furono tutti»76. Si delinearono due concezionidi vittima, quelle che avevano “solo” subito, ossia gli ebrei, e quelle avevano combat-tuto, ossia i perseguitati politici, o meglio, nell’ottica del governo della Rdt, i comu-nisti77. Come ha scritto Goschler, poiché la Rft si rifiutò fino al 1990 di concedereindennizzi ai perseguitati residenti nella Rdt, di fatto, «i perseguitati dai nazisti, in taliStati, restarono vittime del conflitto tra Est e Ovest»78. Di contro, la Repubblicademocratica tedesca non offrì mai alcun rimborso patrimoniale agli ebrei a causadella nazionalizzazione della proprietà privata e rifiutò ogni richiesta di riparazione indi-viduale mentre stabilì un sistema di assistenza sociale che consisteva in una pensionedi vecchiaia riservata soprattutto ai comunisti che avevano combattuto e ai persegui-tati ebrei che, però, dopo gli episodi antisemiti del 1952, erano rimasti in pochi essen-dosi dati alla fuga79. Nell’immediato dopoguerra molti resistenti comunisti tedeschi fati-carono a riconoscere una parità tra i perseguitati politici e i perseguitati per motivi raz-ziali80. Ciò successe in parte anche in Italia, dove
Paradossalmente, la stampa comunista, che era quella che dedicava maggior atten-zione alla storia dei crimini nazisti e che si preoccupava, a nome dell’antifascismo, direcensire sistematicamente tutti quei libri […] sull’argomento, contestava, a nome del-l’unità della lotta antifascista e del primato della persecuzione politica, l’impostazionedegli studi specificamente dedicati allo sterminio degli ebrei81.
76 Citato in Ivi, p. 65.77 Sulla distinzione di una prima fase di costruzione della memoria, in cui fu privilegiata una visione
“eroica” delle vittime con al centro i resistenti armati, durata fino agli anni Sessanta e di una seconda faseche è giunta fino ai nostri giorni, in cui prevale una “vittimizzazione” dei perseguitati, si vedano i lavoridi A. Wieviorka tra cui, L’era del testimone, Milano, R. Cortina, 1999; Id., Auschwitz spiegato a mia figlia,Torino, Einaudi, 1999. Judt ha sostenuto che l’amplificazione dell’esperienza resistenziale ha favorito inEuropa la transizione alla democrazia di molti paesi collaborazionisti con l’occupante nazista cfr. T.Judt, Dopoguerra. Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Milano, Mondadori, 2007. Su questa sciaè stato dimostrato come in Francia, Belgio e Olanda l’enfatizzazione della Resistenza abbia favorito, almenonel dopoguerra, una transizione alla democrazia eludendo una resa dei conti con il proprio passato col-laborazionista P. Lagrou, The Legacy of Nazi Persecution. Patriotic Memory and National Recovery inWesternEurope, 1945-1965, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
78 C. Goschler, Le riparazioni in Europa, in M. Cattaruzza, M. Flores, S. Levis Sullam, E. Traverso(a cura di), Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, vol.III. Riflessioni, luoghi e politiche della memoria, Utet, Torino, 2006, pp. 552-585.
79 Ibidem.80 O. Groehler, “Aber sie haben nicht gekämpft”, in «Konkret», 5, 1992, pp.38-44; Id., Integration
und Ausgrenzung von NS-Opfern. Zur Anerkennungs- und Entschädigungsdebatte in der Sowjetischen Besat-zungszone Deutschlands 1945 bis 1949, in J. Kocka (a cura di), Historische DDR-Forschung. Aufsätze undStudien, Zeithistorische Studien, vol. 1, Berlino 1993.
81 Bertilotti, Contrasti e trasformazioni della memoria dello sterminio in Italia, cit., p. 72.
ANPPIA E VVN PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EX PERSEGUITATI POLITICI 513
Queste distinzioni presero forma nelle politiche di risarcimento effettuate nei dueStati tedeschi82: gli indennizzi si caricarono di una forte valenza politica. Dimenticati,invece, per molti anni furono gli omosessuali, coloro che avevano subito esperimentiscientifici e sterilizzazioni, i lavoratori coatti, gli Internati militari italiani.Certamente l’associazionismo contribuì a non fare cadere nell’oblio la memoria dei
perseguitati e svolse un ruolo non solo informativo sulle normative di risarcimento tra-mite l’attività di pubblicizzazione e chiarimento delle leggi e la consulenza per richie-dere gli indennizzi. Ma il peso fu differente: anche se l’associazionismo italiano non riu-scì a compattarsi esso fu, però, capace di incidere efficacemente in occasione di alcunisnodi politici. Se nel 1955 fu l’Anppia a ricoprire un ruolo guida nella promozione dellalegge 10 marzo n. 96, per arrivare all’accordo italo-tedesco sugli indennizzi del 1961svolsero un ruolo fondamentale l’Anei nella persona del suo presidente Paride Piasenti,l’Aned guidata da Pietro Caleffi e l’Ucii diretta da Sergio Piperno. Nella Germaniaorientale, come abbiamo osservato, la Vvn fu fagocitata da organizzazioni di regime,mentre nella Germania occidentale essa rimase in una condizione di “sorvegliata spe-ciale” perché ritenuta un’appendice del governo tedesco orientale. L’influenza delle dueassociazioni fu dunque diversa perché diversi erano i rispettivi contesti nazionali neglianni Cinquanta. A partire dagli anni Sessanta, con l’avvio della stagione di centro sini-stra in Italia e in occasione di eventi epocali, come il processo Eichmann a Gerusa-lemme o la morte di Konrad Adenauer, si sarebbe verificata una maggiore sensibiliz-zazione delle rispettive società nei confronti delle vittime dei passati regimi e l’avvio dipiù efficaci misure di indennizzo.Ciò che comunque emerge da questa prima comparazione è l’azione congiunta delle
due associazioni che, facendo parte della Fir, collaborarono e si mossero nella comunedirezione di combattere qualsiasi manifestazione apologetica o nostalgica dei passatiregimi denunciando ogni forma di ritorno a opinioni o azioni collegabili alle vecchieideologie e diffondendo la conoscenza della storia della persecuzione nazifascista.Quest’azione ebbe anche una dimensione transnazionale testimoniata dagli sforzi pro-dotti per informare l’opinione pubblica dei rispettivi paesi sulle vicende della perse-cuzione. «Il prezzo della libertà», opera che raccoglieva sessanta «lezioni-testimo-nianze» riguardanti episodi di lotta antifascista narrati dagli stessi protagonisti, uscitaalla fine del 1958 per iniziativa dell’Anppia fu, ad esempio, tradotta nella Repubblicademocratica tedesca e stampata con una tiratura iniziale di 10.000 copie83.
CAMILLA POESIO(Venezia, Università Ca’ Foscari)
82 D. Coehen, Transitional Justice in Divided Germany after 1945, in J. Elster (a cura di), Retributionand Reparation in the Transition to Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
83 Cfr. L. Zocchi, Attività e prospettive dell’Anppia, cit., p. 32.
514 CAMILLA POESIO
Fig. 1. I biancottini ringraziano la V.V.N., immagine tratta da Zehn Jahre Vereinigung der Verfolg-ten des Naziregimes (VVN). IV. Bundeskongress München vom 17. bis 19. Mai 1957.Wir leben fürdas Vermächtnis der Helden des deutschen Volkes, a cura di Vvn, Heimrich, Stuttgart 1957, p. 24.