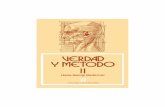Acúmulo de serrapilheira em fragmentos de mata mesofítica e cerrado stricto senso em Uberlândia-MG
Dal sentire al (credere di) sapere. Gadamer e i paradossi del senso comune
Transcript of Dal sentire al (credere di) sapere. Gadamer e i paradossi del senso comune
TONINO GRIFFEROUniversità di Roma “Tor Vergata”
Dal sentire al (credere di) sapere. Gadamer e i paradossi del senso comune
1. Continuismo. «La differenziazione è bella. Ma che cos’è essasenza l’unità e la comunanza, che la generano?»1. Si potrebbeforse anche dire, esagerando un po’, che la filosofia di Gadamerè tutta riassunta in questa affermazione, che segnalal’intenzione di salvaguardare sempre e ovunque la familiarità el’appartenenza, la buona volontà di comprendersi e, più ingenerale, la tradizione come permanente fusione di orizzonti. Sipotrebbe dire, in breve, che la sua impronta stia nell’apologiadella continuità, intesa – problematicamente – come istanza oradi fatto, cioè come l’inaggirabile presupposto di qualsiasiesperienza (compresa quella, sempre relativamente “tragica”,dell’alterità), ora di diritto, ossia come un ideale regolativoatto a sollecitare un’adeguata responsabilizzazione. Nonstupisce, allora, che questa ermeneutica, che può dirsi“canonica” per antonomasia dal momento che si affidacontenutisticamente e assiologicamente alle virtù formativedella “tradizione” pur non riuscendo mai a spiegareesaurientemente quale sia il meccanismo che regola l’istituirsie il rinnovarsi del canone, punti anche sulla riabilitazione delsenso comune, in cui vede il garante dell’accordo profondo chenoi stessi siamo, quell’irriducibile struttura del Vor- di cuigià sempre disponiamo nel nostro essere-nel-mondolinguisticamente mediato, o che dobbiamo sforzarci di tener vivoattraverso il dialogo. È quasi superfluo osservare che è uno deimolti punti in cui Gadamer “urbanizza” Heidegger, nel casospecifico riabilitando sotto il profilo sia etico sia cognitivolo stato interpretativo pubblico che, sprezzantemente, Sein undZeit degradava a “chiacchiera”.
2. Phronesis e appartenenza. Dando vita, com’è noto, a una tra leprincipali riabilitazioni novecentesche del senso comune,l’approccio di Gadamer si presenta apertamente come la solaterapia possibile dinnanzi alle sempre più numerose esperienzecontemporanee di “alienazione per distacco”, archetipicamenteincarnate, come insegna Wahrheit und Methode, dalla “coscienzaestetica” e dall’ “alessandrinismo” della coscienza storica. Lastrategia è nota: positivizzare il pre-giudizio come condizioneepistemologica e ontologica di tutta l’esperienza, valorizzareciò che, essendoci familiare e comune come il linguaggio, già
1 H. G. Gadamer, Studi platonici, ed. it. a cura di G. Moretto, 2 voll., CasaleMonferrato 1983-84, I, p. XX.
1
sempre ci sostiene, permettendo l’emersione stessadell’estraneo; in breve riconoscere proprio nel senso comune unodei principali concetti-guida (relativamente obliati) dellatradizione umanistica, e quindi una delle radici diquell’esperienza extrametodica della verità che sarebbepossibile esclusivamente grazie alle Geisteswissenschaften. Rifacendosi apertamente al modello antiscientistico(anticartesiano) della “scienza nuova” di Vico2, il filosofo diHeidelberg cerca di dimostrare la perenne validità dell’anticoideale retorico dell’eloquentia e della prudentia, superiore inquanto phronesis o saggezza di vita alla più teoretica escolastica sophia, e nella fattispecie di sottolinearel’imprescindibile priorità educativa del sensus communis, cioè diquel senso che, dirigendo la volontà degli uomini nella forma diun “universale concreto” indimostrabile ma pur sempreverosimile, fonderebbe il vero e il giusto di una certa comunitàstorica, evitando così che la forza persuasiva diventiun’esclusiva del logos ai danni del pathos. Argomentando sullabase dell’intuizione e della topica figurata, anziché diun’astrazione concettuale fedele alla correttezza metodica, ilsenso comune o phronesis socialmente istituita sarebbe la capacitàpratica di sussumere la “circostanza”, la situazione concreta,sotto l’universale (il fine prefissato) in vista del giusto, nelquadro di un atteggiamente morale che è sia il presupposto siala meta dell’agire, detto altrimenti di una «virtù sociale,virtù del cuore più che dell’intelletto»3, le cui implicazioninon sono solo morali ma anche metafisiche (si pensi alla sympathyteorizzata da Shaftesbury). Nell’abile e giustamente celebre ricostruzione di Gadamer, la“testa di turco” è notoriamente Kant, di cui stigmatizza lasoggettivizzazione del senso comune, la sua equiparazione algusto (KdU §40) con la conseguente rimozione di ogni valenzaconoscitiva oltre che politico-morale. Kant costruirebbe bensìl’universalità del senso comune, ma soltanto sempre in negativo,astraendo cioè il libero e comunicabile gioco delle facoltàconoscitive da condizioni soggettive a rigore inaggirabili comegli stimoli sensibili e l’emozione, laddove Gadamer s’impegnainvece a riabilitarne l’elemento positivo, ciò che nel sensocomune «rende possibile la comunicazione e fonda l’accordo»4,risultando “evidente” pur senza essere rigorosamente2 Cfr. per un primo approccio: A. Da Re, Retorica ed ermeneutica in Hans-Georg Gadamer,«Verifiche» 2 (1982), pp. 227-248; J. D. Schaeffer, Sensus communis in Vico andGadamer, «New Vico Studies», 5 (1987), pp. 117-130; C. Jermann, La ricezione di Vicoin Gadamer, in AA. VV., Vico in Italia e in Germania. Letture e prospettive, a cura di G.Cacciatore e G. Cantillo, Napoli 1993, pp. 325-343.3 H. G. Gadamer, Verità e metodo, ed. it. a cura di G. Vattimo, Milano 1972, p.48.4 Ivi, p. 69.
2
dimostrabile e quindi oggetto di sapere in senso proprio. Fortedi questa condanna della kantiana depoliticizzazione,intellettualizzazione ed estetizzazione della nozione umanisticadi senso comune (un’interpretazione ovviamente controversa,visto che è lo stesso Kant a suggerire che possa trattarsiaddirittura del presupposto di qualsiasi conoscenza e giudizionon scettico)5, Gadamer ha gioco facile nell’opporre alla meraregolatività kantiana, ossia alla convinzione che l’accordointersoggettivo sia non un dato ma un dover-essere o unanecessità esemplare, la concretezza del senso comuneermeneutico, che non sarebbe affatto soltanto «una facoltàformale», bensì «un insieme di giudizi e di criteri che loqualificano sul piano del contenuto»6, in altre parole unsentimento morale storicamente dato, anzitutto depositato e«concretamente afferrabile»7 nel linguaggio, se è vero che «ciòche è “evidente” è sempre qualcosa di detto»8. Ossia – è il casodi ricordarlo – in quello che è il «modo fondamentale direalizzazione del nostro essere-nel-mondo, la formaonnicomprensiva di tutta la strutturazione del nostro mondo»,«il gioco cui tutti giochiamo»9. 3. Il supplemento d’anima (retorico). Altrettanto noto è il fatto che,proprio in virtù di questa attenzione al linguaggio, Gadamerindividua i benefici del senso comune anche nella mediazioneretorica della scienza. Contando sulla verità come evidenza everosimiglianza, il dominio della persuasione retorico-ermeneutica, infatti, «si estende […] a ogni scoperta dellaricerca scientifica per far valere i suoi diritti su di essa eper adeguarla ai propri criteri», solo in tal modo riuscendo afare «della scienza un fattore sociale di vita»10. Ora, è chiaroche questa traduzione della scienza nel mondo della vita enell’ethos di una comunità non equivale certo alla divulgazionedei suoi esiti nell’opinione pubblica, ma intende dimostrare chela stessa ricerca scientifica dipende da decisioni e paradigmipiù etico-retorici che non strettamente logici, nellapersuasione più generale che il vero non coincida né con la
5 Per una sintesi del dibattito sulla polivocità della nozione kantiana disenso comune (che si presenta a volte come uno stato d’animo universalmentecomunicabile, a volte come la condizione di possibilità di giudizi di gustouniversalmente validi, altre volte infine come l’equivalente della facoltà delgusto), cfr. A. De Simone, Tra Gadamer e Kant. Vertà ermeneutica e cultura estetica, Urbino1996, pp. 195 sgg.6 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 56.7 H. G. Gadamer, Dove si nasconde la salute, ed. it. a cura di A. Grieco e V.Lingiardi, trad. it. di M. Donati e M. E. Ponzo, Milano 1994, p. 127.8 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 553.9 Ivi, pp. 211, 237.10 Ivi, p. 230.
3
dimensione dell’interiorità coscienziale né con le procedure diverifica epistemologica, bensì con lo spazio pubblico generatodal logos tramandato (coscienza comune) e, proprio per questo,anche difficilmente revocabile in dubbio. Siamo a un passo –com’è prevedibile – dalla «pura e semplice accettazione dellacoscienza comune», se non addirittura da «una apologiadell’esistente»11. Colpisce, anzitutto, che le obiezioni gadameriane al mondodella tecnoscienza non ripetano quelle, francamenteirricevibili, di Heidegger. Esse si limitano, infatti, a notarecome la scienza moderna, i cui successi dipenderebbero dallasistematica alienazione metodica, non occupi che una parte di un«più ampio spazio in cui l’umanità si costituisce come comunitàumana e come società», e in cui «la retorica e l’ermeneutica»,in quanto capacità essenziali che si posseggono senza che le sipossa apprendere in senso proprio, «conservano una posizioneinoppugnabile e onnicomprensiva»12, anzitutto arrestandosi allasuperficie dell’ “incontrato”, se è vero che «colui che “mette anudo” nei suoi simili qualcosa che va oltre di loro, cioè coluiche non prende sul serio il gioco che essi giocano, è uno che sicerca evitare»13. Il che esclude però dall’intesa sociale,necessariamente presupposta da qualsiasi comunità, non solo lariflessione critica come coscienza emancipatrice ma anchequalsiasi altra pretesa scientifica, negando perfino chel’istanza della riflessione sia parte di quelle capacitànaturali che, come il saper parlare e il saper comprendere,«possono giungere al pieno sviluppo senza l’uso cosciente diregole tecniche, quando si combinino insieme il dono naturale,la giusta cura e l’esercizio»14. Una esclusione a ben vedereparadossale, perché sacrifica l’indubbia naturalezzadell’impulso scettico, oltre che ovviamente l’idea stessa di unacompetenza tecnica, sull’altare dell’ammissione, in senso latoplatonica, secondo cui la vera retorica come logica delverosimile non può non sapere preliminarmente della verità non solodell’anima ma anche delle cose stesse15. Non ci vuol molto, allora, a identificare questa filosofiadel senso comune con una filosofia dell’autorevolezza, dove“autorità”, beninteso, non significa affatto qualcosa diestraneo all’uomo, bensì – pensiamo a Vico – quel libero usoumano del volere (in ciò contrapposto all’intelletto,inevitabilmente passivo dinanzi alla cogenza del vero) da cui
11 Così G. Vattimo, Verità e retorica nell’ontologia ermeneutica, in Id., La fine dellamodernità. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura post-moderna, Milano 1985, p. 151.12 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 260.13 Ivi, p. 244.14 Ivi, p. 249.15 Ivi, pp. 228, 250, 256.
4
deriva il diritto naturale, ossia un ambito che neppure Diopotrebbe sottrarre all’uomo senza distruggerne di fatto lanatura stessa. Ma, proprio come in Vico la libertà con cuil’uomo “fa” la storia non esclude l’eventuale discrasia fra leintenzioni umane e gli effettivi eventi storici, così anche inGadamer il richiamo all’autolegittimazione dell’autorità aprepiù problemi di quanti ne risolva: se, di contro all’astrattapretesa di autonomia dell’illuminismo, la cui (presunta)illimitata libertà critica non sarebbe che una «libertàdogmatica»16, è necessario riconoscere che rientra nellacostituzione essenziale dell’uomo e della sua vita comunicativaaccettare qualche cosa «senza fare obiezioni»17 (e avrebbeautorevolezza proprio ciò che non ha bisogno di pretenderla), inaltre parole «fare affidamento su qualcosa e infine su qualcuno,a cui offriamo la nostra fiducia»18, perché lo riteniamo inpossesso di una saggezza superiore, il fatto stesso che Gadamermuova obiezioni alla scienza metodica – che gode oggi diindiscussa autorevolezza, pur richiamandosi paradossalmente alrifiuto dall’autorevolezza – ci pare mostri a sufficienza cheuna filosofia dell’autorità rischia, specie quando assume unvolto “reattivo” e antagonistico, di rivelarsi intimamentecontraddittoria, e forse anche irrimediabilmente scettica, se èvero che il realismo istintuale da sempre (pensiamo a Hume)cerca la propria cauzione teorica appunto nello scetticismodella ragione19. Ma la riabilitazione gadameriana del senso comune, di cuiabbiamo fin qui seguito alcune argomentazioni, non implicasoltanto l’esigenza, ai fini di una “sana” convivenza civile, diuna mediazione-traduzione-problematizzazione del saperespecialistico nel quadro del sapere quotidiano, e neppure solol’appello alla sostanziale inindagabilità dello sfondo sulla cuibase, soltanto, si potrebbe distinguere il vero dal falso20,bensì anche l’operatività del senso comune nella prassiermeneutica in senso stretto, dato che proprio il logostramandato può considerarsi tanto la condizione di possibilitàdella dialogicità del comprendere (i pre-giudizi che stimolanol’interprete a porre le “giuste” domande al testo) quanto lameta del compito interpretativo, vale a dire quella continuità
16 H. G. Gadamer, Dove si nasconde la salute, cit., p. 133.17 Ivi, p. 127.18 Ivi, p. 131.19 La credenza è infatti in Hume un’abitudine interna, automatica e vitale, «èla natura vivente che in un certo senso “ragiona” in noi e la consuetudine simostra come il punto in cui l’ordine naturale si manifesta in quello dellenostre rappresentazioni» (F. Moiso, Vita natura libertà. Schelling (1795-1809), Milano1990, p. 17).20 Così L. Wittgenstein, Della certezza, tr. it. di M. Trinchero, Torino 1978, §94, p. 19.
5
semantica di “appartenenza” che ogni interpretazione presupponee insieme ha il dovere di consolidare. Ma quali sono i costi diquesta generale riabilitazione del senso comune? Anzitutto –come si vedrà nel prosieguo – 1) la rimozione di molte dellecomponenti della ben più articolata e sfaccettata storia delconcetto, 2) la rimozione dalla prassi critico-ermeneutica diogni criterio epistemologico, infine 3) la cecità verso altri eassai più promettenti approcci al senso comune.
4. Secolarizzare e defisiologizzare: Gadamer interprete di Oetinger. La primarimozione storiografica consiste nell’accogliere esclusivamentela concezione latina del senso comune e nel liquidaresbrigativamente aspetti non meno fondamentali come quelloteologico e fisiologico-percettivo. L’intento è esplicito:fermarsi al bon sens bergsoniano, ossia al senso comune comesenso sociale o «genio per la vita pratica»21, allo scopo – ci sidice – di risarcire la filosofia tedesca di un aspetto politicodella nozione, rimasto sostanzialmente estraneo al suo approccioprevalentemente teoretico, e quindi ritenuto puramente“negativo” in quanto risolto nell’intellettualizzazioneilluministica. La seconda rimozione, non meno palese, derivadalla scelta di operare una secolarizzazione in grande stile,per cui si potrebbe ragionevolmente sostenere che, delle quattroaccezioni proposte a suo tempo da William Hamilton in un testoemblematico22 per la storia del concetto – ossia 1. percezionesinestetica, 2. luce naturale con valenza gnoseologica e morale,3. intelligenza quotidiana, 4. sensibilità sociale – Gadamerpreservi solo le ultime due. Non irrilevante ci pare che questa duplice rimozione siaagevolmente verificabile nell’interpretazione di un pietistaeccentrico come Friedrich Christoph Oetinger. Certo, pur nonlesinando critiche al tono apologetico e declamatario di questoeclettico settecentesco, Gadamer ha sicuramente contribuito allasua riscoperta in ambito filosofico, citandolo diffusamentenella sua opera maggiore e introducendo una riedizionedell’opera dedicata appunto da Oetinger nel 1753 al sensocomune23. Vi ravvisa un’eccezione nel quadro della ricezioneesclusivamente teoretica in Germania della tradizione del sensuscommunis, ma ne sacrifica indubbiamente vari aspetti: unsacrificio – ermeneuticamente funzionale s’intende –, grazie a21 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., pp. 49-50.22 W. Hamilton, On the philosophy of common sense. Note A, in T. Reid, Philosophical works,ed. by W. Hamilton, Edinburgh 18958, ripr. Hildesheim 1967, pp. 752-759.23 F. C. Oetinger, Inquisitio in sensum communem et rationem, Faksimile-Neudruck derAusgabe Tübingen 1753 mit einer Einleitung von H.-G. Gadamer, Stuttgart-BadCannstatt 1964. La Einleitung (pp. V-XXVIII) è riedita anche in H. G. Gadamer,Oetinger als Philosoph, in Id., Kleine Schriften III, Idee und Sprache, Platon Husserl Heidegger,Tübingen 1972, pp. 89-100.
6
cui Gadamer può costruirsi un precursore di comodo, insistendopiù sull’idea oetingeriana che l’applicazione di regole non puòa sua volta essere garantita da regole, sul ridimensionamentodel valore della scoperta e sul carattere intuitivo e olisticoascritto al senso comune, che non sul tema fisiologico-filosofico-teosofico che invece governa, a ben vedere, tuttal’opera oetingeriana (il filo rosso della Geistleiblichkeit), come sievince dal fatto che, ogni qualvolta deve riferirne una dottrinanon limitata all’ambito etico-sociale, lo fa immancabilmente conuna certa sufficienza. Secolarizza e defisiologizza, cioè, apiene mani, limitandosi a ravvisare nel “sentimento” (o“sensazione”) della vita, che del senso comune è per il pietistala base, nient’altro che un’anticipazione della “coscienzamorale”, e in quanto tale un principio di emendazione dellinguaggio (astratto) oltre che il criterio supremo «di ognicomprendere e di quasiasi interpretazione»24, perdendo così divista però che la dimensione sociale non può pretendere dispiegare con la stessa persuasività di quella fisiologica lanatura infallibile e istintuale, in breve la «forzadittatoriale, irresistibile»25 ascritta al senso comune. Non cheil sensus communis, qual è concepito da Oetinger, non sia, comedice Gadamer contrapponendo a giusto titolo il «senso interno»alla cogitatio cartesiana, anche «un’autoconsapevolezza, un essereconscio e un essere interiore, che caratterizza come umano ognicomportamento umano», detto altrimenti «una suprema ricettività,un saper cogliere ciò che vi è di più elevato, che è logos,spirito e Dio»26, in breve un aspetto naturale contrapposto aquello artificioso della ratio, ma il filosofo dell’ermeneuticalimita questa posizione a un’esigenza antiscientifica eantirazionalistica (donde l’appiattimento di Oetinger suShaftesbury) indubbiamente riduttiva. Senza minimamente poter qui riassumere la dottrina diOetinger27, basterà infatti ricordare che egli giunge alriconoscimento della centralità etico-cognitiva del sensuscommunis ritirandosi in certo qual modo dal terreno dellamistica, ossia maturando la convinzione dell’assolutaeccezionalità della semidivina cognitio centralis, sulla cuiimmediata intuizione della verità e dell’essenza delle coseviceversa confidava in giovane età. Di questa intuizioneaniconica e metamorfica assolutamente certa (perché passivarispetto a Dio e niente affatto acquisibile con l’esercizio),24 Ivi, p. XXVIII.25 Ivi, p. XXII.26 Ivi, p. XX.27 Ci permettiamo di rinviare a T. Griffero, Presentazione. L’«estetica» teosofica diFriedrich Christoph Oetinger, in F. C. Oetinger, Pensieri sul sentire e sul conoscere, a cura diT. Griffero, Aesthetica pre-print, Palermo 1999, pp. 7-43 (e alla letteraturaivi citata).
7
nella maturità radicalmente escatologizzata, o comunque piùprudentemente annoverata tra gli imperscrutabili carismiconcessi dalla grazia divina, il senso comune mantiene comunquealcuni tratti fondamentali, fornendo così al prelato delle arminon strettamente teologiche per combattere il razionalismo e ilpathos a suo parere pericolosamente “inaugurale” dellaSchulphilosophie e in particolare di Wolff. Accogliendo latradizione28, ma anche differenziandosi almeno in parte da chiravvisa nel senso comune il criterio razionalistico didemarcazione dei contenuti religiosi (R. Bentley) oppure ilprincipio di una morale educata dalla convivenza civile e daldialogo sociale (Hutcheson, Hume), da chi ne fa il criteriodella prudentia (l’aristotelica phronesis) e del verosimile umani(Vico) oppure una reazione del cuore avversa a sottigliezzelogico-metafische e sconfinante nell’«amore dell’umanità» (lavirtù estetico-metafisica della sympathy in Shaftesbury, autorepure molto stimato dal pietista), Oetinger sintetizza nellanozione di sensus communis tre orientamenti: quello scolastico-psicologico (senso comune come centro e “giudice” dei cinquesensi), quello medico-stoico (senso comune come lumen naturale – èla linea Ippocrate-Cicerone-Melantone – e consensum gentium),infine quello intenzionalmente eclettico della letteraturaprotocristiana (senso comune come logos spermatikos).Positivizzando le specificità antiscettica della gnoseologia inferiore della gesunde Vernunft di Thomasius, e inquadrandone le istanzein una filosofia-teosofia della “vita”, Oetinger fa del sensuscommunis (che è sfera cognitiva e nel contempo organo cognitivo)una facoltà preposta all’intuizione della verità e, per la suanatura extralogica ed extrariflessiva (e quindi non meramentenominalistico-immaginativa), organicistico-simultanea ancorchénon geometricamente dimostrabile29, riconducibile tanto albinomio sensazione-sentimento (insieme interno ed esterno)quanto alla “sapienza” biblica. Vi si esprime, in accordo conuna definizione non meramente ricettiva del sensus, la(pascaliana) «viva & penetrans perceptio objectorum», ossia ilcontatto con le cose necessarie, tanto visibili quantoinvisibili, garantendo inoltre quell’evidenza immediata che èdeposta da Dio nell’interiorità del soggetto30 e, soprattutto,dell’umanità in generale. Quanto ai suoi “oggetti”, essi vannovisti nelle verità eternamente utili all’uomo e, proprio perquesto, oltre che assolutamente conformi all’Ökonomie Gottes,anche correlate al suo istinto non contingente31. Nonostante si
28 Infatti, delle quattro accezioni, già citate, di William Hamilton nessuna èveramente assente dalla prospettiva di Oetinger.29 F. C. Oetinger, Inquisitio, cit., pp. 28, 19.30 Ivi, pp. 18 sg.31 Ivi, pp. 30-31.
8
tratti di un «senso pragmatico»32, variamente sviluppato dalleistituzioni storiche, è pur sempre, a rigore, una creazione diDio, alla cui scoperta l’uomo è sollecitato interiormente33
quando voglia comprendere – dati i limiti di un mondo creaturaleritenuto “caduto” moralmente non meno che scientificamente –quelle verità «utilissime, necessarissime e semplicissime», che,pur non «dimostrabili» secondo il gusto moderno, sarebbero allabase della filosofia degli «antichi» e della «fisicapatriarcale», che Oetinger oppone con fermezza non tanto allosperimentare come tale, a cui non poteva non essere interessatonella convinzione della diretta proporzionalità tra sentire esapere, quanto alla disorganicità e artificialità della scienzamoderna, segnatamente agli strumenti artificiali a cui questaricorre, obliando così la taglia mesoscopica del mondo esganciandosi dalle esigenze vitali comuni. Si potrebbe dire cheil sensus communis oetingeriano è un “gusto” che, trasformandosiin conformità con lo sviluppo storico della manifestazionedivina, rappresenta più un’esigenza che un mero fatto.Anticipando la riflessione novecentesca sulla Lebenswelt, ma senzarassegnarsi a delegare la verità epistemologica alla scienzaquantitativa, Oetinger vede dunque nel senso comune ilfondamentale criterio estetico-pratico e insieme gnoseologico(visto che la perfezione cognitiva si avrebbe solo dove pensieroe sentire coincidono), dove ciò che conta – almeno per la nostraprospettiva – non è la prevedibile apologia retorica delverosimile e di un metodo vitalistico, bensì una diversaconsiderazione dell’ “estetica”, il cui autonomo valore appareora garantito da un fondamento trascendente non meno cheintersoggettivo e coscienziale, e la cui operatività dipende daun sensorium estetico-logico adeguatamente differenziato sia dall’“entusiasmo” mistico-visionario, sia da ogni logicismo cheecceda quel grado minimo di logica che a tutti appare necessarionella vita. E qui il senso comune allude addirittura a una«sapienza» tanto perfetta e sinestetica da mostrare più di unpunto di contatto con i cosiddetti “sensi spirituali” dellatradizione teologica. Per nulla irrilevante per la storia del pensiero (edell’estetica in modo particolare) è, inoltre, il fatto cheOetinger trasferisca nel corso della sua vita i privilegicognitivi suddetti dalla cognitio centralis non solo al sensus communisma da ultimo anche al sentire in generale, come si ricava da unoscritto del 1775 di valore asolutamente programmatico34, in cui,giovandosi della propria eccentricità extra-accademica, egli
32 Cfr. R. Piepmeier, Aporien des Lebensbegriffs seit Oetinger, Freiburg/München 1978, p.129.33 F. C. Oetinger, Inquisitio, cit., pp. 55, 167.34 F. C. Oetinger, Pensieri sul sentire e sul conoscere, cit.
9
radicalizza la tendenza – ben presente nella filosofia tedescadi metà Settecento (Mendelssohn, Tetens, Crusius e soprattuttoSulzer) e particolarmente in quelle scienze neonate (estetica,antropologia, psicologia) che non per caso appaiono convergentinel rivendicare le virtù del sensualismo – a difenderel’autonomia del sentire come terza facoltà accanto a conoscenzae volontà. Di più: nel riabilitare la sfera affettiva, di controal principio razionalista che ravvisava l’essenza dell’animanella sola vis repraesentativa, la sottrae al tempo stesso ancheall’interiorismo pietista, vedendovi il solo approccio su cuipossa fondarsi un metodo che definisce “fenomenologico” e“generativo”, in quanto volto a riprodurre la genesi delle cose,anziché interrogarsi aridamente sul loro principio di ragionsufficiente, e in ultima analisi idoneo a qualcosa di sfuggentema universale come la “vita”. Capace di percepire in modoimmediato e attivo il cuore e le sfumature delle cose,addirittura metamorfico nel trasformare anche fisiologicamenteil conoscente nel conosciuto (un residuo del sensismorinascimentale e del corpularismo seicentesco, fondato ora sullarevoca del dualismo cartesiano in nome di un influxus physicus),incline a interiorizzare immediatamente il percepito (donde lacoincidenza di etero- e autoesperienza), ma anche assolutamentecerto nel rifuggire ogni nominalismo ed estetismo linguistico,questo (vero) sentire non sarebbe che il verticedell’ininterrotta interazione di anima e corpo, garantita nellasua natura indistintamente fisiologica e spirituale da unMittelding come il succus nervalis, di cui Oetinger fa il veicolo di unpiù elevato fluido, di un autentico “corpo spirituale” cheprende qui il nome di tinctura (Böhme) o di spiritus rector. Ecco: proprio questa apologia teosofica e psicosofica dell’“estetica”, che assegna un primato e una primogenitura delsensibile rispetto al logico, ritenendolo superiore anche perchiarezza e distinzione e surrogando così una perfettaconoscenza estetico-logica, radicalmente escatologizzata con laperdita della sapientia adamica, non è certo nelle corde diGadamer. Pur cogliendo acutamente la fusione, nel pietistasvevo, del significato umanistico-politico con quelloperipatetico, del ben più eclettico enciclopedismo di Oetinger(che è teologo ma anche medico, chimico e cabbalista), Gadamerdecide di sottolineare esclusivamente l’aspetto retorico-morale edermeneutico, sottovalutando il fatto che il senso comune è, senon solo, di certo anche un «un complesso di istinti, cioè unimpulso naturale»35, e ritenendo di conseguenza impossibilel’ideale oetingeriano della compatibilità tra una filosofia-teosofia della vita basata sul senso comune (che è a tutti glieffetti un’«estetica come scienza della percezione35 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 52.
10
dell’apparenza e del verosimile»)36 e la moderna scienza dellanatura. Ma proprio la convinzione del carattere anacronistico diquesto ideale di convivenza tra “estetica” e scienza, in altritermini la cecità per un orientamento che ambisce a non esseremeno scientifico di quello matematico ancorché diretto alqualitativo e alle sfera della sensazione e del sentimento, cipare – lo vedremo – il più ingente dei costi che laricostruzione gadameriana è costretta a pagare, pur diritagliarsi, per esclusione, un ambito veritativo ametodico.
5. I costi ermeneutici ed epistemologici: anything goes. Tuttavia l’adozione delcriterio del senso comune non solo sul piano dei Grundzügedell’ermeneutica filosofica, ma anche su quello della prassiermeneutica comporta inevitabilmente un’altra rimozione, quelladi ogni istanza metodologica e gnoseologicadell’interpretazione. Non è un caso che l’ “altra” ermeneutica,l’ermeneutica metodica o zetetica37 che dir si voglia, quellacioè non totalmente disperata circa una almeno relativaoggettività dell’interpretazione, preferisca spostare ilpresupposto della comunanza o più in alto o più in basso. Piùche di senso comune, infatti, ama parlare o di esperienza comune(o comune umanità) come trascendentale dell’esperienza umana,oppure, più modestamente, di “universo del discorso” inteso comeil sub-cosmo selettivo di esperienze e conoscenze condivise chesi rivelino strettamente pertinenti all’interpretando38. Ora,solo questo arretramento o avvicinamento del presupposto ci pareconsenta, a differenza della generica continuità di sensoinvocata da Gadamer, un’ermeneutica materiale (relativamente)falsificabile, e comunque sicuramente più articolata e sensibilenei confronti degli oggetti interpretati di quella che sarebbegià da sempre garantita da un accordo sulla “cosa”; ci pare chelegittimi cioè una prassi interpretativa in cui si dà un terrenoultimo, il cui preteso oltrepassamento, lungi dal permettere unacomprensione più fine, non produrrebbe se non ulterioriambiguità (un po’ come quando si esige maggiore precisione dachi si è intenzionalmente espresso in modo vago). D’altronde, se il senso comune fornisse davveroun’infallibile garanzia al processo ermeneutico, non sicapirebbe perché fin dall’antichità le società umane abbianoescogitato i più diversi espedienti procedurali e semantici perfacilitare la comprensione. Proprio l’ermeneutica continuistagadameriana, tra l’altro, potrebbe correre il rischio (più volte
36 R. Piepmeier, Aporien des Lebensbegriffs, cit., p. 210.37 Chiaramente contrapposta all’ermeneutica “dogmatica” da L. Geldsetzer, Checos’è l’ermeneutica?, «Rivista di filosofia neoscolastica», 4 (1983), pp. 594-622.38 Cfr. E. D. Hirsch jr., Come si interpreta un testo, tr. it. di L. Valdrè, Roma1977, p. 120.
11
sottolineato da Emilio Betti anche prima di conoscere l’opera diGadamer)39 di obbedire involontariamente all’esigenza, divenutaurgentissima nella civiltà di massa, di prevenire e rimuovere ipossibili attriti e conflitti mediante precomprensioniirriflesse se non addirittura meccaniche, alla pretesa cioè direndere automatico il comprendere, esaurendolo nel mero capireimmediato, in forza di un’erronea generalizzazione dell’anticoditterio secondo cui in claris non fit interpretatio. Pur di difendere ilcomprendere dallo specialismo e dallo scientismo, Gadamerfinirebbe cioè per dare dare la mano a chi favoriscel’istituzione di nefasti surrogati automatici del processointerpretativo, di automatismi emozionali e mentali funzionaliallo standardizzarsi della vita di relazione, che ha appuntobisogno di convergenze rapide e irriflesse. Col che il sensocomune si ridurrebbe a semplificazione espressiva, aanticipazione surrettizia, offrendosi in ultima analisi come unascorciatoia semantico-ermeneutica atta a provocare reazioniuniformi e basata, anziché su una (almeno latente) relazionecomunicativa triadica (interprete-forma rappresentativa-soggettodel senso), su una relazione meramente diadica (o segnaletica),in cui l’emissario, come ventriloquo del senso comune, s’annullanel contenuto espresso. Né bisogna scordare che l’arruolamento gadameriano del sensocomune a presupposto generale del comprendere ricade sottoquella surrettizia trasformazione del concetto di “tradizione”da descrittivo a normativo a suo tempo stigmatizzata da EricDonald Hirsch, e riconducibile a un pragmatismo interpretativoesemplato su quello teologico e giuridico ancorché privo di unagerarchizzazione dei giudizi facente capo, come nei due modellicitati, a un’interpretazione “autentica”. E proprio nelcriticare il cosiddetto “presupposto della perfezione”40 difesoin Verità e metodo, Emilio Betti ha di mira implicitamente anchel’appello al senso comune: tale presupposto, infatti, «nongaranti[rebbe] altro che una mera congruenza fra testo elettore, una corrispondenza cioè fra il senso del testo che sipresenta in apparenza siccome ovvio, a portata di mano, e ilpersonale convincimento del lettore chiamato ad intenderlo»,trattandosi di un procedimento che «si sottrae all’istanzadell’oggettività, essendo unicamente inteso a conseguire lainteriore coerenza, la interiore compiutezza del senso che sitrattava di accertare», oltre che a rivendicare «anche lapretesa sostanziale che ciò che è detto nel testo sia lacompleta verità». Agli occhi di Betti, dunque, Gadamer
39 Cfr. ad es. E. Betti, Teoria generale della interpretazione (1955), edizione correttae ampliata a cura di G. Crifò, 2 voll., Milano 1990, I, pp. 201 sgg.40 Cfr. T. Griffero, Ermeneutica e canonicità dei testi, «Rivista di estetica», 26(1985), nn. 19-20, pp. 93-111.
12
presupporrebbe «che l’interprete che è chiamato ad intenderepretenda per sé il monopolio della verità, se non come possessoacquisito, almeno come istanza di controllo»41: una perditadell’obiettività che «non può in nessun modo essere compensatadalla presa di coscienza della propria storicità acquisita dalsoggetto», tanto più che l’universalizzazione del primatoapplicativo in essa asserita sarebbe giustificata solo«nell’ambito della convivenza e della pratica»42. Se ne evinceche, laddove Betti si sforza di tenere rigorosamente distinti ilpiano storico-teoretico e quello pratico-normativo, lasciandoche il sapere si congiunga con l’eticità ma solo in seguito a unproprio autonomo sviluppo, Gadamer pare dissolvere invece lafilosofia stessa negli strumenti della vita pratica. Com’ènoto43, l’intera controversia si può riassumere nel fatto che,mentre Gadamer crede che il compito dell’ermeneutica sia quello(come riconosce in una lettera inviata a Betti) di «riconoscereciò che è, invece di partire da ciò che appunto dovrebbe opotrebbe essere», dato che «la critica non è normalmentepresente nell’atto del nostro intendere»44, il giurista italianoviceversa giudica un grave errore convertire «la questione dilegittimità che caratterizza i problemi di teoria dellaconoscenza, in una questione fenomenologica, di descrizione diquel che si fa (anziché di quel che si dovrebbe fare)»45, e ciòperché
il problema gnoseologico […] non è una quaestio facti: ma una quaestio iuris:è una questione di legittimità, che non è risolta ad accertare come di fattoavvenga l’attività interpretativa, bensì a sapere come in tale attività ci sidebba regolare: vale a dire, quali scopi il compito dell’interpretazione debbaproporsi, e quali procedimenti eseguire per il buon compimento dell’impresa46. Ora, Betti è tutt’altro che sordo all’esigenza diun’interpretazione “dogmatica”, che cioè esamini un settoredello spirito oggettivato nella sua coerenza e consequenzialitàa partire da determinati valori presupposti, ad esempio sullabase delle sue odierne categorie interne (ne è un esempio laricognizione storico-dogmatica in ambito giuridico, necessariavisto che solo al dogmatico certi fatti del passato appaiono
41 E. Betti, L’ermeneutica storica e la storicità dell’intendere, «Annali della FacoltàGiuridica di Bari», 16 (1961) (ma 1960), pp. 18-20.42 E. Betti, L’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito (1962), saggiointroduttivo, scelta antologica e bibliografie a cura di G. Mura, Roma 1987,pp. 90, 97.43 Cfr. T. Griffero, Interpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto, prefazione di F.Moiso, Torino 1988, in specie pp. 202-214.44 E. Betti, L’ermeneutica come metodica generale, cit., p. 201, nota 118.45 E. Betti, L’ermeneutica storica, cit., p. 27, nota 16.46 E. Betti, L’ermeneutica come metodica generale, cit., pp. 98-99.
13
davvero pregnanti)47; è cioè ben consapevole dell’inevitabilecircolarità di storia e dogma, diacronia e sistema, maaltrettanto certamente vuole opporsi a un’ermeneutica che glipare fondata su un’illecita intesa preliminare sulla Sache esull’acritica sottomissione alla tradizione (che si chiami sensocomune o meno). In sintesi: mentre l’istanza dogmatica èindispensabile in un ambito codificato come quello giuridico,giusta l’avvertenza secondo cui
quanto più si indebolisce il pensiero dogmatico tanto più l’argomentazionegiuridica fondata sull’autorità della tradizione e dell’esperienza si sottraeal controllo razionale, e aumenta la possibilità che nei processi diconcretizzazione del diritto si formi un residuo irrazionale prodotto daelementi non cognitivi provenienti dalla precomprensione soggettiva delgiudice48,
essa per contro difficilmente esercita e deve esercitare questoruolo anche nell’ambito filosofico, dove minore è la necessitàdi una clausola di controllo dell’arbitrio ermeneutico, a menoche non si estenda acriticamente all’intera filosofia l’idea,suggerita dalla dialettica “tragica” vita/forme di Simmel esviluppata ampiamente da Erich Rothacker49, secondo cui, mentrela Sinngebung (l’apertura ontologica, comunque la si vogliaintendere) si sottrarrebbe necessariamente al controlloscientifico, la sua stilizzazione dogmatica potrebbe esseresottoposta a esame, e lo potrebbe, tra l’altro, solo, nelmomento in cui la Lebenswelt da cui discende sia stataadeguatamente superata e quindi relativizzata (il mondotolemaico, in tal senso, diventerebbe un sistema dogmatico solonel momento in cui lo si può considerare dall’esterno, ossiasolo quando sia subentrato un altro sistema, quello copernicanoad esempio). L’ “altra” ermeneutica ritiene cioè che l’appello al sensocomune e la correlata valorizzazione del pregiudizio al di fuoridi contesti rigorosamente pratico-normativi possano far credereche nel comprendere sia all’opera un atteggiamento abituale, chenon si potrebbe cambiare neppure volendolo, anziché unaepistemologicamente assai meno vaga «dottrina della prioritàlogica dell’ipotesi»50, generando così una serie di erroriimmediatamente individuabili: dal misconoscimento del carattereintrinsecamente teorico del senso comune, specie se inteso allamaniera di Gadamer (in senso esclusivamente culturale cioè),47 Cfr. T. Griffero, Interpretazione e astuzia del dogma, in V. Rizzo (a cura di), EmilioBetti e l’interpretazione, Napoli 1991, pp. 73-101.48 L. Mengoni, Interpretazione e nuova dogmatica. L’autorità della dottrina, «Jus», 3 (1985),p. 484.49 E. Rothacker, Die dogmatische Denkform in den Geisteswissenschaften und das Problem desHistorismus, Wiesbaden 1954.50 E. D. Hirsch jr., Come si interpreta un testo, cit., p. 275.
14
all’apologia dell’esistente proprio nei suoi aspetti più anonimie (direbbe Heidegger) inautentici, fino all’impedimento di unacorretta prassi interpretativa51. Del resto, Gadamer difende,com’è noto, il primato e l’universalità dell’applicazione, madeve pur avere avuto i suoi dubbi visto che, come si evince dascritti più recenti, oscilla piuttosto tra un’adesione integralealla logica del coinvolgimento e della (auto)applicazione,soggetta al criterio non della verofalsità ma dell’efficienzatecnica, dell’eleganza formale se non addirittura solo dellapersuasività retorica, e la corretta intuizione del necessariodifferimento del momento applicativo rispetto a quellocognitivo: è Gadamer stesso, in fondo, a ricordarci che «ogniricerca scientifica è in verità ricerca di base e solo in unsecondo momento si può rivolgere alla problematicadell’applicazione delle sue conoscenze»52.
6. A modest proposal: la fisica ingenua. Ma il costo più ingente Gadamerlo paga probabilmente nell’opporre frontalmente il senso comuneal metodo scientifico in generale, e nel degradarlo così ariserva di valore solo poetico o retorico. Per quanto egli neghidi voler difendere un semplice «ideale di rassegnazione»53
rispetto al vincente sapere razionale, e si sforzicontestualmente di conferirgli un significato non solo negativo,in verità non fa molto di più che rivendicare l’importanza diquella «tradizione ininterrotta di cultura retorico-umanistica»54
che riconosce onestamente fuori gioco da almeno un secolo. Ora, c’è probabilmente un solo modo per invalidare la severasentenza con cui Kant fa del senso comune una trovata con cui ilpiù insulso chiacchierone pretende di misurarsi con l’ingegnopiù profondo55, per fare in modo, cioè, che resti un’istanzafilosofica, senza identificarsi con le idee più logore esemplicistiche, e consiste non tanto nel vedervi (per dirla conPareyson) «una presenza originaria dell’essere e della veritànel fondo d’ogni attività umana», «l’incarnazione storica emolteplice della vis veri» come «apertura ontologica dell’uomo», inbreve «quella dimensione ontologica ch’è propria di tutte leattività umane, e ch’è compito della filosofia tradurre intermini verbali e speculativi» 56, bensì, e secondo ragioni
51 Cfr. T. Griffero, Parlare del tempo. Ermeneutica metodica e senso comune, «aut aut»,228 (1988), p. 150.52 H.-G. Gadamer, Elogio della teoria. Discorsi e saggi, a cura di F. Volpi, Milano 1989,p. 62.53 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 45.54 Ivi, p. 47.55 I. Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza, tr. it. di P.Carabellese, a cura di R. Assunto, Roma-Bari 1979, p. 8.56 Così L. Pareyson, Filosofia e senso comune (1967), in Id., Verità e interpretazione,Milano 1972, pp. 225-227, 232.
15
diametralmente opposte a quelle solitamente evocate nell’ambitodell’alleanza postgadameriana tra ermeneutica e nuova retorica,nell’identificare filosofia del senso comune e fisica ingenua.L’imprescindibilità del senso comune è filosoficamenteinteressante, infatti, soprattutto se se ne esamina lacorrispondenza alla “sostanziale” invariabilità del mondoesterno, di contro alla variabilità continua (emendabilità) dellivello epistemologico. 6a. Uno o due mondi? Il primo vantaggio di questa rilettura delproblema del senso comune nella prospettiva che potremmochiamare di “metafisica descrittiva” (e non prescrittiva)57
consiste nel revocare l’ipotesi di un mondo duplice, diventataun luogo comune nell’età contemporanea (anche a a causadell’ermeneutica). Non ci sarebbero affatto due mondi, quellodel senso comune (qualitativo, basato su una fisica e psicologiaingenue) e quello della scienza (quantitativo, basato su calcoliastratti e su osservazioni tecnologicamente mediate), piuttostodue approcci differenti ma egualmente scientifici ad un unicomondo: da un lato la metafisica del senso comune appunto, ofisica ingenua, impegnata a elaborare una scienzadell’ordinario, fondata «su rappresentazioni e princìpiintuitivamente accettabili e pragmaticamente efficaci»58,dall’altro la metafisica sottesa alla fisica matematica. Ora,chi revoca l’ipotesi dei due mondi ha certo buon gioco nelsostenere che una credenza diviene una conoscenza solo se larealtà extramentale la convalida, ragion per cui, ad esempio,non potremmo mai dire che noi “vediamo” che il sole ruotaintorno alla terra, bensì solo che “crediamo” di vederlo, nonpiù di quanto sia possibile al miope che si toglie gli occhialidire che “vede” nuvole confuse anziché tavoli e sedie, dato che«una rappresentazione confusa (sdoppiata, o vaga) di un oggettonon comporta la rappresentazione di un oggetto confuso(sdoppiato, o vago)»59. Ma su questa problematica distinzione tra“vedere” e “credere di vedere” dovremo tornare criticamente. È ben noto che la conoscenza più difficile da comunicare a uncomputer è quella ordinaria, come giustamente emerge dai lavoriin cui Patrick Haynes60 mostra come la costruzione di un robotche sappia cavarsela in una situazione “normale” (ad esempio in
57 Secondo la nota impostazione di P. F. Strawson, Individui. Saggio di metafisicadescrittiva (1959), tr. it. di E. Bencivenga, Milano 1978. Per una sistematica einteressante applicazione recente dell’opposizione, cfr. A. I. Goldman, Liaisons:philosophy meets the cognitive and social sciences, Cambridge (MA) 1992.58 R. Casati-A. Varzi, Un altro mondo?, «Rivista di estetica», n.s. 19 (1/2002),XLII, p. 133.59 Ivi, p. 136.60 Cfr. P. Haynes, The naive physics manifesto, in D. Michiè (ed.), Expert systems in themicroelectronic age, Edinburgh 1979.
16
una tavola calda) debba fare a meno della fisica standard, i cuicalcoli in vista delle situazioni intuitive richieste (sollevarepiatti, tagliare pomodori, ecc.) «sarebbero, e per diversiordini di grandezza, troppo lenti e troppo onerosi in terminicomputazionali, ai fini del compito in esame»61. Subitos’affaccia però la questione se del senso comune sia possibileformulare una “teoria”, oppure se l’esperienza ordinaria siaperfettamente funzionale al nostro sapere proprio perché restaimplicita (coincidendo, eventualmente, con processi sensomotorirefrattari alla teorizzazione, con semplici e tacite abitudinipragmaticamente apprese). Sebbene sembri scientificamentepromettente sottoporre il mondo del senso comune (in tutti isuoi aspetti) a un’indagine ontologica autonoma, perfinoformalizzata, ci si potrebbe però anche accontentare di«sfrondare le parti più “popolari” della fisica del senso comune[come pure della psicologia del senso comune; NdA] al fine distabilire le leggi che governano quel dominio di cose e eventiordinari cui primariamente rimandano tali credenze e desideri»62,individuando così con precisione un dominio che, dettosinteticamente, gode proprio in virtù della sua strutturamesoscopica e mesopsicologica di un grado decisamente elevato diinvarianza storico-geografica al confronto delle sue teoriesecondarie (sorprendentemente differenti da cultura a cultura eda epoca a epoca), pur non giocando alcun ruolo di rilievo nellastruttura causale del mondo (la sola a cui s’interessa la fisicaesperta). Si pensi alle cosiddette qualità secondarie: pur sedistinguibili da quelle primarie, esse non risultano affatto,nel contesto dell’ontologia del senso comune, soggettive nelsenso di essere, come pretende la scienza moderna da Descartesinnanzi, del tutto dipendenti dal piano del linguaggio e dellecredenze. Più semplicemente, possiedono una loro peculiareoggettività che, riflettendo un’articolazione della realtàfisica pertinente solo alla percezione e quindi strettamentecorrelata all’apparato percettivo dei soggetti umani, non haalcuna influenza sui processi strettamente causali del mondofisico. Sebbene si possa ammettere con facilità che chiunque (anchelo scienziato o lo scettico) nella vita quotidiana si affida aquei principi di senso comune che magari teoricamente rifiuta,non è certo pacifico, per la posizione che stiamo descrivendo,che tali conoscenze ingenue siano anche vere. Non lo sono, comea giusto titolo si è osservato63, né se le si paragona alleabitudini percettive (affidabili ma non del tutto esenti dafallacie), né le si considera tanto inaggirabili quanto i
61 B. Smith, Le strutture del mondo del senso comune, «Iride», 9 (1992), p. 25.62 Ivi, p. 34.63 Cfr. R. Casati-A. Varzi, Un altro mondo?, cit., passim.
17
vincoli cognitivi impostici dagli organi di senso (vincoliinevitabili, ma non per questo automaticamente veri)64, e neppurese vi si vede (adattazionismo alla Dennett) il risultato di unaselezione dei metodi con cui i sistemi cognitivi meglio hannosaputo reagire all’ambiente (dimostrandosi utili, ”economici” manon certo veri). Il guaio è che queste obiezioni, purstigmatizzando l’idea assai diffusa secondo cui l’immaginescientifica del mondo non sarebbe che uno sviluppo dell’immaginedel mondo prodotta dal senso comune, e per cui, viceversa, ilsenso comune non sarebbe che il residuo di una fase scientificasuperata (il che pare smentito sia dall’estraneità al sensocomune di molte credenze scientifiche del passato, sia dal fattoche l’affinità sempre sottolineata tra le invarianti del sensocomune e l’aristotelismo sembra derivare unicamente dal comuneorientamento non teoretico ma percettivo-fenomenologico epsicologico), presuppongono però già una nozione di veritàunivocamente modellata su quella epistemologica. E a poco serveribadire la banale contrapposizione tra la sferadell’approssimazione (senso comune) e quella della precisione(scienza), se non altro perché se è (scientificamente) imprecisodire “mi sono innamorato”, è senz’altro altrettanto impreciso(rispetto alla psicologia ingenua) ridurre un sentimento diquesto tipo a un evento chimico sul piano cerebrale, tanto piùche potremmo ravvisare anche nella descrizione in terminichimici del sentimento nient’altro che un errore, che siamomagari disposti a tollerare per onorare gli sforzi della ricercaneuroscientifica (come accettiamo quelli con cui il senso comuneci guida nell’esperienza ordinaria), ma che di per sé non spiegaaffatto ciò che “sentiamo”, e che ha tutto l’aspetto diun’invariante psicologica autoesplicativa. Ci pare di poterneconcludere – e ovviamente senza aderire alla soluzione radicaledi Russell, secondo cui, se lo sviluppo del senso comune conducealla fisica, conduce allora proprio a ciò che invalida il sensocomune – che una credenza del senso comune non può, restando nelsuo ambito, essere emendata senza perdere la sua funzione(semantica e pragmatica) originaria. Non intendiamo certo minimizzare la tesi, suggestiva ancheper la sua eleganza e perspicuità65, secondo cui l’autonomiadelle conoscenze di senso comune dipenderebbe dal loroattribuire agli oggetti del mondo percepito proprietà che nonsono essenziali (definitorie), bensì solo utili a fissare ilriferimento del termine utilizzato o pensato. Da questaestensione all’ambito extralinguistico del cosiddetto “uso
64 È ciò che intende chi si limiti a sottolineare, banalmente, come ci si possaoccupare di fisica solo articolando anche immagini del mondo e linguaggio disenso comune.65 Cfr. R. Casati-A. Varzi, Un altro mondo?, cit., pp. 140-142.
18
referenziale” (e non attributivo) del linguaggio, fondato nonsulla correttezza delle caratteristiche attribuite alle cose,bensì sull’efficacia contestuale (sempre rivedibile) delladescrizione che di esse si serve, deriverebbe che
la fisica ingenua, e più in generale la descrizione del mondo propria delsenso comune, è nella sua totalità un sistema di descrizioni o di pensieri, dipercetti, di intenzioni linguistiche e comunicative che hanno valoresoprattutto sul piano referenziale. Esse hanno principalmente lo scopo difissare il riferimento, per così dire, anche a costo di fallire sul pianoattributivo66.
Ora, in prima istanza si può certo dire che uno capisce qualesia l’oggetto su cui verte la domanda circa il sorgere del soleanche qualora non sia convinto che tale oggetto nella realtàsoddisfi la descrizione (di senso comune) contenuta nelladomanda. Ma, per fare un altro esempio, pur capendoperfettamente chi mi dica “passami quell’acqua, perché ho sete”,non farei forse bene a sindacare questa affermazione, cioè atentare di trasformare l’uso referenziale in attributivo, nelcaso sapessi che non si tratta di acqua bensì di un potenteacido? Il successo del riferimento è davvero il solo criteriodelle cognizioni di senso comune? Sviluppiamo un esempio diLinsky67: quando di una donna che non è sposata si dice che “suomarito è gentile con lei”, nonostante la presupposizione diesistenza non sia soddisfatta, ci si riferisce effettivamentecon successo a colui che vediamo parlare con lei, ma di certoforniremmo un’informazione quanto meno erronea se volessimo conciò alludere alla tesi pseudosociologica secondo cui i maritisono generalmente gentili con le loro consorti (tra l’altro, seanche fosse sposata, potrebbe in questo caso trattarsidell’amante!). L’asserzione, insomma, ci pare piuttosto correttae al tempo stesso fuorviante (e non vera o falsa, giacché talealternativa ci pare presupponga già un criterio di veritàesterno al dilemma in questione), a seconda cioè delleintenzioni del parlante e della rilevanza contestuale deglioggetti cui fa riferimento, perché, se dice il vero sullagentilezza della persona (ma se sapessimo che non è il marito,non avremmo forse qualche difficoltà a usare proprio questoenunciato?), l’attribuisce però alla persona sbagliata, anzisarebbe un’asserzione del tutto fuorviante, se volesse direqualcosa di specifico proprio di quello che (erroneamente) siritiene suo marito. Potrei infatti commentare l’asserzione “suomarito è gentile con lei” nei modi seguenti: 1) “è vero, sivede” (sto camminando per la strada e non conosco né l’uomo né
66 Ivi, p. 156.67 L. Linsky, Reference and referents, in C. Caton (ed.), Philosophy and ordinary language,Urbana 1963, p. 80.
19
la donna di cui si parla); 2) “sì, ma è solo un’apparenza”(potrei infatti dubitare della correttezza dell’interpretazionedel predicato, giudicando l’atteggiamento in questione comedelle false gentilezze o magari degli atti casuali, erroneamenteinterpretati come gentilezze); 3) “è vero, peccato che non siail marito”; 4) “non capisco quello che vuoi dire” (so che non èil marito e trovo perciò fuorviante l’intera asserzione).Davvero è possibile porre tutte queste reazioni (e altreimmaginabili) sullo stesso piano solo perché implicano ilsuccesso di una iniziale funzione referenziale, cheindubbiamente bisogna ammettere, quale che sia la reazioneall’asserzione? A noi pare piuttosto interessante che, se lareazione 1 è precipitosa e credulona, la reazione 4 esprime(certo caricaturalmente) proprio la posizione scientista di chisi sentisse in dovere di riformulare pedantemente in terminiepistemologicamente corretti ogni espressione linguistica, inaltre parole di chi si opponesse per ragioni rigorosamenteepistemologiche al senso comune e alla validità della metafisicadescrittiva che ne tenta l’analisi. 6b. Livelli di realtà: ontologia del senso comune. Ci pare insomma unpo’ riduttivo ricondurre la validità del senso comune alla suasola funzione referenziale, e limitarsi, di conseguenza, asostenere che la differenza tra senso comune ed epistemologia«non riguarda il mondo stesso ma le categorizzazioni e leintenzioni linguistiche e comunicative di cui ci serviamo perfissare il riferimento del nostro discorso e del nostro pensierosul mondo»68. Il fatto stesso che l’uso attributivo oreferenziale di una descrizione dipenda dal contesto, sia cioè«una funzione delle intenzioni del parlante in un casoparticolare»69, non segnala appunto la possibilità che, pur entroil medesimo mondo, si diano molteplici e talora incommensurabililivelli di realtà? E d’altro canto, la limitazione delladistinzione al piano descrittivo non comporta, da un lato, cheil piano attributivo sia considerato di fatto un dominioesclusivo dell’epistemologia e, dall’altro, che uno statuto diperenne emendabilità sia conferito non solo all’epistemologia,ma anche, del tutto controintuitivamente, al senso comune (chesi fonderebbe perciò su descrizioni rivedibili)? In sintesi, evolendo anche qui valutare i costi, quelli pagatidall’identificazione di sapere ingenuo e referenzialismo cipaiono riassumibili nel fare della verità un dominio esclusivodelle scienze esperte, per cui si dovrebbe ammettere che, quandovediamo il sole ruotare intorno alla terra, in realtà “abbiamo
68 R. Casati-A. Varzi, Un altro mondo?, cit., p. 158.69 K. S. Donnellan, Riferimento e descrizioni definite (1966), in A. Bonomi (a cura di),La struttura dogica del linguaggio, Milano 1973, p. 241.
20
solo l’impressione che”, giacché «quel che vediamo in effetti èla rotazione della terra su se stessa; solo che vediamo talerotazione attraverso una immagine scorretta»70. Questa identitàtra il vedere e il suo correlato oggettivo, per ingegnosa chesia la sua fondazione sulla portata fattiva del verbo “vedere”,implica alcune assurdità che mette conto citare: comporta,anzitutto, che io possa nominare ciò che “vedo” in questomomento solo in seguito a un accertamento scientifico, ma ancheche debba, fino a quel momento e pur vedendo indubbiamentequalcosa, pensare piuttosto che mi pare soltanto di vedere, inaltri termini che l’uso di una certa teoria può bensì sembrarmiattributivo (credo di stare descrivendo veracemente qualcosa),laddove sarebbe di per sé (!) puramente referenziale – cosadecisa, in ultima analisi, unicamente dallo stato attualedell’epistemologia. Ci pare dunque che tale soluzione sottendauno “strumentalismo interpretazionista” (secondo la psicologiaingenua: la decisione puramente pragmatica di attribuire statimentali ad altri)71 che esclude che qualsiasi cognizione di sensocomune, giudicata epistemologicamente scorretta mareferenzialmente efficace, possa mai esprimere una qualcheverità. Ora, indubbiamente nessuno (sano di mente) si rifiuteràdi aiutare una persona in pericolo solo perché non concorda conla descrizione datane da chi sta lanciando l’allarme, ma nonmeno vero è che a nessuno che s’abbandoni fiducioso al flussopercettivo passa per la mente di dire non che vede, ma che gli“sembra” soltanto di vedere, in attesa di una qualche ratificaepistemologica di quanto acquisito. Né sarà facile far digerireal presunto colpevole in attesa di giudizio che il giornale si èriferito a lui come “l’assassino di Smith” in maniera del tuttoinnocente, solo in ossequio alla possibilità di usare ladescrizione definita in questione in modo referenziale, ossiaper fare in modo che «l’uditorio [possa] riuscire a comprenderea quale cosa uno si riferisce anche se né quella né alcun’altracosa soddisfa la descrizione»72, e cioè anche se né egli ècolpevole, né esiste in generale un colpevole (potrebbe pursempre trattarsi di suicidio). Certo, ci si potrebbe obiettare che noi non potremmo spiegarecome sorge e si sviluppa un sistema di credenze se non neconoscessimo già la falsità (epistemologia), o se quanto menonon ne potessimo dubitare (scetticismo). Ma sia questaobiezione, sia l’osservazione secondo cui «il bisogno didescrizione di un mondo di fisica ingenua si fa avanti solo nelmomento in cui non sussiste alcun dubbio rispetto a una fisicaesperta, e si abbia una piena consapevolezza del divario tra le
70 R. Casati-A. Varzi, Un altro mondo?, cit., p. 157.71 Cfr. C. Meini, Psicologia ingenua. Una teoria evolutiva, Milano e a. 2001, pp. 5-6.72 K. S. Donnellan, Riferimento e descrizioni definite, cit., p. 236.
21
due»73, configurano a nostro parere una prospettiva ancora tropposubordinata ai criteri dell’epistemologia, giacché nienteesclude, viceversa, che una metafisica impegnata a descriveredelle invarianze ingenue nella dimensione tanto fisico-percettologica quanto psicologica, possa definire del tuttolegittimamente “verità” delle credenze che risultano tantoautonome dalle scienze fisiche della natura quanto lo sono leverità “estetiche”, nella loro natura necessariamentechiaroscurale, da quelle strettamente logiche. Scegliamo pure,dal punto di vista “tattico”, di «attribuire quante maggioriproprietà possibili agli oggetti (al mondo esterno)» e di«ricorrere solo in ultima istanza ai soggetti e al mondointerno», facendo sì che «solo nel momento in cui l’oggetto nonbasterà più, salterà fuori il soggetto, e le sue eventualiresponsabilità»74, al fine di concentrarsi su quanto “resiste”,se non a tutti, di certo a molti cambiamenti, a quanto appareinemendabile perché dipendente da quella taglia “media” (realtàdi senso comune, ragionamento ingenuo) a cui né la fisica né lalogica scientifica sono propriamente interessate, ma nonlimitiamoci a considerare la filosofia del senso comune come unmero spazio negativo («un grimaldello […] la spia di unadifferenza tra il percepito e il concettualizzato»)75. Il mondodel senso comune, tutt’altro che esaurito e forse perfinoinesauribile per i saperi ingenui, finalizzati appunto a rendereconto del mondo dell’esperienza, ci pare cioè dimostri che nondiventa necessariamente scienza (nel senso matematico-quantitativo del termine) tutto ciò che potrebbe(riduzionisticamente) diventarlo, segnalando così la propriavistosa indipendenza dai saperi esperti, una indipendenza che,appunto, dovrebbe stare a cuore alla filosofia che rifiuta diconsiderarsi teleologicamente orientata all’epistemologia. 7. Con Gadamer, oltre Gadamer. Intendiamoci: Gadamer non è poidistantissimo da questo ordine di idee, ma purtroppo si limita avedere nel fatto che «per noi il sole continua a tramontare(come era ovvio per l’astronomia precopernicana)», anzichéun’invarianza percettiva cognitivamente inemendabile,semplicemente una ancora sempre «dominante ed efficace […]interpretazione retorica del mondo»76. Dov’è evidente che, purcogliendo l’identificazione tra il linguaggio naturale (ilmetalinguaggio sempre-in-ordine), che reggerebbe ogni linguaggio
73 M. Ferraris, Inemendabilità, ontologia, realtà sociale, «Rivista di estetica», n.s. 19(1/2002), XLII, p. 178.74 Ivi, pp. 168, 197. Cfr., per una più estesa e originale difesa del realismoontologico, M. Ferraris, Il mondo esterno, Milano 2001.75 Ivi, p. 193.76 H.-G. Gadamer, Elogio della teoria, cit., p. 114.
22
specializzato (compreso quello formalizzato delle scienze), el’ontologia del senso comune, Gadamer non s’avvede però che nonè tanto alle scienze umane, per di più classicisticamenteintese, che converrebbe rifarsi per riabilitare la portataveritativa dell’esperienza ordinaria, quanto a una sfera assaipiù ampia, oltre che scientificamente più avvertita, costituitadai cosiddetti saperi ingenui. Uno strabismo, del resto,attestato anche dal fatto – emblematico – che, pur consapevoledell’evoluzionismo epistemologico77, egli finisce poi non deltutto coerentemente per ascrivere proprio alla scientificitàmoderna alcuni dei tratti (dall’immutabilità all’oggettualitàmetodo-dipendente)78 che paiono viceversa specifici dell’oggettodei saperi ingenui. Si pensi, da un lato, all’immutabileinclinazione alla fallacia dell’affermazione del conseguente (sep allora q, ma q e allora p) studiata dalla psicologia delragionamento ingenuo79, e, dall’altro, all’inemendabilità dellepercezioni sensoriali come nel caso dell’illusione di Müller-Lyer. Certo, nella sua formulazione più generica – quella, percapirci, secondo cui «per quello che si può volere, aspirare etentare di realizzare attraverso il proprio agire, bisognatrovare negli elementi della propria esistenza finita unfondamento»80 –, la proposta gadameriana potrebbe magari anchesembrare relativamente conforme ai desiderata dell’ontologia delsenso comune, così come nell’escludere che nell’interpretare sisegua, nonostante le apparenze, una libera scelta, e si possaesplicitare tutto ciò che è implicitamente presupposto, potrebbeben ricordarci la scoperta dell’indipendenza delle leggipercettive dagli schemi concettuali. Ma si tratta, a ben vedere,solo di convergenze parziali e occasionali, sia perché Gadameridentifica di fatto senso comune e dominio etico, escludendotanto la sfera estetico-percettiva quanto quella psicologica,sia perché del senso comune (nel senso qui proposto) mai sipotrebbe dire, come invece osserva Gadamer a proposito delbuonsenso, che lo si è perso, che si è dimenticata la capacitàdi giudicare «che generalizza a partire dall’esperienza dellavita e che quindi esprime quei giudizi politici e sociali che siè formato non attraverso regole e libri o la cosiddetta
77 Si tratterebbe infatti di «porre in questione se non sia un pregiudiziodell’età moderna che la nozione di progresso, in realtà essenziale per laricerca scientifica, venga applicata alla vita e alla cultura dell’uomo nelsuo complesso» (H.-G. Gadamer, La ragione nell’età della scienza, tr. it e note di A.Fabris, introd. di G. Vattimo, Genova 1982, p. 83).78 La scienza matematica tematizzarebbe «un nuovo concetto di oggetto, che cometale non era esistito né come parola né come realtà» (ibidem).79 Cfr. ad esempio V. Girotto, Il ragionamento, Bologna 1994, pp. 29 e sgg.,nonché P. Legrenzi, Come funziona la mente, Roma-Bari 1998, pp. 3 e sgg.80 H.-G. Gadamer, Elogio della teoria, cit., p. 59.
23
dottrina, ma attraverso l’esperienza»81. A ciò si aggiunga, pervalutare adeguatamente la distanza tra i due approcci, che se ilsenso comune retorico s’affida a una persuasività che esclude inlinea di principio ogni riflessione critica, quello percettivo-ontologico non esclude invece qualsiasi verifica bensì soloquella tecnologicamente mediata, e neppure fa del tutto a meno,all’occorrenza, di metodi e strumenti epistemologici. Laddovel’ermeneutica ambisce inoltre ad estendersi a ogni scopertascientifica, riconducendola al proprio tessuto, e cosìconferendole quel valore sociale oltre che esistenziale di cui(chissà perché!) di per sé sarebbe priva, l’ontologia comefisica ingenua ci pare invece possa vivere di vita propria,emancipandosi più e meglio dell’ermeneutica dalla qualifica,pericolosamente servile, di interprete divulgativo del livelloepistemologico. Se la filosofia del senso comune non fa questo passo avanti,se non accoglie, senza sudditanze verso le scienze fisiche maanche senza ridicoli atteggiamenti antiscientifici, anche imetodi e le finalità dei saperi ingenui, finisce semplicementeper accodarsi alle ormai datate lamentele per quella patologicadissoluzione dei riferimenti collettivi di cui si presentainvano come la terapia (dall’esilio, implementato da Kant, delsenso comune dalla dimensione conoscitiva e pratica, per finirealla tesi di Kürnberger, resa celebre da Adorno, secondo cui dasLeben lebt nicht82); finisce, insomma, per limitarsi a postularenostalgicamente improbabili società stabili, in cui le certezzedel senso comune fioriscano spontanee – chissà come – sia daindividualità tanto forti da essere rappresentativedell’universalità, sia da saperi che non conoscono ancora latragica vicenda dello specialismo. Di più: l’apologiagadameriana della verità extrametodica delle scienze umane e diuna nozione esclusivamente etica di senso comune, presentandosia tutti gli effetti e nonostante le buone intenzioni come unmero Resignationsideal, finisce a nostro parere per dare cartabianca al riduzionismo, se non addirittura aquell’eliminativismo cui inclina lo scientismo pressoché intutte le sue varianti più dogmatiche, lasciando in ultimaanalisi tutto come prima: e cioè alle scienze naturalil’esclusiva del vero sapere, alle mode (ultima la new age) quelladelle credenze verosimili ma inverificabili, e, quel che èpeggio, al populismo mediatico la promozione e l’immediatanaturalizzazione in pregiudizio di un sentire comuneprecedentemente e subliminalmente indotto nella “gente” proprioda quello stesso populismo (ciò per cui calzerebbe perfettamente
81 Ivi, p. 64.82 T. W. Adorno, Minima moralia, tr. it. di R. Solmi, introd. di L. Ceppa, Torino1979, p. 9.
24
l’espressione goethiana: «Ich finde nicht die Spur von einemGeist, und alles ist Dressur»; Faust I, 1172-3) Certo, tutto dipende da quanto possa essere (resa) persuasivaun’immagine più articolata di scienza, in cui convivano conpiena legittimità le analisi relative alle diverse “taglie”, aidiversi livelli del mondo83, in cui abbiano diritto dicittadinanza, per riprendere un celebre esempio cartesiano, sialo studio fisico-ingenuo del sole (grosso quanto una moneta) sialo studio rigorosamente astrofisico del grande corpo celeste. Infondo, come ricordava Austin, «non esiste una risposta generalealla domanda su quanto deve essere finemente graduata una scala,o quanto strettamente determinata l’applicazione di una parola,in parte perché non c’è alcun limite al processo di rifinituradelle divisioni e delle discriminazioni, e in parte perché ciòche è (abbastanza) preciso per certi propositi sarà troppogrossolano e approssimativo per altri»84. Così, anche a chi silimita allo studio delle credenze fisiche o psicologiche ingenue(ancorché verosimili) è oggi offerta forse una nuova chance: nontanto quella di rivendicare una verità alternativa a quelladelle scienze matematico-sperimentali, quanto quella di megliocomprendere le invarianti psicologiche e percettologiche che,fondate sull’inestricabile interdipendenza tra strutturepercettive e sistemi di credenze, costituiscono pur sempre laparte preponderante della nostra esistenza. In fondo, anche ilsapere pratico e la comprensione ermeneutica, cui Gadamer dedicatanta attenzione, potrebbero giovarsene, se è vero che «è grazieall’aiuto delle credenze di fisica ingenua che gli esseri umanisono capaci di trovare la loro strada, per quanto malcerta, nelmondo, proprio come è grazie all’aiuto delle credenze dipsicologia ingenua che gli uomini sono capaci di effettuarepredizioni normalmente affidabili sulle azioni degli altri»85. Ilprogramma ambizioso di una filosofia dei saperi ingenui ci pare,in conclusione, possa rispondere all’auspicio, formulato dallostesso Gadamer, che la filosofia non sopravviva allascientificizzazione «solo ritirandosi nel privato»86, che cioèsvolga adeguatamente il suo compito, restando filosofia, senzaperò impegnarsi (alla maniera di Heidegger) in impreseimpossibili oltre che anacronistiche di svalutazione dellaricerca scientifica (anche per Gadamer «solo dei pazzi possonovedere in tale dipendenza ontologica [dell’oggettività dellascienza; NdA] una diminuzione dell’importanza o della
83 Per un primo ma recente approccio all’annoso problema dell’ontologia deilivelli di realtà, cfr. ora R. Poli, Qualche domanda sui livelli di realtà, «Rivista diestetica», n.s., 18 (3/2001), XLI, pp. 115-131.84 J. L. Austin, Senso e sensibilia, tr. it. di A. Dell’Anna, Genova 2001, p. 124.85 B. Smith, Le strutture del mondo del senso comune, cit., p. 40.86 H.-G. Gadamer, La ragione nell’età della scienza, cit., p. 109.
25