«Dal bicchiere d'acqua al microfono: gli intellettuali e la pratica della conferenza»
Transcript of «Dal bicchiere d'acqua al microfono: gli intellettuali e la pratica della conferenza»
DAL BICCHIER D’ACQUA AL mICROFONO:GLI INTELLETTUALI
E LA PRATICA DELLA CONFERENzA
Nelly Valsangiacomo
Il corso, il convegno, la conferenza sono luoghi storiografici privilegiati per indagare gli scambi, la socialità, la legittimazio-ne sociale e le pratiche professionali degli intellettuali1, la cui comunicazione orale – nelle forme di trasmissione pubblica citate – è strettamente correlata allo scritto, lasciando pertanto delle tracce nelle pubblicazioni e negli archivi. Negli ultimi anni l’apertura degli archivi, sonori e aziendali, di molte radio ha permesso ai ricercatori di estendere l’analisi alla forma ra-diofonica e televisiva di alcuni di questi interventi, soprattutto dagli anni Cinquanta in poi, momento in cui la maggior parte delle trasmissioni comincia a essere registrata.
Questo contributo vuole indagare la conferenza pubblica, pratica professionale che accompagna gli intellettuali lungo tutto il Novecento e fu anche tra i primi suoi apporti alla nuova oralità radiofonica. Genere forse “minore”, la conferenza, qua-le luogo in cui si manifesta la presenza degli intellettuali nella società civile, permette di ragionare sui modi e sui significati di questo manifestarsi. L’analisi che qui si propone riguarda gli interventi pubblici degli intellettuali italiani nella Svizzera ita-liana. Le particolari condizioni culturali e politiche di questa regione permettono di offrire uno studio di caso sulla pratica
1 Cfr. F. Waquet, Parler comme un livre. L’oralité et le savoir (XVIe-XXe siècle), michel, Paris 2003.
ultima.indd 539 26-10-2010 13:59:22
540 nelly valsangiacomo
delle conferenze pubbliche e del loro utilizzo successivo al-la radio, in un intervallo che dalla fine degli anni venti, mo-mento di creazione del medium, si estende fino all’inizio degli anni Settanta, periodo in cui i campi intellettuale, politico e giornalistico si avvicinano creando nuove interazioni e nuove forme di intervento2.
S’impongono però alcune precisazioni. Anzitutto va rileva-to che i termini “conferenza” e “conversazione” nel caso sviz-zero sono indifferentemente usati nei documenti radiofonici, intendendo un monologo di approfondimento su un tema di cultura generale. Si riscontra – non a caso, poiché si insiste-rà sempre più sulla brevità del discorso a carattere divulgati-vo – una propensione per il secondo termine a partire dagli anni Sessanta. Secondariamente, non si faranno in questa sede distinzioni particolari sul tipo di oralità: la conferenza radio-fonica nel periodo considerato rimane ancorata a un’oralità strettamente dipendente dalla scrittura. Infine, una definizio-ne troppo politica di intellettuale sembra poco adatta3; si utiliz-zeranno dunque indifferentemente le espressioni intellettuali e uomini e donne di cultura.
La conferenza tra politica e cultura. L’intervento pubblico come momento simbolico durante il fascismo
Nel corso dell’Ottocento e del Novecento, la Svizzera in-trattiene stretti rapporti con il mondo culturale italiano, non solo per la comunanza linguistica di una delle sue regioni, ma
2 Riprendendo l’espressione di Régis Debray, dalla fine degli anni Sessanta gli intellettuali entrano nel «cycle média».3 Sui problemi di definizione di intellettuale nei media, Cfr. D. Buxton, Un problè-me de définition, in Les intellectuels des médias en France, a cura di D. Buxton, F. James, L’Harmattan, Paris 2005, in particolare pp. 11-7. Pur analizzando il particolare caso francese della seconda parte del XX secolo la riflessione di Buxton può essere per buona parte generalizzata. Sulla stessa questione Hélène Eck scrive: «une définition trop exclusivement politique des «intellectuels» paraît-elle mal ajustée à notre sujet. L’expression plus général et bien plus floue, d’«hommes de culture», conviendrait peut-être mieux pour désigner l’ensemble très varié et très composite de personnalité du monde culturel qui participa, à quelque titre que ce soit, aux émissions de la radio et de la télévision»; H. Eck, Médias audiovisuels et intellectuels, in m. Leymarie, J.F. Sirinelli, L’histoire des intellectuels aujourd’hui, Puf, Paris 2003, p. 204.
ultima.indd 540 26-10-2010 13:59:22
dal bicchiere d’acqua al microfono 541
anche per le divergenti evoluzioni politiche che regolarmente portano una parte del mondo politico e intellettuale italiano a rifugiarsi o a stabilirsi nel territorio elvetico. A cavallo del No-vecento, inoltre, la maggiore mobilità e la creazione di nuove attività culturali sul territorio permettono alla Svizzera italiana di diventare una meta interessante per la pratica delle confe-renze. L’avvento del fascismo e un primo interesse del regime per le attività inerenti alla cultura italiana su suolo elvetico inducono però i Governi federale e cantonale ad essere molto attenti alla partecipazione degli italiani agli avvenimenti pub-blici4.
Fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale la Sviz-zera è regolarmente visitata dagli intellettuali della Penisola. Presso la Scuola ticinese di cultura italiana di Lugano, all’epoca la più importante istituzione organizzatrice di conferenze della regione, tra le due guerre, centotre intellettuali ita-liani tengono circa la metà delle quattrocento conferenze. Diretta da Francesco Chiesa5, la Scuola ha un ruolo maggiore nello sviluppo culturale di questa regione e la sua funzio-ne è politicamente legittimata, poiché iscritta nel bilancio ufficiale del Governo cantonale. Nel tempo, i contatti che l’istituzione intrattiene per invitare i conferenzieri italiani si sovrappongono sempre più ad alcuni canali ufficiali, in particolare il Consolato italiano a Lugano e le Università del vicino regno. Gli italiani sembrano ben disposti a raggiunge-re la cittadina sul Ceresio; si può supporre che le condizioni proposte abbiano un certo peso: oltre alle spese di viaggio e alloggio, ottengono per il loro intervento tra i 50 e i 200
4 La conferenza in questi anni è ancora considerata come uno strumento privile-giato per la propaganda culturale fascista all’estero: «Uno dei mezzi più efficaci per la propaganda qui della nostra cultura continua ad essere quello delle con-ferenze», Lettera del console italiano a Losanna, Francesco Daneo al ministero degli Affari esteri, 17.2.1926, cit. in R. Bütikofer, L’institut italien de culture de Lau-sanne: un instrument de la propagande fasciste en Suisse romande (1936-1943), in Les Annuelles, histoire et société contemporaine, Antipodes, Lausanne 1990, 1, pp. 71-95 (qui p. 74).5 Francesco Chiesa (1871-1973), rappresentante incontrastato della cultura uffi-ciale del Canton Ticino. La sua opera e il suo ruolo gli valgono diverse distinzioni in Svizzera e in Italia. Si ricordano, per il periodo qui considerato: Il Premio del Romanzo mondadori (1927), il dottorato Honoris causa dell’Università di Roma (1928) e il Premio dell’Accademia d’Italia (1940).
ultima.indd 541 26-10-2010 13:59:22
542 nelly valsangiacomo
franchi svizzeri, cioè circa 750 lire italiane6, una cifra corri-sponde a circa il 25% del salario mensile di un Accademico d’Italia alla fine degli anni venti. L’argomento finanziario è dunque tra i fattori che spiegano la partecipazione rilevante e regolare degli italiani in un circolo culturale di provincia come quello luganese, per un pubblico definito colto ma non specialista7 e che sembra preferire le «conversazioni brillan-ti, divertenti e superficiali»8. Gli oratori sono principalmente universitari (e in seguito accademici d’Italia), giornalisti delle grandi testate italiane e scrittori. Si ritrovano intellettuali vicini al fascismo come Giovanni Gentile9 e massimo Bontempelli; il denominatore comune non è però l’ideologia, ma la notorietà: si avvicendano, tra gli scrittori, Alfredo Panzini, Carlo Linati, Delio Tessa, filosofi quali Francesco Orestano e Emilio Bodre-ro, matematici come Federico Enriques, o ancora personaggi che hanno rapporti contrastati con il fascismo, come Giuseppe Antonio Borgese, Egidio Rea le e Diego valeri. Se nel pubblico l’elemento femminile pare ben rappresentato10, le relatrici so-no rare: tra queste margherita Sarfatti e Annie vivanti. Tutti i conferenzieri sono dunque molto noti ai contemporanei, non solo nel Nord Italia, riferimento culturale per eccellen-za della Svizzera italiana, ma nell’intera Penisola.
Le conferenze si occupano in particolare di argomenti umanistici, con l’esplicita richiesta da parte del direttore della Scuola di non parlare di politica. Non pago di questa limitazio-
6 Biblioteca Cantonale di Lugano, Libreria Patria (BCL/Pa), Fasc. Scuola ticinese di coltura italiana: 1926-1927, lettera di Francesco Chiesa a Ildebrando Pizzetti, 27.9.1926. 7 BCL/Pa, Scuola popolare di cultura italiana, fasc. corrispondenza, dossier 1925-1926, lettera di Francesco Chiesa a Gallaresi, 11.10.1925. v. anche Ibid., dossier 1926-1927, lettera di Chiesa a Benedetto Croce, «La scuola ticinese di coltura italiana […] è una specie di Università popolare, che promuove ogni anni con-ferenze e lezioni allo scopo di tener vivo nel nostro paese […] il culto delle cose italiane. Il nostro pubblico non è certo un collegio di specialisti, ma serio, colto e capace di poter apprezzare il valore del dono che Ella ci farebbe venendo».8 BCL/Pa, fasc. Scuola ticinese di coltura italiana, dossier 1926-1927, Relazione di Corinna Chiesa, novembre 1926, p. 3.9 La conferenza di Gentile sarà pubblicata: G. Gentile, Il pensiero italiano del secolo XIX, discorso tenuto a Lugano il 27 aprile 1928, Treves, milano 1928.10. v. BCL/Pa, Fondo Scuola popolare di cultura italiana, fasc. corrispondenza, dossier 1927-1928, lettera agli aderenti della «Scuola ticinese di cultura italiana», 13.12.1927.
ultima.indd 542 26-10-2010 13:59:22
dal bicchiere d’acqua al microfono 543
ne, nel 1938, il Governo cantonale insiste affinché siano privi-legiate le conferenze sulle scienze adducendo la loro maggiore neutralità e aggiungendo che tale decisione deriva dalla non sufficiente comprensione della cultura svizzera da parte degli intellettuali italiani11. Tale insistenza su una “politica dell’apoli-tica” è spiegata dal ruolo istituzionale di questo circolo cultura-le, luogo di espressione di una stretta relazione tra la Svizzera ufficiale e i rappresentanti della cultura italiana dell’epoca. L’attenzione all’aspetto di “apoliticità” delle conferenze e l’in-tenzione dichiarata di voler scindere cultura e politica incorre nelle difficoltà ampiamente studiate dagli storici: titoli di con-ferenze come “I problemi della razza” svolta da Padre Agosti-no Gemelli nel 1933 o “L’espansionismo europeo”, tenuta da Pietro Silva nel 1934, senza giungere ad affrettate conclusioni, sono in questo senso emblematici.
Inoltre, poiché spesso nel rituale dell’incontro pubblico è l’avvenimento e non la conferenza ad essere protagonista, al-cune presenze non possono che avere un’accezione politica: tale forte aspetto simbolico è confermato dal rifiuto opposto nel 1928 a Gaetano Salvemini12 da Francesco Chiesa, sostenu-to dal Governo federale. Chiesa afferma che la fondamentale tutela dell’italianità ticinese si nutre soprattutto delle relazioni con i rappresentanti della “cultura ufficiale italiana”13, indi-pendentemente dalla loro fede ideologica14 e, suscitando le
11 Archivi di Stato del Canton Ticino, Bellinzona (ASTi), Dipartimento dell’Edu-cazione pubblica (900) (DPE/900), fasc. verbali [della commissione della Scuo-la], seduta del 12.11.1937. 12 Sull’“affare Salvemini” v. P. Codiroli, L’ombra del Duce. Lineamenti di politica cul-turale del fascismo nel Cantone Ticino (1922-1943), Angeli, milano 1990, pp. 108 e sgg.; m. Cerutti, Le Tessin, la Suisse et l’Italie de Mussolini. Fascisme et antifascisme, 1921-1935, Payot, Lausanne 1988, pp. 337-51.13 «mi sono rifiutato a invitare Gaetano Salvemini, non certo perché io disconosca il suo valore scientifico, ma perché non credo opportuno che la nostra scuola in-viti una persona la quale, fuori di patria, ha assunto un atteggiamento così aperto di battaglia contro il Governo del suo paese. Governo che indipendentemente da ogni consenso o dissenso dottrinale, rappresenta per noi l’Italia». Lettera aperta di Francesco Chiesa al giornale «Avanguardia», 14.1.1929. 14 Scrive Francesco Chiesa al cognato Brenno Bertoni: «Io m’accontento di dirti questo: che se in Italia, anziché le camicie nere trionfassero oggi le camicie rosse, cercherei (con qualche sforzo) di tenermi in buone relazioni con le camicie ros-se. E questo non per considerazioni di interesse (come può pensare il volgo), ma perché il Ticino dev’essere amico dell’Italia […]». Lettera del 5.4.1931, in B. Ber-
ultima.indd 543 26-10-2010 13:59:22
544 nelly valsangiacomo
indignate proteste dei fuorusciti, disapprova apertamente l’at-teggiamento di Salvemini, il quale attacca il suo paese «dietro delle frontiere che lo mettono in sicurezza».
L’intensa polemica che si sviluppa ha due conseguenze principali: anzitutto il Governo cantonale deciderà di pubbli-care una lista di conferenzieri “autorizzati”; in secondo luogo, sarà creata l’Associazione Romeo Manzoni15, frutto della collabo-razione tra politici antifascisti ticinesi e fuorusciti, in particola-re il repubblicano Randolfo Pacciardi. L’associazione, che ha il chiaro scopo di offrire agli intellettuali antifascisti un mezzo di espressione pubblica, non essendo sostenuta dalle istituzioni, limita la sua attività alla sola stagione invernale 1929-1930, du-rante la quale si alternano nomi conosciuti dell’antifascismo italiano e internazionale, tra i quali Luigi Campolonghi, Fran-cesco Luigi Ferrari, Arturo Labriola, Eugenio Chiesa, Carlo Sforza, victor Basch, Emile vandervelde16.
Le conferenze, seguite da un folto pubblico, affrontano te-mi disparati, ma sempre correlati all’attualità: dai commenti che ci sono pervenuti dalla stampa e da alcune conferenze pubblicate17, gli oratori sono concordi nell’esprimere la ne-cessità dell’intellettuale di impegnarsi per la difesa della de-mocrazia contro il fascismo. È indispensabile lottare contro la rassegnazione, all’origine della “dissimulazione” che rende incapaci di lottare contro gli ostacoli della vita, afferma Arturo Labriola, parlando del pessimismo di voltaire18. Si può suppor-re un riferimento alla condizione intellettuale contemporanea e fors’anche alle sue divergenze con Croce.
toni - F. Chiesa, Carteggio 1900-1940, a cura di G. Orelli, D. Rüesch, Casagrande Editore, Lugano 1994, p. 211.15 Romeo manzoni (1847-1912), filosofo. Antimilitarista, partigiano di uno stato laico e di una scuola non confessionale. 16 Per ragioni strategiche, la Romeo Manzoni invita anche personalità vicine al fascismo, tra i quali Giuseppe Bottai, Padre Agostino Gemelli, Arturo Farinelli e Pao lo Arcari; consigliati dal ministro italiano degli affari esteri non accetteranno l’invito (Cerutti, Le Tessin, la Suisse et l’Italie de Mussolini cit., pp. 349-50). Per con-tro, alcuni di loro interverranno nelle attività della Scuola di cultura e in seguito alla Radio della Svizzera italiana.17 Cfr. N. valsangiacomo, Militantisme intellectuel dans le canton du Tessin pendant le fascisme, in Les intellectuels antifascistes dans la Suisse de l’entre-deux-guerres, a cura di A. Clavien - N. valsangiacomo, Antipodes-GRHIC, Lausanne 2006, pp. 19-40.18 «Avanguardia», 15.2.1930.
ultima.indd 544 26-10-2010 13:59:22
dal bicchiere d’acqua al microfono 545
Gli oratori senza volto19. Dalla conferenza alla conversazione
Per la radio, le relazioni intessute da questi circoli sono un primo bacino nel quale attingere. In onda dal 1932, dal punto di vista dell’evoluzione dello stile radiofonico e degli scopi che si prefigge, la Radio della Svizzera italiana (conosciuta all’epo-ca come Radio monte Ceneri, dal nome del trasmettitore), si inserisce a pieno titolo, per genere, stile e tempi, nella radiofo-nia di servizio pubblico europea. Sussistono però due peculia-rità. Anzitutto, Radio monte Ceneri è emanazione di una radio di monopolio, dunque medium nazionale20, concepita però per una minoranza linguistica. Conseguenza di questa situazio-ne particolare – frutto dell’articolazione tra il forte federalismo elvetico, l’esiguità demografica della Svizzera italiana e la posi-zione di frontiera – Radio monte Ceneri si deve appoggiare in maniera consistente a risorse intellettuali esterne alle frontiere politiche: certamente una rarità in Europa per una radio na-zionale di servizio pubblico. Durante il fascismo, la capacità di penetrazione delle onde radiofoniche nella Penisola compor-ta tensioni diplomatiche fra i due paesi: il regime fascista con-sidera Radio monte Ceneri (che rivendica la sua distanza dal fascismo definendosi sì «italiana», ma anche «libera») una vera e propria minaccia per le province di frontiera e il suo ascolto sarà sovente disturbato21. Al contempo, però, in seguito ad un decreto del Consiglio federale del 1934 limitante la libertà di stampa, Radio monte Ceneri, come le consorelle elvetiche di lingua francese e tedesca, applica un’autocensura sistematica e molto efficace. Inoltre, a seguito della delicata situazione politica internazionale, ma anche dei difficili rapporti con la stampa, l’informazione resta dominio di quest’ultima che tra-
19 Il titolo riprende la conversazione del giornalista e commediografo Umberto morucchio sulla “conferenza radiofonica”: L’oratore senza volto, «Radioprogram-ma», 26.2.1938, pp. 1-2.20 Creata nel 1931, Radio monte Ceneri è parte della Società Svizzera di Radiodif-fusione (SSR), società di diritto semi-privato controllata dalle Autorità federali. Anche in Svizzera, come nel resto dell’Europa, in questo periodo si delinea la prevalenza delle radio di servizio pubblico. Cfr. La radio et la télévision en Suisse. Histoire de la Société suisse de radiodiffusion SSR jusqu’en 1958, a cura di m. T. Drack, Hier und Jetzt, Baden 2000. 21 Le lettere al «Radioprogramma» che giungono dall’Italia attestano un ascolto attento nella Penisola, che spazia ben oltre il Nord Italia.
ultima.indd 545 26-10-2010 13:59:22
546 nelly valsangiacomo
mite l’Agenzia Telegrafica Svizzera (ATS) gestisce gli stringati bollettini radiofonici. Nella programmazione dominano dun-que l’intrattenimento musicale e le cosiddette conversazioni, le quali occupano un ampio spazio dei momenti dedicati al parlato e sono tra i primi strumenti radiofonici di “democra-tizzazione delle conoscenze”22,con l’intento di elevare cultural-mente la popolazione.
La conversazione è essenzialmente una trasposizione della conferenza pubblica; esistono tuttavia degli elementi di cam-biamento che è utile ricordare. Dapprima lo scritto non solo è indispensabile, ma è verificato in precedenza e dunque l’in-tellettuale non può aggiungere nessun elemento nuovo, né di contenuto né di forma, durante la sua dizione. Inoltre, l’autore del testo non è per forza il lettore23: può essere infatti sostituito dallo speaker, per motivi connessi alla sua impossibilità di es-sere presente nello studio al momento della trasmissione (non esistono all’inizio registrazioni), ma anche per le difficoltà sog-gettive che possono insorgere nella lettura al microfono. Non bastano difatti la fama e le competenze, ma si ricercano esplici-tamente «felici espositori»24. Privato della possibilità di intera-gire con il pubblico, di accompagnare con gesti incisivi le frasi, di alzare e abbassare la voce per porre l’accento sui passaggi importanti (la tecnologia dell’epoca non lo permette), l’intel-lettuale all’inizio non sempre è sufficientemente a suo agio. Lo scritto è in seguito pubblicato nel «Radioprogramma».
La radio, che sta cercando un suo particolare stile, offre con regolarità consigli agli autori delle conversazioni25. Sono spesso gli stessi intellettuali che elaborano queste norme e alla Radio della Svizzera italiana ci si riferisce con frequenza direttamente ai protagonisti della radiofonia milanese, come Enzo Ferrieri. Non si è ancora giunti alle articolate “norme per la redazio-ne di un testo radiofonico” stilate da Carlo Emilio Gadda nel 1953; si è però in presenza di un forte aspetto normativo che
22 E. Celio, La radio nella scuola ticinese, «Radioprogramma», 29.10.1933, p. 6.23 Sulla concomitanza tra animatore, autore e mandante cfr. E. Goffman, La confe-renza, in Forme del parlare, il mulino, Bologna, 1987.24 R. Roedel, Cultura e radio, «Radioprogramma», 12.3.1939, p. 2. 25 «Evita le parole e le frasi difficili […]; Pensa sempre al livello intellettuale e cul-turale dei tuoi ascoltatori […] Fa che non si senta la presenza del manoscritto». Dal Decalogo per chi parla, «Radioprogramma», 17.6.1933.
ultima.indd 546 26-10-2010 13:59:22
dal bicchiere d’acqua al microfono 547
se da un lato vuole sviluppare uno stile radiofonico più grade-vole, dall’altro limita lo spazio di manovra dell’intellettuale, confrontato a una nuova oralità, che lo priva di una serie di elementi persuasivi e sottoposto a una censura preventiva che impedisce ogni eventuale deviazione dal testo. Questa minor libertà di azione è causata sia dalla capacità radiofonica di su-perare le frontiere politiche sia dalla percezione della radio di servizio pubblico come di un’appendice diretta del Governo.
Come le altre radio dell’epoca, anche Radio monte Ceneri ha nelle conversazioni, che variano tra i quindici e i quaranta-cinque minuti, uno dei momenti forti della sua programma-zione, che richiede un ascolto attento. Se nel programma si riscontrano regolarmente monologhi scherzosi, molte sono conversazioni improntate a una cultura divulgativa. Si afferma, anzi, la volontà di fare astrazione delle contingenze sociali e politiche, evitando le correnti artistiche e letterarie italiane contemporanee «perché le opere moderne portano quasi tut-te l’impronta delle idee fasciste, e non si deve rimproverare alla stazione del monte Ceneri di rendersi propagatrice di con-cezioni straniere»26 (in effetti, non si potrà fare una distinzione così netta). L’organizzazione di questi momenti è da attribuire all’opera di organizzatore di Delio Tessa. Il poeta milanese non solo partecipa assiduamente come oratore ed estensore di arti-coli nel «Radioprogramma», ma è il promotore di buona parte delle conversazioni che radiofoniche e dei veri e propri giri di conferenze intrapresi nel cantone e in Svizzera dai letterati27: Trilussa, Francesco Pastonchi, Salvatore Gotta, Francesco Flora e molti altri.
Si sviluppa dunque una vera e propria industria locale delle conferenze umanistiche e scientifiche, il che coinvolge anche diversi accademici: nel 1937, Arturo Farinelli (peraltro assiduo frequentatore anche dei microfoni italiani)28, Emilio Bianchi,
26 «Radioprogramma», 13.6.1936, p. 1.27 «Il Ticino per Tessa significò un posto dove poteva parlare liberamente. Lui si sentiva rinascere». Testimonianza di Luigi Rusca in Teche della Radio e Televisio-ne della Svizzera italiana, Lugano (TRTSI), CP 26756, Poesia del Vecchio Natale, in Terza Pagina, Rete 1, 25.2.1979.28 Cfr. le sei conversazioni riprodotte in A. Farinelli, Nuovi saggi e nuove memorie, con un’appendice: Conversazioni alla radio torinese (inedite), Paravia, Torino 1942-XX. Nel libro, dedicato a Luigi Federzoni e ad Alessandro Tavolini, si trovano
ultima.indd 547 26-10-2010 13:59:23
548 nelly valsangiacomo
Giotto Dainelli. Sono significativi alcuni nomi, già conosciuti dal pubblico della Scuola ticinese di cultura italiana, nel 1938 in-terviene massimo Bontempelli, “[…] artista eletto, fine aristo-cratico che ha sempre inteso la sua arte come una missione e che a un chiaro momento ritiene di poter propagandare il suo credo elevando il tono della letteratura corrente»29. Personag-gio preminente della cultura letteraria militante nel venten-nio fascista, anche come propagandista della cultura italiana all’estero, proprio in questi mesi sta maturando il distacco dal fascismo. Bontempelli parla di Aspetti letterari del ventesimo seco-lo30. Padre Agostino Gemelli sarà accolto con grandi onori ai microfoni nell’aprile 193931: in Scienziati cattolici nel mondo, egli riprende l’i dea del positivismo come pensiero anacronistico e perora i «sistemi i dea listi, spiritualisti, fenomenismi»32.
Tessa invita dunque una varietà di personaggi che spazia dai poeti dialettali milanesi agli Accademici d’Italia. Persiste una certa ambivalenza, che ricorda per certi versi la condizio-ne del mondo culturale italiano coevo; non bisogna del resto dimenticare che è lo stesso governo fascista a concedere il visto d’uscita dall’Italia di questi conferenzieri. Il gruppo di italiani che partecipano alle trasmissioni radiofoniche è così compo-sto sia da aderenti convinti al fascismo sia da antifascisti non militanti. Si può dunque supporre anche in questo caso un tentativo di sviluppare una “politica dell’apolitica”. Eppure, come per la scuola, attraverso il filtro di tale apparente apo-liticità emergono alcuni messaggi, sia nei testi del «Radiopro-
riferimenti sui rapporti di Farinelli con la Svizzera (Ricordi di fanciullezza e ado-lescenza, pp. 1-28); Farinelli visse, infatti parte dell’infanzia a Bellinzona. Nella presentazione del «Radioprogramma» si afferma: «Nel Ticino, ove felicemente si concilia l’attaccamento alla lingua che è sua e nostra colla fedeltà integra alla patria Svizzera, Arturo Farinelli deve sentirsi ospite gradito». Arturo Farinelli, «Ra-dioprogramma», 6.11.1937, p. 1. La didascalia alla foto di Farinelli negli studi della RSI recita: «è il primo accademico d’Italia che ha onorato della sua visita il nostro studio». «Radioprogramma», 20.11.1937, p. 1.29 Massimo Bontempelli alla R.S.I., in «Radioprogramma», 26.3.1938, p. 3.30 m. Bontempelli, Aspetti letterari del ventesimo secolo, Rassegna, «Radioprogram-ma», 11.6.1938, pp. 4-5. La conversazione è presentata come «Una sintesi acutis-sima dell’attuale situazione del pensiero europeo».31 D. Tessa, Padre Agostino Gemelli e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in La Settima-na radiofonica, «Radioprogramma», 24.1939, p. 4. 32 Padre A. Gemelli, Conversazioni trasmesse: Scienziati cattolici nel mondo, «Radiopro-gramma», 5.8.1939, pp. 5-6.
ultima.indd 548 26-10-2010 13:59:23
dal bicchiere d’acqua al microfono 549
gramma» (la censura radiofonica ha maglie molto più larghe nei confronti del giornale) sia attraverso le onde. In partico-lar modo, la conversazione che Benedetto Croce tiene ai mi-crofoni di Radio monte Ceneri è il nucleo attorno al quale si costruirà nel dopoguerra la memoria antifascista della radio. Sarà del resto l’unica ricordata dalla storiografia33. Nel 193634, infatti, il filosofo – che aveva declinato per due volte l’invito di Francesco Chiesa alla Scuola di cultura italiana e che non aveva mai parlato prima alla radio – sollecitato da Tessa, si esprime ai microfoni elvetici. L’intervento di Croce riveste una tale im-portanza che non pare un caso se è tra i pochi documenti so-nori del periodo conservati35. Croce sviluppa il suo intervento di quindici minuti attorno alla morte delle vite romanzate, e alla sostanziale differenza che esiste tra queste, connotate ne-gativamente, e il romanzo storico, scaturito nel pieno del XIX secolo e della scoperta della storicità
Nacque come il riflesso di questo moto intellettuale a cui volle da-re il sussidio dell’immaginazione per divulgare e rendere popola-ri taluni risultamenti. E poiché questo mondo intellettuale non si avvolgeva e terminava in se stesso, ma sorgendo da passioni poli-tiche e da esigenze morali profonde dell’anima europea, a questa ritornava per convalidarle e indirizzarle, il romanzo storico, come la storiografia sulla quale si interessava, si riempì di quegli affetti e rivendicò la libertà contro la tirannia e l’assolutismo, propugnò l’indipendenza delle nazioni asservite, spirò nobiltà di i dea li e di sacrifici […] ammirazione per gli eroi e gli uomini di genio che innalzarono e ampliarono l’umanità
Le vite romanzate, invece, «una delle manifestazioni patolo-giche del periodo di vita europea seguito alla grande guerra», suscitano
Un’impressione, peggio che di immeschinimento, di vergogna […]. Tutto quanto si attiene agli i dea li e alle glorie dell’uomo,
33 Cfr. G. Isola, L’ha scritto la radio. Storia e testi della radio durante il fascismo (1924-1944), mondadori, milano 1998, p. 372.34 Cfr. Benedetto Croce, «Radioprogramma», pp. 1, 3-4. (alle pp. 3-4 il testo integrale). 35 TRTSI, CP 3454, Documento sonoro, Discorso del filosofo italiano Benedetto Croce, 4.10.1936, 14’05’‘. Il confronto tra il documento sonoro e il testo pubblicato nel radioprogramma conferma la sovrapposizione tra scritto e orale.
ultima.indd 549 26-10-2010 13:59:23
550 nelly valsangiacomo
al suo lavoro, alle sue opere di pensiero e di azione, che vivono eterne, sempre attive nella storia dell’umanità, nella storia della civiltà, è da esse assente.
Se nella prima parte della conferenza, Croce rimane mag-giormente ancorato ad aspetti di storia letteraria, nella con-clusione la traslazione tra questione letteraria e attualità è più esplicita. Certo, afferma Croce, i segni del tramonto delle vite romanzate potrebbero rallegrare, ma per potersene veramente rallegrare bisognerebbe assistere in pari tempo al mutamento degli stati d’animo che le hanno prodotte e le producono
se, in altri termini vedessimo gli i dea li di umanità, di libertà e di civile progresso uscire dai rari cuori nei quali ora sembrano esser-si rifugiati, e ripigliare largo vigore sociale. Fintanto che questo non avvenga, scarso sarà il beneficio che non si scrivano o si legga-no più vite romanzate, perché quello stato d’animo persistendo, troverà altre forme in cui manifestarsi.
È dunque difficile essere ottimisti poiché il discorso non si può chiudere «con l’annuncio lieto della fine di un malanno, e neppure con la speranza di una prossima fine». Tuttavia
[..] si chiuderà con lo augurio che delle “vite romanzate”, come di molte altre cose del nostro tempo, si parli, in un avvenire più o meno prossimo, non con la nostalgia che avvolge di solito tante parti del passato, ma con quel fastidio e disdegno con cui si suol parlare delle goffe metafore dei secentisti o delle smanie dei con-vulsionari
Delle conversazioni degli intellettuali italiani pervenuteci, quella di Croce sembra essere la più esplicitamente critica nei confronti della temperie politica e culturale del periodo.
morto Delio Tessa, lo scoppio della guerra rende più labo-riosa l’organizzazione delle conferenze radiofoniche36. Fanno
36 La RSI non può approfittare del massiccio rientro in patria di artisti e letterati svizzeri: «Oltre Gottardo il conflitto ha fatto rimpatriare un numero notevole di artisti che in altri tempi non avrebbero mai collaborato ai programmi degli studi confederati: da noi nulla di simile è accaduto, le frontiere sono diventate mu-raglie cinesi impenetrabili, il viaggio attraverso le Alpi si è fatto più lungo e più costoso». I programmi della RSI, «Radioprogramma», 8.7.1944, p. 2.
ultima.indd 550 26-10-2010 13:59:23
dal bicchiere d’acqua al microfono 551
tuttavia capolino nella programmazione del parlato, nomi di artisti e letterati italiani residenti in Svizzera e alcuni prove-nienti dalla Penisola: Riccardo Bacchelli, Carlo Carrà, France-sco Pastonchi e pochi altri. Il crollo del fascismo e il massiccio arrivo dei rifugiati dopo l’8 settembre non cambia la situazio-ne: la radio, come i circoli culturali, deve rispettare il severo divieto di coinvolgere i rifugiati. Le trasmissioni del parlato ricominciano cautamente ad aprirsi agli intellettuali italiani solo nella primavera del 1945: tra i primi Guido Lodovico Luz-zatto.
La conferenza paradigma della radio educativa
Nel 1947, in occasione delle giornate culturali organiz-zate dalla Radio della Svizzera italiana, Carlo Bo parla della radio durante la guerra come la «compagna fedele e attesa con ansia», mentre «oggi è uno strumento senza la schiavitù dei confini». Nella stessa occasione, Elio vittorini la definisce uno strumento più di servitù che di libertà umana, poiché sarà un’invenzione intera solo al momento che avrà dato agli uomi-ni la possibilità di non subirla37. Se si ritrova in questa doppia visione l’ambivalenza del mondo culturale che accompagna la radiofonia sin dagli esordi38, è però certo che non solo la Radio acquista una vasta popolarità durante il conflitto, ma anche che molti uomini di cultura la annoverano ormai tra le loro regolari fonti di sostentamento; le donne continueranno a rimanere una minoranza, anche se in posizione sempre più rilevante, sia come organizzatrici radiofoniche del parlato sia come collaboratrici delle diverse trasmissioni culturali.
Nei primissimi anni del dopoguerra, la Radio della Svizzera italiana riallaccia i rapporti preesistenti. Personalità già presen-ti sulle onde elvetiche negli anni precedenti al conflitto e in-tellettuali rifugiati durante il momento bellico, diventano voci regolari per gli ascoltatori della radio svizzera: il critico teatrale
37 TRTSI, CP 2579, Messaggi in occasione delle serate culturali di (Radio Monteceneri) Radio della Svizzera italiana, 30.3.1947.38 Cfr., tra gli altri, Il pensiero e la radio: cento anni di radio, a cura di R. Grandi, Lu-petti, milano 1995.
ultima.indd 551 26-10-2010 13:59:23
552 nelly valsangiacomo
Silvio d’Amico, già presente con assiduità prima della guerra e attivo collaboratore della RAI, lo slavista Ettore Lo Gatto, le cui lezioni sulla letteratura dei paesi dell’est saranno un regolare appuntamento per decenni al microfono svizzero39, Guglielmo Usellini, responsabile durate la guerra della «pagina dell’emi-grazione italiana» di Libera Stampa, Aldo Borlenghi, tra gli ani-matori più assidui dei programmi culturali, e molti altri.
Le relazioni intessute prima del conflitto favoriscono la ricostituzione di un solido gruppo di collaboratori italiani e l’ampliamento per osmosi dello stesso. A ciò si aggiungono la buona fama di cui gode la Radio della Svizzera italiana nel-la Penisola40 e il difficile momento economico nel quale ver-sa l’Italia del secondo dopoguerra, che porta gli italiani, tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, a proporre la loro collaborazione41; la Radio svizzera però non regge a lungo la competizione dal punto di vista dei compensi con la rinata e potente radiodiffusione italiana. Enzo Paci, nel 1953, scrive di un’insostenibile proporzione di uno a sette42; tale motivo sembra essere la causa anche di diversi rifiuti43. A maggior ragione dunque la piccola industria locale delle con-ferenze deve forzatamente coinvolgere sia la radio sia i circoli culturali regionali e nazionali44, per richiamare nomi di rilievo. Scrive Roberto Longhi allo scrittore Piero Bianconi:
39 v. TRTSI, Ettore Lo Gatto compie 90 anni. Un omaggio al grande slavista, 20.5.1980.40 «Io pure sono lieto di collaborare con qualche trasmissione per la Radio Svizze-ra italiana, di cui ho sempre ammirato la serietà dei programmi e la bontà delle trasmissioni.». Archivio Prezzolini, Biblioteca Cantonale, Lugano (APL), Fondo Felice Filippini, lettera di mario Fubini a Felice Filippini, capo del parlato, To-rino, 29.10.1949. Fubini fu in Svizzera durante la guerra. Felice Filippini (1917-1988), Scrittore e pittore, fu direttore dei programmi parlati della Radio della Svizzera italiana dal 1945 al 1969. Collaborò anche con la RAI.41 «Per la radio, sì, potrei farti molta roba Da Hemingway, a René Clair, a Salvador Dalì […] Io potrei farti dei bei servizi scritti. vorresti una quindicinale “lettera da Roma”? Potrei metterci dentro tutto (letteratura, cinema, teatro, varietà, in-contri, interviste)». APL, Archivio Felice Filippini, lettera di Giancarlo vigorelli a Felice Filippini, Roma, «La Fiera Letteraria», 18.11.1948.42 APL, Archivio Bixio Candolfi, lettera di Enzo Paci a Bixio Candolfi, 12.7.1953.43 «I temi di lezioni che Ella mi propone per i corsi di cultura […] sono molto attraenti [….], ma il compenso che la R.S.I. è troppo esiguo davvero, ed io non posso accettare». APL, Fondo Bixio Candolfi, Lettera di Pietro Pao lo Trompeo, Biella, 4.9.1954.44 Scrive Giuseppe Ungaretti, chiedendo la cifra del compenso per una conferen-za radiofonica: «In febbraio sarò in Isvizzera per tenere conferenze a zurigo, Lo-
ultima.indd 552 26-10-2010 13:59:23
dal bicchiere d’acqua al microfono 553
venire in Svizzera a far conferenze? Con molto piacere […]. Bisognerebbe che verso luglio qualche svizzero gentile venisse a prendermi con una macchina e poi mi pilotasse attraverso la Svizzera. Si potrebbe combinare anche con l’amico Contini a Friburgo. Se riuscite a farmi un buon programma e ad assicu-rare un viaggio comodo per me e mia moglie, vengo volentieri, molto volentieri 45
I carteggi tra intellettuali italiani e organizzatori radiofo-nici danno atto di questo sistema sempre più consolidato. La conversazione si inserisce dunque appieno nel complesso del-le attività professionali di una parte degli intellettuali italiani, cooptati come specialisti delle diverse discipline. Se l’apporto degli intellettuali alle trasmissioni di attualità culturale è faci-litato dal fatto che la radio non sembra prediligere solo pezzi inediti46, la conversazione mantiene generalmente un aspetto originale e di approfondimento.
Inseriti nella rete di rapporti tessuti dalla fine del conflitto, si susseguono alla radio molti nomi noti della cultura italiana: Giacomo Devoto, Diego valeri, Attilio Nobile ventura, Nino Salvaneschi, Riccardo malipiero, vito Pandolfi, o ancora Ric-cardo Bacchelli, Giansiro Ferrata, vittorio Sereni, Giosuè Bon-fanti e Carlo Bo, veri e propri habitué del mondo culturale can-tonale. L’intento dichiarato è di proporre specialisti per ogni ambito e la lista dei protagonisti delle conferenze radiofoniche negli anni Cinquanta e in parte anche nel decennio successivo conferma la riuscita dell’intento: Carlo Cordiè, mario Praz, Eugenio Garin, Luigi Russo, Guido Calogero, Bruno miglio-rini, Roberto Rebora, Bonaventura Tecchi e i molti altri sono interpellati per la loro specializzazione.
Letterati e docenti universitari rappresentano dunque il nucleo forte degli intellettuali che partecipano alle trasmis-sioni della radio in particolar modo ai Corsi, umanistici e
sanna, Basilea, ecc..». APL, Fondo Bixio Candolfi, lettera di Giuseppe Ungaretti a Bixio Candolfi, Roma, 17.10.1955.45 ASTI, Fondo Piero Bianconi, lettera di Roberto Longhi a Piero Bianconi, 20.4.1947.46 «Noi utilizziamo, di solito, articoli già apparsi, sia pure accomodati e taglia-ti». APL, Archivio Felice Filippini, lettera di Felice Filippini a Piero Cimatti, 30.5.1961.
ultima.indd 553 26-10-2010 13:59:23
554 nelly valsangiacomo
scientifici47: lezioni radiofoniche per una radio che si defi-nisce come Università popolare. In questi anni, una parte preponderante delle trasmissioni del parlato è pertanto man-tenuta da trasmissioni culturali dalla chiara valenza formativa per pubblici diversi. I Corsi perdurano negli anni Sessanta, assumendo la forma di veri e propri cicli di lezioni variabili di numero (da due fin oltre venti) e continuano a essere te-nuti da docenti universitari o letterati, con una prevalenza di italiani nei corsi culturali48; è una chiara simmetria con ciò che accade nell’organizzazione delle conferenze nei circoli di cultura: generalmente sono i centri maggiori a ospitare i più noti conferenzieri italiani.
Per questi protagonisti della cultura italiana, si continua a riprodurre il passaggio scritto-orale-scritto. I testi, verificati dagli organizzatori culturali prima della lettura radiofonica, sono registrati dagli intellettuali stessi o da lettori professio-nisti. In seguito, sono spesso riprodotti nel Radioprogramma o nelle riviste e giornali locali e italiani, o ancora sono pubbli-cati, sia per volontà degli autori stessi sia per iniziativa degli organizzatori radiofonici. Sulla scia delle Edizioni della Radio Italiana, alcune serie di conferenze sono riunite in volume49. Seppure in maniera sporadica, la tradizione della pubblica-zione delle conversazioni radiofoniche non si perde nel corso degli anni50. Questa prassi – che sembra voler rimediare alla
47 L’orientazione del direttore della RSI all’Assemblea generale del 25 marzo 1950, «Radio-programma», 15.4.1950, p. 2. I primi corsi sono creati nel 1946. Nel 1949 sono introdotti i corsi scientifici.48 Nel 1947, Filippini parla di trentaquattro collaboratori ai corsi, di cui gli italiani sono: Giacomo Devoto, Gaetano Salvemini Riccardo malipiero, vito Pandolfi, Giancarlo vigorelli, Ugo della Seta, vittorio Sereni, Aldo Borlenghi, Carlo Bo, Eugenio Gerli, Attilio Nobile ventura. Dallo scandaglio del «Radioprogramma» si evince però una presenza maggiore di conferenzieri italiani. 49 Nel 1955, appaiono le otto lezioni del ciclo Biblioteche di scrittori, curate, tra gli altri, da Riccardo Bacchelli, Aldo Borlenghi, Gabriele Fantuzzi, Cesare Segre e maurizio vitale. La medesima operazione si ripete l’anno seguente con le Celebri polemiche letterarie: anche in questo caso i collaboratori sono grandi nomi della cultura italiana: Eugenio Garin, mario Apollonio, maurizio vitale, Cesare Segre, maria Corti, Luciano Anceschi, Roberto Rebora, Ferruccio Ulivi e altri. Ultima pubblicazione scaturita dai Corsi di cultura Il giornale letterario in Italia, del 1960, vede la partecipazione di Aldo Borlenghi, Adriano Soldini, Bortolo Tommaso Sozzi, Ferruccio Ulivi, Giansiro Ferrata e Pio Fontana.50 Le pubblicazioni facevano (e fanno) generalmente capo agli animatori e pro-duttori radiofonici. Si pensi alle edizioni Pantarei, create da Eros Bellinelli che
ultima.indd 554 26-10-2010 13:59:23
dal bicchiere d’acqua al microfono 555
labilità radiofonica e ci confronta all’i dea della cultura come necessariamente scritta – è aiutata dall’utilizzo di un linguag-gio radiofonico serio, che ancora ricalca lo stile di una lezione. Prevale inoltre l’i dea forte di una netta separazione tra politica e cultura, in una radiofonia, quella elvetica, dove l’informazio-ne e il dibattito politico stentano a farsi largo al microfono.
La radio continua a essere il medium più controllato, in un periodo in cui si sviluppano i giornali di opinione ai quali gli intellettuali partecipano massicciamente. Se il fascismo alle frontiere aveva rafforzato la censura radiofonica preventiva, questa, infatti non scema: dal 1949, i programmi che trattano questioni inerenti all’Europa orientale subiscono la medesima sorte. Particolare attenzione è riservata ai programmi prove-nienti dall’estero e a quelli inviati dai collaboratori stranieri residenti in Svizzera, come pure a tutti i programmi che trat-tano di politica estera. Le rare improvvisazioni al microfono sono attentamente controllate, mentre i dibattiti, le dichiara-zioni, le interviste o le conferenze di collaboratori occasionali devono essere sottoposti alla direzione per l’approvazione dei contenuti. Rassicura Enzo Paci riferendosi a una sua prevista conferenza sull’esistenzialismo in Italia
vittorio [Sereni] mi ha accennato a sue preoccupazioni sulla scel-ta dei filosofi che potrebbero venire ricordati nella conversazio-ne, preoccupazioni inerenti alla mia eventuale posizione politica. Stia tranquillo, io non appartengo a nessun partito, e non sono nemmeno iscritto al Partito di Saragat, per il quale ho votato. Cre-do che oggi gli uomini di cultura abbiano il compito di difendere a qualsiasi costo l’autonomia e la libertà 51
Eppure, ancora una volta, le conversazioni non sono esen-ti da questioni politiche. Oltre alle polemiche regolarmente sollevate dalla stampa su una troppo folta partecipazione di stranieri alla radiofonia è anche la loro supposta colorazione politica, il «color rosso di cui sono tinte tutte le nostre trasmis-
pubblicarono nel 1966 le conversazioni di Luigi Ambrosoli e Ferdinando vegas Il mondo dell’antepace e nel 1982 le cinquanta trasmissioni divulgative Viaggio nella letteratura italiana di Sergio Antonielli, andate in onda nella trasmissione La gio-stra dei libri.51 APL, Fondo Bixio Candolfi, lettera di Enzo Paci a Bixio Candolfi, 14.10.1948.
ultima.indd 555 26-10-2010 13:59:23
556 nelly valsangiacomo
sioni letterarie» 52 a suscitare proteste. Si lamenta in genere una scarsa presenza di intellettuali di matrice cattolica nelle emissioni di carattere letterario, a favore di una cultura laica e progressista e si parla di eccessiva frequenza radiofonica di alcuni intellettuali. Si può senz’altro avvalorare la risposta del-la direzione, che adduce aspetti prettamente economici nel ricorrere frequentemente ad alcuni «nomi di specialisti»53 pa-lesando la strutturazione di una solida, e al contempo poco elastica, rete di rapporti, sovente di amicizia, che non si disco-sta della real tà delle altre radio di servizio pubblico.
All’inizio degli anni Sessanta, il monologo, la conversazio-ne, continua essere un momento significativo della presenza dell’intellettuale alla radio. Sempre più però, tali trasmissioni sono relegate in ambiti (la Seconda rete) e fasce orarie de-stinati a un ascolto di nicchia. Nel frattempo, i programmi culturali aprono a nuovi generi che preannunciano i grandi cambiamenti del periodo successivo.
«A che servirebbe avere un’opinione se non si può esprimerla?»: quando la conversazione incontra l’attualità
Gli anni Sessanta e Settanta sono dunque anni di profondo cambiamento nel genere radiofonico sia per l’arrivo di nuovi media (televisione, radio libere) sia per le innovazioni tecno-logiche (come il transistor o il magnetofono). L’informazione, anche nella reticente radiofonia elvetica, prende il sopravvento dando più visibilità alla professione del giornalista e le trasmis-sioni culturali evolvono verso momenti definibili di cultura in-formativa. Aumentano nettamente le interviste e si sviluppano i “dibattiti”, che permettono ad alcuni intellettuali di ritornare nelle fasce orarie di maggior ascolto. Le trasmissioni culturali troppo dichiaratamente “educative” sono relegate a fasce ora-rie di minore ascolto.
52 Archivi Aziendali Radio e Televisione della Svizzera italiana, Comano (AART-SI), Intervento di Don Franco Leber, verbale dell’assemblea generale della so-cietà cooperativa per la radiodiffusione nella Svizzera italiana del 26 marzo 1960, p. 3.53 AARTSI, verbale dell’assemblea generale della società cooperativa per la radio-diffusione nella Svizzera italiana del 14.3.1959, passim.
ultima.indd 556 26-10-2010 13:59:23
dal bicchiere d’acqua al microfono 557
Eppure, l’intervento individuale, la conversazione perma-ne, a volte inserita nei programmi di attualità e continua a subire un controllo particolare. La corrispondenza intercorsa tra la direzione della Radio e Eros Bellinelli54, Capo del servi-zio “Radio e pubblico” (settore che si occupa delle trasmissioni culturali), a cavallo degli anni Settanta, è significativa di come il monologo dell’intellettuale, ancora una volta, sia il nodo del contendere della volontà della radiofonia di scindere infor-mazione e cultura, come de facto accade a livello di organizza-zione interna. La guerra del vietnam e la presa di posizione nei confronti degli Stati Uniti è il tema che più si presta alle polemiche. Nel 1968 una trasmissione sulla poesia americana contro questa guerra55 è criticata dal direttore per i forti com-menti di accompagnamento (si parla di esercito americano «impegnato in una guerra dichiaratamente imperialista», dei giovani americani che sentono forse per la prima volta «che le strutture stesse della democrazia americana sono poste in questione», di «sporca storia che gli Americani stanno scriven-do in vietnam»). Se Bellinelli insiste sul «lavoro oggettivo e di informazione»56, il direttore, Stelio molo, fa presente che i commenti di natura politica sono «estranei agli intendimenti di una trasmissione culturale» e che «se tutte le opinioni sono legittime, non è meno vero che la Radio non ha nessun obbli-go di farsene portavoce»57.
Si pone qui il problema della definizione di cultura, in par-ticolar modo del suo apporto alla comprensione dell’attualità, al quale la radio deve far fronte; si scontrano, inoltre, due visio-
54 Eros Bellinelli (1920-) Socialista, redattore del giornale «Libera Stampa» (1942-46), cofondatore, segretario e giudice del premio letterario Libera Stampa. Colla-boratore della Radio e Televisione della Svizzera italiana dal 1941. Cofondatore delle edizioni Pantarei nel 1965.55 Si tratta della trasmissione di Guglielmo volonterio La voce della sinistra america-na nella poesia di protesta contro la guerra nel Vietnam, in Bricolla, 23.2.1968. Le poesie sono tratte dalla rivista di cultura contemporanea «marcatré», di Sanguineti, Eco e Pandolfi.56 «[…] la guerra nel vietnam è quella che è. La cultura non può prescindere da questo dato di fatto per essere oggettiva. Non mi risulta d’altra parte, che ci siano poesie che esaltano la guerra dell’esercito statunitense nel vietnam. È con enorme piacere che le diffonderò allorché Johnson le scriverà». AARTSI, Lettera di Eros Bellinelli a Stelio molo, 27.2.1968.57 AARTSI, lettere di Stelio molo a Eros Bellinelli, 27.2.1968 e 28.2.1968.
ultima.indd 557 26-10-2010 13:59:23
558 nelly valsangiacomo
ni del ruolo degli intellettuali alla radio e del ruolo della radio stessa nella società. Tutti, sostiene Bellinelli, devono potersi esprimere sull’attualità, anche gli organizzatori e i collabora-tori della radio
È chiaro che i temi politici non debbano essere approfonditi uni-camente da artisti e letterati. ma non è questo che noi sostenia-mo. Semmai è proprio il contrario e cioè che anche gli artisti e i letterati debbano occuparsi di politica come scienza e prassi per governare e migliorare il vivere e sociale […] non si può colloca-re arte e cultura da una parte e politica dall’altro
L’augurio è che l’intellettuale non abbia delle esternazioni partitiche, ma «prenda coscienza della real tà circostante, delle contingenze storico-sociali in cui vive e opera»58. L’argomento non si esaurisce e ritorna costantemente, anche con l’arrivo di una nuova direzione, a dimostrazione del fatto che la discus-sione travalica le prese di posizione personali ed è intrinseca al cambiamento in atto nella radiofonia. Alcune conversazioni di sintesi e commento all’attualità svolte da Ferdinando vegas, sono ripetutamente contestate, ancora una volta a causa di al-cune prese di posizione contro la guerra del vietnam59. Il tema è delicato: «uno potrebbe approfittare del fatto di essere solo per affermare anche le cose più sballate e poco gli importa se l’ascoltatore scorge nella sua la voce della radio»60. Il monolo-go dunque va sorvegliato attentamente. Bellinelli, però, insi-ste sulla necessità di poter esprimere la propria opinione («a che servirebbe avere un’opinione se non si può esprimerla?»), anche se il regolamento della Radio e televisione è chiaro in proposito61.
58 AARTSI, lettera di Eros Bellinelli a Stelio molo, 27.2.1968.59 Si tratta di L’avventura del mondo: rapporto di gennaio, in Terza pagina, trasmesso alle 22.00 sul secondo programma.60 AARTSI, lettera di Cherubino Darani a Eros Bellinelli, 30.1.1973.61 «Autonomia della SSR in materia di programma non significa assolutamente libertà d’espressione individuale al microfono dei suoi impiegati, giornalisti o collaboratori». SSR, L’autonomia della SSR, la libertà e il controllo dei programmi, p. 4. Risponderà Bellinelli: «E se le direttive fossero sbagliate? O superate? Allora, non sarebbe il caso di riesaminarle? […] e pensi alla noia di una società in cui tutti staranno zitti, perché oggetti, o in cui tutti diranno sì (o no)». Lettera di Eros Bellinelli a Cherubino Darani, 1.2.1973.
ultima.indd 558 26-10-2010 13:59:23
dal bicchiere d’acqua al microfono 559
Se si definiscono gli ambiti in cui esiste teoricamente mag-giore libertà di opinione, ossia l’intervista e il dibattito62, resta comunque l’i dea forte che la radio non debba ignorare «quel-la che è la real tà del suo pubblico: non certo per tema delle reazioni o per mancanza di coraggio, bensì solo per non esse-re – o non sembrare – provocatoria».
La conversazione radiofonica di stampo più culturale con-tinua però a sussistere, anche se nettamente ridotta nei tempi: ne è esempio la richiesta a Franco Fortini da parte della Radio della Svizzera italiana di «preparare 50 conversazioni di ca. 3’ l’una per la rubrica “La Selva letteraria”»63; conversazioni dove peraltro l’aspetto di opinione personale è marcato. La confe-renza più estesa e con accenni più scolastici esce dal medium, non prima però di aver provato l’ebbrezza televisiva, con un certo successo, a dimostrazione del passaggio di ruolo tra i due media.
Dal sapere all’opinione? Alcune considerazioni conclusive
La permanenza della conferenza durante tutto il XX secolo permette di analizzare questa attività nell’ottica di un appor-to allo studio del sistema di organizzazione degli interventi dell’intellettuale nello spazio pubblico e della correlazione tra le pratiche professionali e la funzione (o rappresentazione) sociale dell’intellettuale. Riprendendo il discorso iniziale, lo studio di caso della piccola “industria delle conferenze” della Svizzera italiana permette alcune riflessioni più generali.
Anzitutto, la radio si appoggia su una pratica già esistente e fonda anche sulla presenza degli intellettuali la sua legittimità di mediatrice e produttrice di cultura. Fino agli anni Sessanta, la conferenza (sia pubblica sia radiofonica) è un avvenimento
62 Intervista e dibattito sono termini molto generici che malgrado alcune costanti evidenti, hanno temi e modi di svolgimento diversi. Inoltre, la variabile dell’in-tervistatore (o moderatore radiofonico) ha una grande influenza sui modi e i contenuti dell’intervento dell’intellettuale considerato.63 Cit. nella nota al testo di L. Lenzini, in F. Fortini, Breve secondo Novecento, Editori di comunicazione Lupetti-Piero manni, milano-Lecce, 1998, p. 81. Il libro racco-glie le conversazioni tenute nel 1984 da Fortini alla Radio della Svizzera italiana nell’ambito della rubrica “La Selva lettereraria”.
ultima.indd 559 26-10-2010 13:59:23
560 nelly valsangiacomo
che comprende tre momenti: la presentazione sulla stampa degli autori, la conferenza e, in seguito, il resoconto, se non la pubblicazione dell’intervento. Tale procedura mostra il credi-to sociale detenuto da questa pratica.
S’instaura inoltre una continuità tra le conferenze pubbli-che e le conversazioni. I legami di amicizia e le conoscenze, molto più che le motivazioni di ordine politico o partitico64, inseriscono l’intellettuale in determinate reti culturali istitu-zionali. In questo senso, è interessante rilevare che il bacino al quale la Radio della Svizzera italiana attinge è parzialmente quello dei collaboratori della RAI; lo si constata sia dagli scam-bi di corrispondenza qui velocemente accennati, ma anche da un paragone con le trasmissioni culturali della vicina radiofo-nia. Buona parte dei protagonisti della famosa trasmissione l’Approdo, ad esempio, (Carlo Bo, Nicola Lisi, Riccardo Bac-chelli, Diego valeri, Giuseppe Ungaretti,….) si ritrovano an-che ai microfoni elvetici. Gli uomini di cultura dunque parteci-pano massicciamente alla radio: la conversazione è certamente tra i primi momenti radiofonici che offrono prestigio culturale e autorità intellettuale.
Un secondo aspetto è legato all’oralità che prima della ri-voluzione informatica è, assieme alla stampa, tra i mezzi di espressione più immediati a disposizione dell’intellettuale per esprimere la propria opinione a un pubblico più o meno vasto. La parola è difficilmente censurabile a posteriori. Le conferen-ze e le conversazioni, momenti pubblici formalizzati dell’ora-lità intellettuale, mostrano una serie di strategie di control-lo (anche attraverso l’utilizzo della scrittura), rielaborate ma sempre presenti. Se fino alla seconda metà degli anni Sessanta il controllo preventivo è forte, gli ultimi “interventi censori” qui considerati sono posteriori alla trasmissione e denotano la possibilità di un dibattito tra gli intellettuali radiofonici (pro-duttori, animatori e collaboratori) e l’istituzione. L’evoluzione dei rapporti tra i primi e la seconda non sarà però lineare negli anni successivi.
Sorge dunque una terza considerazione. I circoli culturali e la radio sono istituzioni che hanno legami con lo stato. È un
64 Alla stessa conclusione giunge per il caso francese H. Eck, Média audiovisuels et intellectuels cit., p. 213.
ultima.indd 560 26-10-2010 13:59:23
dal bicchiere d’acqua al microfono 561
elemento possibile di comprensione del tentativo costante di tali istituzioni di separare cultura e politica; gli esempi citati palesano come anche in un paese democratico l’attività pub-blica degli intellettuali dipenda per buona parte dal sostegno concesso dalle istituzioni. Nell’ambito della radio di servizio pubblico, dunque istituzionale, lo sforzo è teso per lungo tem-po a separare lo studioso dal politico, come si separano nella struttura stessa della radio le informazioni dalla cultura. L’ope-razione, lo si è visto, riesce solo parzialmente: talvolta il valore simbolico del conferenziere supera il suo intervento, talaltra l’intervento stesso è recepito (spesso a giusto titolo) come po-litico. È da rilevare però che, nonostante alcune plateali defe-zioni, una parte ragguardevole degli intellettuali, anche negli anni della più forte contestazione della cultura dei media di servizio pubblico, sembra accettare le regole del gioco.
Infine, se la conferenza pubblica e la conferenza radiofoni-ca sembrano, per lungo tempo, simili, nondimeno il supporto è una variabile fondamentale. Già nei primi tempi, alla radio si insiste sull’impostazione della voce e si stabiliscono norme chiare per il discorso radiofonico. Negli anni, si assiste a una frammentazione dell’intellettuale nel flusso radiofonico, a una riduzione della complessità del messaggio e a una diminuzio-ne del tempo (dapprima per le conferenze, ma in seguito per buona parte delle interviste e dei dibattiti). Si può pertanto ipotizzare una forte correlazione tra il supporto, le sue varia-zioni, e la forma e i contenuti dei messaggi veicolati dagli in-tellettuali attraverso il medium radiofonico generalista65. Lo stesso concetto di intellettuale del resto, come dimostrano in maniera più o meno esplicita gli ampi studi in proposito, va affrontato tenendo in considerazione anche queste forme di trasmissione
Ci sono intellettuali di altissimo livello che non sanno parlare in pubblico, s’imbarazzano davanti alla telecamera, non rendono dal punto di vista spettacolare, non fanno immagine: e tutto ciò viene considerato una colpa, o comunque una diminutio. E perché mai? Non so com’era Einstein quando parlava in pubblico, e se
65 Per questo motivo, anche se una storia dei media non può essere fatta prescin-dendo dalla loro interazioni è pur vero che il termine di media audiovisivi, in questo caso come in altri, è forse troppo generico.
ultima.indd 561 26-10-2010 13:59:23
562 nelly valsangiacomo
sapeva volgarizzare la relatività generale. Confesso che neppure m’importa. Resta un grande scienziato al di là delle sue capacità di comunicatore66
Nello studio delle relazioni tra intellettuali e media audio-visivi, forse più che per altre forme dell’industria culturale, la questione è nodale: se gli intellettuali sono «i personaggi a cui l’opinione pubblica attribuisce il ruolo di testimoni e control-lori della società civile»67, la società mediatica recepisce come intellettuale chi deduce la verità da un’approfondita e soprat-tutto onesta analisi dei documenti e poi se ne fa portavoce68, o unicamente chi sa comunicare?
66 E. Garin, Intervista sull’intellettuale, a cura di m. Ajello, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 120.67 A. Abruzzese, Intellettuali e industria culturale, in Il Medioevo italiano. Industria culturale, TV e tecnologie tra XX e XXI secolo, a cura di m. morcellini, Carocci, Roma 2005, p. 122. 68 Ci si riferisce qui alla presentazione del convegno di A. D’Orsi.
ultima.indd 562 26-10-2010 13:59:23
































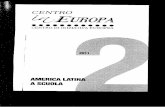

![Popsophia. Teoria e pratica di un nuovo genere filosofico [XVI, 2014 (III)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321b63a050768990e0f84f3/popsophia-teoria-e-pratica-di-un-nuovo-genere-filosofico-xvi-2014-iii.jpg)










