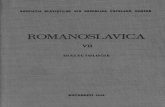L'autunno dello scorpione: la famiglia Annibaldi della Molara in età moderna, "Archivio Storico...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L'autunno dello scorpione: la famiglia Annibaldi della Molara in età moderna, "Archivio Storico...
AlessAndro Cont
l’Autunno dello sCorpione: lA fAmigliA AnnibAldi dellA molArA
in età modernA
f i r e n Z el e o s. o l s C H K i e d i t o r e
mmXiii
segue nella 3a pagina di copertina
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANAPresidente : Giuliano Pinto
Consiglio direttivo :Rosalia Manno, italo MoRetti, Renato Pasta, MauRo Ronzani
ARCHIVIO STORICO ITALIANODirettore : Giuliano Pinto
Comitato di Redazione :MaRio ascheRi, seRGio BeRtelli, eMilio cRistiani, RiccaRdo FuBini,
RichaRd a. Goldthwaite, chRistiane KlaPisch-zuBeR, halina ManiKowsKa, Rosalia Manno, Rita Mazzei, Renato Pasta,GaBRiella Piccinni, MauRo Ronzani, thoMas szaBó, andRea zoRzi
La redazione si avvale della consulenza scientifica di referees esterni
Segreteria di Redazione :loRenzo tanzini, seRGio toGnetti, claudia tRiPodi
Direzione e Redazione: Deputazione di Storia Patria per la ToscanaVia dei Ginori n. 7, 50123 Firenze, tel. 055 213251
www.storia.unifi.it/–pim/asi-dspt
I N D I C E
Anno CLXXI (2013) N. 635 - Disp. I (gennaio-marzo)
Memorie
Amedeo Feniello, Per la storia del commercio mediterraneo del lino. Il caso napoletano (X-XV) . . . . . . . . . pag. 3
Pierluigi licciArdello, Le visite pastorali all’abbazia di Sanse-polcro nel Duecento . . . . . . . . . . . . . » 35
cesArinA cAsAnovA, Medici in provincia: le condotte nel Bolo-gnese tra il dominio francese e l’Unità . . . . . . . » 83
AlessAndro cont, L’autunno dello scorpione: la famiglia Anni-baldi della Molara in età moderna . . . . . . . . » 105
Documenti
Bruno Figliuolo, Sulla costruzione di un ponte in legno nei pressi di Tolmino (1321) . . . . . . . . . . . » 145
Recensioni
BArBArA visentin, La nuova Capua longobarda. Identità etnica e coscienza civica nel Mezzogiorno altomedievale (Fulvio delle donne) . . . . . . . . . . . . . . » 155
Amministrazione Casa editrice leo s. olschki
Casella postale 66, 50123 firenze • Viuzzo del pozzetto 8, 50126 firenze e-mail: [email protected] • Conto corrente postale 12.707.501
tel. (+39) 055.65.30.684 • fax (+39) 055.65.30.214
2013: ABBonAmento AnnuAle - AnnuAl subscription
istituzioni - institutions
la quota per le istituzioni è comprensiva dell’accesso on-line alla rivista.indirizzo ip e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione
dovranno essere inoltrati a [email protected] Subscription rates for institutions includes on-line access to the journal.The IP address and requests for information on the activation procedure
should be sent to [email protected]
italia: € 115,00 • Foreign € 143,00
PrivAti - individuAls
(solo cartaceo - print version only)italia: € 84,00 • Foreign € 113,00
PAolo gABriele noBili, Alle origini della città. Credito, fisco e società nella Bergamo del Duecento (AlmA Poloni) . . pag. 157
BeAtrice del Bo, La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino (giAn PAolo g. schArF) . . . . . » 160
mArco Pellegrini, Religione e Umanesimo nel primo Rinasci-mento da Petrarca a Valla (lorenzo tAnzini) . . . . » 163
donAtA BAttilotti, giAnlucA Belli, Amedeo Belluzzi, Nati sotto Mercurio. Le architetture del mercante nel Rinasci-mento fiorentino (giuliAno Pinto) . . . . . . . . » 166
YAel mAnes, Motherhood and Patriarchal Masculinities in Six-teenth century italian Comedy (FrAncescA FAntAPPié) . . » 169
AnnA mAriA rAo, Lumi Riforme Rivoluzione. Percorsi storio-grafici (rolAndo minuti) . . . . . . . . . . . » 171
simon levis sullAm, L’Apostoli a brandelli. L’eredità di Maz-zini tra Risorgimento e fascismo (michele simonetto) . » 177
Notizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 179
Summaries . . . . . . . . . . . . . . . . . » 201
Alessandro Cont
L’autunno dello scorpione: la famiglia Annibaldi della Molara
in età moderna *
1. Tema per un’indagine. – Il nome degli Annibaldi è solito evocare figure, momenti, atmosfere di storia medievale. La straordinaria importanza che questa famiglia raggiunse nel Lazio del Duecento giustifica la suggestione, poiché proprio nella seconda metà del XIII secolo gli Annibaldi si affermarono come il più influente tra i casati baronali di Roma. In particolare gli studi genealogicoprosopografici di Fedele Savio e Marc Dykmans, i profili biografici di personaggi della casata nel Dizionario biografico degli italiani, le ampie analisi di Sandro Carocci sul ceto dell’alta aristocrazia romana e sul nepotismo papale e cardinalizio tra fine XII e primo XIV secolo, e ancora il più recente volume collettaneo dedicato alla nobiltà romana nel Medioevo ci permettono di delineare sulla carta un impressionante sviluppo dinastico.1
Accanto alle ragioni dell’ascesa, sono emerse con evidenza al
A. ConT è funzionario archivista della Soprintendenza per i Beni storicoartistici, librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento [email protected]
* L’autore ringrazia quanti lo hanno favorito nella ricerca, e precisamente Luciano Borrelli, Tommaso di Carpegna Falconieri, Michele Di Sivo, Isabella Farinelli, Elia Mariano, Elisabetta Mori e Christine Pennison.
1 Cfr. F. Savio, Gli Annibaldi di Roma nel secolo XIII, «Studi e Documenti di Storia e Diritto», XVII, 1896, pp. 355363; Dizionario biografico degli italiani, III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961, pp. 340352; m. dykmanS, D’Innocent III à Boniface VIII. Histoire des Conti et des Annibaldi, «Bulletin de l’Institut historique belge de Rome», XLV, 1975, pp. 2744, 109114 (tav. I); S. CaroCCi, Baroni di Roma. Do-minazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1993, in partic. pp. 311319; id., Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali e famiglie nobili, Roma, Viella, 1999; La nobiltà romana nel Medioevo, a cura dello stesso autore, Roma, École Française de Rome, 2006.
106 Alessandro Cont
cune delle principali cause che, a partire dall’ultimo Duecento, provocarono la decadenza della famiglia. Un primo, notevole fattore di debilitazione fu la pratica, adottata dai nipoti e pronipoti del cardinale Riccardo, di parcellizzare il patrimonio ereditario, disperdendo i beni tra molteplici rami dinastici.2 Si aggiunse il dissolversi dell’appoggio diretto assicurato agli Annibaldi da pontefici ora impegnati nel sostenere le proprie famiglie (Orsini, Caetani, Colonna) e risoluti nel rivendicare la supremazia nell’area laziale. In terzo luogo si è constatata l’assenza, nella sequela delle nuove generazioni di casa Annibaldi, non solo di cardinali e vescovi, ma altresì di condottieri capaci d’imporsi per talenti e autorevolezza sulla scena romana e sovraregionale.3
Gli Annibaldi per conseguenza subirono un progressivo decadimento politico, economico e sociale. Quale maggior titolo di nobiltà la stirpe riuscì a conservare l’appartenenza al patriziato, ossia al ceto di governo della città di Roma. In effetti sullo scorcio del XVI secolo e nel primo Seicento, nell’età del «nepotismo istituzionalizzato», dell’avvento delle nuove stirpi dell’aristocrazia papale (i Boncompagni, i Barberini, i Chigi ecc.), nessuna tra le dominazioni castrensi che avevano annoverato gli Annibaldi nel ceto delle prosapie baronali si trovava ancora nel possesso dei signori di un tempo. Nessuna delle dignità ecclesiastiche, delle cariche di governo e degli uffici di corte a cui aspirarono i membri seisettecenteschi della famiglia, che oramai preferiva il cognome di «Annibali» a quello latineggiante di «Annibaldi», riuscì a riguadagnare le posizioni di grande forza e prestigio ricoperte dai loro avi duecenteschi.4
2 Cfr. CaroCCi, Baroni di Roma cit., pp. 313316.3 Cfr. ibid., p. 44; F. allegrezza, Trasformazioni della nobiltà baronale nel Trecen-
to, in Roma medievale. Aggiornamenti, a cura di P. Delogu, Firenze, All’insegna del giglio, 1998, pp. 211220; v. BeolChini, Tusculum II. Tuscolo, una roccaforte dinastica a controllo della Valle Latina. Fonti storiche e dati archeologici, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2006, pp. 103109.
4 Cfr. g. TomaSSeTTi, La campagna romana antica, medioevale e moderna [19101926], nuova ed. aggiornata a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, Roma, Banco di Roma, 1976, IIIV, passim; m. ToSi, La società romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853), Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1968, pp. 4243, 140; r. J. Ferraro, The nobili-ty of Rome, 1560-1700. A study of its composition, wealth and investment, Ann Arbor (Michigan), UMI, 1994, 2 voll., in partic. pp. 69, 71, 73, 527528, 579, 632, 644645,
107La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
Per un verso è dunque comprensibile l’attenzione assai limitata, quasi assente, che la letteratura scientifica relativa all’età moderna ha riservato a una casata antica e illustre come gli Annibaldi. Certo, notizie su singoli esponenti della schiatta si rintracciano in opere erudite, edizioni di fonti, lavori prosopografici e contributi che hanno dato voce agli stessi personaggi inserendoli in contesti istituzionali e sociali di indubbio fascino: ad esempio quello dei pii sodalizi, quello dei figli spirituali di Filippo Neri, o quello dell’ordinamento militare dello Stato pontificio tra Cinque e Seicento.5 A un esame comparativo, però, colpisce il divario emergente tra le conoscenze acquisite sugli Annibaldi medievali e la modesta disponibilità di informazioni edite concernenti i loro discendenti dei secoli XVI, XVII e XVIII, tenendo conto che la casata si estinse in linea maschile solo nel primo Settecento. Pertanto è palese il fatto che la penuria di risultanze bibliografiche ha contribuito sino ad oggi ad alimentare la scarsa attenzione storiografica verso gli Annibaldi, o Annibali, d’epoca moderna.
Occorre precisare inoltre come l’ottica di uno studio che si confronti con la famiglia Annibaldi tra Cinquecento e Settecento esclusivamente incentrato sulla sua rigorosa successione patrilineare sia riduttiva e in qualche misura deviante. Il dibattito storiografico ha da tempo illuminato l’importanza dei legami di parentela femminili, orizzontali tra fratelli e obliqui tra zii e ni
657660; m. piCCialuTi, L’immortalità dei beni. Fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII, Roma, Viella, 1999, pp. 561; n. la marCa, La nobiltà roma-na e i suoi strumenti di perpetuazione del potere, Roma, Bulzoni, 2000, I, pp. 15165; La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali, a cura di M. A. Visceglia, Roma, Carocci, 2001.
5 Nell’impossibilità di darne un elenco completo, si segnalano alcuni titoli significativi: d. van ameyden, La storia delle famiglie romane, con note ed aggiunte di C. A. Bertini [1910], anastatica, Bologna, Forni, 1979, I, pp. 6669 note, II, pp. 8385; Il primo processo per San Filippo Neri nel Codice Vaticano latino 3798 e in altri esemplari dell’Archivio dell’Oratorio di Roma, edito e annotato da G. Incisa della Rocchetta e N. Vian con la collaborazione di C. Gasbarri, 4 voll., Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 19571963; d. roSSelli, Tra Campidoglio e luoghi pii. Élites romane di età barocca, in Gruppi ed identità sociali nell’Italia di età moderna, a cura di B. Salvemini, Bari, Edipuglia, 1998, p. 185; F. SolinaS, La signora degli Scorpioni. Un inedito di Ottavio Leoni (1578-1630) e qualche ritratto romano del tempo di Caravaggio, in Cara-vaggio nel IV centenario della cappella Contarelli, a cura di C. Volpi, s.l., CAM editrice, 2002, in partic. pp. 255259, 264265; g. Brunelli, Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della Chiesa (1560-1644), Roma, Carocci, 2003, p. 212.
108 Alessandro Cont
poti, potendo questi rivelarsi più forti e socialmente utili di quelli verticali maschili. Per giunta, le relazioni professionali tra singoli personaggi, i vincoli stabiliti individualmente per ragioni di vicinato o per una comune provenienza geografica hanno manifestato in molte congiunture una prevalenza rispetto agli originari legami di consanguineità.
Più generalmente, anche in Italia si assiste, dopo gli slanci dei primi anni ottanta, alla crisi della storia della famiglia intesa come storia delle strutture dei gruppi domestici, delle loro strategie di adeguamento al mutare delle situazioni ‘esterne’ o, ancora, dell’affermazione ‘moderna’, al loro interno, dell’affettività e della soggettività.6
Di siffatte sollecitazioni è debitore il presente contributo, frutto di uno studio che si è posto l’obiettivo di svelare l’ordito e trame di rapporti familiari intessuti tra XVI e XVIII secolo nell’ambito di quei vari rami della casata Annibaldi che nel cognome ricordavano il loro trascorso dominio della Molara e nel contempo si distinguevano dalla linea degli Annibaldi un tempo signori del castello di Zancati presso Paliano.
La stirpe degli Annibaldi della Molara costituisce un interessante campo di studio grazie agli stimoli generati dal suo passato medievale, ben più importante di quello vantato dai lontani cugini Annibaldi di Zancati, ma anche per la scarsità di cognizioni biografiche e genealogiche concernenti i suoi protagonisti e le sue vicende dinastiche nei secoli dell’età moderna.
Si deve deplorare che gli effetti di successioni ereditarie, alienazioni, debiti abbiano disperso od occultato preziose testimonianze archivistiche, quando non siano state intenzionalmente eliminate. Non manca tuttavia una certa quantità di fonti in grado di prestare valido aiuto di supporto documentario. Tra le più rilevan
6 Cfr. Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente, a cura di I. Fazio e D. Lombardi, Roma, Viella, 2006; n. milaniCh, Whither Family History? A Road Map from Latin America, «The American Historical Review», CXII, II, aprile 2007, in partic. pp. 439449; Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna, a cura di R. Ago e B. Borello, Roma, Viella, 2008; i. Fazio, Matrimoni, conflitti, istituzioni giu-diziarie. Le specificità italiane di un percorso di ricerca, «Rivista storica italiana», CXXI, 2009, II, in partic. pp. 639645. Per gli orientamenti tradizionali cfr. Storia della fami-glia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese, a cura di M. Barbagli e D. I. Kertzer [2001], traduzione dall’inglese, RomaBari, Laterza, 2002.
109La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
ti si annoverano i registri della parrocchia dei Santi XII Apostoli presso l’Archivio Storico Diocesano di Roma, e gli atti e memorie dell’archivio Annibaldi del ramo di Zancati custoditi nel fondo Capranica dell’Archivio Storico Capitolino sempre a Roma. Sono meritevoli di nota anche le «provanze» della nobiltà di Bruto della Molara nel fondo dell’Ordine dei cavalieri di Santo Stefano all’Archivio di Stato di Pisa, nonché il testamento di Riccardo, fratello maggiore dello stesso Bruto, conservato tra gli atti dei notai di Veroli nell’Archivio di Stato di Frosinone.
Documenti del genere costituiscono tasselli ragguardevoli per una ricostruzione storica che, nelle pagine che seguono, dovrà inevitabilmente rinunciare alla completezza. Questo contributo sulla famiglia Annibaldi, o Annibali, della Molara in età moderna ha mirato piuttosto concretamente a far dialogare nuove acquisizioni archivistiche con aggiornati schemi d’interpretazione storiografica. In sostanza, il saggio qui offerto rappresenta un bilancio interlocutorio, una tappa lungo un percorso di ricerca scientifica che dischiude opportunità molteplici per future indagini e approfondimenti.
2. memorie di paTrimoni, paTrimoni di memorie. – «Vive ancora in Roma l’antica, e nobil famiglia de gli Annibali romana», esordisce una memoria anonima composta a metà del Seicento.7 Il casato annibaldesco, all’epoca, contava «tre rami quali tutti habitano in Roma»: quello degli Annibaldi dei signori di Zancati e gli altri due degli Annibaldi dei signori della Molara. Ma esisteva altresì un ramo dinastico che sempre nel cognome perpetuava una discendenza in via femminile dagli Annibaldi. Infatti, Clemenza di Mattia Annibaldi della Molara, unica erede della sua linea del casato, aveva sposato sulla metà del Cinquecento il cittadino romano Valerio Valentini.8
Destino speculare a quello dei Valentini della Molara ebbero, sempre negli anni centrali del XVI secolo, gli Arcioni della Mola
7 Cfr. Archivio Storico Capitolino di Roma, Archivio Capranica (d’ora in poi: ASCR, ACa), b. 1362, s.n., c. 1r.
8 Cfr. ASCR, ACa, b. 1360, s.n.; Il primo processo cit., I, p. 7; r. Carloni, Le tom-be degli Annibaldi in una lettera inedita del Seicento (appendice II ad a. m. romanini, Nuove ipotesi su Arnolfo di Cambio), «Arte medievale», I, 1983, p. 220.
110 Alessandro Cont
ra (o Molara Arcioni), uno dei due rami nei quali, come s’è visto, era divisa la generazione maschile degli Annibaldi della Molara. Lontano cugino di Clemenza Annibaldi della Molara – i rispettivi bisnonni erano fratelli – Giovanni Annibaldi della Molara aveva impalmato Vincenza, ultima della stirpe dei patrizi romani Arcioni.9 Il costume che nella Roma cinquesecentesca introdusse e utilizzò l’istituto del fedecommesso, operando all’occorrenza il trasferimento di patrimoni materiali come pure di un cognome e di un blasone da una famiglia in estinzione a un’altra ancora fiorente, non aveva quindi mancato di produrre effetti diffusi anche nel frondoso albero degli Annibaldi.10
Diversa fu la sorte toccata a un altro ramo annibaldesco, gemmato a inizio Cinquecento da un fratello minore (Annibale) del capostipite (Francesco) di quegli Annibaldi che poi si fecero Arcioni della Molara.11 Trascorsero le generazioni, ma il fedecommesso non si impose mai nella progenie di Annibale della Molara.12 Con il suo testamento del 23 gennaio 1689 il vescovo Riccardo della Molara, estremo rappresentante maschio della sua linea dinastica, nominò «erede universale» senza vincoli fedecommissari un nipote: il primogenito della propria sorella minore Vittoria, cioè il canonico della basilica lateranense Antonio Francesco de Grassis.13 Per tramite di questi, la famiglia dei patrizi romani de Grassis (Grassi) subentrò poi nel relativo patrimonio, e con l’andare del tempo la memoria degli antenati annibaldeschi andò scemando.14 Pertanto, dopo che nel 1722 pure i Valentini della Molara si estinsero nei romani Sinibaldi,15 spettò a Lorenzo Serlupi
9 Cfr. ameyden, La storia cit., I, pp. 7475; ToSi, La società romana cit., p. 41 nota; Carloni, Le tombe cit., p. 220.
10 Cfr. piCCialuTi, L’immortalità cit.; la marCa, La nobiltà romana cit.11 Cfr. Carloni, Le tombe cit., p. 220.12 Cfr. i testamenti di Tebaldo (1550) e Riccardo (1689) rispettivamente in ASCR,
ACa, b. 1361, n. 109; Archivio di Stato di Frosinone, Archivi notarili (d’ora in poi: ASFr, AN), Giuseppe Iaboni di Veroli, 23 gennaio 1689.
13 Cfr. ASFr, AN, Giuseppe Iaboni di Veroli, 23 gennaio 1689, c. 57v.14 Cfr. Archivio Storico del Vicariato di Roma (d’ora in poi: ASVR), Parrocchia
dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16941699, c. 9v (a. 1694).15 Il canonico Fabrizio e il marchese Cesare Sinibaldi erano figli di Giulio e di Lu
crezia Valentini della Molara, sorella di quel Prospero che il 19 settembre 1722 pose termine alla successione maschile della sua famiglia. Cfr. v. ForCella, Iscrizioni delle
111La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
la responsabilità di eternare il ricordo di casa Molara, in cui aveva visto la luce la sua consorte. Sposata infatti Cleria di Giovanni Arcioni della Molara, nel 1725, Serlupi prese il cognome Molara, che ancor oggi è tramandato dai discendenti ed eredi di una sua pronipote, la marchesa Isabella Caucci Molara (17911845).16
La famiglia Annibaldi della Molara fornì quindi prove significanti in merito all’efficacia delle norme fedecommissarie ai fini della perpetuazione di una specifica memoria familiare, associata al prestigio dinastico. Si può osservare che la trasmissione del cognome e dei titoli per via obliqua costituiva una sorta di espediente necessario nell’ottica di una concezione patrilineare del casato. Il ricorso al ‘vettore’ femminile (Costanza e Cleria per i Molara, Vincenza per gli Arcioni) va inteso come rimedio che suppliva alla ‘detestabile’ mancanza dell’atteso figlio maschio. Le surrogazioni ereditarie dei Ludovisi, dei Pamphilj, o ancor più degli Aldobrandini, sono esempi rilevanti, ma tutt’altro che rari nella Roma dell’età moderna, dove tra Cinque e Seicento il fedecommesso istituito per via testamentaria fu adottato quale tipica forma di trasmissione dei patrimoni nobiliari, affiancandosi ai giuspatronati gentilizi su chiese o cappelle nel favorirne la tutela in forza del vincolo d’inalienabilità dei beni.17
3. di padre in Figlio: l’avara ForTuna del ramo di anniBale della molara. – L’adozione del fedecommesso, nelle sue forme di primogenitura, maggiorascato o seniorato, si sarebbe dunque potuto giustificare con l’esigenza di salvaguardare, di vincolare, una base patrimoniale già modesta, inibendo ulteriori alienazioni e divisioni.18 Ciò malgrado, il fedecommesso non incontrò mai
chiese e d’altri edificii di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, I, Roma, Tip. delle Scienze Matematiche e Fisiche, 1869, p. 261 n. 989; VIII, Roma, Ludovico Cecchini, 1876 p. 78 n. 212; Mostre di quadri a S. Salvatore in Lauro (1682-1725). Stime di colle-zioni romane. Note e appunti di Giuseppe Ghezzi, a cura di G. De Marchi, Roma, Societa alla Biblioteca Vallicelliana, 1987, p. 105 nota. Per la data di morte di Prospero Valentini della Molara cfr. C. maSSimo, Memorie storiche della chiesa di S. Benedetto in Piscinula nel rione Trastevere, Roma, Tip. Salviucci, 1864, p. 135.
16 Cfr. C. WeBer, con la collaborazione di M. Brecker, Genealogien zur Papstge-schichte, II, Stuttgart, Hiersemann, 1999, p. 868.
17 Cfr. la marCa, La nobiltà romana cit., pp. 2829, 5055, 95.18 Cfr. ibid., p. 22.
112 Alessandro Cont
un terreno adeguato di sviluppo nel ramo dinastico germogliato a inizio del XVI secolo con Annibale della Molara, figlio di Giovanni e di Aurelia de’ Bossi.
Questa progenie dovette dibattersi in ricorrenti ristrettezze finanziarie. Già nelle sue disposizioni testamentarie del 1550 Tebaldo della Molara, figlio di Annibale, rimarcava l’angustia delle proprie risorse, «et se lui havesse facultà assai non mancheria dargli [alla moglie] molto più di quello havessi da havere».19 Nell’ultimo quarto di quel secolo, il figlio Gaspare vendette gli esigui diritti che ancora godeva sulla tenuta e sul castello diroccato della Molara.20 Il nipote Bruto, figlio di un altro Tebaldo, spirando nel 1685, lasciò pochi beni e insufficienti, secondo l’ipotesi di un nobile romano, a onorare «i debbiti, che haveva».21 E, ancora, il testamento di Riccardo, fratello più anziano di questo Bruto, non risalta certo per magnificenza e liberalità nei legati in temporali-bus a favore di parenti e servitori.22
Lo status patrimoniale goduto dagli altri rami della discendenza Annibaldi non appare più brillante. Francesco Valentini della Molara, deponendo nel terzo processo per la beatificazione di Filippo Neri (1610), suo amico e direttore spirituale, dipingeva sé stesso come «un povero gentilhuomo in respetto della famiglia, ma vivo della mia entrata».23 Invece la memoria storica già citata in esordio, reperita tra le carte secentesche di Giuseppe Annibaldi di Zancati, evidenzia come la famiglia sopravvivesse ormai «in poca fortuna, rispetto alla grandezza, in che ella si vidde ne’ tempi passati, qual’era connumerata fra più potenti, e principali baroni di Roma».24
In realtà, le cause che nello specifico perpetuarono la debolezza
19 ASCR, ACa, b. 1361, n. 109.20 Cfr. TomaSSeTTi, La campagna romana cit., IV, p. 528.21 Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Scolastica di Subiaco, Archi
vio Colonna (d’ora in poi: BSS, ACo), Carteggio di Lorenzo Onofrio Colonna, fasc. 8, Marcantonio Colonna da Milano, 17 ottobre 1685.
22 Cfr. ASFr, AN, Giuseppe Iaboni di Veroli, 23 gennaio 1689. Per utili raffronti con altri testamenti di nobili romani d’epoca barocca cfr. piCCialuTi, L’immortali-tà cit., pp. 157163.
23 Cfr. Il primo processo cit., IV, p. 27 (23 agosto 1610).24 ASCR, ACa, b. 1362, s.n., c. 1r.
113La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
degli Annibaldi del ramo di Annibale furono plurime e sedimentate nel corso di lustri, di decenni. Innanzitutto si deve osservare che Annibale stesso scomparve troppo presto per consolidare un suo ruolo di rilievo nella società romana del tempo. Quando rimase ucciso in una rissa scoppiata vicino alla basilica di San Sebastiano fuori le mura, nel 1517, contava appena ventidue anni.25 Ancor più devastante negli effetti fu la disgrazia nella quale il figlio ed erede Tebaldo precipitò agli occhi del pontefice: la pena capitale cui fu condannato per motivi oggi oscuri, ed eseguita il 21 settembre 1550, inflisse alla sua famiglia un marchio di disonore che stentò ad attenuarsi e dissolversi.26
La docilità e l’eccezionale longevità dell’unico erede maschio della famiglia, Gaspare della Molara, figlio di Tebaldo, favorirono a poco a poco la ripresa e il consolidamento, senza comunque che gli orizzonti di questo patrizio si proiettassero molto oltre le mura della sua città. Qui egli fu eletto più volte all’ufficio di conservatore della camera capitolina. Sempre a Roma spirò quasi ottantanovenne, l’8 gennaio 1632.27 Analogo cammino, del resto, avevano intrapreso gli Annibaldi di Zancati, che dall’ostilità di Alessandro VI «per li loro eccessi commessi in Roma, e nelli loro castelli» erano pervenuti, in grazia del perdono papale, a un accomodamento, siglato nel 1555, con i loro nemici Colonna di Paliano.28
Tuttavia gli Annibaldi del ramo di Annibale seppero conquistarsi una preminenza sulle altre linee del casato annibaldesco
25 Nel combattimento perì anche il fratello Cesare, di diciotto anni: era il 31 di maggio. Cfr. SeBaSTiano di B. Tedallini, [Diario romano. Dal 3 maggio 1485 al 6 giu-gno 1524], edizione a cura di P. Piccolomini, in Rerum Italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da L. A. Muratori, nuova edizione riveduta, ampliata e corretta, con la direzione di G. Carducci e V. Fiorini, XXIII, III, V, Città di Castello, S. Lapi, 1911, p. 374.
26 Cfr. Archivio di Stato di Torino, Raccolta Mongardino, vol. 78, C. Colleine, [Diario] [15211561], copia del sec. XVII, c. 58r; ameyden, La storia cit., II, p. 84.
27 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Morti 16311661, c. 6r ; Stati delle anime 15981620, c. 71v (a. 1600); Archivio di Stato di Pisa, Ordine dei cavalieri di S. Stefano (d’ora in poi: ASP, OC), filza 149, ins. 20, fasc. Processo fabbricato in Roma …, attestato dello scriba del senato romano e altro dei conservatori della camera capitolina, 7 marzo 1657 (in copia) e 18 febbraio 1664; giaComo pieTramellara, Il libro d’oro del Campidoglio [18931897], anastatica, Bologna, Forni, 1973, II, pp. 201203.
28 Cfr. ASCR, ACa, b. 1362, s.n., cc. 3v7, 1314r.
114 Alessandro Cont
che derivò soprattutto dalle opportunità di carriera nella Chiesa e nell’esercito. Tra i quattro figli maschi di Gaspare, infatti, Orazio, già canonico di Santa Maria in Trastevere, riuscì a ottenere nel 1630, a quarantaquattro anni d’età, il pallio arcivescovile di Manfredonia.29 Per conto suo, il fratello più anziano Tebaldo seguì le orme di tanti aristocratici secolari dell’epoca, tra i quali in particolare lo zio materno Giovanni Battista Gottifredi, e compì la sua immediata esperienza militare alla «scuola» di Fiandra.30 Poi, approfittando dell’avvenuto ristabilimento delle milizie nello Stato della Chiesa, si inserì in questa istituzione territoriale per divenire mastro di campo della provincia di Romagna, sergente maggiore a Jesi e, infine, mastro di campo della provincia d’Umbria.31
L’improvviso decesso del sessantaquattrenne Tebaldo, stroncato «d’un accidente» a Perugia nel 1642, e la scomparsa di poco posteriore, nel 1643, dell’arcivescovo Orazio non eliminarono del tutto i vantaggi accumulati. Eppure le possibilità di ascesa per i congiunti dei due fratelli patirono senz’altro un rallentamento.32 Né i sette figli di Tebaldo sopravvissuti all’infanzia furono in grado di incrementare in modo costante le fortune familiari, malgrado gli sforzi di autopromozione personale e dinastica attuati soprattutto da Riccardo e da Bruto. Di questi ultimi, Riccardo (1631 circa 1689) servì il papa a capo di più governatorati nelle città dello Stato ecclesiastico finché nel 1675 divenne vescovo di Veroli. Per parte sua, Bruto (16391685), dopo un periodo tra
29 Cfr. Hierarchia catholica medii et recentioris ævi, IV (15921667), a cura di P. Gauchat, Monasterii, Regensberg, 1935, p. 316. Era nato il 27 settembre 1685, e battezzato il 4 del mese seguente. Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Battesimi 15841595, c. 11v.
30 Cfr. m. giuSTiniani, De’ vescovi e de’ governatori di Tivoli libri due, Roma, F. M. Mancini, 1665, p. 232.
31 Cfr. BSS, ACo, Carteggio di Girolamo I Colonna, n. 95.1, Tebaldo della Molara da Jesi, 6 gennaio 1631; v. ForCella, Catalogo dei manoscritti riguardanti la storia di Roma che si conservano nella Biblioteca Vaticana, Torino ecc., Bocca, 1881, p. 138; g. Brunelli, «Prima maestro, che scolare». Nobiltà romana e carriere militari nel Cin-que e Seicento, in La nobiltà romana in età moderna cit., p. 106; id., Soldati del papa cit., pp. 212, 279.
32 Cfr. Archivio di Stato di Perugia, Archivio Storico del Comune di Perugia, Registri Parrocchiali, n. 304, Morti della parrocchia di S. Fiorenzo 15881694, c. 91r (4 novembre 1642); Hierarchia catholica cit., IV, p. 316 nota. Tebaldo era nato il 29 ottobre 1578. Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Battesimi 15721583, c. 38r.
115La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
scorso serenamente alla corte del granduca di Toscana, dovette affrontare un’esistenza amara trascorsa in Umbria, a Roma e nello Stato di Milano.33
I rapporti tra i fratelli Riccardo e Bruto della Molara furono segnati da contrasti riguardo alla gestione del patrimonio comune come nella concezione di strategie funzionali all’ascesa del casato, conflittualità che si possono meglio interpretare alla luce del dibattito storiografico dell’ultimo ventennio sulla compattezza degli aggregati familiari in età moderna e presso la nobiltà della Roma barocca. Ricerche recenti, infatti, hanno messo in discussione questa coesione anche sulla base delle prove documentarie emerse riguardo all’esistenza di stati di tensione e di reali spazi d’autonomia psicologica, sentimentale, comportamentale vissuti da consorti, figli o fratelli al di là di una teorica potestà paterna e degli imperativi strategici di un comune gioco di squadra coinvolgente i vari componenti della «casa».34
4. non Solo primogeniTi, né Solo maSChi. – Dal punto di vista del patrilineaggio, i risultati del ramo di Annibale furono in definitiva deludenti. Eppure, due problemi sollevati da tempo nel dibattito storiografico sulla nobiltà romana d’epoca moderna inducono a intendere più articolatamente le logiche patrimoniali di casa Annibaldi della Molara. Approfondite, tali questioni obbligano a discostarsi da una visione meramente verticale della famiglia, che sottostima personalità e apporti culturali ‘eccentrici’ rispetto alla concezione di una dinamica successoria che procede di padre in erede maschio.
33 Cfr. a. ConT, Riccardo e Bruto Annibaldi della Molara: professioni, strategie, af-fetti nella nobiltà romana del Seicento, «Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica», 2011, II, pp. 231259.
34 Cfr. i. Fazio e d. lomBardi, Introduzione, in Generazioni cit., pp. 2226; r. ago e B. Borello, Introduzione, in Famiglie cit., pp. 1012, 1617; d. lomBardi, Donne, famiglia e genere, in Spagna e Italia in Età moderna. Storiografie a confronto, a cura di F. Chacón et alii, Roma, Viella, 2009, pp. 7584; Fazio, Matrimoni cit. Sull’argomento delle «strategie familiari» cfr. l. FerranTe, Strutture o strategie? Discussione sulla storia della famiglia, «Quaderni storici», nuova serie, LVI, agosto 1984, in partic. pp. 619623; r. ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, RomaBari, Laterza, 1990, in partic. pp. 3242; id., Giochi di squadra. Uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo, in Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell’Età moderna, a cura di M. A. Visceglia, RomaBari, Laterza, 1992, pp. 256264.
116 Alessandro Cont
Il primo problema riguarda l’adozione del fedecommesso, già accennata, da parte dei testatori romani del periodo barocco. Riccardo della Molara, al momento di sottoscrivere le sue ultime volontà nel gennaio 1689, contava su di una formazione giuridica e politicoamministrativa sviluppata attraverso il «giro de’ governi» nello Stato pontificio e l’attività pastorale al vertice della diocesi di Veroli.35 Uno spirito forgiato alla prudenza e alla mediazione, esplicitamente richiesto dalla corte papale nei governatori dello Stato ecclesiastico, potrebbero avere influito sulla rinuncia del quasi sessantenne vescovo di Veroli a regolamentare nei minuti dettagli la successione ereditaria della propria famiglia per i secoli e i millenni futuri.36
Se così fu, il disinteresse di Riccardo Annibaldi della Molara verso i fedecommessi non rappresentò unicamente l’approdo definitivo di un fallimento dinastico e politicoeconomico. Riccardo concesse al nipote Antonio Francesco de Grassis ampia discrezionalità nella disponibilità di un patrimonio relativamente esiguo, non prestabilendo alcuna modalità di passaggio ulteriore dei beni e solo riservandone l’usufrutto «vita durante» al suo primo cugino, celibe, Giuseppe della Molara.37
Forse in questo operare si cela almeno un indizio di un più generale mutamento di mentalità, già rilevato in sede storiografica. Tale evoluzione, come è stato osservato, portò i fedecommessi a rarefarsi nella Roma settecentesca, per cedere più respiro allo spirito di iniziativa economicofinanziaria e alla dimensione affettiva dei singoli individui.38 Né si deve trascurare il fatto che Riccardo Annibaldi esercitò la sua missione episcopale sotto l’austero
35 Per la citazione cfr. Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo del Principato, fasc. 5544, n. 688, Bruto della Molara a Leopoldo de’ Medici, Foligno 5 agosto 1670.
36 Sulla natura di questi condizionamenti cfr. a. menniTi ippoliTo, Il tramonto del-la Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo [1999], Roma, Viella, 2008, pp. 139145; i. FoSi, Il governo della giustizia nello Stato ecclesiastico fra centro e periferia, in Offices et papauté (XIV e-XVII e siècle). Charges, hommes, destins, a cura di A. Jamme e O. Poncet, Rome, École Française de Rome, 2005, pp. 216221; id., La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna, RomaBari, Laterza, 2007, pp. 158161.
37 Cfr. ASFr, AN, Giuseppe Iaboni di Veroli, 23 gennaio 1689, c. 51v.38 Cfr. piCCialuTi, L’immortalità cit., pp. 275277.
117La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
regno di Innocenzo XI (16761689), il primo papa marcatamente antinepotista.39 Non è escluso che il carisma e lo stile di questo pontefice, fautore di una riforma moralizzatrice e pastorale nella Chiesa dei vescovi, oggi conosciuta col nome di «svolta innocenziana», abbia lasciato un timido segno anche nelle ultime volontà del presule Molara.40
Complementare a quello relativo all’utilizzo di prassi fedecommissarie, si delinea un secondo problema storiografico, che interessa la posizione sociale della donna aristocratica nell’Urbe barocca. Come hanno dimostrato ricerche accurate, le dame della città pontificia in epoca moderna usufruirono di molteplici opportunità per imporre la loro voce in un sistema di rapporti soprattutto familiari, contrastando ostracismi culturali fondati sulle differenze di genere e convertendo sovente a proprio utile la restrittiva legislazione in vigore.41 Assai sentite tra le nobili romane furono in particolare l’urgenza di contrastare soprusi nel trattamento dei loro figli da parte del capofamiglia, nonché una volontà attiva nel ricomporre eventuali dissidi insorti tra gli stessi.42 È lecito supporre che sulla relativa libertà esercitata dai tre maschi di Tebaldo della Molara e Giulia Rasponi, cioè Riccardo, Gaspare e Bruto – Annibale si spense prematuramente – abbia influito il regime di tutela e curatela materna a cui tutti loro sembra siano andati soggetti dopo la scomparsa del padre.43
Definire le dame di casa Molara semplici strumenti per la tra
39 Sulla posizione di Innocenzo XI rispetto al nepotismo cfr. menniTi ippoliTo, Il tramonto cit.
40 Per il governo di Riccardo a capo della diocesi di Veroli cfr. ConT, Riccardo e Bruto Annibaldi della Molara cit., pp. 241242.
41 Cfr. ago, Carriere cit., in partic. pp. 6071; m. d’amelia, Nepotismo al femmi-nile. Il caso di Olimpia Maidalchini Pamphilj, in La nobiltà romana in età moderna cit., pp. 353399; B. Borello, Trame sovrapposte. La socialità aristocratica e le reti di relazio-ni femminili a Roma (XVII-XVIII secolo), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, in partic. pp. 115228; S. FeCi, Pesci fuor d’acqua. Donne a Roma in età moderna. Di-ritti e patrimoni, Roma, Viella, 2004; I linguaggi del potere nell’età barocca, a cura di F. Cantù, II: Donne e sfera pubblica, Roma, Viella, 2009.
42 Cfr. r. ago, Giovani nobili nell’età dell’assolutismo. Autoritarismo paterno e li-bertà, in Storia dei giovani, I, a cura di G. Levi e J.C. Schmitt, RomaBari, Laterza, 1994, pp. 412415; Borello, Trame sovrapposte cit., pp. 122127.
43 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16381651, cc. 106v, 121r, 133r, 149r, 166r, 183r, 200r, 218r; Stati delle anime 16521667, cc. 5r, 55v, 66r.
118 Alessandro Cont
smissione di beni materiali, di un cognome e di un blasone condurrebbe a una sottovalutazione del ruolo che alcune di loro seppero conquistare nella quotidianità domestica. Considerevole fu infatti il credito che, nel secolo XVI, Francesca di Mariano de’ Dossi della Palma godette presso il suo sventurato figlio Tebaldo della Molara. Questi il 20 settembre 1550, nella notte precedente la sua decapitazione, ne implorò il perdono «se mai havesse fatta cosa gli fussi dispiaciuta», la pregò di continuare a sostenere la famiglia con «la roba sua» affinché non cadesse in rovina, e la elesse tutrice e curatrice dei nipoti «per haver fede» in lei.44
All’incirca un secolo più tardi, dopo il decesso di un altro Tebaldo della Molara e dei fratelli di costui Pietro Paolo, Orazio e Mario, fu Giulia Rasponi, vedova di questo stesso Tebaldo, a rimanere la primaria custode delle memorie della famiglia del marito, durante la crescita dei suoi tre maschi e delle sue quattro femmine.45 Venivano così tramandate nel tempo le vicende dinastiche che la giovane Giulia, d’origine ravennate, aveva appreso ascoltando i racconti del consorte e dei cognati, e scrutando le testimonianze iconografiche sedimentate nella loro dimora romana.46
5. TopograFie di parenTadi. – Mediante il matrimonio, è ben noto, si sosteneva il proprio status sociale oppure si promuoveva la propria ascesa grazie al peso che il parentado acquisito era in grado di far valere nella vita politica ed economica di una città, di una provincia, di uno Stato. In tale prospettiva, l’apporto delle donne accolte in casa Molara e delle rispettive famiglie d’origine si rivelava a volte decisivo nel condizionare il destino sociale della dinastia di cui quelle dame entrarono a far parte.
Se nel XVI secolo il contributo materiale di una Francesca della Palma arrestò il tracollo economico degli Annibaldi del ramo
44 Cfr. ASCR, ACa, b. 1361, n. 109. Per la morte di Tebaldo cfr. inoltre B. Ca-pogroSSi guarna, Notizie storiche della famiglia Tebaldi, «Il Buonarroti», s. III, IV, I, 1890, p. 33; a. SaTTin, Il diario romano di Cola Colleine (1521-1561). Appunti e spi-golature, in Studi linguistici per Luca Serianni, a cura di V. Della Valle e P. Trifone, Roma, Salerno, 2007, p. 22 nota.
45 Mario si spense a Roma il 17 maggio 1643. Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Morti 16311661, c. 71r.
46 Cfr. SolinaS, La signora cit., p. 256.
119La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
di Annibale, le nozze del pronipote Tebaldo con Giulia dei conti Rasponi, benedette nel 1618, intrecciarono le sorti dei Molara con quelle di una tra le più illustri e facoltose casate della periferia pontificia.47 Per quanto li riguardava, i Rasponi, patrizi di Ravenna, dovettero accettare con favore l’unione del loro sangue con quello di una famiglia che non soltanto vantava un’antica nobiltà, ma che all’epoca stava riacquistando maggior prestigio grazie al comando conferito a Tebaldo sulle milizie papali di Romagna.
Tra il secondo Cinquecento e il primo Seicento, le distinte linee dei Rasponi rinnegarono progressivamente il loro passato di ribellismo, banditismo e violenza efferata che tanto aveva scosso i primi decenni di dominio pontificio diretto su Ravenna e il suo territorio.48 Dunque l’accasamento di Giulia del conte Bruto Rasponi con il mastro di campo della Romagna Tebaldo della Molara si inseriva felicemente nel clima di distensione e stabilità che improntava ormai le relazioni tra uno dei principali casati ravennati e la Santa Sede di Roma. «E tu campion beato/non hai, non hai rapito?», chiedeva verseggiando il capitano Marco Petrocini al valoroso Tebaldo, rapitore della vezzosa Giulia, «poiché sì ricca stella al Ciel togliesti»? 49
In quale misura un matrimonio potesse glorificare una casata è palesato dalle pagine di uno scritto di storia annibaldesca che Giuseppe Annibaldi di Zancati commissionò a metà Seicento. «Li parentati l’Annibali l’hanno continuati con le prime fameglie di
47 Cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20, attestato dei savi ad utilia della città di Ravenna, 9 aprile 1658 (in copia); ivi, fasc. Pro illustrissimo domino Brutto […] super pro-batione nobilitatis illustrissime domine Iulie Raspone Ravennatis eius matris, cc. 7, 9, 1112r (7 e 20 maggio 1661). Per la data del matrimonio cfr. m. peTroCini, La rapi-na, nella raccolta dello stesso autore Le pompe d’imeneo, Ravenna, Pietro de’ Paoli e Giovanni Battista Giovannelli, 1618, pp. 7581; da cui g. BoSi maramoTTi, Le muse d’imeneo. Metamorfosi letteraria dei libretti per nozze dal ’500 al ’900 [1995], seconda edizione ampliata, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1996, pp. 150151. La collocazione di Giulia nella genealogia Rasponi è indicata in http://www.genmarenostrum.com/paginelettere/letterar/rasponi.htm.
48 Cfr. C. CaSanova, Potere delle grandi famiglie e forme di governo, in Storia di Ravenna, IV: Dalla dominazione veneziana alla conquista francese, a cura di L. Gambi, Ravenna, Comune di Ravenna, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 3947, 84118; id., Gentil-huomini ecclesiastici. Ceti e mobilità sociale nelle Legazioni pontificie (secc. XVI-XVIII), Bologna, CLUEB, 1999, pp. 2945; Brunelli, Soldati del papa cit., p. 72.
49 peTroCini, La rapina cit., p. 80.
120 Alessandro Cont
Roma», e a questa asserzione l’anonimo estensore faceva seguire una lista che sciorinava nomi altisonanti del baronato romano, dai Savelli ai Colonna, dagli Orsini ai Capocci, dai Conti ai Caetani.50 Assai saldo emergeva il nesso tra tali unioni e le lotte violente che, rappresentate nella stessa scrittura con toni compiaciuti, vedevano gli Annibaldi medievali tenere testa ad alcune di quelle stesse famiglie, perché «non furno l’inimicitie degli Annibali solo con l’Orsini e Colonnesi, ma anco con li Savelli».51 L’uno e l’altro aspetto erano le due facce di un’unica medaglia, che restituiva l’immagine di un casato, gli Annibaldi, assurto ai vertici dell’aristocrazia romana e quindi divenuto partecipe a pieno titolo delle dialettiche interne di questo ceto elitario.
Né può sfuggire, tuttavia, come l’elencazione di matrimoni eccellenti si arrestasse con il secolo XV, comprovando così implicitamente la decadenza politicosociale intervenuta nella famiglia Annibaldi tra medioevo ed epoca moderna. Una prosapia così importante quale quella dei Colonna di Paliano nel secolo XVII, che figurava tra le maggiori dello Stato pontificio, non poteva assolutamente definirsi alleata o antagonista dei Molara, secondo logiche di fazione pur aggiornate nel contesto della Roma barocca. Tra il XIII e il XV secolo entrambe le stirpi avevano fatto parte del medesimo ceto sociale, cioè del baronaggio romano. Con il declassamento della casa Annibaldi, i Colonna avevano assunto una funzione semitutelare nei confronti dei Molara del ramo di Annibale, mai scontata e sempre soggetta a un corrispettivo di lealtà e servizio.
E che tale funzione ricoprisse notevole importanza per le fortune e le carriere dei membri di casa Molara della linea di Annibale lo si può meglio comprendere rapportandosi ai risultati ottenuti negli ultimi decenni dagli studi sulla dialettica tra tattiche clientelari ed etica d’ufficio nella Roma e nello Stato pontificio del Seicento. A questo proposito è significativo constatare come Giuseppe Tabacchi, che pure contesta la teoria di una prevalenza qualitativa pressoché assoluta delle fedeltà personali nell’apparato pontificio quale viene invece sostenuta da Wolfgang Reinhard, ri
50 Cfr. ASCR, ACa, b. 1362, s.n., cc. 14v15.51 Ibid., c. 2v. Da qui, SolinaS, La signora cit., p. 255.
121La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
conosca la coesistenza di un servizio al sovrano e di logiche clien-telari che fra tardo Cinquecento e metà Seicento avrebbero esercitato un ruolo considerevole di corresponsabilità nel condizionare le progressioni di carriera negli ambiti del governo papale.52 In seguito, sostiene Tabacchi, l’ideale di servizio al principe e di bene pubblico avrebbe preso il sopravvento, quale criterio selettivo, su nepotismo e clientelismo, rivelatisi sempre meno idonei a garantire un’efficace amministrazione dello Stato.53
Di fatto patroni e fautori sono rilevanti negli epistolari annibaldeschi specialmente, ma non esclusivamente, in presenza di qualche sollecitazione ed esigenza di avanzamento di carriera. Riportare una grazia per sé o per un proprio «affettionato», ovvero agevolare le procedure attinenti all’esercizio dei propri compiti istituzionali (ad esempio quelli episcopali di Riccardo della Molara a Veroli) non erano ambizioni velleitarie se si poteva contare sul supporto di un personaggio influente presso le autorità superiori e presso quelle sovrane.54
Nei confronti dei connestabili e dei cardinali Colonna di Paliano, loro «sostegnio» e «refugio», i Molara secenteschi della linea di Annibale figuravano dunque come clienti, servitori per bisogno e per gratitudine.55 Di conseguenza, era divenuto impensabile anche istituire un vincolo di sangue tra le due casate, come invece si era verificato nel lontano Medioevo. E così nel secolo XVII, mentre i Colonna di Paliano potevano stipulare contratti matrimoniali con schiatte prestigiose e potenti quali i Branciforte, i Gioeni, i Conti
52 Cfr. S. TaBaCChi, L’amministrazione temporale pontificia tra servizio al papa ed interessi privati (XVI-XVII), in Offices, écrit et papauté (XIIIe-XVIIe siècle), a cura di A. Jamme e O. Poncet, Roma, École Française de Rome, 2007, pp. 569599. Per il pensiero di Reinhard cfr. i suoi interventi Papal Power and Family Strategy in the Six-teenth and Seventeenth Centuries, in Princes, Patronage, and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age. C. 1450-1650, a cura di R. G. Asch e A. M. Birke, London, The German historical institute, Oxford, Oxford University Press, 1991, pp. 329356; Amici e creature. Micropolitica della curia romana nel XVII secolo, in Amici, creature, parenti. La corte romana osservata da storici tedeschi, a cura di I. Fosi, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2001, II, pp. 5978.
53 Cfr. TaBaCChi, L’amministrazione cit., pp. 598599.54 Per la parola citata cfr. BSS, ACo, Carteggio di Lorenzo Onofrio Colonna, fasc.
89, Riccardo della Molara da Monte San Giovanni, 23 agosto 1660.55 Cfr. BSS, ACo, Carteggio di Girolamo I Colonna, n. 460, Tebaldo della Mola
ra da Perugia, 19 aprile 1639.
122 Alessandro Cont
o i de la Cerda, gli orizzonti nuziali degli Annibaldi della Molara soggiacevano a pretese decisamente meno ambiziose.
Per i matrimoni delle figlie di Tebaldo e Giulia Rasponi fu quindi essenziale acconciarsi a soluzioni relativamente modeste, pur convenienti a una famiglia dell’aristocrazia municipale dell’Urbe. Poco prima della morte dello stesso Tebaldo, nell’aprile 1642, tramontarono i progetti per le nozze di Olimpia della Molara con il cugino Bruto Gottifredi, membro di un lignaggio del patriziato romano che stava superando le proprie difficoltà finanziarie di fine XVI e inizio XVII secolo.56 La medesima Olimpia andò poi in sposa, nel 1647, al patrizio Filippo Carlo Sacco (Sacchi), che in precedenza era stato canonico della cattedrale di San Pietro nella sua Bologna.57 Quanto a Vittoria, la più giovane della casa, fu impalmata cinque anni più tardi dal nobile concittadino Marco Antonio de Grassis, il quale sarebbe assurto alle primarie cariche del Campidoglio solamente nel 1679.58 Delle altre giovani nubili, Porzia rimase zitella.59 Invece Veronica, nel 1652, prese l’abito di terziaria francescana nel monastero trasteverino di clausura dedicato a Santa Margherita, con il nome di suor Florida Celeste.60 Forse questa di Veronica fu una vocazione autentica, o forse la sua famiglia non era stata in grado di provvederle più di una dote spirituale, quella richiesta appunto alle novizie degli istituti religiosi.61
56 Cfr. FeCi, Pesci fuor d’acqua cit., pp. 236238. Bruto, che avrebbe sposato Lucrezia Ceva, era figlio di Giovanni Battista, prozio di Olimpia. Cfr. WeBer, Genealo-gien cit., IV, Stuttgart, Hiersemann, 2001, p. 626.
57 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Matrimoni 16311677, c. 66r (13 novembre 1647). Per la genealogia di casa Sacco cfr. p. S. dolFi, Cronologia delle fami-glie nobili di Bologna, Bologna, Giovanni Battista Ferroni, 1670, p. 365; e specialmente Archivio di Stato di Bologna, g. guidiCini, Alberi genealogici, ms., sec. XIX, Sacchi.
58 Il 1652 è l’ultimo anno in cui Vittoria è attestata nubile nella casa paterna. Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16521667, c. 5r. Sulla schiatta di Marco Antonio de Grassis, figlio di Antonio Francesco, cfr. ForCella, Iscrizioni cit., I, pp. 610, 1216, 19; IV, Tip. dei fratelli Bencini, 1874, pp. 359 n. 854, 360 n. 855; pieTramellara, Il libro d’oro cit., I, pp. 180181.
59 Cfr. ASFr, AN, Giuseppe Iaboni di Veroli, 23 gennaio 1689, c. 51v.60 Emise i voti l’anno successivo. Cfr. F. BalBoni, Roma riscopre un gioiello. San-
ta Margherita: porta d’Oriente e d’Occidente, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, p. 140.
61 Nei monasteri più esclusivi della città eterna, la dote non superava i 1000 scudi.
123La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
Non molto differente, d’altronde, fu il ventaglio di opzioni matrimoniali agibili per i maschi degli altri rami Annibaldi, se Tiberio Arcioni della Molara (1576 circa1654) sposò Laudomia Biscia e il loro figlio Annibale (16191691) impalmò Isabella Capranica vedova Acciaioli, nel mentre Lucrezia Morelli si maritò con Giuseppe di Zancati (16041684) e il figlio di costoro Riccardo (16311666) convolò a nozze con Antonia dei Colonna Romano.62
6. un Cavaliere «per giuSTizia». – Nella settima decade del secolo XVII Bruto della Molara, il più giovane dei maschi Annibaldi della linea di Annibale, sarebbe stato molto probabilmente nelle condizioni di avvalersi della sua crescente influenza politica alla corte granducale di Toscana per imparentarsi con un casato che gravitava su Palazzo Pitti. Tuttavia Bruto preferì assecondare le proprie inclinazioni personali. Pur disposto all’ossequio verso sovrani, porporati e monsignori per fabbricare o risollevare le proprie fortune, egli antepose sempre alle frequentazioni di dame quelle del proprio sesso.63
Ad ogni modo, la valutazione della personalità di Bruto introduce anche degli elementi di riflessione che ancora una volta dilatano i termini di una lettura puramente patrilineare delle vicende dinastiche degli Annibaldi della Molara. Furono le «provanze» per la sua ammissione a cavaliere milite «per giustizia» dell’ordine toscano di Santo Stefano a porre il diciassettenne Bruto, nell’autunno del 1656, di fronte all’obbligo di «giustificare leggitimamente la nobiltà de’ suoi quarti».64
Cfr. S. FeCi, Guardare al futuro. Il destino dei figli minori nei testamenti paterni (Roma, XVII secolo), in Famiglie cit., p. 103.
62 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16311692; We-Ber, Genealogien cit., V, Stuttgart, Hiersemann, 2002, p. 269. Per le date di nascita e di morte cfr. anche ASCR, ACa, b. 1359, s.n., fedi di battesimo di Angelo Giuseppe Eleuterio e di Riccardo Giuseppe Felice Angelo Francesco Annibaldi di Zancati, sec. XVII; ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Battesimi 16041634, c. 91r (Annibale Baldassare Annibaldi della Molara); Morti 16311661, c. 142v (Tiberio Annibaldi della Molara); Morti 16611692, cc. 21r (Riccardo Annibaldi di Zancati), 107v (Giuseppe Annibaldi di Zancati), 153v (Annibale Annibaldi della Molara).
63 Cfr. ad es. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (d’ora in poi: BNCF), Ms. Gal. 162, cc. 138v139r, Bruto della Molara a Vincenzo Viviani, Piediluco 27 ottobre 1663.
64 Cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20, fasc. Processo fabbricato in Roma …
124 Alessandro Cont
Gli statuti dell’ordine stefaniano (1562 e 1590), recependo l’insigne modello dell’ordine di Malta, pretendevano che un cavaliere «per giustizia» fosse in possesso, tra gli altri requisiti, dei quattro quarti di nobiltà. In altre parole, un milite era nominato «per giustizia» dal granduca di Toscana e gran maestro dell’ordine se egli aveva provato nel tribunale del consiglio dei dodici cavalieri, con le formalità dettate dagli statuti, tra l’altro la nobiltà del «quarto» del proprio padre, del quarto della madre e così dei rispettivi quarti della nonna paterna e materna.65
Per ottemperare a questa prescrizione, Bruto e i suoi fratelli Riccardo e Gaspare, alleati nell’impresa, furono dunque indotti a indagare le loro ascendenze non solo maschili ma altresì femminili, affacciandosi così su realtà sociali, consuetudini municipali e storie familiari delle quali ben poco conoscevano. Fu necessario certificare, infatti, che nel lontano 1590 una contessa bergamasca, Veronica Secco Suardo, si era congiunta in matrimonio con il ravennate Bruto Rasponi. E parimenti si dovette testificare che pressappoco sedici anni più tardi da tale unione aveva visto la luce Giulia, la madre di Bruto della Molara.66 Del resto, nel suo stesso primo nome di battesimo, Bruto recava vivido stampo di una parentela acquisita.67 Annibale, Riccardo o Tebaldo erano nomi ricorrenti nell’albero di casa Molara, mentre quello di Bruto era pervenuto in casa Annibaldi attraverso i più recenti matrimoni con i Gottifredi e i Rasponi.68
Assistendo gli Annibaldi nella riscoperta delle loro origini, per il lato paterno come per il lato materno, le provanze di nobiltà assolsero dunque a un’importantissima funzione pedagogica nei
65 Cfr. F. angiolini, I cavalieri e il principe. L’Ordine di Santo Stefano e la socie-tà toscana in età moderna, Firenze, Edifir, 1996, pp. 69, 114116; B. CaSini, I Cavalie-ri degli Stati Italiani, membri del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire, II, Pisa, ETS, 2001, p. 513.
66 Cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20. Per l’anno di nascita di Giulia cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16381651, c. 121r (a. 1645).
67 Correttamente, egli si chiamava Bruto Michele Tommaso Melchiorre Baldassare. Cfr. Archivio Capitolare di Perugia, Cattedrale di S. Lorenzo, Battesimi 16281695, c. 55r (16 marzo 1639).
68 Cfr. WeBer, Genealogien cit., IV, p. 626; http://www.genmarenostrum.com/paginelettere/letterar/rasponi.htm. Per il figlio nato il 14 novembre 1628, Tebaldo e Giulia avevano scelto il nome di Annibale. Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Battesimi 16041634, c. 181r (19 novembre 1628).
125La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
confronti dei giovani rampolli del ramo di Annibale della Molara. L’autocoscienza aristocratica di costoro doveva esserne rinsaldata, vivificata, ancor prima di riportare l’anelata approvazione granducale.
L’ordine di Santo Stefano era teso a istituzionalizzare una nobiltà prestigiosa quanto leale al granduca mediceo, una nobiltà anzi che dalla quarta decade del secolo XVII sempre più accentuò il proprio carattere ‘nazionale’ in senso toscano.69 Per l’adolescente Bruto della Molara, servitore del granduca Ferdinando II in qualità di paggio, non fu difficile lasciarsi sedurre dalle attrattive di un ordine cavalleresco molto accreditato in Italia. Di questo facevano parte i più eminenti personaggi della corte medicea, gentiluomini di antica stirpe ma anche giovanissimi, poco blasonati titolari d’una commenda di padronato che un loro antenato aveva eretto nell’ordine al fine di eludere il requisito dei quarti di nobiltà.70
Tuttavia l’aspirazione di Bruto per la dignità cavalleresca non fu influenzata totalmente dalla temperie politicoculturale, quella medicea, in cui egli proseguiva e completava la sua educazione umanisticocavalleresca. Verosimilmente un’ulteriore, più sottile motivazione concorse nell’iniziativa formalizzata nel settembre 1656 con la supplica di Bruto al granduca Ferdinando II per ottenere l’abito di cavaliere stefaniano,71 rendendo un poco più convinto e fattivo il sostegno che Riccardo e Gaspare della Molara intesero prestare al loro più giovane fratello. Siffatto incoraggiamento risiedeva negli sviluppi in atto tra XVI e XVII secolo nel sistema politicosociale dell’aristocrazia civica di Roma, il ceto in cui si riconoscevano tutti gli Annibaldi della Molara.
Valori ereditari come le «sustantie», il «sangue» e i «costumi», decantati da Marco Antonio Altieri agli albori del XVI secolo, non bastavano più per fissare i caratteri propri di un ceto di governo cittadino. É indubbio che nel Cinque e nel Seicento,
69 Cfr. e. iraCe, La nobiltà bifronte. Identita e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo, Milano, Unicopli, 1995, pp. 5253; angiolini, I cavalieri cit., pp. 2022, 99, 148.
70 Nel 1686 divenne cavaliere commendatore un fanciullo di 8 anni, il livornese Lelio Franceschi. Cfr. angiolini, I cavalieri cit., p. 94.
71 Cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20.
126 Alessandro Cont
sotto influenze straniere, il possesso di insegne cavalleresche e di attribuzioni feudali contribuì in misura crescente alla definizione e alla gerarchizzazione di un più circoscritto ed esclusivo patriziato romano.72 Gli onori e i titoli accordati da un monarca ecclesiastico o secolare attenuarono o bilanciarono quella tradizionale apertura e mobilità dell’aristocrazia municipale dell’Urbe che per molti aspetti resse sino alla bolla Urbem Romam di Benedetto XIV del 1746.73
Sempre più spesso, dal XVI al XVIII secolo, nelle città dello Stato della Chiesa il discrimine tra nobili e plebei venne stabilito dal diritto di accesso alle maggiori dignità e cariche dell’amministrazione municipale, il quale divenne una prerogativa o ereditaria o attribuita per via graziosa.74 Ove gli statuti e le consuetudini locali non avevano attuato la piena, formale, netta «ordinum et graduum distinctio», come nella stessa Roma ancora a metà del Seicento, la giustizia distributiva di un principe sovrano sopperiva offrendo a persone e famiglie la possibilità di potenziare la loro reputazione in patria e di consolidarla oltre i confini politicoterritoriali di essa.75 Significativamente, numerosi casati dell’aristocrazia civica romana del Seicento furono investiti di feudi dal granduca di Toscana, dal duca di Savoia o dal pontefice stesso, mentre altri, come gli Annibaldi della Molara per l’appunto, esaudirono le loro aspirazioni in primo luogo facendosi ammettere nell’ordine
72 Cfr. e. mori, «Tot reges in urbe Roma quot cives». Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento, in Il Comune di Roma. Istituzioni locali e potere centrale nella capitale dello Stato pontificio, a cura di P. Pavan, «Roma moderna e contemporanea», IV, II, maggioagosto 1996, pp. 387401.
73 Cfr. B. g. zenoBi, Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle pe-riferie pontificie in età moderna, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 162166; mori, «Tot reges» cit.; piCCialuTi, L’immortalità cit., pp. 1620, 4461; m. a. viSCeglia, Introduzione. La nobiltà romana: dibattito storiografico e ricerche in corso, in La nobiltà romana in età moderna cit., pp. xiii-xv; a. Camerano, Le trasformazioni dell’élite capitolina fra XV e XVI secolo, ivi, pp. 129.
74 Cfr. zenoBi, Le «ben regolate città» cit., in partic. pp. 195204. Per l’Italia settentrionale cfr. C. donaTi, L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, RomaBari, Laterza, 1988; id., Nobiltà e arti meccaniche. L’«ateneo dell’uomo nobile» di Agostino Paradisi [1990], ristampato nella raccolta dello stesso autore Nobili e chierici nell’Italia del Seicen-to e del Settecento. Studi e ricerche storiche, Milano, CUEM, 2002, in partic. pp. 6774.
75 La citazione è tratta dalla bolla «benedettina» (1746). Per un importante raffronto con Perugia, la città dove nacquero i fratelli Gaspare, Vittoria e Bruto della Molara, cfr. iraCe, La nobiltà bifronte cit., pp. 3970.
127La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
mediceo di Santo Stefano.76 Varcare la soglia di un consesso quale era la religione stefaniana delineava per i Molara un’indubitabile rafforzamento della loro valenza nobiliare. Senza scordare peraltro che la nomina a cavaliere milite «per giustizia» era subordinata, nel caso del patrizio romano, proprio alla sua appartenenza all’«ordine senatorio», cioè al patriziato, della propria città.
Il dover rispondere a questa precisa esigenza spiega principalmente perché la candidatura di Bruto della Molara al titolo cavalleresco nell’ordine di Santo Stefano assunse i connotati di un’operazione strategica familiare adeguatamente finalizzata. Così, se Bruto si dedicò a coltivare i rapporti nella corte toscana, ricevendo appoggi e suggerimenti, e fu tra tutti il più attivo,77 Gaspare funse da suo procuratore a Roma nel processo delle provanze per i quarti del padre e della nonna Gottifredi. Fu dunque Gaspare a indicare al giudice deputato i testimoni da interrogare, fu inoltre lui a produrre attestati «ad docendum de nobilitate familiarum Anibaldensium de Molaria, et de Gottifredis»», nonché a segnalare i monumenta pubblici delle due casate (vetusti sepolcri, marmorei stemmi, ecc.) disseminati nelle chiese, nei palazzi e nei monasteri dell’Urbe.78
L’abito di cavaliere giunse infine il 24 marzo 1666, allorché Bruto lo ricevette dalle mani del gran connestabile Ugo Della Stufa nella chiesa dei barnabiti di Livorno.79 Fu quindi necessario operare e attendere per ben un decennio prima che l’investi
76 Tra il 1562 e il 1697 vestirono l’abito di cavaliere 36 membri di 19 famiglie ‘romane’: Orsini (4), Massimo (2), Alli (6), Fabi, Gigli, Mantica, Bufalini, del Bufalo, Cenci (2), Grifoni (2), Aquilani (5), Conti, dal Pozzo, Carducci, Annibaldi della Molara, Mandosi (3), Pallavicino, Maccarani e Lanci. Cfr. CaSini, I Cavalieri cit., I, Pisa, ETS, 1998, pp. 473486; II, pp. 508518.
77 Cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20, nota di Francesco Berti, governatore dei paggi del granduca di Toscana, 1656 circa; inoltre, le missive di Bruto a Vincenzo Viviani in BNCF, Ms. Gal. 161, c. 216r (Firenze 5 gennaio 1660 [1661?]); Ms. Gal. 163, c. 12r (Pisa 20 febbraio 1666).
78 Cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20, fasc. Processo fabbricato in Roma …, 6 novembre 1656 20 marzo 1657 (tutta la documentazione è in copia del 1657). Cfr. anche le lettere di Bruto a Vincenzo Viviani in BNCF, Ms. Gal. 161, c. 343v344r (Pisa 31 dicembre 1661), 355v (Pisa 18 gennaio 1662 [1663]; da cui la citazione), 360r (Pisa 27 gennaio 1662 [1663]). I luoghi romani visitati in occasione del processo furono la chiesa di Santa Maria in Aracœli, il Campidoglio, la chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, il monastero di San Silvestro al Quirinale e la basilica lateranense.
79 Cfr. ASP, OC, n. 577, c. 70r; da cui CaSini, I Cavalieri cit., II, p. 513.
128 Alessandro Cont
mento in risorse umane, sociali e finanziarie operato dai fratelli Molara fruttificasse lungo un iter processuale e attraverso i meccanismi della corte medicea. Ma infine nel 1666, grazie all’esito positivo delle provanze, la nobiltà degli Annibaldi della Molara acquisì un nuovo, autorevole riconoscimento. A promozione più gratificante del proprio status sociale, nessun Molara sarebbe mai più pervenuto in seguito, e la qualifica di «cavaliere» rimase per Bruto Annibaldi della Molara un genuino motivo di aristocratico orgoglio.80
Malgrado il suo carattere corale, però, l’impresa indubbiamente familiare finalizzata all’investitura cavalleresca di Bruto non basta a contraddire una recente tesi emersa dal dibattito sui legami di parentela in età moderna. Secondo tale posizione storiografica, le norme stesse attinenti all’onore familiare non sarebbero rimaste indiscusse e cogenti nella loro traduzione pratica poiché, a seconda delle necessità e convenienze del momento, padri, figli, fratelli avrebbero potuto impiegare, distorcere, o contestare a loro vantaggio le leggi canoniche, civili, cavalleresche.81 A conferma dell’assunto, come si è già avuto modo di osservare, si pongono le differenze di mentalità, cultura e carattere fondanti la crisi che guastò le relazioni fra Bruto e Riccardo della Molara nei primi anni settanta, a fronte dell’esigenza di rimediare alla perdita della carica di cameriere segreto e tesoriere di camera subita dal primo dei due fratelli presso la corte del granduca toscano.82
7. la noBilTà dei puBBliCi onori. – Con l’obiettivo della dignità di cavaliere stefaniano, Bruto Annibaldi della Molara seppe comprovare in sede legale il possesso di una antica nobiltà, immune dalla contaminazione dei mestieri servili, una nobiltà esclusivamente municipale. Anche i suoi parenti Secco Suardo e Brembati di Bergamo e Rasponi di Ravenna erano in primis dei patrizi, e tra i più potenti delle loro città.83 Di un titolo comitale, però, al pari
80 Come si può cogliere tra le righe in BSS, ACo, Carteggio di Lorenzo Onofrio Colonna, fasc. 1, Bruto della Molara da Milano, 12 novembre 1681.
81 Cfr. Fazio e lomBardi, Introduzione cit., p. 2427; lomBardi, Donne cit., pp. 7980.
82 Cfr. ConT, Riccardo e Bruto Annibaldi della Molara cit., pp. 249252.83 Cfr. CaSanova, Potere cit., in partic. pp. 84118; a. ConT, Il Capitolo della Cat-
129La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
dei Brembati, dei Rasponi e dei Secco Suardo, i cugini romani di casa Molara non furono mai autorizzati a fregiarsi.84
La nobiltà annibaldesca si esprimeva principalmente nella serie secolare di detentori della carica di conservatore della camera capitolina di Roma, a prescindere dall’evoluzione storica che l’insigne magistratura aveva conosciuto a partire dalla sua genesi trecentesca.85 Da tale punto di vista, l’approccio genealogico dei Molara del XVII secolo si riappropriava di una rappresentazione in chiave agnatizia. In effetti era su di una linea di successione patrilinea, verticale, che i gruppi patrizi poggiavano e, con gelosa suscettibilità, preservavano i loro diritti di governo e di preminenza sociale nella loro città.86
Sia Gaspare che Bruto della Molara erano consapevoli dell’alto senso politico di una loro elezione a «quelli offitii, magistrati, e dignità, e gradi di maggioranza soliti darsi a’ veri nobbili, e gentilhuomini come sono l’esser conservatore di Roma, et altri».87 La dignità di conservatore della camera capitolina aveva impegnato per un mandato il loro padre Tebaldo (1616), per due lo zio Mario (1627, 1632 e 1637), per quattro il nonno Gaspare (1577, 1583, 1590 e 1604), e per una il bisnonno Tebaldo (1547).88 Rispetto alla strada aperta dagli avi, e seguita anche dai cugini Got
tedrale di Bergamo (1708-1773). Un corpo ecclesiastico ai margini della Terraferma ve-neta, Bergamo, Litostampa istituto grafico, 2008, passim.
84 Per i Brembati e i Secco Suardo cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20, provanze di nobiltà per il quarto della nonna materna Veronica Secco Suardo, cc. 710r, 16v46; Civica Biblioteca Archivi Storici «Angelo Mai» di Bergamo, Gabinetto 3.55/2 (nuova segnatura: AB 11), Registro di famiglie titolate, e feudatarie di Bergamo, ed altre d’origine medesima descritte nel libro d’oro de’ veri titolati della serenissima Republica di Venezia, ms., sec. XVIII, pp. 27, 67. Invece per i Rasponi cfr. F. giorgi e v. SpreTi, Rasponi, in Enciclopedia storico-nobiliare italiana, a cura di V. Spreti [19281936], anastatica, Bologna, Forni, 19681969, V [1932], p. 618. Se talvolta Bruto della Molara è stato appellato con il titolo di «conte», ciò è accaduto per mera ignoranza. Cfr. ad es. BNCF, Ms. Gal. 162, c. 258r, Antonio Francesco Balatri a Vincenzo Viviani, Pisa 20 febbraio 1665 [1666].
85 Cfr. m. FranCeSChini, Dal consiglio pubblico e segreto alla congregazione econo-mica: la crisi delle istituzioni comunali tra XVI e XVII secolo, in Il Comune di Roma cit., pp. 343359.
86 Cfr. zenoBi, Le «ben regolate città» cit.87 ASP, OC, filza 149, ins. 20, fasc. Processo fabbricato in Roma …, deposizione di
Girolamo Muti Papazzurri, 22 novembre 1656.88 Cfr. ibid., attestato dello scriba del senato romano, 7 marzo 1657 (in copia);
pieTramellara, Il libro d’oro cit., II, pp. 198, 201203, 208211.
130 Alessandro Cont
tifredi, Arcioni della Molara, Valentini della Molara e Annibaldi di Zancati, non bisognava assolutamente divergere, pena la perdita di una posizione d’invidiabile prestigio in seno all’aristocrazia romana.89
Gaspare fu il primo a farsi carico di una simile responsabilità verso la propria casata, verso gli antenati e i parenti più stretti. Diciottenne, egli fu eletto dagli «imbussolatori», a loro volta eletti dai concittadini romani, quale capo del suo stesso rione di residenza, Trevi, per il trimestre da luglio a settembre 1655.90 Per questa via concretizzò il suo autentico esordio nella vita pubblica, sintonizzato con le finalità identitarie e autorappresentative della più ristretta oligarchia capitolina.91 Pressappoco in contemporaneità alla morte della madre Giulia, che spirò durante la pandemia di peste il 14 aprile 1657, i caporioni lo elessero loro priore per i mesi da luglio a settembre del medesimo anno.92 Tuttavia, egli non volle compiere passi ulteriori. La sua partenza da Roma, una volta scaduto l’ufficio, per raggiungere il fratello Riccardo governatore a Forlì, nonché la dimora del l’altro fratello Bruto dapprima a Firenze, poi tra l’Umbria e le Marche, ostarono a un più intenso coinvolgimento dei tre Molara nelle dinamiche interne dell’amministrazione municipale capitolina.93
Le vicende biografiche dei fratelli Riccardo, Gaspare e Bruto Annibaldi della Molara possono dunque recare un’ulteriore, pur modesta conferma agli studi che, focalizzati su fonti seriali e qualitative dei secoli dal XVI al XVIII, hanno argomentato la critica
89 Cfr. ForCella, Iscrizioni cit., I, pp. 17; pieTramellara, Il libro d’oro cit., II, pp. 192219.
90 Cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20, fasc. Processo fabbricato in Roma …, attestato dello scriba del senato romano, 7 marzo 1657 (in copia). Gaspare vide la luce a Perugia il 28 giugno 1636. Cfr. Archivio Capitolare di Perugia, Cattedrale di S. Lorenzo, Battesimi 16281695, c. 39v.
91 Cfr. Ferraro, The nobility cit., p. 69.92 Cfr. ASP, OC, filza 149, ins. 20, fasc. Processo fabbricato in Roma …, attestato
dei conservatori della camera capitolina, 18 febbraio 1664; ForCella, Iscrizioni cit., I, p. 3. Per la morte di Giulia Rasponi della Molara cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Morti 16311661, c. 153r.
93 Sulla presenza di Gaspare presso Riccardo cfr. BSS, ACo, Carteggio di Girolamo I Colonna, nn. 48, 418, Gaspare della Molara da Cesena, 16 dicembre 1657 e Forlì 19 dicembre 1658.
131La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
alla definizione e classificazione di rigidi modelli di composizione degli aggregati familiari. Rispetto agli schemi teorici relativi a famiglie nucleari o senza struttura, estese o multiple, ma sempre «sotto lo stesso tetto», esse documentano l’azione e gli esiti scaturenti da una duttilità e da una mutevolezza che era in sintonia con l’interagire di fattori biologici, sociali, ed economici.94
Comunque, si deve osservare, fu lo stesso Bruto della Molara, cioè il meno ‘romanesco’ tra i figli maschi di Tebaldo della Molara, a rivitalizzare per un momento almeno il costume municipale interrotto dal fratello maggiore Gaspare. Avvalendosi del suo stabile rientro in patria come mastro di camera al servizio del cardinale Francesco Nerli iunior, egli accettò di sedere nella magistratura dei tre conservatori eletti dagli imbussolatori per l’ultimo trimestre del 1675.95
Nella coincidenza temporale tra la carica esercitata in Campidoglio e lo sfarzoso giubileo del 1675 il trentaseienne Bruto trovò senz’altro un motivo di appagamento per la visibilità che gli veniva offerta. La concomitanza risarciva in parte le carenze che l’organismo capitolino soffriva per la quasi completa interruzione, dal 1664, dell’attività dei due consigli segreto e pubblico deliberanti sulle «quæstiones rerum ad populum romanum pertinentium».96 Lo strumento compensatore era fornito dalla partecipazione coreografica conferita alle principali magistrature civiche dagli appuntamenti solenni dell’anno santo, e in modo speciale dalla cerimonia di chiusura della Porta santa, in una metropoli affollata da pellegrini e visitatori.97 «Ci vorria, ch’io potessi rivedervi qui
94 In generale cfr. Fazio e lomBardi, Introduzione, in Generazioni cit., pp. 1218, 2122; S. Cavallo, L’importanza della «famiglia orizzontale» nella storia della famiglia italiana, ivi, pp. 6992; lomBardi, Donne cit., pp. 7475. La citazione è tratta dal titolo della nota opera di m. BarBagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna, Il mulino, 1984.
95 Cfr. ForCella, Iscrizioni cit., I, p. 5.96 Per lo svuotamento delle competenze di entrambe le assemblee cfr. FranCe-
SChini, Dal consiglio pubblico cit., p. 359. La citazione è tratta da Statuta almæ urbis Romæ auctoritate s.d.n.d. Gregorii papæ XIII pontificis maximi a senatu, populoque ro-mano reformata et edita, Romæ, in ædibus populi romani, 1580, III, cap. III, ma cfr. altresì ibid., III, cap. II.
97 In merito al penultimo giubileo del sec. XVII cfr. Papi, plebei e pellegrini. La storia di Roma attraverso i Giubilei, a cura di E. Mori, Roma, Comune di Roma, 1999, pp. 3334; i. FoSi, Fasto e decadenza degli anni santi, in Storia d’Italia. Annali, XVI:
132 Alessandro Cont
all’anno santo, e servirvi, o questo sì saria la mia contentezza maggiore», aveva scritto Bruto all’amicissimo scienziato Vincenzo Viviani il 7 luglio del precedente anno 1674.98
Del resto, una chiara, onorifica collocazione nel rituale delle funzioni pontificie costituiva un’esigenza imperativa, irrinunciabile per i rampolli dell’aristocrazia romana, tenuti a sostenere esteriormente, pubblicamente, le loro prerogative di rango, la loro nobiltà in quel gran teatro europeo che era la Roma barocca «per la qualità della corte» pontificia.99
Così fu quasi un preannuncio del suo ingresso al Campidoglio la presenza di Gaspare della Molara nel novero dei quarantuno paggi, «nobili romani», che il 9 maggio 1655 accompagnarono il nuovo papa Alessandro VII alla presa di possesso della basilica lateranense.100 Una comparsa del genere rimembrò cavalcate antecedenti per il medesimo possesso del Laterano, nelle quali i membri del lignaggio di Gaspare, e nello specifico il fratello Riccardo (1644) e il padre Tebaldo (1590), avevano occupato posti corrispondenti alla loro età puerile o adolescenziale, ma sempre deferenti verso la loro appartenenza al ceto dirigente del municipio romano.101
La comparsa ad alcune prese di possesso dei papi nonché l’esercizio dei più appetibili uffici municipali, in veste di conservatori, di priori dei caporioni e di caporioni, fu il vero contribu
Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla, a cura di L. Fiorani e A. Prosperi, Torino, Einaudi, 2000, in partic. p. 798. Sul calendario dell’anno giubilare cfr. m. a. viSCeglia, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Roma, Viella, 2002, pp. 255266.
98 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 164, c. 336r.99 Cfr. mori, «Tot reges» cit., pp. 381382. La citazione proviene da Archivio di
Stato di Modena, Archivio segreto estense, Sezione Casa e stato, Carteggi tra principi estensi, b. 262, Cesare Ignazio d’Este a Rinaldo d’Este, Sassuolo 5 settembre 1691. Per un recente saggio sui rituali del potere a Roma nel sec. XVII, con bibliografia, cfr. m. BoiTeux, Linguaggio figurativo ed efficacia rituale nella Roma barocca, in I linguag-gi cit., I: Politica e religione, Roma, Viella, 2009, pp. 3979.
100 Cfr. F. CanCellieri, Storia de’ solenni possessi de’ sommi pontefici detti antica-mente processi o processioni dopo la loro coronazione dalla basilica vaticana alla latera-nense, Roma, L. Lazzarini, 1802, p. 269.
101 Tebaldo fece una sontuosa apparizione al possesso di Gregorio XIV nel mezzo dei «pueri romani […] ex nobilioribus urbis familiis electi», e Riccardo partecipò al corteo per il possesso di Innocenzo X nel novero degli «iuvenes nobiles romani». Cfr. CanCellieri, Storia cit., pp. 132133, 232233.
133La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
to ai «fasti» capitolini dei primogeniti di questo ramo della casa Molara.
A cariche non immediatamente collegate, almeno sul piano normativoformale, all’istituzione civica, ma comunque volte a ribadire il loro carattere di patrizi romani, pervennero, dal primo XVII secolo, cadetti o membri di altre linee della famiglia Annibaldi i cui nomi figurano anche tra i conservatori della camera capitolina e tra i priori dei caporioni. Uno dei quattro consoli dell’arte dell’agricoltura, «nobili uomini scelti fra quelli dell’arte medesima», fu, nel 1627 e nel 1642, Mario della Molara, senza dubbio il più attivo sulla scena dell’Urbe tra i quattro figli maschi di Gaspare e Olimpia Gottifredi.102 Così pure Giuseppe Annibaldi di Zancati figura quale console dell’agricoltura per ben otto volte tra il 1622 e il 1679, mentre alcuni esponenti di casa Arcioni della Molara, ossia Tiberio, suo figlio Annibale e il nipote Giovanni, sedettero nel collegio consolare in trenta occasioni dal 1643 al 1718.103
Con la sola eccezione di Mario, si tratta degli stessi personaggi che onorarono la genealogia annibaldesca ricoprendo cariche amministrative quali deputati, guardiani, custodi o priori in una o più di quelle confraternite che nella Roma controriformista e barocca furono importanti sedi d’incontro, devozionalità, carità e di autocelebrazione dell’aristocrazia senatoria: il SS. Salvatore, la SS. Annunziata, e la Consolazione.104 L’assenza da tali deputazioni dei figli di Tebaldo e Giulia Rasponi si comprende di nuovo con la lontananza di questi personaggi da Roma, protrattasi per lunghi anni e, nel caso di Riccardo, imposta da esigenze di una carriera prelatizia che erano incompatibili con l’assunzione di magistrature cittadine.
8. Con «un SCorpione Solo»? – Un’armoniosa spartizione di ruoli istituzionali e sociali tra i rampolli delle distinte linee del ca
102 Cfr. Gli Statuti dell’agricoltura con varie osservazioni, bolle, decisioni della s. ruota, e decreti intorno alla medesima, Roma, Stamperia della reverenda camera apostolica, 1718, pp. 1, 225.
103 Cfr. ibid. Giovanni «de Molaria» è menzionato quale figlio di Annibale in Archivio di Stato di Roma, Notai AC, v. 4701, cc. 543545, 588590.
104 Cfr. roSSelli, Tra Campidoglio e luoghi pii cit., pp. 168169, 185.
134 Alessandro Cont
sato Annibaldi poté concretizzarsi di rado nel Seicento, poiché la nobile famiglia aveva crescenti difficoltà a compattarsi puntando su obiettivi comuni. L’esperienza dell’età moderna rese evidente come la vetusta casata annibaldesca, che nel corso del XIII secolo aveva saputo concordare strategicamente progetti dinastici coordinando le tattiche individuali dei suoi singoli membri, fosse oramai troppo disarticolata e debilitata per far convergere i diversi rami in ambiziosi progetti condivisi di politica familiare. Anzi, il punto ove le discordanze e i rancori esplosero più accesi fu proprio la difesa delle rispettive origini dinastiche.105
Sulla considerevole antichità della schiatta degli Annibaldi non v’erano molte perplessità nella Roma cinquesecentesca. Un severo laudator temporis acti come Marco Antonio Altieri annoverava gli «Hanniballi» tra le «nobilissime famiglie» dell’Urbe.106 Verso il quinto decennio del Seicento, una relazione dell’avvocato fiammingo Dirk van Ameyden poneva quella dei «Molara de gl’Anibali» tra le cinquantanove prosapie romane che vantavano più di trecento anni di vita: essa era, in altre parole, «antichissima, e nobilissima».107 Sebbene Ameyden fosse amico personale dei fratelli Valerio, Prospero e Cesare Valentini della Molara, che in altra sede definì «gentiluomini d’ottimi e nobilissimi costumi», la sua era senz’altro una convinzione largamente diffusa alla sua epoca.108
Ciò malgrado, qualche anno più tardi Giuseppe Annibaldi di
105 Cfr. ameyden, La storia cit., I, pp. 6668; p. adinolFi, Laterano e via maggio-re. Saggio della topografia di Roma nell’età di mezzo dato sopra pubblici e privati docu-menti, Roma, Tip. Tiberina, 1857, p. 25; Carloni, Le tombe cit., p. 215; Die mittelal-terlichen Grabmäler in Rom und in Latium. Vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, II: Die Monumentalgräber, con la collaborazione di U. KnallBrskovsky et alii, a cura di J. Garms et alii, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994, pp. 42, 4445; i. herkloTz, «Sepulcra» e «Monumenta» del Medioevo. Studi sull’arte sepolcrale in Italia, [1985], terza edizione con presentazione di P. Delogu, Napoli, Liguori, 2001, pp. 254255, 340342.
106 Cfr. m. a. alTieri, Li nuptiali [tra il 1506 e il 1509, e addizioni posteriori al 1513], a cura di E. Narducci [1873], anastatica con introduzione di M. Miglio e appendice documentaria e indice ragionato dei nomi di Anna Modigliani, Roma, Roma nel Rinascimento, 1995, p. 130, ma anche p. 16.
107 d. van ameyden, Relatione di Roma, in Li tesori della corte romana in varie relationi …, Bruselles, s.e., 1672, pp. 137, 140.
108 Cfr. ameyden, La storia cit., II, p. 84.
135La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
Zancati si vide costretto ad adire la via giudiziaria per sostenere la sua diretta discendenza dallo stesso stipite del cardinale duecentesco Riccardo Annibaldi.109 Precisamente, egli contestò le analoghe rivendicazioni avanzate dagli Arcioni della Molara, che accusò di essersi appropriati in modo indebito della sua ascendenza annibaldesca.
Tiberio Arcioni della Molara unitamente al figlio canonico Giovanni Battista aveva promosso, dal 1646, la dislocazione del sepolcro ritenuto in quel tempo del cardinale Riccardo. Una decisione, questa, da comprendere nel più generale contesto del restauro borrominiano di San Giovanni in Laterano voluto da Innocenzo X e delle questioni politicoideologiche, artistiche, antiquarie che esso suscitò in merito alla sistemazione definitiva da riservare alle antiche memorie papali e cardinalizie collocate nella basilica. Agli occhi indignati di Giuseppe Annibaldi, tuttavia, era ancora più grave l’intenzione nutrita dai due Arcioni della Molara di ricollocare sulla tomba del cardinale un’epigrafe tardocinquecentesca che assegnava al defunto il cognome «de Molaria».110
La causa civile che ne scaturì fra Giuseppe e lo stesso Tiberio Arcioni della Molara fu portata attraverso più istanze di giudizio, dal vicario del Laterano all’alto tribunale della Rota Romana.111 Con sentenza del 12 giugno 1651, la Rota riconobbe infine salomonicamente le ragioni di ambedue le parti sui due punti controversi, ovverosia «ad quem spectet conservatio dicti depositi, & inscriptionis», e «an dictum cognomen de Molaria deleri debeat».112
109 Copia ms. dell’albero genealogico ricostruito per Giuseppe Annibaldi è in ASCR, ACa, b. 1360, s.n.
110 Cfr. ASCR, ACa, b. 1360, a. SaraCinelli, Romana iuris honorifici pro illustrissi-mo domino Iosepho de Annibaldensibus contra dominos de Molaria, Romæ, ex typographia reverendæ cameræ apostolicæ, 1650. In verità, il monumento, di cui sopravvivono frammenti eseguiti da Arnolfo di Cambio nel Museo di San Giovanni in Laterano, non era stato concepito per il cardinale Riccardo, bensì per il suo omonimo nipote, notaio papale deceduto nel 1289. Cfr. herkloTz, «Sepulcra» cit., pp. 256261; n. gio-vè marChioli, L’epigrafia nobiliare romana: il caso delle iscrizioni funerarie, in La nobil-tà romana nel Medioevo cit., pp. 354355.
111 Cfr. SaraCinelli, Romana iuris honorifici cit.; ameyden, La storia cit., I, pp. 6668.
112 Il testo della sentenza è riportato da ameyden, La storia cit., I, pp. 6668 nota. Ma la citazione proviene da SaraCinelli, Romana iuris honorifici cit.
136 Alessandro Cont
Pure, la strenua lotta contro gli ‘usurpatori’ di casa Arcioni della Molara mostrò i benefici tratti di un’indagine documentaria svolta principalmente a Roma sotto la direzione del medesimo Giuseppe Annibaldi di Zancati e finalizzata agli immancabili riscontri storicogenealogici. Studi recenti hanno evidenziato come nell’Italia d’età moderna i criteri di ordinamento o riordinamento degli archivi e delle carte di famiglia potevano enfaticamente risultare funzionali all’immagine celebrativa che le casate o loro membri miravano a trasmettere di sé: secondo una finalità complementare a quella caratterizzante le ‘memorie familiari’ in forma scritta.113 E infatti, importanti tracce del lavoro di recupero e valorizzazione commissionato da Giuseppe Annibaldi e ordinato alla raccolta di testimonianze archivistiche, storicoletterarie, epigrafiche e iconografiche, sono oggi conservate, per lo più inedite, nell’archivio che fu dello stesso Giuseppe e dei suoi eredi, preziosa reliquia di un’ardente, possessiva pietas familiaris.114
Fulcro dell’intera questione dibattuta in sede legale fu la difesa di un patrimonio d’identità dinastica, motivata dalla fierezza di appartenere a una grande stirpe. Il settantenne Tiberio Arcioni della Molara e i suoi tre figli Giovanni Battista, Cesare e Annibale ritenevano che Giuseppe avesse derivato il cognome di «Annibali» da un certo antenato Annibale di Valmontone, frate conventuale.115 Per contro, Giuseppe mirava a dimostrare che la custodia della tomba di Riccardo era a lui riservata in quanto discendente diretto di Annibale (Annibaldo), fratello del cardinale Riccardo. Inoltre, sulla base della sua personale interpretazione, il capostipite dei Molara era stato null’altro che uno dei figli naturali di quel Tebaldo Annibaldi morto all’inizio del XV secolo.116 E tanto sa
113 Cfr. ago e Borello, Introduzione cit., pp. 1719. 114 Il fondo è aggregato a quello della famiglia Scarlatti, che lo ereditò per linea
femminile, in ASCR, ACa, bb. 13591369.115 Cfr. SaraCinelli, Romana iuris honorifici cit. Una tavola genealogica a stam
pa prodotta di parte Arcioni della Molara, risalente al 1650, è oggi custodita presso la famiglia Caucci Molara.
116 Cfr. ASCR, ACa, b. 1360, Inventario delle scritture di casa della Molara che si ritorceno contro di loro per escluderli dalla descendenza dal cardinal Riccardo de gl’An ni-bali, ms. Tebaldo si era spento nel 1404. Cfr. C. da roma, Memorie istoriche della chie-sa e convento di S. Maria in Araceli di Roma, Roma, R. Bernabò, 1736, p. 393.
137La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
rebbe bastato per escludere legalmente tutti gli Arcioni della Molara dalle prerogative di casa Annibaldi, «ubi quod in re honorifica ad splendorem familiæ facta non succedunt illegitimi, neque eorum descendentes, quia per eos familia non decoratur».117
Nel corso della vertenza le altre linee dei Molara preferirono mantenere un profilo più sobrio, marginale. In una fede rilasciata da Cesare Valentini della Molara il 26 giugno 1650, tuttavia, trovava conforto la tesi di Giuseppe secondo cui «quelli di casa della Molara» non avevano mai usato i due leoni e le sei palle del blasone annibaldesco, bensì «hanno sempre fatto per arme un scorpione solo».118 In effetti, le dimore dei Valentini della Molara e dei Molara del ramo di Annibale pullulavano di arme recanti lo scorpione, aracnide simbolo di lussuria, di vendetta e di eresia che si ostentava, marcando il territorio, scolpito o dipinto su usci, caminetti, travi di soffitto e mobili antichi.119
Ma la decisione rotale del 1651 spogliò del suo ruolo di spicco lo scorpione dei Molara, sancendo un pieno e definitivo successo della pretesa araldica sostenuta dagli Arcioni della Molara. A entrambe le parti avversarie la Rota permetteva di inalberare le armi degli Annibaldi, «quia», come risolveva il tribunale pontificio,
ex instrumentis, aliisque scripturis publicis, ac tertium depositionibus constat eos, ac eorum ascendentes exactis seculis eiusdem familiæ Anibalorum, sive Anibaldensium cognomine publice, et palam usos fuisse.120
Così Bruto della Molara, per le provanze finalizzate alla sua ammissione all’ordine di Santo Stefano, si premurava di commis
117 SaraCinelli, Romana iuris honorifici cit.118 Ibid.119 Cfr. ibid. Lo scorpione era tenebroso convitato ad assolvere una simile voca
zione araldica in due ritratti di dame secentesche delle quali è ignoto il nome: tessuto nell’abito in un’imponente tela di Ottavio Leoni a Palazzo Lancellotti, fissato sulla mantellina, come spilla, in un olio di Giovanni Battista Passeri presso la collezione Maurizio Marini sempre a Roma. Cfr. rispettivamente SolinaS, La signora cit., in partic. pp. 249, 255; Donne di Roma dall’Impero Romano al 1860. Ritrattistica romana al femminile, a cura di M. Natoli e F. Petrucci, Roma, De Luca, 2003, p. 118 (F. Petrucci). Sul simbolismo dello scorpione cfr. g. di Crollalanza, Enciclopedia araldico-ca-valleresca. Prontuario nobiliare [18761877], anastatica, Bologna, Forni, 1980, p. 527; g. Cairo, Dizionario ragionato dei simboli. Con 160 disegni originali … [1922], anastatica, Bologna, Forni, 2001, p. 283.
120 Cfr. ameyden, La storia cit., I, p. 67 nota.
138 Alessandro Cont
sionare uno stemma di famiglia più sfarzoso dello «scorpione solo» sul quale avevano prestato fede il cugino Cesare Valentini della Molara nel 1650 e la stessa madre Giulia Rasponi nel 1644.121 Il blasone che in data 22 novembre 1656 i patrizi romani convocati a testimoniare sul quarto paterno di Bruto riconobbero per quello degli Annibaldi della Molara era quindi «con doi leoni dritti, doi sbarre, sei palle ogni cosa sudetta in campo rosso, et un scorpione nero in campo giallo».122 Questa volta, Giuseppe Annibaldi di Zancati preferì non adire in giudizio. E il pur longevo gentiluomo non era più in vita nel 1687, allorché Marco Antonio de Grassis e Vittoria della Molara fecero esporre nella basilica di San Marco al Campidoglio una memoria ove l’arme Annibaldi della Molara scolpita nel loro stemma nuziale si appoggiava nuovamente alla sentenza rotale di trentasei anni prima.123 Quindi i Molara non potevano più desistere dall’esibire, con disinvolta autocoscienza e buona fortuna, la loro legittima appartenenza alla progenie dei gloriosi Annibaldi medievali.
9. la domus del paTrizio romano. – Nonostante la composizione imposta nel 1651 tra gli Annibaldi di Zancati e gli Arcioni della Molara, sarebbe stato ingenuo auspicare un avvicinamento più sostanziale tra le varie linee degli Annibaldi. Il reciproco distanziarsi di questi rami continuò a esprimersi in forma visibile nella rigorosa distinzione tra le loro dimore urbane, situate peral
121 Cfr. il disegno acquerellato in ASP, OC, filza 149, ins. 20, fasc. Processo fab-bricato in Roma … Per l’attestato di Giulia Rasponi della Molara cfr. SolinaS, La si-gnora cit., p. 256.
122 ASP, OC, filza 149, ins. 20, fasc. Processo fabbricato in Roma …, deposizioni di Girolamo Muti Papazzurri (donde la citazione), Stefano Alli e Francesco Capizucchi. Più esattamente, lo stemma Annibaldi della Molara è un troncato semipartito: nel 1° di rosso, a 2 leoni d’argento affrontati; nel 2° di rosso, a 6 palle d’argento poste 3,2,1; nel 3° d’argento, allo scorpione di nero posto in palo; alla fascia di rosso, bordata d’argento, attraversante sulla troncatura. La descrizione si deve alla competenza e cortesia di Luciano Borrelli.
123 Cfr. Archivio di Stato di Roma, Notai capitolini, uff. 18, v. 504, cc. 221226, 3 agosto 1687. Lo stemma è partito: nel 1° troncato: in a) a 3 stelle (8), male ordinate; in b) all’aquila (de Grassis); nel 2° a 2 gemelle, accompagnate in capo da due leoni, controaffrontati e sostenenti una palla, in punta da 6 palle, poste 1,2,2,1; allo scorpione, posto in palo, attraversante sulla punta (Annibaldi della Molara). Anche questa descrizione è di Luciano Borrelli. Il testo della lapide, tuttora visibile in basilica, è pubblicato da ForCella, Iscrizioni cit., IV, p. 360 n. 655.
139La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
tro tutte nel rione di Trevi, presso la fontana tardo cinquecentesca delle Tre Cannelle.124 Per conto loro, invece, i Valentini della Molara risedevano nel rione Campitelli, «dietro alle moniche di Tor di Specchi», sino a quando, a metà del Seicento, non traslocarono in Trastevere vicino al Ponte Cestio.125
Per le finalità autorappresentative dei quattro rami annibaldeschi, quello di possedere una casa in città era un requisito censuario di ragguardevole importanza: esso annoverava tra i caratteri distintivi del cittadino e patrizio romano.126 Tanto più che il palazzo sito nell’Urbe fu l’unica proprietà architettonica di pregio che gli Annibaldi della Molara e di Zancati conservarono dopo la perdita, definitiva dalla fine del XVI secolo, dei loro castelli nella campagna romana.
Talvolta, per il vero, la casa di città era pervenuta a uno o all’altro ramo della famiglia in eredità trasversale: così il palazzo Molara a Trevi, già degli Arcioni, e così il palazzo Valentini della Molara in Trastevere, già di Mario Mattei.127 Circostanze similari erano destinate a mutare nuovamente il nome di queste stesse dimore, vale a dire in seguito a un’ulteriore trasmissione ereditaria determinata dall’estinguersi di una discendenza virile. Pertanto sulla metà del XVIII secolo il rione Trevi ospitava un «palazzo Grassi» che in passato era stato abitato dai Molara del ramo di Annibale, nonché la sede di un casato, quello d’origini fiorentine dei baroni Scarlatti, che nel 1710 aveva surrogato gli estinti Annibaldi di Zancati.128
124 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 15981699; BNCF, Ms. Gal. 162, c. 5, Bruto della Molara a Vincenzo Viviani, Pisa 31 marzo 1663.
125 Cfr. ASCR, ACa, b. 1360, s.n.; maSSimo, Memorie storiche cit., pp. 101, 135; Guide rionali di Roma, Rione XIII: Trastevere, a cura di L. Gigli, III, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1982, p. 106.
126 Cfr. Statuta almæ urbis cit., III, capp. LVILVIII.127 Cfr. ASCR, ACa, b. 1360, s.n.; B. Bernardini, Descrizione del nuovo riparti-
mento de’ rioni di Roma fatto per ordine di n.s. papa Benedetto XIV. Con la notizia di quanto in essi si contiene, Roma, G. Salomone, 1744, p. 55.
128 Cfr. Bernardini, Descrizione cit., pp. 5556; S. BorSi, Roma di Benedetto XIV. La pianta di Giovan Battista Nolli, 1748, Roma, Officina, 1993, p. 245; http://nolli.uoregon.edu/gazetteer.asp, II.Trevi, nn. 266, 270. Dal 1702 Antonia, figlia di Curio Gaetano e Domitilla Annibaldi di Zancati, fu consorte di Filippo Massimiliano Scarlatti. Cfr. B. SCherBaum, Die bayerische Gesandtschaft in Rom in der frühen Neuzeit, Tübingen, Niemeyer, 2008, pp. 183, 187 e nota. Curio Gaetano, unico maschio degli Anni
140 Alessandro Cont
Questi edifici non si ergevano quali presidio di vaste zone soggette all’esclusivo controllo politicodinastico degli Annibaldi, diversamente da quanto era accaduto nella Roma dei secoli XIII e XIV.129 Come ha comprovato Antonio Menniti Ippolito in una sua documentata indagine, il rione di Trevi nell’età barocca gravi tava piuttosto sul palazzo del Quirinale, la residenza prediletta dai pontefici che richiamava nella zona curiali e famiglie nobili, concorrendo pertanto a qualificarla e promuoverla maggiormente.130
Comunque, le proprietà annibaldesche potevano talora estendersi per un intero isolato o imprimere su questo il sigillo della loro presenza con un apporto toponomastico. Ne recano vivide tracce gli stati delle anime compilati ogni Pasqua dal parroco della basilica dei Santi XII Apostoli, a Trevi.
La dimora degli Annibaldi di Zancati non lasciò tracce nella denominazione della «insula de Ciccolinis», nella quale era compresa «passata la piazza SS. Apostoli entrato ch’si è la strada per andare a Monte Magnanapoli» (l’attuale via di S. Eufemia).131 Per contro, la vicina «insula maior de Molaria» derivò nel 1646 tale suo nome dal palazzo degli Arcioni della Molara, collocato nell’area oggi prospiciente le vie IV Novembre, delle Tre Cannelle e della Cordonata.132 A distanza di altri pochi passi, ridi
baldi di Zancati dopo la morte del nonno Giuseppe (15 agosto 1684), si spense il 30 giugno 1710, e la vedova Domitilla Annibaldi gli sopravvisse fino al 26 febbraio 1715. Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Morti 16931727, cc. 88v, 109r.
129 Sui fortilizi dei baroni nell’Urbe medievale e sulle aree che, assoggettate, li circondavano cfr. S. CaroCCi, Baroni in città. Considerazioni sull’insediamento e i diritti urbani della grande nobiltà, in Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi, a cura di E. Hubert, Roma, Viella, 1993, pp. 137173; id., Il nepotismo cit., pp. 177182.
130 Cfr. a. menniTi ippoliTo, I papi al Quirinale. Il sovrano pontefice e la ricerca di una residenza, Roma, Viella, 2004, in partic. pp. 140152.
131 ASCR, ACa, b. 1360, s.n. L’isola chiamata dal nome della dimora della famiglia Cigolini «incipit ab introitu platee oratorii Sancte Marie Montis Carmeli versus pla team SS. 12 Apostolorum, usque ad idem oratorium circumeundo»: ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16381651, c. 199r (a. 1650). Si inizia da via del Carmine in direzione ovest, si percorrono le vie delle Tre Cannelle, S. Eufemia e IV Novembre fino all’imbocco di via del Carmine che riconduce al punto di partenza.
132 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16381651, c. 133r (a. 1646). L’isola maggiore dei Molara «incipit a conventu Sancti Silvestri in monte Quirinali reverendorum patrum clericorum regularium, usque ad eundem descendendum per salicatam a latere dicti conventus, peragendo per viam Pilotte, capuccinorum
141La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
scendendo verso ovest, la «insula minor de Molaria» era formata da un isolato che, a dispetto della «insula maior», ricadeva in toto nelle mani di una famiglia Molara: quella della linea di Annibale.
L’agglomerato urbano che fino al 1646 recò il nome di «insula de Molaria» e poi di «insula minor de Molaria» per distinguerla dall’altra e più vasta ove risedevano gli Arcioni della Molara, era delimitato dalle presenti via del Carmine, via IV Novembre e via delle Tre Cannelle.133 La superficie totale era di circa 740 m2. Nel 1650 vi si ergevano il palazzo di famiglia, altre quattro abitazioni, il magazzino e la fontana. Tutti si trovavano accorpati in un complesso architettonico che rispondeva a molti bisogni dei proprietari e degli inquilini, con una gerarchia funzionale degli spazi ossequiente ai precetti della dottrina cinquesecentesca dell’eco-nomica. Mentre il casato padronale, un paio di domestiche e altri tre soggetti vivevano nel palazzo, gli edifici che ne disegnavano le propaggini erano occupati da affittuari e dai rispettivi servitori, totalizzando trentaquattro individui.134
Si deve osservare che a quel tempo era effimera anche la denominazione delle insulæ romane. L’isolato minore dei Molara venne a chiamarsi «de Bentivoliis» nello stato delle anime del 1676, poiché nel palazzo, ormai da sedici anni, risedeva la famiglia del
veterum, et ascendendo per aliam salicatam montis Caballi versus equos marmoreos a dextris semper»: ibid., c. 200v (a. 1650). Partendo dalla chiesa di San Silvestro al Quirinale, si scende a sud e poi a ovest per le vie XXIV Maggio, della Cordonata e delle Tre Cannelle, si prosegue per le vie IV Novembre, della Pilotta e dei Lucchesi, quindi si risale per via della Dataria, al termine della quale, sulla destra, si ritrova l’iniziale via XXIV Maggio.
133 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16381651, c. 200r (a. 1650). All’isolato era estranea la «turris de Molaria», in laterizi di fine sec. XII, che oggi fa angolo tra via IV Novembre e via delle Tre Cannelle guardando a ovest. Cfr. a. CameTTi, Chi era l’«Hippolita», cantatrice del cardinal di Montalto, «Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft», XV, I, ottobredicembre 1913, pp. 121122 nota; Guide rionali di Roma, a. negro, Rione II: Trevi, IV, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1995, p. 76. Nel 1678 il monumento era detto «turris Colonnensium prius dictum Molarie». Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16671692, c. 184v.
134 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16381651, c. 200 (a. 1650). Le prescrizioni della dottrina «economica» per la «fabbrica» della dimora aristocratica sono illustrate da d. Frigo, Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell’Economica tra Cinque e Seicento, Roma, Bulzoni, 1985, pp. 133145.
142 Alessandro Cont
conte Carlo Andalò Bentivoglio.135 Ma i legittimi proprietari restavano i Molara della linea di Annibale, che, trattenuti all’estero e in altre città dello Stato ecclesiastico, avevano affittato la loro dimora nell’Urbe a degli amici. E infatti dopo il 1689 negli stati delle anime non si incontra più né «insula minor de Molaria», né «insula minor de Molaria nunc de Bentivoliis», bensì una «domus e palazzo del signor Grassi».136 Il quale gentiluomo non era altri che il padre di Antonio Francesco de Grassis, dell’erede universale, cioè, nominato dal defunto presule Riccardo della Molara.
Con somma discrezione si perfezionò dunque l’atto delle consegne tra due famiglie della nobiltà municipale di Roma: i Molara del ramo di Annibale e i de Grassis. Dalla limitata incidenza politica di queste prosapie nel teatro europeo della corte pontificia non ci si sarebbe potuti attendere un esito molto differente. Del resto, la discendenza maschile degli Annibaldi della Molara era ancora rappresentata da personaggi operosi nella sfera cittadina e curiale dell’Urbe, come Giovanni, più volte citato, e Pietro Antonio che divenne canonico della basilica lateranense e commissario generale delle armi pontificie. Entrambi costoro erano nipoti ex patre di quel Riccardo che a metà del secolo XVII si era confrontato in tribunale con Giuseppe Annibaldi di Zancati.137
Si è già osservato che nella Roma settecentesca l’incombenza di vincere il tempo garantendo continuità alla memoria della famiglia Annibaldi della Molara restò affidata al ramo degli Arcioni della Molara, cioè a Giovanni e alla figlia Cleria avuta da Ca
135 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16521667, cc. 97v, 109r, 120r, 131v, 145v, 159r, 173r, 185v; Stati delle anime 16671692, cc. 11v, 28v, 57v, 74r, 86r, 103r, 121r, 141v, 148v.
136 ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16941699, c. 9v (a. 1694).
137 Cfr. ForCella, Iscrizioni cit., I, pp. 5, 7, 9, 12; Mostre di quadri cit., p. 114 nota; C. WeBer, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher. Elenchus congregationum, tri-buna lium et collegiorum Urbis (1629-1714), Rom, Herder, 1991, p. 79; id., Die päpstli-chen Referendare (1566-1809). Chronologie und Prosopographie, Stuttgart, Hiersemann, 2003, II, pp. 412413. Giovanni nacque da Annibale e Isabella Capranica nel 1658, il fratello Pietro nel 1660. Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stati delle anime 16521667, cc. 74v, 110r; Notizie per l’anno 1726, Roma, Stamparia del Chracas, 1726, p. 123.
143La famiglia Annibaldi della Molara in età moderna
terina Nunez.138 Per quello che concerne i Molara della linea di Annibale, usciti di scena quasi in punta di piedi, neppure il loro palazzo alle Tre Cannelle conservò le vestigia dei suoi antichi signori, cancellate da ripetuti rimaneggiamenti.139
Roma immancabilmente non sconfessava la sua eterna vocazione di ondivaga dispensatrice di fortune e di sventure familiari. Una casata che aveva goduto delle opportunità sociali ed economiche profferte dall’Urbe, aveva assistito a poco a poco al proprio declassamento, alla sua sostituzione da parte di nuove stirpi più agguerrite e vitali. Però gli incerti vincitori erano destinati a loro volta a cedere il passo ad altre famiglie e individui, non appena l’interruzione degli eredi maschi diretti, i fallimenti patrimoniali, le grandi riforme e rivoluzioni politicosociali ne avessero decretato la fine. Di tutto ciò le vicende legate alla dimora romana dei Molara della linea di Annibale sono un’eloquente conferma, documentando dal Sette al Novecento una teoria di soggetti che ne assunsero l’uno di seguito all’altro la proprietà integrale o parziale: dopo i de Grassis, vennero le famiglie dei Magnani, dei Biondi e dei Merolli, lo statista Giorgio Sidney Sonnino e infine una grande compagnia di assicurazioni agrarie.140
Forse una successione ereditaria regolata attraverso le puntigliose clausole di un fedecommesso avrebbe potuto attenuare taluni effetti prodotti dall’estinzione dell’antica e illustre casata. Poiché tuttavia Riccardo della Molara non intese cercare rifugio tra gli artifici fedecommissari, l’eclisse delle tradizioni della sua famiglia per opera di quella dei Grassis sopraggiunse ineluttabile. Non a caso, nel 1722, il corpo dell’ottantaquattrenne Vittoria Annibaldi della Molara, sorella minore di Riccardo, non fu tumulato presso i suoi avi nella chiesa ‘civica’ dell’Aracœli, bensì nella
138 Giovanni della Molara aveva sposato Caterina Nunez nel 1701 ricevendo una dote di 22 mila scudi. Cfr. la marCa, La nobiltà romana cit., II, p. 702 nota.
139 Cfr. negro, Rione II: Trevi cit., pp. 7980.140 Cfr. e. piSCiTelli, Una famiglia di mercanti di campagna: i Merolli, «Archivio
della Società romana di Storia patria», s. III, LXXXI, 1958, p. 159; BorSi, Roma di Benedetto XIV cit., p. 252; negro, Rione II: Trevi cit., pp. 7980. Nel 1800 il «palazzo Magnani» presso l’oratorio del Carmine era residenza del marchese Antonio Magnani e della sua consorte Lucia nata Sacripanti. Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Stato delle anime 1800, n. 263.
144 Alessandro Cont
cappella de Grassis della vicina basilica di San Marco.141 Anche dopo la sua morte, Vittoria seguitava dunque a fare parte in pri-mis della famiglia del suo defunto marito e dei suoi figli: in altre parole, della famiglia «del signor Grassi».
141 Cfr. ASVR, Parrocchia dei SS. XII Apostoli, Morti 16931727, c. 142r (5 marzo 1722). Per la data di nascita di Vittoria cfr. Archivio Capitolare di Perugia, Cattedrale di S. Lorenzo, Battesimi 16281695, c. 49r (23 dicembre 1637).