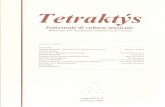Immagini e Testi dello Spazio Geografico nella Mesopotamia del III Millennio
La vulgata nella tradizione dei testi per musica
Transcript of La vulgata nella tradizione dei testi per musica
Direttori · EditorsSimone Albonico (Pavia) · Stefano Carrai (Siena)
Vittorio Formentin (Udine) · Paolo Trovato (Ferrara)
*
Comitato di lettura · RefereesGino Belloni (Venezia) · Saverio Bellomo (Venezia)Lucia Bertolini (Chieti) · Guido Capovilla (Padova)
Paolo Cherchi (Chicago) · Claudio Ciociola (Pisa, «Normale»)Luciano Formisano (Bologna) · Giorgio Inglese (Roma, «La Sapienza»)
Guido Lucchini (Pavia) · Livio Petrucci (Pisa)Marco Praloran (Losanna) · Brian Richardson (Leeds)
Francisco Rico (Barcelona) · Claudio Vela (Cremona-Pavia)Massimo Zaggia (Siena, Stranieri) · Tiziano Zanato (Venezia)
*
Redazione · Editorial AssistantFabio Romanini (Milano-Bicocca)
*
Per la migliore riuscita delle pubblicazioni, si invitano gli autori ad attenersi, nelpredisporre i materiali da consegnare alla Redazione ed alla Casa editrice, alle norme
specificate nel volume Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali,Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2004 (ordini a: [email protected]).
Il capitolo Norme redazionali, estratto dalle Regole, cit., è consultabileOnline alla pagina «Pubblicare con noi» di www.libraweb.net.
*
La Accademia Editoriale®, Pisa · Roma, pubblica con il marchio
Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma, sia le proprie riviste precedentemente edite con
il marchio Istituti editoriali e poligrafici internazionali®, Pisa · Roma, che i volumi
delle proprie collane precedentemente edite con i marchi Edizioni dell’Ateneo®, Roma,
Giardini editori e stampatori in Pisa®, Gruppo editoriale internazionale
®, Pisa · Roma,e Istituti editoriali e poligrafici internazionali
®, Pisa · Roma.
LA VULGATA NELLA TRADIZIONEDEI TESTI PER MUSICA
Carlo Caruso
Università di Durham e Siena
1.
n discorso sulla poesia italiana per musica non può che aprirsi con un accenno aitesti lirici antichi tornati recentemente alla luce. Com’è noto, sia la pergamenaravennate riesumata da Alfredo Stussi sia il frammento piacentino scoperto da
Claudio Vela recano, oltre ai testi, anche notazioni neumatiche. 1 In entrambi i docu-menti, al di là della mera compresenza sul supporto della scrittura, poesia e musica sem-brano intrattenere un mutuo rapporto funzionale: che è dato per certo nel caso delframmento piacentino, e per assai probabile – ancorché negato in prima istanza 2 – nelcaso della pergamena ravennate. Dunque i più antichi testi lirici italiani a noi noti, neidocumenti stessi che ce li tramandano in esemplare unico, hanno accanto a sé la musicaper la loro esecuzione. La recentissima comparsa a stampa degli Atti di un Convegnodedicato a queste due importanti testimonianze mi esime dal trattare argomenti per iquali non possiedo competenza specifica. 3 Con ciò anche prescindo dalla questione, cheper questi componimenti necessariamente si pone, della simultaneità della nascita dipoesia e musica, anche in rapporto al problema del cosiddetto ‘divorzio’ fra le due arti;e parimenti mi astengo dall’accennare alla questione dei contrafacta, di grande impor-tanza anche per i secoli successivi: problemi entrambi aVrontati e discussi da Maria SofiaLannutti. 4 Ma occorre almeno sottolineare come questo volume giunga in buon puntoper richiamarci all’importanza di quel «legame musaico» che proprio per i testi delleOrigini anche i più ottimisti avevano creduto, se non proprio del tutto inesistente, certoassai meno significativo di quanto non fosse, o apparisse, in altre età. I saggi accolti negliAtti illustrano inoltre come una più stretta collaborazione fra discipline diverse possacondurre alla revisione di nozioni e convinzioni date per acquisite, e contribuisca nellafattispecie a estrarre dal suo splendido isolamento la vicenda della lirica delle Origini,la cui ricostruzione sembra talora trascolorare nel mito (anche nel mito filologico) a sca-pito della storia. Infine, i ritrovamenti invitano implicitamente a valutare quanto abbiaimportato per la storia della civiltà letteraria italiana, sin dai suoi primissimi passi, la frui-zione in chiave di esecuzione canora del genere lirico: genere che per lunghi secoli – al-meno sino all’Ottocento – è superiore a ogni altro per prestigio e dovizia di testi. Talefruizione abbraccia testi espressamente composti per musica, così come testi rivestiti dinote in un momento successivo alla loro composizione. Da ciò discende una tradizionetestuale legata alla musica e all’esecuzione musicale, dunque una vulgata musicale deitesti, che può dirsi parallela alla tradizione letteraria; e che anzi in molti casi – più nu-merosi di quanto in genere non s’immagini – ci conserva in attestazione unica o plurimacomponimenti poetici di cui la tradizione letteraria non conserva più traccia.
1 Stussi 1999; Vela 2005.2 Nota musicologica di Claudio Gallico in appendice a Stussi 1999, p. 69.3 Lannutti, Locanto 2005, con bibliografia relativa.4 Lannutti 2005.
U
78 carlo caruso
Questa trattazione riguarda principalmente testi poetici aYdati a testimoni musicali,ed è di necessità ristretta a quegli ambiti in cui presumo di poter fornire un contributoconcreto alla discussione; e in anticipo mi scuso non solo per l’andamento piuttosto rap-sodico che organico del discorso, ma anche per una forse eccessiva insistenza su argo-menti da me già trattati in passato. 1
2.
Il filologo interessato alla tradizione musicale dei testi poetici si imbatte in una situa-zione nella quale l’elemento verbale, pur imprescindibile, è nel processo copiativo po-sto in secondo piano rispetto all’elemento musicale. Le parole, per la presunta parzia-le o minore attenzione di cui sono oggetto da parte di compositori e copisti musicali,appaiono maggiormente esposte a quelle alterazioni che comunemente si dicono cor-ruttele: onde l’impressione che i testimoni musicali poco possano contribuire alla con-stitutio textus dei versi. Ma la tradizione musicale dei testi poetici comporta ben altroche semplici corruttele. Essa è di per sé estremamente (e consapevolmente) produt-tiva e mutevole: perché accanto alle alterazioni banalizzanti, tipiche di ogni vulgatatestuale, accoglie anche le alterazioni promosse dalla prassi esecutiva; si dimostrainoltre generalmente propensa al rimaneggiamento, per quell’urgenza di ottenere econservare vivo l’incontro con il proprio pubblico che è caratteristica principe dei ge-neri i cui testi sono destinati all’esecuzione e alla rappresentazione. Di qui un ancorpiù vivace e variegato movimento, insieme con il testo musicale, anche del testo poe-tico: tanto più interessante, ove si consideri che tale vulgata esecutiva può anche es-sere, come spesso è, promossa o autorizzata, per la parte che lo riguarda, dal poetastesso. Negli odierni studi filologici tutto, o quasi, sembra essersi come d’incanto di-namizzato, per cui autografi, apografi e persino archetipi vengono spesso detti, a tor-to o a ragione, ‘in movimento’. Io spero di non essere accusato di cedere alla modaimperante se aggiungerò a questo elenco anche la nozione di ‘vulgata in movimento’:formula che mi pare quanto mai adatta a definire il tratto saliente della vulgata mu-sicale dei testi poetici.
L’entità delle alterazioni consapevoli che riguardano il testo verbale si situa fra i duepoli del minimo ritocco eufonico o ritmico da un lato, e della soppressione, e più rara-mente aggiunta, di parti del testo dall’altro (ma può anche agevolmente oltrepassarequest’ultimo limite e risolversi in un rifacimento globale del testo). Ne segue che la frui-zione della poesia attraverso l’esecuzione musicale, quindi attraverso l’ascolto piuttostoche la lettura, si appaga non di rado di un testo variato o parziale, e in molti casi ade-spoto. Faccio un gran salto innanzi, e ricordo che sul principio del suo fondamentalesaggio La melica italiana dalla seconda metà del Cinquecento al Rolli e al Metastasio, riferen-dosi alle «ariette d’Italia bella» e alla loro amplissima circolazione all’inizio del secolodecimottavo, Carlo Calcaterra osservava: «Donde venissero, come si diVondessero, achi fossero dovuti i versi, a chi la musica, spesso non si sapeva né si cercava». 2 E ram-mentava l’episodio di una celebre canzonetta, L’inverno è alla montagna, che nel 1728 aParma, Carlo Innocenzo Frugoni ravvisava come «canzone d’incerto autore» allora al-lora «scappata fuori», e subito intonata dalle dame di Parma dopo che al testo era stataadattata una gradevole melodia: tutto ciò a dispetto del fatto che i versi in questione erano stati pubblicati appena l’anno prima a Londra dall’autore stesso, il tutt’altro che
1 Fondamentale per il discorso qui appena accennato è l’introduzione di Maria Caraci Vela a CaraciVela 1995, pp. 3-35. 2 Calcaterra 1926, p. i.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 79
ignoto Paolo Rolli. 1 Non meno esemplare è l’altro caso, famosissimo, dell’ottuagenarioGoethe intento a dettare nel 1828 l’autobiografico Dichtung und Wahrheit, e ancora predadell’impressione ricevuta negli anni dell’infanzia dal suono delle parole melodiose, ancorché incomprensibili, di un’altra e più celebre canzonetta rolliana, Solitario boscoombroso: della quale però – a conferma di quanto si è venuto dicendo – nelle memoriegoethiane non è ricordato l’autore. 2 I modi stessi di una siVatta tradizione testuale sem-brano dunque congiurare al sacrificio di un’informazione, qual è quella riguardante lapaternità di un testo, tutto sommato non essenziale, e anzi irrilevante, per il godimentoestetico dell’esecuzione musicale del testo stesso. Né sarà sfuggito come, nella letteradel Frugoni testé citata, la ricezione di L’inverno è alla montagna si traduca immediata-mente in un adattamento della stessa a una nuova musica, con prevedibili aggiustamen-ti anche verbali. Frugoni stesso riconosce di essersi subito provato a imitarla, compo-nendo due nuovi testi «sulla misura di detta canzone»: intertestualità tipica del genere,promossa, piuttosto che dal contenuto, dalla «misura», cioè dal metro, nonché – si puòforse aggiungere – dalla musica e da ogni altro aspetto fonico-ritmico legato a quel me-tro, come rime, accenti e così via, e che ha per risultato finale qualcosa di molto simileal medievale contrafactum. 3 Del resto, quale altro trattamento si sarebbe dovuto serbarea un testo che si presentava, sin dai primi stadi della sua diVusione, come res nullius?
3.
Anche passando a calcare terreno apparentemente più saldo, qual è quello costituitoda componimenti attestati in manoscritti e stampe musicali, ci si trova spesso in condi-zioni non dissimili. Nei testimoni musicali le indicazioni di paternità del testo verbalesono notoriamente rare: non sarà un caso che la conferma della paternità si cerchi diregola fra le attestazioni di manoscritti e stampe del solo testo poetico. Un esempio elo-quente a questo proposito è costituito dalla «dolorosa istoria» – come ebbe a definirlaAntonio Enzo Quaglio – della vicenda testuale delle canzonette di Leonardo Giusti-nian, che dall’edizione Wiese (1883) sino ai più recenti contributi ha occupato e occupaun posto di rilievo nella storia della filologia italiana. 4 In materia di attribuzione la vul-gata è di regola generosa e accogliente, e pertanto scarsamente selettiva; tanto più nelcaso di un autore che, come Giustinian, abbia goduto di grande rinomanza in vita e neidecenni successivi alla morte: il termine stesso di ‘giustiniana’ denota il successo tra-volgente di un genere che in lui riconosceva il proprio maestro, ma che del maestro an-che annacquava i tratti distintivi in una ‘maniera’ non sempre consona per stile. Il ten-tativo di rivendicare al Giustinian testi che ricorrono anonimi nei manoscritti musicaliquattrocenteschi, e di cui si ha riscontro in una tradizione letteraria non sempre al disopra di ogni sospetto, è stato compiuto più volte. 5 È certo che tali testi non meritanodi essere posti da parte senza almeno conceder loro il beneficio del dubbio, come delresto già riconosceva Giuseppe Billanovich; 6 e il documentato impegno del Giustiniannel definire un proprio canone di testi soprattutto per opera di levare fa sì che la pre-senza di ‘residui d’autore’ diventi altamente probabile nella vulgata musicale di età alta,quella appunto maggiormente indagata nei contributi più recenti. Diverse le ipotesiavanzate: alcune plausibili, altre solo suggestive; che ve ne siano anche di interamente
1 Rolli 1727, contenente – caso non frequente per edizioni di poesia melica – un’appendice di melodieadespote (del medesimo Rolli?) per l’esecuzione delle dette canzonette.
2 Bellina, Caruso 1998, p. 260. 3 Caruso 1992, pp. 419-24.4 Quaglio 1988, p. 164, con indicazione della bibliografia pregressa.5 Fallows 1995 e Harrán 1998, con bibliografia relativa. 6 Billanovich 1937, p. 228.
80 carlo caruso
persuasive non oserei dire, perché l’incontro tra musicologia e filologia dei testi lette-rari – premessa essenziale alla comprensione e all’eventuale soluzione dei problemiprospettati – mi pare che in questo caso sia avvenuto (quando è avvenuto) a un livellopoco più che superficiale.
Il rinvenire il nome dell’autore di testi che si presentino come anonimi nella tradizio-ne musicale è tuttavia, come ognuno sa, compito tutt’altro che facile. 1 Per rompere ilmuro dell’anonimato gli incipitari di testi poetici sono e restano gli strumenti più validi,quantomeno nella fase iniziale della ricerca. Se tali repertori di base non sono suYcienti,ci si aYda, ove esistano, a repertori specifici, tanto più utili quanto più larghi sono i cri-teri che li informano. Di uno di questi in particolare mi sono giovato aiutando un col-lega nell’organizzazione di un concerto di madrigali cinque-secenteschi, un congruonumero dei quali, al di là di quelli istantaneamente attribuibili ai ben censiti Tasso, Gua-rini e Marino, restava senza paternità. Ma buona parte di ciò che non compariva nelNuovo Vogel, nel rism, nel Lincoln o nello iupi poté rinvenirsi negli incipitari della mo-numentale Bibliografia delle opere a stampa di Giovan Battista Marino di Francesco Giam-bonini, strumento insostituibile per la lirica del Seicento e precipuamente della liricaraccolta in antologie, di molte delle quali – tutte quelle, e sono molte, contenenti testimariniani – Giambonini ha sistematicamente censito il contenuto. 2 Anche strumentimeno sofisticati, tuttavia, possono riuscire ancora utili. Per un concerto di arie e roman-ze italiane, allestito da un altro collega che desiderava riproporre il programma di unasoirée zurighese degli anni trenta dell’Ottocento, si pensò che in area germanofona, siapure in pieno secolo decimonono, la parte del leone spettasse ancora a Metastasio; e in-fatti, tramite l’incipitario delle arie dell’edizione Brunelli, si riuscì subito a identificarequattro degli otto pezzi in programma. 3 Ma anche così le caselle vuote rimanevano co-munque molte. È prevedibile che i nuovi strumenti informatizzati ancora in via di alle-stimento, come il repim e il Nuovissimo Vogel, 4 faranno compiere un decisivo passo in-nanzi alle ricerche in questi ambiti.
4.
Nel trattare della vulgata musicale dei testi ho finora quasi sempre accennato alle tur-bative: corruttele, alterazioni, perdita del paratesto. La natura diVerenziale della tradi-zione musicale rispetto a quella ‘letteraria’ è però tale anche in positivo. È nozione ac-quisita, ma tutto sommato non ancora suYcientemente messa a frutto, che lacircolazione di un testo in manoscritti o stampe musicali sia di norma anteriore all’ac-coglimento dei versi in un testimone letterario, manoscritto o stampa. Altrettanto ac-quisita è la nozione che la tradizione musicale possa accogliere varianti poetiche d’au-tore. Sono fatti che non dovrebbero destare stupore, perché è naturale che sia così. Male testimonianze musicali restano spesso poco ricercate o compulsate dai filologi e daglistorici della letteratura, forse in virtù della loro appartenenza a un’altra ‘parrocchia’. Icasi relativi al già citato Giustinian, all’Aquilano, al Tasso, al Guarini, al Marino – per ci-tare nomi fra i notissimi – mostrano però quanto possa riuscire fruttuosa un’indagine
1 A proposito di Giustinian e di altri autori quattrocenteschi si veda Cattin 1990.2 Giambonini 2000. 3 Brunelli 1943-1954.4 Il repim (Repertorio della poesia italiana in musica), progetto coordinato da Lorenzo Bianconi, Angelo
Pompilio e Antonio Vassalli, mira all’identificazione degli autori dei testi poetici musicati nei secoli xvi exvii. Il Nuovissimo Vogel-nnv, in corso di realizzazione per le cure di Angelo Pompilio, prevede la scheda-tura di tutte le raccolte a stampa di musica profana e devozionale in lingua italiana edite lungo il mede-simo arco di tempo.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 81
di questo genere. 1 Per quanto ho potuto direttamente constatare, la situazione in cui cisi imbatte nella tradizione testuale di arie e cantate settecentesche non è sostanzialmen-te diversa. Questo naturalmente non comporta che, una volta stabilita la seriorità deltestimone letterario, anche la cronologia relativa delle varianti debba ritenersi automa-ticamente risolta. A rigore, la data più tarda del testimone letterario indica niente più diun terminus ante quem. Ciò significa che il testo della tradizione letteraria può essere, co-me spesso in eVetti è, una versione seriore rispetto a quella che compare nei testimonimusicali: da questa derivata, e rivista e corretta nella prospettiva di una fruizione emi-nentemente letteraria. Ma il testo restituitoci dalla tradizione letteraria potrebbe altresìrivelarsi come la versione primigenia, che il poeta avrebbe poi adattato per il composi-tore: per cui, in questo secondo caso, la redazione seriore ci sarebbe conservata dallatradizione musicale. Come in tutti i problemi di natura filologica, ogni caso richiede diessere valutato con criteri definiti ad hoc.
È opportuno ancora osservare come una diversa prospettiva critica faccia assumerea una medesima testimonianza due significati e due valori diVerenti. Si dia il caso piùcomune, quello cioè di un testo primamente attestato nella tradizione musicale e in se-guito accolto, con correzioni progressive, nella tradizione letteraria: il sonetto Laura, delvostro lauro in queste carte di Torquato Tasso. Secondo l’edizione oVertane da Bruno Bri-zi, la prima attestazione è quella della silloge musicale Il lauro verde. Madrigali a sei vocidi diversi autori (Ferrara, per Vittorio Baldini, 1583), riedita nel 1591 ad Anversa e nel 1593
a Venezia. 2 Queste tre stampe danno l’avvio alla vulgata musicale, della quale, perquanto si sa, Tasso non ebbe mai a curarsi. La vulgata letteraria, invece, sottoposta alpuntiglioso suo scrupolo di correttor di se stesso, presenta tre diversi ‘stati’ del testo: ri-spettivamente nelle Rime et prose del 1586, nelle Rime del 1591, e finalmente in un esem-plare postillato di quest’ultima edizione. 3 Si viene qui a toccare con mano un aspetto ti-pico della tradizione di testi intonati: l’esistenza di due tradizioni parallele, ugualmentelegittime e ugualmente ‘prestigiose’, che dipartìtesi dal medesimo punto procedono poiper linee parallele l’una accanto all’altra. Si noti inoltre come il testo che nella prospet-tiva dell’ultima volontà d’autore rappresenta solo uno stadio iniziale, nella prospettivadella tradizione musicale è invece il testo vulgato.
5.
È risaputo che nelle vulgate testuali si annidano lezioni spurie o palesemente scorrette.Ciò è tanto più vero nel caso della vulgata musicale, dove, per le condizioni cui si accen-nava prima, il testo verbale appare più esposto ad alterazioni di tal fatta. Ma le esitazioninei confronti di un eventuale intervento inteso a sanarle si fanno in questo ambito piùforti: come può intendersi da un semplice sguardo alla prassi ecdotica dei musicologi.Se ai filologi della letteratura è infatti accaduto di indulgere, magari più spesso del lecito,all’ideale – e forse al pregiudizio – del testo ‘ricostruito’, dal canto loro molti musicologisembrano aver palesato un’opposta e forse eccessivamente tenace preferenza (a qualcu-no sarà parso feticismo) per la vulgata del testo letterario. La ragione principale di que-sto atteggiamento risiede, credo, in quel ‘doppio legame’ – per utilizzare una celebremetafora chimica di Primo Levi – che s’instaura fra testo e musica, e che, una volta sta-bilito, è, nel bene come nel male, diYcilmente solubile senza pregiudizio di una soddi-sfacente esecuzione del ‘doppio testo’, che è anzi oramai un testo a sé. 4 Tale legame è
1 Cattin 1990; Brizi 1995; La Face Bianconi, Rossi 1995; Pompilio, Vassalli 1997; La Face Bianconi, Rossi1999; Giambonini 2000. 2 Brizi 1995, pp. 17, 22, 29; Basile 1994, nº 192.
3 Brizi 1995, p. 22. 4 Castelvecchi 1994, p. 312; La Face Bianconi 1994.
82 carlo caruso
inoltre rinsaldato proprio dal più volte citato, in questa sede, ‘prestigio storico’ della vul-gata: che in ambito musicale e musicologico ha agito sia attraverso le grandi edizionisette-, otto- e novecentesche degli Opera omnia (almeno per i grandi compositori), sia,più in generale, attraverso la prassi concertistica.
Intervengono infine ragioni di gusto, anch’esse aVerenti all’influsso esercitato dallatradizione esecutiva. Ha naturalmente ragione Maria Caraci Vela nel fare netta distin-zione, anche a fini metodologici, tra la filologia musicale da un lato, che si occupa dimusica scritta, e la prassi esecutiva dall’altro, che si occupa invece di musica da eseguire. 1
Ma quando in un consesso di filologi – come è anche il caso nostro – si viene a trattaredella vulgata e del suo prestigio storico, ci si trova d’improvviso in una zona grigia, dovele ragioni dell’una e dell’altra parte avanzano fino a toccarsi e confondersi. Mi sia con-sentito un esempio, forse banale, ma indicativo di ciò che gli odierni direttori d’orche-stra devono aVrontare nel momento in cui applicano i criteri della filologia d’autore acomposizioni per il teatro d’opera. Ricordo infatti distintamente, a questo proposito, ladelusione di amici melomani ogniqualvolta venisse annunciata in cartellone un’operadi Rossini fondata sull’edizione critica. Era come se, con l’eliminare tutte quelle varia-zioni e infiorettature con le quali generazioni di cantanti avevano arricchito la tradizio-ne esecutiva, venisse negato al pubblico il divertimento principale, fors’anche la ragioneprima di assistere a un’opera del genere. Nostalgico attaccamento a un uso passivamen-te accettato? Forse. Ma anche legittima e fondata percezione di uno stile – il virtuosisticostile del belcanto – che di tali variazioni, indubbiamente spurie e a quanto pare non sem-pre gradite allo stesso Rossini, aveva fatto uno dei propri punti di forza. In casi comequesti il ritorno alla lezione autentica, genuina, deve fare i conti con le aspettative di unpubblico presso il quale continua a perpetuarsi una tradizione non d’autore, ma stori-camente ed esteticamente non del tutto ingiustificata. È insomma un dissidio analogoa quelli in cui si contrappone la lettera allo spirito del testo: per i quali, com’è noto, visono in genere scarse speranze di soluzione.
Ma queste aspettative, sia pure in forma più pacata e meno clamorosa, non esistonoforse anche presso quel pubblico di lettori adusato a un certo modo di fruire i nostri clas-sici, specie i più noti? Non si è forse sobbalzati dinanzi a un Boiardo restituito da AntoniaTissoni Benvenuti a una lingua e a una versificazione ben più scabre di quanto una vul-gata a lungo limata dagli editori – e sulla quale pesava tuttavia, in maniera forse irrifles-sa, l’ipoteca secolare del rifacimento del Berni – ci avesse invece abituato? E non ci si èparimenti allarmati – ma per motivi opposti – dinanzi al Dante di Federico Sanguineti,che a fronte del Dante dell’«antica vulgata» di Petrocchi è parso oVrire un testo quasibanalizzato (o forse solamente meno eclettico)? Del resto, il Dante di Petrocchi avràscosso a sua volta il lettore abituato al Dante del Centenario (1921), e così via su su finoal Dante del 1595 e a quello delle famose (o famigerate) Terze rime bembine del 1502. Epoi la nostra percezione di lettori di un certo testo non si arresta alla lettura di quel testo,ma anzi, in virtù della natura stessa di tanta nostra poesia, ispirata a un ideale classici-stico di imitazione e di dialogo intertestuale, ci richiama implicitamente anche ai mo-delli dell’autore del testo in questione: il Dante di Ariosto o di Tasso – e mi scuso perl’ovvietà che sto per dire – non era certo quello dell’«antica vulgata» o dell’Urbinate,bensì, presumibilmente, quello edito dal Bembo, o un derivato di esso. La forza dellavulgata dei testi agisce comunque su di noi, lo si voglia o no; e la consapevolezza dellacomplessità del fenomeno della fruizione letteraria non può che arricchire e aYnare inostri metodi d’indagine sui testi stessi.
1 Caraci Vela 1995, pp. 10-12.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 83
6.
Torno alle diVerenze fra tradizione musicale e tradizione letteraria dei testi per spinge-re l’argomentazione un poco oltre. L’aneddoto della prima reazione di Goethe al-l’ascolto di Solitario bosco ombroso, rammentato poco sopra, riesce forse emblematicoanche per altri rispetti. Un giovinetto che ascolta la madre cantare un’odicina in italianosenza intenderne il senso, ma tuttavia persuaso, sia pure ingenuamente, di poterne co-munque ricavare quell’idea di quintessenziale ‘italianità’ che doveva rimanergli fitta incapo per il resto della sua lunga vita: non è questo un aspetto tipico della ricezione deltesto musicato, cioè la comunicazione che avviene al di là del senso delle parole? 1 An-che qui si trascende l’àmbito proprio della filologia, perché un testo privo di senso, oquantomeno dal senso imperfetto, è, per un filologo, inagibile e dunque, almeno in li-nea di principio, inaccettabile. Ma scendendo nuovamente sul piano delle attestazioniscritte, in molti testi restituiti dalla vulgata musicale ci si imbatte in passi il cui senso èsfocato, incerto, talora addirittura assente, e tuttavia – in sede d’esecuzione – raramen-te avvertito come tale. Credo per esempio che pochi abbiano avvertito il senso non per-fettamente perspicuo dei versi che precedono la celebre aria La donna è mobile in Rigo-letto, iv, i: «duca Due cose, e tosto. sparafucile Quali? / duca Una stanza, e del vino./ rigoletto [dall’esterno] Son questi i suoi costumi! sparafucile Oh il bel zerbino!». 2
Che male c’era, si chiederà, nel chiedere una stanza e del vino, sì da suscitare l’irosareazione di Rigoletto e l’ironia scanzonata di Sparafucile? Ma l’autografo di Verdi, co-me ben sanno i musicologi, reca «Una stanza» in soprascritta, mentre il verso originale,cassato a causa dell’intervento della censura, leggeva invece: «Tua sorella, e del vino». 3
L’originale è indubbiamente e intenzionalmente più forte ed eYcace, perché la rozzasensualità del Duca deve palesarsi all’ancora innamorata Gilda (condotta dal padre Ri-goletto ad assistere alla scena dall’esterno della locanda) in tutta la sua brutalità. Ma ilpubblico, anche in virtù della successiva scena fra Maddalena e il Duca, non dura co-munque fatica a intendere che quest’ultimo si è recato alla locanda per godervi qualcheora d’amore mercenario. E del resto né Piave né Verdi – particolare che ha pure la suaimportanza – sentirono mai il bisogno di ritornare su quella lezione coatta per resti-tuirla alla sua forma primigenia: per cui «Una stanza, e del vino» restò la lezione accoltae approvata da entrambi. 4
Sembra insomma prevalere, in casi di questo genere, una nozione di senso per cosìdire ‘suYciente’: magari non interamente perspicuo, e tuttavia sostenuto da tutte quellealtre componenti legate alla notazione e all’esecuzione – melodia, armonia, accenti, mi-mica, gestualità, e in rappresentazioni operistiche anche scene, luci, movimenti sul pal-co, abiti – che rendono la parola, almeno in certi frangenti, di secondaria importanza,se non addirittura superflua.
1 Anche se il ricordo dell’esperienza giovanile di un apprezzamento del suono delle parole, prima an-cora che del loro senso, sembra obbedire a un topos antico: Agostino, Confessioni, v 13, sulla suavitas dellatino di Ambrogio, e Petrarca, Senili, xvi 1, sulla dulcedo del latino di Virgilio e Cicerone.
2 Francesco Maria Piave, Rigoletto, in Chusid 1983, i, p. 258; Gronda, Fabbri 1997, p. 1326.3 Chusid 1983, i, p. 258; ii, pp. 74-75.4 Come tale, essa dovrebbe dunque figurare anche nel testo critico, dove invece è promosso a testo
«Tua sorella, e del vino» (Chusid 1983, p. 258). Che questa sia naturalmente la lezione preferita da registie direttori d’orchestra odierni, si capisce e si giustifica per le ragioni accennate sopra; ma un’edizione cri-tica, piaccia o non piaccia, deve innanzi tutto fondarsi su quanto è eVettivamente restituito dai testimoni.Si veda in proposito Caruso 2004, pp. 218-19.
84 carlo caruso
Questo significa che non si dovrà intervenire nemmeno quando ci si imbatte in un er-rore materiale e palese? Certo, se in un’aria autografa di Händel mi capita di leggere ilseguente testo: «Nubiloso fra tempeste / cangia in furie le sue stelle / e col mare e conla terra / mi fa guerra il cielo e amor», io non ho dubbi che l’ultimo verso vada emen-dato: «mi fa guerra il cielo ancor». 1 Ma in altri casi meno evidenti occorrerà cautela, per-ché forte è il rischio di intervenire dove invece non si dovrebbe; persino nei casi in cui iltesto, in origine diVerente e indubbiamente migliore, è stato poi manipolato per unaqualche ragione, come si è visto poco sopra nel caso di Verdi, e non è più stato riportatoalla lezione autentica. È insomma necessario, per il filologo, saper assegnare il giusto va-lore alla mutata natura di parole messe in musica: poiché il ‘senso’ di un testo destinatoalla pura lettura, o anche alla recitazione, può avere esigenze e priorità diVerenti daquelle di un testo destinato invece alla notazione e all’esecuzione canora; e per quellasorta di accordo – tacito o esplicito – che s’instaura nel momento in cui il poeta conse-gna i propri versi nelle mani del musicista o del cantante, quegli stessi versi possono es-sere manomessi, se le circostanze lo richiedano, a fini che non collimano necessaria-mente con quelli di una fruizione puramente ‘letteraria’.
Occorre inoltre aggiungere che la nozione di lectio diYcilior può riuscire qui inoppor-tuna, perlomeno nell’accezione in cui essa è comunemente intesa. S’intende che il criterio della lectio diYcilior, per risultare eYcace, dev’essere adattato di volta in voltaall’età, al genere, all’usus scribendi dell’autore: deve essere cioè costantemente e adegua-tamente contestualizzato. Resta tuttavia il fatto che esso è stato divisato per testi stilisti-camente sostenuti, dove il senso, spesso anzi un senso non ovvio, è il presupposto primodel funzionamento della comunicazione fra il poeta e il suo pubblico seletto: un poetache nella maggior parte dei casi si appaga, e anzi si studia, di rivolgersi paucis lectoribus.Ora molta poesia per musica tende esattamente verso il polo opposto: si assiste infattia una forte semplificazione della lingua in ogni suo aspetto – lessicale, sintattico, meta-forico – che per certi versi si avvicina, e talora si sovrappone, alle caratteristiche dellapoesia popolare. Ne segue che una sottile casistica filologica, forgiata e aYnata su versidi ardua testura dove lessico e sintassi – per rimanere al livello puramente grammaticaledella lingua – tendono di proposito alla complessità e alla ricercatezza, male si adatta aun linguaggio che invece presenta e persegue una dizione di complessità considerevol-mente inferiore. Del resto, è proprio in tale radicale semplificazione che la lingua dellapoesia melica trovò il presupposto non solo di un’eYcace alleanza con la musica, maanche del congiunto successo a livello internazionale. 2
7.
Sono gli strumenti critici delle due discipline – della filologia di testi letterari e della filo-logia musicale – incompatibili? Io credo di no. Il dovuto rispetto reciproco per le diversecompetenze settoriali non preclude, né deve precludere, la collaborazione. Certo, laprassi editoriale dei testi per musica che va imponendosi oggigiorno, e a buon diritto,è quella del testo a doppia uscita: testo per la lettura e testo per l’esecuzione musicale,magari per buona parte o in tutto e per tutto coincidenti, ma di fatto due testi distinti.Ciò non significa però che i due (o più) testi paralleli non possano giovarsi di un riscon-tro vicendevole. I timori, invero un poco irrazionali, di chi in ambito musicologico ha
1 Caruso 1993a, p. xxxi.2 Per cui Dionisotti 1967, p. 85 parla di linguaggio «genialmente semplificato» a proposito di Metasta-
sio, intendendo quest’ultimo come il supremo rappresentante del genere melico e melodrammatico.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 85
paventato e paventa l’uso ‘combinato’ delle fonti come sintomo di cedevolezza versoinaccettabili pratiche contaminatorie, sono stati eYcacemente dissipati, mi pare, da Ma-ria Caraci Vela e da Reinhard Strohm. 1 Vero è che, a proposito del testo verbale, ClaudioVela ha sottolineato (del resto opportunamente) come i testimoni musicali non possanoessere posti sul medesimo piano dei testimoni letterari; ma occorre anche dire che lasua proposta di assegnare alle varianti da loro recate, in linea di principio, mero valoredi lectiones singulares pare in eVetti un po’ troppo restrittiva. 2 E infatti Mila De Santis haeYcacemente ribattuto sottolineando come sia in realtà «diYcilmente ascrivibile al mu-sicista una riscrittura integrale, o comunque di ampie proporzioni, di un componimen-to poetico», dal momento che il suo intervento si lascia piuttosto «sospettare in singolesostituzioni lemmatiche o nella mancata musicazione di parti del componimento stes-so». 3 Quando poi si tratti di collaborazione accertata fra poeta e musicista, e non di sem-plice musicazione di un testo poetico liberamente circolante, ci si può spingere un pocopiù in là coll’aVermare, da un lato, che, fatte salve tutte quelle pseudovarianti tipichedella composizione musicale e quindi attribuibili senza diYcoltà al compositore – quali,per fare un esempio classico, le ripetizioni di segmenti di testo –, le varianti ‘di sostanza’presenti in partitura debbano, in linea di principio e fino a prova contraria, essere asse-gnate al poeta; dall’altro, che distinzioni rigide in una situazione di responsabilità con-divisa sono forse controproducenti. 4 Né sarà un caso che il concetto stesso di ‘volontàd’autore’ sia entrato in crisi giusto a proposito della poesia per musica, e più in partico-lare della librettistica, sì da generare un’impostazione filologica con al centro non tantogli artefici, quanto l’opera nella sua complessa natura ‘mista’. 5
Credo tuttavia che ancora persista un pregiudizio, come già accennavo prima, duroa morire: che cioè quanto contenuto in una partitura debba interessare solo e unicamen-te i colleghi musicologi. Ma è proprio l’alterità del testimone musicale, la sua ‘sfasatura’rispetto ai testimoni letterari – sfasatura cronologica e tipologica insieme – che consen-te di penetrare nell’oYcina degli artefici di un testo per musica, e isolarvi gli stadi pro-gressivi del loro congiunto operare: un qualcosa, cioè, che la disamina dei soli testimoniletterari non potrebbe in alcun modo oVrire. Il vasto campo delle collezioni di mano-scritti musicali è un immenso e ancora assai poco sfruttato serbatoio di quelle che siamosoliti chiamare varianti d’autore. Non che io auspichi un ripetersi di certi allarmanti ac-cumuli di varianti provocati dall’estremizzazione del concetto di filologia d’autore: tan-to più in ambiti, come per esempio quello del dramma per musica, dove di tali variantisi potrebbe cogliere amplissima e anzi sovrabbondante messe. Ma se diretto all’analisie alla valutazione di modi diVusi e generalizzati di comporre, sì da individuare costantie variabili di un tipo di poesia che è stato spesso detto, non senza ragione, formulare,allora un confronto a largo raggio fra libretti e relativi testimoni musicali sarebbe dav-vero il benvenuto. Né mancherebbe lo stimolo di poter iniziare da un grande autore, ilpiù grande, forse, di quanti abbiano mai scritto per musica: Pietro Metastasio. L’eccel-lente edizione sinottica su Cd-Rom delle versioni autorizzate dei suoi drammi, curatada Anna Laura Bellina, Luigi Tessarolo e collaboratori, è già di per sé uno splendido tra-guardo del progetto editoriale tuttavia in corso, ma è al contempo una mirabile occa-sione per chi, da tale solida base, desideri estendere l’indagine alla tradizione nel suocomplesso, comprensiva dei testimoni musicali. 6
1 Caraci Vela 1995, pp. 16-18; Strohm 1995. 2 Vela 1984, p. 17.3 De Santis 1995, p. 58, nota; De Santis 2000.4 Castelvecchi 1994, p. 311; Caruso 1995, pp. 435-46.5 Accorsi 1989; Gronda 1990; Bianconi 1995. 6 Bellina, Tessarolo 2003.
86 carlo caruso
Sono infine persuaso del fatto che il testo poetico restituito dalla partitura possa es-sere eYcacemente chiamato a emendare il testo del libretto in quei casi in cui l’edizionea stampa, per il processo di riproduzione tipografica che le è proprio, conduce alla per-dita meccanica di uno o più versi; così come, per le medesime ragioni, il testo restitui-toci dal libretto – o dalla stampa in volume – può a sua volta migliorare quello, diversa-mente corrotto, trasmessoci dalla partitura. Tutto questo, s’intende, dopo che si siasoppesato e valutato con la dovuta cautela natura e cronologia dei testimoni e delle varianti nelle due tradizioni parallele, e individuato quale partitura (l’autografo? la partitura di direzione? un apografo autorevole?) e quale libretto (la prima stampa? unariedizione? un esemplare emendato?) possano profittevolmente essere fatti ‘reagire’ insieme. 1 All’antico adagio scolastico distingue frequenter s’ispira necessariamente anchelo studioso di testi per musica.
8.
L’aneddotica, anche quotidiana, ci palesa l’influsso prepotente, quasi ammaliante, chela vulgata musicale esercita sui testi poetici fruiti attraverso il suo filtro. Un collega eamico mi confessava tempo fa di non saper più ripetere mentalmente il verso conclusivodel componimento Der Erlkönig di Goethe – «In seinen Armen das Kind war tot» (‘nellesue braccia il bimbo era morto’) – senza automaticamente inserirvi, in maniera aVattoirriflessa, la lunga e drammatica sospensione enunciativa che Schubert divisò fra war etot nella sua celebre intonazione del pezzo, 2 con eYcacissimo eVetto ‘ritardante’ intesoa isolare l’estrema, tragica parola. Un altro amico, narrandomi di una messinscena delMariage de Figaro di Beaumarchais cui aveva assistito, mi diceva di essersi più volte sorpreso nel vedere gli autori entrare in scena recitando, e non cantando: evidente -mente per il condizionamento esercitato su di lui dalla versione operistica di Da Pontee Mozart.
Piuttosto però che insistere sull’aneddotica, mi pare proficuo riflettere sull’eventua-lità che la vulgata musicale possa rivelare aspetti del testo verbale che, nella tradizionetestuale letteraria, rimangono invece inespressi. In altri termini: un testo cantato è untesto enunciato, eseguito; a tal fine esso richiede una serie di indicazioni specifiche – in-tonazione, tempi, pause, dinamiche, ecc. – che ci sono trasmesse (quando lo sono) daitestimoni musicali, mai però (o quasi mai) da quelli letterari. Possono queste indicazio-ni, che sono per l’appunto tipiche della tradizione musicale dei testi, trasmetterci nozio-ni utili anche a intendere aspetti del testo poetico che non sapremmo come altrimentiottenere?
Il problema non mi pare sia mai stato aVrontato, specie nelle sue implicazioni di na-tura prosodica. In quest’àmbito l’attenzione degli studiosi si è volta soprattutto al rap-porto fra scansione prosodica e ritmo musicale nelle arie, dove però la musicazione sem-bra svilupparsi su linee che solo occasionalmente obbediscono ai presupposti prosodicidel testo poetico. 3 Naturalmente non dev’essere trascurata l’eventualità che il testo mu-sicato presenti alterazioni – frutto d’accidente o d’intervento consapevole – tali per cuil’iniziale assetto metrico-prosodico risulta essere parzialmente dissolto: fenomeno co-mune alle scritture musicali di ogni età. Occorre tuttavia presupporre, in linea di prin-cipio, l’esistenza iniziale di un testo metricamente e prosodicamente integro, che in
1 Sull’importanza di queste distinzioni: Trovato 1990; Caruso 1993a, pp. xxvii-xxxv; Caruso 1993b; Castelvecchi 1994, p. 311; Caruso 1995. 2 Deutsch 1978, D 328.
3 Lippmann 1986, OsthoV 1986, Fabbri 1988, Walker 1995.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 87
quanto tale condiziona e fino a un certo segno determina l’uso che il compositore fa deltesto stesso; ma occorre altresì riconoscere che, in sede di musicazione, il metro cessadi essere un istituto, cioè un fattore primario e strutturante del testo in questione, e sipresenta piuttosto come un insieme di potenzialità ritmico-espressive cui il compositoreattinge più o meno sistematicamente.
Nemmeno si può sottacere l’eventualità – tutt’altro che remota in un contesto inter-nazionale – di una men che perfetta dimestichezza con la lingua italiana da parte di com-positori stranieri. Al convegno di Cremona del 1992 su L’edizione critica tra testo musicalee testo letterario Walther Dürr mostrò come le due diverse intonazioni di un medesimotesto da parte del giovane Schubert – la cosiddetta ‘aria dell’angelo’ – presentino due di-versi trattamenti prosodici del testo italiano, a causa di un’iniziale, errata scansione qua-drisillabica della parola consiglio; e anche mostrò come nella seconda versione, ritoccatadall’allievo Schubert su istigazione del maestro Salieri, la dizione sia prosodicamenteesatta: il verso suona cioè come un settenario prosodicamente corretto anche nella resamusicale. 1
Nella medesima sede Dürr accennò anche al rapporto fra prosodia e musicazione deirecitativi. Egli osservava, non senza sorpresa, che nel recitativo dell’Ezio metastasianomusicato da Gluck (seconda versione, Vienna, 1763-1764) il compositore tedesco «quasisempre stacca sillaba da sillaba» (non opera cioè le sinalefi che l’uso comune e la misuradel verso prescriverebbero), «mentre nelle arie declama secondo l’uso italiano». «Comespiegare il fatto», si chiede Dürr, «che proprio nei recitativi più vicini alla lingua parlatail compositore usi una declamazione così insolita?». Dürr immagina che, mentre sullearie Gluck avrà lavorato con maggiore scrupolo, ricorrendo ove necessario al parere deisuoi cantanti italiani, per i recitativi, d’importanza relativamente minore, avrà invececonfidato in un intervento rettificante da parte dei cantanti stessi in sede di esecuzione.I recitativi di Gluck sarebbero stati insomma composti con un certo margine di appros-simazione, margine che un cantante esperto della sua arte avrebbe provveduto a elimi-nare riducendo le aberrazioni prosodiche alla norma. 2
9.
A dire il vero, i due problemi appena prospettati non mi paiono essere realmente tali.L’‘errore’ di Gluck è condiviso, per quanto ho potuto constatare, da pressoché tutti icompositori italiani; i quali, intonando i versi, non si peritano di inserire dialefi doveuna corretta lettura prosodica avrebbe invece richiesto una sinalefe, e viceversa. Se icantanti fossero davvero chiamati a rimediare a tale situazione non saprei dire. L’‘er -rore’ di Schubert, invece, è linguistico prima ancora che prosodico: consiglio non puòevidentemente essere quadrisillabo. Schubert avrà forse pensato al lat. consilium, natu-ralmente dieretico, ovvero – più banalmente – avrà distinto scrupolosamente le vocalicome sogliono fare molti stranieri quando sono posti dinanzi a questi falsi dittonghidella lingua italiana.
Qualcosa si può forse dire, invece, di un altro fenomeno ritmico-prosodico: la fre-quente coincidenza fra pause musicali da un lato, misure e cesure versali dall’altro. Pro-prio i due versi dell’Ezio di Gluck citati da Dürr (III i) possono essere utilizzati come pri-mo esempio. Segno con «v» le dialefi ‘improprie’ che la notazione comporta, e con unabarra verticale, senza distinzione di diversa durata, le pause musicali:
1 Deutsch 1978, D 17; Dürr 1995, p. 77. 2 Dürr 1995, pp. 77-78.
88 carlo caruso
valentiniano Disponi v i tuoi più fidi |di questo loco v in su l’oscuro v ingresso. | 1
Si sarà notato come le pause musicali coincidano con la fine del verso. Quanto può es-sere significativo un fatto simile? Qui arrischio solo osservazioni preliminari su casi iso-lati, dai quali è sempre diYcile, nonché imprudente, estrarre linee generali di tendenza.Ma le poche parole che seguono potranno forse contribuire ad avviare un’indagine piùdettagliata e sistematica, che va al di là delle forze e delle competenze di chi scrive.
Una rapida analisi da me condotta sul rapporto fra pause musicali e metro pressocompositori di diverse età, ma in maniera più sistematica nel recitativo händeliano (dalquale traggo gli esempi che seguono), ha posto in luce alcuni aspetti non trascurabili.Illustro subito i risultati ovvi o quantomeno prevedibili. Le pause musicali coincidonospesso con l’interpunzione del testo poetico, e di questo esaltano le caratteristiche se-mantico-esecutive: sottolineandone quindi, oltre le pause, le apostrofi, le enumerazioniscandite, i passaggi più concitati, i rallentati e i ‘segmentati’, e facendosi di norma piùfitte in prossimità della cadenza. Trascelgo, fra i molti disponibili, un passo dall’atto ter-zo del Muzio Scevola (Londra, 1721). 2 Nella rievocazione romanzata della guerra di Ro-ma contro gli Etruschi, Pòrsena, vinto dai sublimi esempi della virtù romana (OrazioCoclite, Muzio Scevola, Clelia), promette di interrompere le ostilità contro l’Urbe (II x
35-46) e si riappacifica così anche con Muzio, che pure ha attentato alla sua vita. Questidichiara al re etrusco la propria disponibilità ad esaudire ogni suo desiderio (III ii 11:«Chiedi, se vuoi, la vita»); Pòrsena però, inaspettatamente, gli domanda aiuto per con-quistare l’aVetto di Clelia, che Muzio, riamato, ama. Partito il re, Muzio illustra il pro-prio dilemma in un concitato monologo dal fraseggio fortemente segmentato. Le barreverticali segnalano la posizione delle pause nel testo musicato.
muzio Un fulmin mi percosse, |màncami | e moto | e voce. |Aita? | E come? | Ma |generoso, | magnanimo ed amico |perdona | ed ama, | ricompensa e priega, |ed ingrato | io sarò? |
(Muzio Scevola, III ii, 26-31) 3
Questo è naturalmente un caso limite, scelto per mostrare il potenziale espressivo dellapausa musicale e l’eVetto da essa esercitato sull’esecuzione del verso. Preme invece sot-tolineare il rapporto ordinario, per così dire, fra pause musicali e metro: caratteristicocioè di brani drammaticamente meno rilevati. Si osservino i due esempi seguenti, trattirispettivamente da Floridante (Londra, 1721) e da Deidamia (Londra, 1741), che ritraggonocon suYciente fedeltà la situazione più comune per passi in cui la dizione sembra con-formarsi a maggiore compostezza:
1 Gluck 1992, p. 247; Dürr 1995, p. 78.2 Libretto di Paolo Rolli; musiche di Filippo Amadei (atto I), Giovanni Bononcini (atto II), Georg Frie-
drich Händel (atto III).3 Londra, British Library, ms. r.m. 20.b.7, cc. 9v-10r (Burrows, Ronish 1994, p. 43). Alla lezione del
manoscritto aggiungo solamente gli accenti tonici e le dieresi. Oltre all’autografo händeliano e all’edi-zione rolliana (Caruso 1993a, p. 88), rinvio anche alle edizioni standard delle opere di Händel: Chrysan-der 1874, p. 11.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 89
elmira Oggi di Tracia | il Prencipe guerriero |giunge vittorïoso |delle sconfitte già navi di Tiro. |Della caccia al diporto |voler gir con Rossane | ò finto anch’io, |sol per mostrar che il caso |l’incontro porterà non il desio.rossane Veggo, Elmira, | spuntar già da quel colle |l’esercito festivo | e trïonfante. |Il nobil Floridante |alto a tutti sovrasta, | e il primo viene. |
(Floridante, I i, 1-11) 1
ulisse Per vendicar | di Menelao l’oVesa |cui Paride Trojan, | di Priamo un figlio, |tradì | l’ospizio santo, | ed in Micene |già rapì la consorte | Elena bella; |tutta la Grecia | è in armi |per l’eccidio di Troja. | A te n’invia |il Re de’ Regi | Agamennòne: | Ei brama |che Lycomede | Re di Sciro, | sia |a parte ancor | della commun vendetta; |e le tue Navi | all’alta Impresa aspetta. |
(Deidamia, I i, 1-10) 2
Di quest’uso della pausa musicale mi pare notevolissima, in primo luogo, l’adesionequasi sistematica alla misura dei versi, a prescindere o meno dalla concomitante presen-za di pause di senso. 3 Ma non solo la misura del verso è sottolineata nella notazione.Anche all’interno del verso, fatti salvi i casi in cui ribadisce l’interpunzione (che peraltromeriterebbe un discorso a sé), la pausa musicale viene pressoché sempre a disporsi incorrispondenza della cesura.
Si può citare un caso ancor più eloquente e anzi probante: quello della cantata rolliana Il gelsomino (inc.: «Son gelsomino, son picciol fiore», hwv2, nº 164), che Händelmusicò in due versioni diVerenti, per soprano (nº 164a) e per alto (nº 164b). 4 Trascrivoqui il testo della prima versione (nº 164a), con in apparato le varianti della seconda (nº164b) e dell’edizione del testo approntata da Rolli nel 1727. Quel che importa sotto -lineare qui è che Händel, pur riscrivendo integralmente la musica per i versi in cui ri-corre la prosopopea del gelsomino – con voce, tonalità e melodia diVerenti –, pose lepause musicali esattamente dove le aveva poste nella prima versione (con un’unica,trascurabile eccezione). 5
1 Londra, British Library, ms. r.m. 20.b.2, cc. 6r-7v (Burrows, Ronish 1994, pp. 31-32); Caruso 1993a, p.113; Chrysander 1876, p. 8.
2 Londra, British Library, ms. r.m. 20.a.11, cc. 3v-4r (Burrows, Ronish 1994, pp. 23-24); Caruso 1993a, p.517; Chrysander 1885, pp. 5-6; Best 2001, p. 16.
3 Anche notevole, per la probabile intenzionalità che l’ispira, l’unico passaggio non marcato da pausa,quello tra il v. 7 e il v. 8 del Floridante, corrispondente al cambio di battuta fra Elmira e Rossane: dove suun «a parte» si innesta, con repentino trapasso, un annuncio solenne.
4 Baselt 1984 (hwv2), nº 164a, autografo: Londra, British Library, ms. r.m. 20.d.12, c. 36v (Burrows, Ronish 1994, pp. 104-5); nº 164b, autografo: Cambridge, Fitzwilliam Museum, ms. 30.h.2, p. 17 (Burrows,Ronish 1994, pp. 219-20). Si veda anche Mayo 1981.
5 In 164b la seconda pausa del verso finale è eliminata («mi pon com’in trionfo | agli altri in cima.|»).
90 carlo caruso
Tremulante e leggiero |fra strette verdi | e ben disposte fronde |bel vedermi ornamento | a un vago crine, |
10 e lievemente | ver‹’› la guancia inflesso |dar | e prender bellezza | a un tempo stesso [!] |Quand’uno stuol di fior‹’› | meco abbellisce |una brillante testa | o un molle seno, |fassi di me più stima, |
15 e la candida man | di chi s’adorna |mi pon com’in trionfo | agli altri | in cima. | 1
7 Tremulante] Tremolante 164b 8 fronde] foglie Rolli 1727 11 stesso] istesso 164b, Rolli 1727 12-13Quand’uno … seno,] Quando uno stuol di fiori / meco abbellisce una brillante testa, / o fa d’un colmosen margine all’onda; Rolli 1727
La cesura in particolare è l’araba fenice degli studi di prosodia italiana, e della sua pre-senza nei versi ad accenti mobili, esagerando un poco, si potrebbe arrivare a dire: che visia ciascun lo dice, dove sia (istituzionalmente) nessun lo sa. Del resto, come Aldo Me-nichetti ha osservato nella sua lucida trattazione del fenomeno, di cesura si può parlaresenza riserve solo quando la posizione di essa sia prescritta dal metro stesso, come nelcaso – per es. – dell’alessandrino, del doppio senario, del doppio quinario, e così via. Perversi a cesura mobile, come l’endecasillabo e il settenario, occorrerà maggiore discre-zione, anche rammentando che la cesura è fenomeno metrico, non linguistico, e quindinon equiparabile tout court alla pausa. 2 Ma qui, nel rapporto concreto fra il testo poeticoe la prassi compositiva ed esecutiva, la cesura cessa forse di essere quell’astrazione di cuinon sempre si riesce a dare compiuta definizione teorica, e pare invece lasciarsi eYca-cemente definire con le parole di Girolamo Ruscelli: «un certo convenevol riposo, ofiato, che viene a far la pronuncia più leggiadra e il numero [cioè il ritmo] del verso piùgiusto alle orecchie nostre». 3 E del resto «fiato», nel Cinquecento, era sinonimo, oltreche di ‘pausa’, anche di ‘virgola’; ma di virgola in quanto espressione di un sistema in-terpuntivo che sottolineava pause e sospensioni di tipo retorico piuttosto che logico,con l’obiettivo, magari solo ideale, della recitazione piuttosto che della scansione razio-nalizzata dei membri del discorso. 4 Tale sistema interpuntivo perpetuava altresì l’anticoideale retorico-oratorio di un corretto discernimento e uso delle pause, poiché – comediceva Cicerone – è l’orecchio a giudicare ciò che è o non è sintatticamente completo,ed è il nostro respiro, quasi per legge di natura, a determinare la fine di un periodo; ondeper l’oratore sarebbe assai poco dignitoso, nonché restare senza fiato, anche solo mo-strare diYcoltà nel coordinamento della respirazione con le esigenze esecutive del te-
1 Londra, British Library, ms. r.m. 20.d.12, c. 36v (Chrysander 1887, p. 127), con ricostituzione dell’as-setto metrico, ma con riproduzione fedele dell’interpunzione. Sostituisco il punto fermo con un puntoesclamativo alla fine del v. 11.
2 Menichetti 1993, pp. 462-77 (dal quale traggo le successive citazioni degli antichi trattatisti), e in par-ticolare pp. 466-68.
3 Ruscelli 1559, p. 41, citato in Menichetti 1993, p. 474. Un critico della generazione di Händel, FrancescoSaverio Quadrio – il quale della cesura sottolineava però la natura aleatoria –, riconosceva che essa riu-sciva al verso italiano «di non picciola grazia e di non mediocre ornamento» (Quadrio 1739-1752, t. i, p.686, citato in Menichetti 1993, p. 467).
4 Di qui la necessità, come già accennavo sopra, di studiare l’interpunzione del testo poetico nei ma-noscritti musicali in rapporto alle pause musicali. Si vedano intanto le osservazioni di Durante 1995.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 91
sto. 1 Apparirà inoltre evidente, anche da questa pur limitatissima esemplificazione (cheè però ampliabile a piacere su ogni pagina di recitativo del maestro sassone), l’insistenzadi Händel (e del suo poeta Paolo Rolli) su quelle cesure che hanno, come diceva un altroe ancor più autorevole teorico cinquecentesco, «grandissima forza», e fanno «più belloe più sonoro il verso»: 2 le cesure, cioè, di quinta e di settima, nelle varianti rispettiva-mente ossitone e parossitone (quindi cesure di 4a /5a e di 6a /7a). 3
10.
Mi sarebbe diYcile dire se questo sia un tratto stilistico, anzi stilematico, caratteristicodi Händel, o non debba invece intendersi come un patrimonio culturale comune a tuttiquei compositori che scrivevano musica su versi italiani, denotante una loro generaleconsapevolezza delle regole, o meglio delle potenzialità prosodico-ritmiche, inerenti al-la versificazione. Mi pare tuttavia che un’adesione di massima alla misura del verso ealla cesura, sia pure con maggior libertà rispetto agli esempi händeliani, persista ancora,per esempio, nel recitativo mozartiano, e più nel Mozart operista serio che non in quellocomico o ‘giocoso’. Ecco un esempio dall’Ascanio in Alba – dunque del Mozart giova-nissimo – su libretto di Giuseppe Parini: dove anche ho sottolineato le sillabe su cui sidovrebbe eseguire l’appoggiatura. Pur consapevole di quanto l’impiego di quest’ultimasia un fatto da definirsi volta a volta e con notevole margine d’incertezza, 4 mi pare tut-tavia che anche alla collocazione di essa, come già della pausa, non sia estranea l’impor-tanza della misura versale o della cesura:
venere
(al suo seguito che si ritira nell’indietrodella scena, disponendosi vagamente)Geni, | Grazie, ed Amori, |Fermate il piè, | tacete,Frenate, | sospendete, |Fide colombe, il volo: |Questo è il sacro al mio Nume | amico suolo. |Ecco, Ascanio, mia speme, ecco le piagge, |Che visitammo insieme, |Il tuo gran Padre, ed io. | Quel tempo ancora |Con piacer mi rammento. | Anco i presagi |Parvero disegnar, | che un giorno fora |
1 Cicerone, Brutus, 34: «nam et aures ipsae quid plenum, quid inane sit iudicant, et spiritu quasi neces-sitate aliqua verborum comprensio terminatur; in quo non modo defici, sed etiam laborare turpe est».È naturale che i teorici della poesia volgare, equiparando di fatto la cesura a una pausa (sia pure di naturaparticolare), finissero per attingere alla teorica dell’oratoria antica, che riconosceva importanza fonda-mentale all’actio. I riferimenti alla tecnica della recitazione dei versi, invece, sono negli autori antichi rarie generici; del resto, la cesura dei versi greci e latini è, com’è noto, altra cosa rispetto alla cesura dei versiitaliani.
2 Giangiorgio Trissino nella sua Poetica, in Weinberg 1970-1974, vol. i, pp. 62-64 (citato in Menichetti1993, p. 475).
3 È nel trattatello quattrocentesco di Francesco Baratella (Compendium particulare Artis Ritmice in septem generibus dicendi. F[rancesco] B[aratella] L[aureo]) che si accenna per la prima volta alla «Cesura, ouerdivisione del uerso, che se clama pausa», dove sono ammesse cesure di terza, quarta, quinta, sesta e settima, e dove anche si aVerma che «la quinta e la septima cesura son piu consonante a la suauitade» –in Grion 1869 (1970), pp. 182-83. Si veda in proposito Dionisotti 1947, p. 13.
4 Si vedano le osservazioni di Luigi Ferdinando Tagliavini nell’introduzione all’Ascanio in Alba della«Neue Mozart Ausgabe» (Tagliavini 1956, pp. x-xi).
92 carlo caruso
Del mio favore oggetto |Questo popolo eletto. | […] 1
Ancora un esempio: dalla Clemenza di Tito – dunque del Mozart più maturo (ma conpossibili interventi di Franz Xaver Süssmayr, che per Mozart musicò parte dei recitativi)– su testo originale di Metastasio rivisto da Caterino Mazzolà:
vitellia Ma che? sempre l’istesso, |Sesto, a dirmi verrai? | So, che sedottofu Lentulo da te; | che i suoi seguacison pronti già; | che il Campidoglio acceso |darà moto a un tumulto. | Io tutto questo |già mille volte udii, | la mia vendettamai non veggo però. | S’aspetta forse |che Tito a Berenice | in faccia miaoVra d’amor insano |l’usurpato mio soglio, | e la sua mano?Parla, di’, che s’attende? |sesto Oh Dio! |vitellia Sospiri! |sesto Pensaci meglio, o cara,pensaci meglio. | Ah non togliamo in Tito |la sua delizia al mondo, | il Padre a Roma, |l’amico a noi. | Fra le memorie antiche |trova l’egual, | se puoi. | Fìngiti in mente |Eroe più generoso, | e più clemente. | 2
Benché posti in luce dalla tradizione musicale, i fenomeni sopra descritti appartengonoanche alla storia della nostra poesia, e attendono di essere esaminati più a fondo. È for-tuna grande che il filologo dei testi letterari non si trovi solo di fronte all’impresa, mapossa invece contare sull’ausilio della parallela tradizione di studi musicali.
1 Tagliavini 1956, pp. 23-25. Testo del libretto in Mazzoni 1925, p. 210, e in Mioli 1996, i, pp. 127-28.2 Giegling 1970, pp. 21-22. Testo del libretto in Mioli 1996, ii, pp. 214-17.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 93
Abbreviazioni bibliografiche
Accorsi 1989 = Maria Grazia Accorsi, Problemi testuali dei libretti d’opera fra Sei e Settecento, gsli,106, pp. 212-25.
Baselt 1984 (hwv2) = Bernd Baselt, Händel-Handbuch, herausgegeben vom Kuratorium derGeorg-Friedrich-Händel-Stiftung von Walter Eisen, Bd. 2, Thematisch-systematisches Verzeich-nis: Oratorische Werke, vokale Kammermusik, Kirchenmusik, Leipzig, Deutsche Verlag für Musik (Kassel-Basel-London, Bärenreiter).
Basile 1994 = Torquato Tasso, Le rime, a cura di Bruno Basile, 2 voll., Roma, Salerno Editrice.Bellina, Caruso 1998 = Anna Laura Bellina, Carlo Caruso, Oltre il Barocco: la fondazione dell’Arca-
dia. Zeno e Metastasio: la riforma del melodramma, in Storia della letteratura italiana, diretta da Enrico Malato, vi, Il Settecento, Roma, Salerno Editrice, pp. 239-312.
Bellina, Tessarolo 2003 = Pietro Metastasio, Drammi per musica, a cura di Anna Laura Bellina eLuigi Tessarolo, con la collaborazione di Enrica Bojan, Luciana Grappeggia, Sandra Marin,Anna Vencato, Venezia, Marsilio (versione in Cd-Rom).
Best 2001 = Hallische Händel-Ausgabe. Kritische Gesamtausgabe, herausgegeben von der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft, Serie 2, Opern, Bd. 41, Deidamia, herausgegeben von TerenceBest, Kassel-Basel-London-New York-Prag, Bärenreiter.
Bianconi 1995 = Lorenzo Bianconi, Hors-d’œuvre alla filologia dei libretti, in Borghi, Zappalà 1995,pp. 421-28.
Billanovich 1937 = Giuseppe Billanovich, Per l’edizione critica delle canzonette di Leonardo Giusti-nian, gsli, 110, pp. 197-251.
Borghi, Zappalà 1995 = L’edizione critica tra testo musicale e testo letterario. Atti del Convegno inter-nazionale (Cremona, 4-8 ottobre 1992), a cura di Renato Borghi e Pietro Zappalà, Lucca, Li-breria Musicale Italiana.
Brizi 1995 = Bruno Brizi, «Il lauro verde»: questioni relative alla trascrizione di testi polifonici del Cinquecento, in Borghi, Zappalà 1995, pp. 17-43.
Brunelli 1943-1954 = Pietro Metastasio, Tutte le opere, a cura di Bruno Brunelli, 5 voll., Milano,Mondadori.
Burrows, Ronish 1994 = Donald Burrows, Martha J. Ronish, A Catalogue of Handel’s Musical Autographs, Oxford, Clarendon Press.
Buschmeier 1992 = Christoph Willibald Gluck, Sämmtliche Werke, Abt. 3, Italienische Opere serieund Opernserenaden, 24, Ezio (Wiener Fassung von 1763/64), herausgegeben von Gabriele Buschmeier, Kassel-Basel-London-New York-Prag, Bärenreiter.
Calcaterra 1926 = Paolo Rolli, Liriche, a cura di Carlo Calcaterra, Torino, utet.Caraci Vela 1995 = La critica del testo musicale. Metodi e problemi della filologia musicale, a cura di
Maria Caraci Vela, Lucca, Libreria Musicale Italiana.Caruso 1992 = Carlo Caruso, Il commento a testi per teatro musicale del Settecento, in Il Commento ai
testi, Atti del Seminario di Ascona (2-9 ottobre 1989), a cura di Ottavio Besomi e Carlo Caruso,Basel-Boston-Berlin, Birkhäuser, pp. 409-32.
Caruso 1993a = Paolo Rolli, Libretti per musica, edizione critica a cura di Carlo Caruso, Milano,Franco Angeli.
Caruso 1993b = Carlo Caruso, Note filologiche sul melodramma del Settecento, sfi, 51, pp. 213-24.Caruso 1995 = Carlo Caruso, Libretto, partitura, volume, in Borghi, Zappalà 1995, pp. 433-36.Caruso 2004 = Carlo Caruso, Three Cases of Censorship in Opera Theatre: Mozart, Rossini, Verdi,
«The Italianist», 24, pp. 208-23.Castelvecchi 1994 = Stefano Castelvecchi, Sullo statuto del testo verbale nell’opera, in Gioachino
Rossini 1792-1992: il testo e la scena. Convegno internazionale di studi (Pesaro, 25-28 giugno 1992),a cura di Paolo Fabbri, Pesaro, Fondazioni Rossini, pp. 309-14.
Cattin 1990 = Giulio Cattin, Nomi di rimatori per la polifonia profana italiana del secondo Quattrocen-to, «Rivista italiana di musicologia», 25, pp. 209-311.
Chrysander 1874 = Georg Friedrich Händels Werke, für die Deutsche Händelgesellschaft, heraus-gegeben von Friedrich Chrysander, Bd. 64, Muzio Scevola, Leipzig, Breitkopf & Härtel (rist.anast. Ridgewood, nj, Gregg, 1965-1966).
94 carlo caruso
Chrysander 1876 = Georg Friedrich Händels Werke, für die Deutsche Händelgesellschaft, heraus-gegeben von Friedrich Chrysander, Bd. 65, Floridante, Leipzig, Breitkopf & Härtel (rist. anast.Ridgewood, nj, Gregg, 1965-1966).
Chrysander 1885 = Georg Friedrich Händels Werke, für die Deutsche Händelgesellschaft, heraus-gegeben von Friedrich Chrysander, Bd. 94, Deidamia, Leipzig, Breitkopf & Härtel (rist. anast.Ridgewood, nj, Gregg, 1965-1966).
Chrysander 1887 = Georg Friedrich Händels Werke, für die Deutsche Händelgesellschaft, heraus-gegeben von Friedrich Chrysander, Bd. 51, Cantate a voce sola e basso. Libro secondo, Leipzig,Breitkopf & Härtel (rist. anast. Ridgewood, nj, Gregg, 1965-1966).
Chusid 1983 = Giuseppe Verdi, Rigoletto, a cura di Martin Chusid, 2 voll.: i, Testo; ii, Commentocritico, Milano-Chicago-London, Ricordi-University of Chicago Press.
De Santis 1995 = Mila De Santis, Questioni di prassi ecdotica nell’edizione dei testi poetici musicati daAndrea Gabrieli, in Borghi, Zappalà 1995, pp. 57-68.
De Santis 2000 = Mila De Santis, Ancora sull’edizione dei testi poetici musicati nel Cinquecento, in Pro-blemi e metodi della filologia musicale. Tre tavole rotonde, a cura di Stefano Campagnolo, Lucca,Libreria Musicale Italiana, pp. 63-64.
Deutsch 1978 = Otto Erich Deutsch, Franz Schubert: Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chro-nologischer Folge, Kassel-London, Bärenreiter.
Dionisotti 1947 = Carlo Dionisotti, Ragioni metriche del Quattrocento, gsli, 124, pp. 1-34.Dionisotti 1967 = Carlo Dionisotti, Per una storia della lingua italiana, in Geografia e storia della let-
teratura italiana, Torino, Einaudi, pp. 75-102.Dürr 1995 = Walther Dürr, L’edizione di testi letterari nel contesto dell’edizione musicale, in Borghi,
Zappalà 1995, pp. 69-83.Durante 1995 = Sergio Durante, Sulla punteggiatura del testo verbale nei pezzi chiusi del melodramma
settecentesco, in Borghi, Zappalà 1995, pp. 471-72.Fabbri 1988 = Paolo Fabbri, Istituti metrici e formali, in Storia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo
Bianconi e Giorgio Pestelli, 6 voll., Torino, edt: vi, pp. 165-233.Fallows 1995 = David Fallows, Leonardo Giustinian and Quattrocento Polyphonic Song, in Borghi,
Zappalà 1995, pp. 247-60.Giambonini 2000 = Francesco Giambonini, Bibliografia delle opere a stampa di Giambattista Marino,
2 voll., Firenze, Olschki.Giegling 1970 = Wolfgang Amadeus Mozart, La clemenza di Tito, herausgegeben von Franz
Giegling, Kassel-London, Bärenreiter.Grion 1869 (1970) = Antonio Da Tempo, Delle rime volgari. Trattato di Antonio Da Tempo giudice pa-
dovano composto nel 1332, dato in luce integralmente ora la prima volta per cura di Giusto Grion,Bologna, Bologna, Forni (rist. anast. dell’ed. Bologna, 1869).
Gronda 1990 = Giovanna Gronda, La carriera di un librettista. Pietro Pariati da Reggio di Lombardia,Bologna, il Mulino.
Gronda, Fabbri, 1997 = Libretti d’opera italiani, a cura di Giovanna Gronda e Paolo Fabbri, Milano,Mondadori.
Harrán 1998 = Don Harrán, Nouvelles variations sur «O Rosa bella», cette fois avec un «ricercare» juif,in Johannes Ockeghem, Actes du xi
e Colloque international d’Études humanistes, édités par Philippe Vendrix, Paris, Klinksieck, pp. 365-79 (versione inglese in «Studi musicali», 27, 1998,pp. 241-86).
La Face Bianconi 1994 = Giuseppina La Face Bianconi, Filologia dei testi poetici nella musica vocaleitaliana, «Acta musicologica», 66, pp. 1-21, 139.
La Face Bianconi, Rossi 1995 = Giuseppina La Face Bianconi, Antonio Rossi, Serafino Aquilano nelle fonti musicali, li, 47, pp. 345-86.
La Face Bianconi, Rossi 1999 = Giuseppina La Face Bianconi, Antonio Rossi, Le rime di SerafinoAquilano in musica, Firenze, Olschki.
Lannutti 2005 = Maria Sofia Lannutti, Poesia cantata, musica scritta. Generi e registri di ascendenzafrancese alle origini della lirica italiana, in Lannutti, Locanto 2005, pp. 157-97.
Lannutti, Locanto 2005 = Tracce di una tradizione sommersa. I primi testi lirici italiani tra poesia e mu-sica, a cura di Maria Sofia Lannutti e Massimiliano Locanto, Firenze, Edizioni del Galluzzo.
la vulgata nella tradizione dei testi per musica 95
Lincoln 1988 = Harry B. Lincoln, The Italian Madrigal and Related Repertories: Indexes to PrintedCollections 1500-1600, New Haven-London, Yale University Press.
Lippmann 1986 = Friedrich Lippmann, Versificazione italiana. I rapporti tra verso e musica nell’operaitaliana dell’Ottocento, Napoli, Liguori.
Mayo 1981 = John S. M. Mayo, Einige Kantaten-Revisionen Händels, «Händel-Jahrbuch», 27, pp. 63-81.
Mazzoni 1925 = Giuseppe Parini, Tutte le opere edite e inedite, a cura di Guido Mazzoni, Firenze,Barbèra.
Menichetti 1993 = Aldo Menichetti, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova,Antenore.
Mioli 1996 = Wolfgang Amadeus Mozart, Tutti i libretti d’opera, a cura di Piero Mioli, 2 voll., Roma, Newton Compton.
OsthoV 1986 = Wolfgang OsthoV, Musica e versificazione: funzioni del verso poetico nell’opera italia-na, in La drammaturgia musicale, a cura di Lorenzo Bianconi, Bologna, il Mulino, pp. 125-41.
Pompilio, Vassalli 1997 = Angelo Pompilio, Antonio Vassalli, Indice delle rime di Battista Guariniposte in musica, in Guarini, la musica, i musicisti, a cura di Angelo Pompilio, Lucca, Libreria Musicale Italiana, pp. 185-225.
Quadrio 1739-1752 = Francesco Saverio Quadrio, Della storia e della ragione d’ogni poesia, 4 voll. in7 tt., Bologna, Ferdinando Pisarri-Milano, Federico e Giambattista Agnelli.
Quaglio 1988 = Antonio Enzo Quaglio, Da Benedetto BiVoli a Leonardo Giustinian, fec, 13, pp. 157-83.
Rolli 1727 = Paolo Rolli, Di canzonette e cantate libri due, Londra, Edlin.Ruscelli 1559 = Girolamo Ruscelli, Trattato del modo di comporre in versi nella lingua italiana, Vene-
zia, Giovan Battista e Melchior Sessa.Strohm 1995 = Reinhard Strohm, Does Textual Criticism have a Future?, in Borghi, Zappalà 1995,
pp. 193-211.Stussi 1999 = Alfredo Stussi, Versi d’amore in volgare tra la fine del secolo XII e l’inizio del XIII, cn, 59,
pp. 1-69.Tagliavini 1956 = Wolfgang Amadeus Mozart, Ascanio in Alba, herausgegeben von Luigi Ferdi-
nando Tagliavini, Kassel-London, Bärenreiter.Trovato 1990 = Paolo Trovato, Note sulla fissazione dei testi poetici nelle edizioni critiche dei melodram-
mi, «Rivista italiana di musicologia», 25, pp. 333-52.Vela 1984 = Claudio Vela, Osservazioni sulla tradizione musicale dei testi poetici italiani, in C. V., Tre
studi sulla poesia per musica, Pavia, Aurora, pp. 3-27.Vela 2005 = Claudio Vela, Nuovi versi d’amore delle origini con notazione musicale in un frammento
piacentino, in Lannutti, Locanto 2005, pp. 3-29.Walker 1995 = Thomas Walker, Un appunto sul rapporto fra metrica e ritmo nelle opere italiane del
tardo Seicento, in Borghi, Zappalà 1995, pp. 463-69.Weinberg 1970-1974 = Giangiorgio Trissino, Poetica, in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento,
a cura di Bernard Weinberg, 4 voll., Bari, Laterza: i, pp. 21-58; ii, pp. 7-90.Wiese 1883 = Poesie edite ed inedite di Lionardo Giustinian, per cura di Bertold Wiese, Bologna, Ro-
magnoli (rist. anast. Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1968).
Accademia editoriale®
Casella postale n. 1, Succursale n. 8 · i 56123 PisaTel. +39 050 542332, fax +39 050 574888
E-mail: [email protected] · www.libraweb.net
Abbonamenti · SubscriptionsItalia: Euro 85,00 (privati) · Euro 140,00 (enti, con edizione Online)
Abroad: Euro °†ù,¢¢ (individuals) · Euro °úù,¢¢ (Academic Institution, with Online Edition)Prezzo copia singola / Single issue: Euro 160,00
I pagamenti possono essere eVettuati tramite versamento sul c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (American Express, Eurocard, Mastercard, Visa).
UYci di Pisa: Via Santa Bibbiana 28 · i 56127 PisaUYci di Roma: Via Ruggiero Bonghi 11/b · i 00184 Roma
*
La casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possi-bilità di richiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo al nostro indirizzo. Le informa-zioni custodite dalla casa editrice verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati
nuove nostre proposte (D. Lgs. 196/2003).
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 18 del 26 novembre 2003
Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento anche parziale oper estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi messo eVettuati, compresi la copia fotostatica,il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc. senza la preventiva autorizzazione della
Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma,
un marchio dell’Accademia editoriale®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2007 by Fabrizio Serra · Editore
®, Pisa · Roma,un marchio dell’Accademia editoriale
®, Pisa · Roma.
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 1724-6113
issn elettronico 1825-1021
SOMMARIO
Premessa 9
Michelangelo Zaccarello, Tradizione d’autore vs tradizione vulgata 11
Stefano Carrai, Per il testo del «Corbaccio»: la vulgata e la testimonianza del codiceMannelli 23
Paolo Trovato, Per le nozze (rinviate) tra storia e filologia. Sulle vulgate di alcuni pel-legrinaggi tre- e quattrocenteschi (Lionardo Frescobaldi, Mariano da Siena, AlessandroRinuccini) e sulle guide di Terrasanta 31
Carlo Caruso, La vulgata nella tradizione dei testi per musica 77
Italo Pantani, La «Bella mano». Tradizioni vulgate e tradizione d’autore 97
Alessio Decaria, Michelangelo Zaccarello, Il ritrovato ‘Codice Dolci’ e la costi-tuzione della vulgata dei «Sonetti» di Matteo Franco e Luigi Pulci 121
Antonio Sorella, La vulgata nella tipofilologia: due casi esemplari 155
Fabio Forner, Sul dibattito teologico antierasmiano intorno alla «Vulgata» nel Cinque-cento 173
Giulia Montemezzo, L’«Orlando innamorato» nel Sette e nell’Ottocento: aspetti diuna vulgata 183
Antonio Corsaro, Lino Leonardi, Paolo Pellegrini, Esperienze di lavoro 217
i. Antonio Corsaro, I casidel «Messaggiero» di Tasso e delle «Rime»di Michelangelo 217
ii. Lino Leonardi, Il caso di Jacopone 220
iii. Paolo Pellegrini, Il caso dei «Praeludia» di Pierio Valeriano 225
Indici, a cura di Fabio Romaninii. Indice dei nomi 231
ii. Indice dei manoscritti e dei postillati 243
Sigle impiegate in questa rivista 247