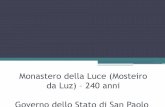LA MUSICA ANCELLA DELLA RIVELAZIONE in 'RIVELAZIONE E STORIA" (2014 Sacra Fraternitas Aurigarum)
-
Upload
sanpietroamajella -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LA MUSICA ANCELLA DELLA RIVELAZIONE in 'RIVELAZIONE E STORIA" (2014 Sacra Fraternitas Aurigarum)
323
Aurelio Porfiri, diplomatosi in Roma maestro corale, svolge la sua attività in Asia e Oceania mantenendo vivaci contatti culturali con l’Europa e specialmente con la sua Patria. La sua stima della musica come arte autonoma e come sussidiaria liturgica lo induce a sottolineare le disposizioni interiori dell’ascoltatore nel recepire l’eventuale messaggio musicale ed è proprio inserendosi nelle disposizioni interiori che la grazia (o illuminazione) divina può sprigionare quell’attrazione verso l’Infinito semper Maior, stretto parente dell’ineffabile conoscenza (o gnosi) mistica (e.i).
La musica ancella della Rivelazione
Aurelio PorfiriDottorando in musica
nell’University of Western Australia
La Rivelazione del Figlio di Dio, che si incarna per la vita del mondo, e’ fatto centrale della fede cattolica. Ma certamente l’idea di “Rivelazione” è presente anche in altre manifestazioni religiose, come nell’ebraismo . Con la Rivelazione la divinità rende manifeste alcune verità di ordine soprannaturale o che, pur se possedute gia’, nell’ordine naturale non vi erano ancora perfettamente espresse. Così nella idea di Rivelazione abbiamo contenuta questa nozione per cui cio’ che era nascosto e’ ora manifesto:
“Ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della terra, perche’ hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perche’ così hai deciso nella tua benevolenza . Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e Colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”180.
In questo versetto notiamo una tensione fondamentale, che è quella fra apokryptō
(nascondere) ed apokalyptō (rivelare). È interessante riflettere sulla paradossale ten-sione fra questi due termini . Dicevo paradossale, non in senso oppositivo . Infatti “pa-radosso”, significa apparente opposizione di termini che in realta’ possono essere non inconciliabili. Perche’ mai Dio avrebbe deciso di non rilevare ai sapienti e ai dotti e far presente ai piccoli e agli umili? E di quale sapienza si parla? Cosa ha a che fare la musica con tutto questo? La rivelazione non è riservata solo ad alcuni, ma elegge chi la cerca con cuore puro e sincero181. Credo sia importante identificare questa dinamica rivelativa che non procede da una sapienza nascosta nel senso di esclusiva ma da una sapienza nascosta nel senso di esigente . La analogia tra la Rivelazione e la musica, a pensarci bene, e’ sorprendente. Certamente anche la musica è sapienza e al suo livello piu’ alto è certamente anche riservata a coloro che sanno cercare. Ma questo approdo di conoscenza non è poi così semplice e scontato. Mentre nella Rivelazione sappiamo che lo scopo finale è la visione beatifica di Dio, quale è lo scopo finale della musica?
180 Mt 11, 25-27; vedi anche Lc 10, 21.181 Sal 50, 12
324
Ha la musica uno scopo finale in se stessa? Credo che la musica, come sapienza, parte-cipi ad una sapienza piu’ grande, noi diremmo alla sapienza divina, sia una delle vie di conoscenza attraverso cui si possa “toccare i piedi della divinita’”, per usare una bella immagine del poeta indiano Rabindranath Tagore. Ma questa conoscenza ha una sua dinamica che va investigata cercando di collocarsi nell’intersezione fra diverse disci-pline cogliendone le emanazioni piu’ attraenti. Sara’ interessante per qualche istante considerare il pensiero di Mo tzu (480-400 AC), filosofo cinese anticonfuciano. Il nostro filosofo, da perfetto oppositore della filosofia di Confucio, ne criticava anche l’enfasi che Kong Fu Zi (Maestro Kong, latinizzato in Confucio) poneva nella musica . Leggiamo quanto Mo tzu dice sulla musica:
“Il Maestro Mo chiese ad un confuciano: “Qual e’ il motivo per cui si fa musica?” Ri-sposta: “Si fa musica per amore della musica” . Il maestro Mo tzu disse: “Tu non mi hai ancora risposto. Se ora ti chiedo: ‘Qual’e’ il motivo per cui si costruiscono le case?’ tu mi rispondi: ‘Per allontanare il freddo in inverno e il caldo in estate; si costruiscono le case anche per separare gli uomini dalle donne’. Rispondendo così, mi hai detto qual e’ il motivo per cui si costruiscono le case. Se io ora ti chiedo: ‘Qual e’ il motivo per cui si fa musica?’, e tu mi rispondi: ‘Si fa musica per amore della musica’, cio’ equivale a rispondere alla domanda: ‘Qual’è il motivo per cui si costruiscono le case?’ [che] ‘Le case si costruiscono per amore delle case”182 .
Pur essendo io musicista, non prendo come negativa l’osservazione del Maestro
Mo e infatti la considero con la serietà che merita. Serve la musica a qualche cosa? Noi possiamo certamente dare un valore di utilità alla Rivelazione, che si è data per la salvezza di tutti . Ma per quanto riguarda la musica possiamo dire le stesse cose o no? Mi si permetta di notare come nella domanda di Mo tzu e nel suo esempio per esemplificare la risposta c’e’un approccio prettamente utilitaristico che certamente non puo’ essere usato per spiegare ogni cosa esistente . Dicendo questo non si intende negare il finalismo ma che esso vada inteso solo in senso materialistico (“costruire la casa”) e non anche in senso spirituale. In questo senso la risposta del confuciano (“musica per amore della musica”) pur essendo propria di un’altra dimensione rispet-to a quella evocata con il suo esempio dal Maestro Mo, apre piu’ problemi di quelli che risolve. Perché la musica, rimane ancora una domanda aperta a molte possibili risposte .
Musica come via della RivelazioneSi potrebbe obiettare qui che, se poniamo la musica come una delle vie per cui la
Rivelazione si disvela, per cui la musica concorre alla comprensione di questo dato rivelato, dobbiamo tenere conto che la musica puo’ essere usata per scopi non buoni. Questo è indiscutibile183. Ma è anche vero che cio’ si puo’ anche dire della Filosofia,
182 Mo tzu, Edizioni Ssu pu ts’ung k’an, cap. 48,9, pp. 1-2 in Arena L. (1991). Antologia della Filosofia Cinese. Milano (Italia): Arnoldo Mondadori Editore, pag. 84.
183 Posso citare un esempio personale. Ricordo che nei miei anni di insegnamento universitario qui a Macao davo ai miei studenti un tema da svolgere chiedendo di commentare la loro canzone preferita
325
della Teologia e quant’altro. Cio’ non trasforma queste discipline in negative perche’ di esse si possa fare un uso cattivo. Anzi, si pensa che esse siano un modo di cono-scenza attraverso cui la Rivelazione si fa presente agli uomini e alle donne di tutti i tempi. Si potrebbe obbiettare che, mentre Filosofia e Teologia possono comunicare concetti, la musica non puo’ . Questo è uno dei temi portanti di questo scritto, in quan-to la natura “semantica” della musica e’ oggetto di studi e ricerche che si sono andate intensificando nel corso almeno del secolo ventesimo e ventunesimo. Io tento una via possibile di comprensione di questo fenomeno, che, ripeto, è una via possibile fra altre vie possibili . Il grande compositore e direttore americano Leonard Bernstein, nelle sue Lectures nella Universita’ americana di Harvard si occupa proprio di questo problema annoso, come la musica “significa”. In un punto della sua lezione sulla se-mantica musicale, egli evoca le menti filosofiche e non, che hanno tentato di dare una risposta al quesito del significato in musica. E dopo il breve elenco egli ci dice:
“Una cosa su cui essi sono d’accordo, in una via o l’altra, e’ che il significato musicale esiste, che sia di tipo razionale, affettivo o entrambi”184 .
Le pioneristiche lezioni del grande direttore d’orchestra hanno certamente
segnato un’epoca ed ispirato altri ad intraprendere quel tipo di approccio alla musica . Ma certamente egli non e’ stato il primo a porsi questi problemi, tutt’altro: il doman-darsi a cosa serve la musica e come essa significa e’ antico quanto l’uomo.
Nascondere e rivelareDicevamo della tensione fra nascondere e rivelare . Non posso non pensare a questa
tensione cosi’ presente nei versi spirituali piu’ alti, quelli del “Cantico dei Cantici” . Vorrei che ci si soffermasse su questi passaggi, in quanto la musica io la concepisco in una dinamica che puo’ essere intravista in queste righe del poema biblico:
“Dimmi, o amore dell’anima mia, dove vai a pascolare il gregge, dove lo fai riposare al meriggio, perche’ io non sia vagabonda dietro i greggi dei tuoi compagni”185 .
Dove vai a pascolare il gregge? Dove sei? Ma anche “amore delll’anima mia”.
La presenza-assente, la rivelazione-nascosta . L’amore presente nell’anima ma ancora nascosto. E la risposta non abbandona questa dinamica, ma anzi la rafforza:
“Se non lo sai, o bellissima fra le donne, segui l’orma del gregge e mena a pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori”186 .
e per quale motivo era da loro prediletta. Spesso accadeva che questi studenti trovavano particolar-mente attraenti canzoni che incitavano al suicidio o anche alla violenza, come accade negli stili piu’ estremi del rock o nel rap .
184 Bernstein L . (1976) . The Unanswered Question. Six Talks at Harvard. Cambridge, Massachussets and London, England: Harvard University Press, Pagg.133-135 (mia traduzione dall’inglese).
185 1,7186 1,8
326
Se non lo sai . . .l’amore si rivela parlando, ma vela il rivelato . In questo primo capitolo ci si ama cercandosi, e ci si cerca amandosi . Dove sei . . .dove sei . . .Re-velare (re=dietro + velare= velo), cio’ che e’ dietro il velo. In questo senso, alcuni eti-mologi esemplificano il significato di questa parola latina composta dicendo che rivelazione e’ “cio’ che e’ dietro il velo”. Mi permetto di non accettare inferenze non contenute nella scomposizione dei termini stessi e di accettarla nel suo senso prossimo di “dietro il velo” . La rivelazione e’ semplicemente il manifestarsi di un mistero che, pur rimanendo mistero, si fa misteriosamente conoscibile. A chi si fa conoscibile? A coloro che sanno vedere ed ascoltare svuotando il proprio cuore da malizia e impurita’. So che alcuni possono controbattere che mi sto muovendo su un limen pericoloso, al confine di una interpretazione che puo’ sconfinare nei terri-tori infidi dell’ermetismo: ebbene, non e’ cosi’. La mia interpretazione del rivelare il mistero, che pur rimanendo mistero si fa conoscibile, echeggia le parole della Sacra Scrittura che abbiamo citato poc’anzi: “hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli..” Egli nasconde a coloro che sarebbero meglio attrezzati ad una comprensione intellettuale per rivelare a coloro che privilegiano un’altra via di conoscenza .
In questo senso non si pensi ad una deriva del discorso sulla Rivelazione che va a rifugiarsi in vaghi ed indefiniti approdi. Quanto si va dicendo su presenza/assen-za, non intende diluire le differenze concettuali tra i due elementi . Naturalmente la galassia monista potrebbe ritenere che la mia posizione sia confacente ad alcuni postulati di questa vasta corrente filosofica ma in realta’ io credo di poter sfuggire a questa pretesa: assenza e presenza non si liquefanno, rimangono semanticamente e concettualmente presenza ed assenza. Quello che io cerco di investigare, rifacen-domi al Cantico dei Cantici e ad altre fonti, è la relazione tra i due termini che non intende discutere l’elemento oppositivo, ma bensi’ quello esclusivo. Cioé, questi due concetti rappresentano due idee opposte ma non escludenti . La tentazione del moni-smo naturalmente puo’ toccare il cristianesimo, apparentemente consimile nella sua visione cosmologica. Anche i cristiani credono che la fonte ed origine di tutte le cose è una sola, Dio Padre Creatore del cielo e della terra . Ma le differenze fra le due con-cezioni, cristiane e moniste, non sono negligibili . Lo studioso e sacerdote Pacifico Massi, in un interessante volume sul dialogo possibile tra Cristianesimo e New Age osserva che ci sono alcune ideologie che sono incompatibili con la visione cristiana ed elenca: monismo puro, panteismo e reincarnazione . Soffermiamoci un attimo sul monismo puro,
“secondo il quale tutto quello che esiste deriva da un unico essere universale, che e’ il tutto e il resto e’ pura apparenza e illusione . Le differenze fra gli esseri sarebbero illusorie. Da ricordare che monismo non e’ la stessa cosa che unita’, oltre la dualita’. Il monismo esclude il concetto di un Dio personale, che e’ il Dio della Bibbia. Il monismo non riconosce il dogma cattolico della Trinita’, nega la trascendenza di Dio, la sua per-sonalita’ e la creazione del mondo”187 .
187 Massi P . (2007) . Dialogo Possibile con la New Age. Spunti di Riflessione Cristiana . Ascoli Piceno (Italia): Edizione Librati, Pag. 86.
327
Questa chiara disamina della differenza fra unita’ e monismo dovrebbe anche met-terci in salvo dal farci considerare come monisti latenti . Nel nostro caso non si annulla l’opposizione ma la si rivaluta in una luce diversa .
Certamente, non sarebbe congruo non far riferimento qui ad un altro “pericolo” la-tente, quello della violazione del cosiddetto “principio di non contraddizione” . Se una cosa e’ non puo’ non essere (anche se non ci si deve sottrarre alle sfide che a questo riguardo lanciano le scoperte dovute alla meccanica quantistica) . Ma continuiamo per un momento nella riflessione sulla presenza/assenza.
Nell’antichita’ c’era questa idea forte per cui l’autorita’ si mostrava con l’as-senza, con il silenzio . Quindi si era presenti nel modo piu’ evidente quando si tace-va188 . È un concetto interessante: l’autorita’ suprema, il capo, il leader, si mostrava proprio presente in quanto assente . Qui vorrei agganciarmi alla musica . Nella musica la presenza rivelata del mistero musicale si fa piu’ presente proprio nel momento che ci sfugge. Sembra sempre che si possa essere in grado di farsi prossimi al mistero della musica che pero’ e’ poi sempre oltre. Ma e’ indubbio che la musica veicoli un qualcosa che ci interpella ma che possiamo solo accettare nel suo sottrarsi al godimen-to supremo, lasciandoci le gioie di allegrezze contingenti .
Definire la musicaCosa e’ la musica? Se pure tentiamo di dare mille definizioni non se ne da mai
nessuna che veramente rende giustizia a quello che la musica e’. Io provo sempre a chiedere ai miei studenti di definirmi la musica e, malgrado siano immersi nella musi-ca per tutta la loro vita, fanno fatica a dire qualcosa. Non li biasimo, così sono anch’io. La musica e’ una sublime forma di conoscenza, e proprio per questo non conosce . An-che qui ritorniamo alla dinamica espolorata in precedenza, nascosto-rivelato. Come puo’ qualcosa che conosce non conoscere? Anche qui dobbiamo abbandonarci alle sublimi leggi del paradosso. Perche’ solo il paradosso puo’ permetterci di accettare che non riusciamo a parlare propriamente di cio’ che ci circonda da quando siamo al mondo, come l’elemento musicale. Naturalmente si puo’ dare una definzione pu-ramente acustica, dicendo che la musica e’ il prodotto di una vibrazione di un corpo atto a vibrare, ma anche qui ci scontriamo con varie difficolta’: ogni suono e’ prodotto da una vibrazione ma non ogni suono noi chiamiamo musica189; quale e’ il confine fra suono e rumore? Se riduciamo la musica ad un fatto fisico, come spiegarsi gli influssi emozionali potentissimi che la musica stessa produce in chi la ascolta? Qui andiamo a toccare il tema centrale del nostro scritto: come la musica si rivela? E come la musica
188 Questo fa molto pensare alle varie polemiche che si sono avute dopo l’elezione di Papa Francesco o anche in precedenza riguardo al pontificato di Giovanni Paolo II, per cui il Papa dovrebbe mantenere una certa distanza, che non significa distacco, per non intaccare quell’aurea che si ritiene doveroso i fedeli percepiscano verso il successore di Pietro e Vicario di Cristo in terra . Certamente sarebbe un argomento molto delicato da trattare in cosi’ poche righe ma serva a farci pensare come anche nell’ipertecnologico XXI secolo si pensa che l’autorita’ vada esercitata negandosi.
189 Anche qui un’altra difficolta’: l’influente compositore e pensatore americano John Cage dissentireb-be con me in questo punto. Il suo motto “everything is music”, tutto e’ musica, in effetti va proprio a toccare nel suo fondamento quella distinzione che classicamente viene fatta fra musica e rumore (entrambi suoni). È un tema complesso. Vedi: Giordano M. (2003). John Cage. L’Espressione si Sviluppa in Colui che la Percepisce. Lucca (italia): LIM.
328
quindi si fa compagna della Rivelazione, come la rende manifesta . Sono due temi en-trambi complessi, uno inerente alla musica stessa, l’altro inerente al concetto di musi-ca nell’ambito piu’ ampio della rivelazione cristiana. Ma forse questi due temi che ora affrontiamo come separati non lo sono poi veramente. Cerchiamo di procedere con un certo ordine . Intanto come si puo’ accostare la musica dal punto di vista del suo darsi a noi? Certamente la si puo’approcciare da varie angolature ma io dividerei le possi-bilita’ di interpretazione del fenomeno musicale in due grandi campi che certamente hanno punti di contatto importanti fra loro, punti di contatto che forse riusciremo a toccare piu’ tardi: musica come fenomeno fisico, musica come fenomeno emozionale.
a) Fenomeno fisico
Certamente la musica puo’ essere compresa da un punto di vista meramente funzionale, come il prodotto di fenomeni acustici provocati dalla vibrazione di corpi elastici . In questo senso lo studio del fenomeno musicale interessa varie scienze come l’acustica e la fisica, per esempio:
“Che la produzione della musica e la sua percezione e fruizione siano essenzialmente basate sui principi fisici delle onde stazionarie e della risonananza e’ una nozione con-solidata tanto per gli scienziati del suono che per i musicisti (sia pure con diverse sen-sibilita’ e diversi linguaggi), ed e’ ora parte integrante del patrimonio irrinunciabile di conoscenze necessarie per bene operare in campo musicale tanto secondo i paradigmi della scienza quanto secondo quelli dell’arte”190 .
In questa asettica affermazione troviamo una esposizione molto chiara di questo
tipo di concezione della musica, che la vede come un fenomeno che piu’ attiene al dominio della fisica. Come detto in precedenza, questo approccio e’ anche necessa-rio per capire il fenomeno musicale nelle sue multiformi dimensioni, ma forse non puo’ essere considerato a se stante per avere una idea completa dello stesso . Si deve far riferimento anche all’aspetto “fisico” della musica, al suo essere scientificamente osservabile e verificabile, anche se forse lo sguardo scientifico non ne esaurisce le potenzialita’ . In effetti sembra strano il rapporto fra musica e scienza se lo osserviamo con i parametri di oggi. Oggi la musica e’ sempre piu’ spiegata dalla scienza, mentre un tempo la musica era usata per spiegare il mondo in senso scientifico. Sarebbe sor-preso chi considerasse il fatto che Matteo Ricci traducendo i testi del suo insegnante Cristoforo Clavio, includeva nella Geometria anche la musica. La sorpresa svanirebbe quando si pensasse alla concezione che viene fatta a risalire a Boezio (428 ca .-524), il quale ricollegandosi all’antichita’ classica rappresenta un punto fondamentale della riflessione teorica sulla musica nel medioevo:
“Per Boezio la musica e’ “scienza” e come tale oggetto della ragione piuttosto che dei sensi . Questi sono infatti incapaci di cogliere i suoni nella loro autenticita’ piu’ profonda . ( . . .)Uno dei capisaldi estetici dell’estetica boeziana e’ la tripartizione della
190 Allia P. Risonanze Ovvero Piccola Passeggiata in Compagnia delle Onde Stazionarie in Beltrami C. Curatore (2013) . Arte e Fisica del Suono . Milano (Italia): FrancoAngeli . Pag .96 .
329
musica in mundana, humana e instrumentalis. Come Pitagora, Boezio pone alla base dell’ordine cosmico il numero in quanto esso esprime le armoniose proporzioni che costituiscono l’ammirevole spettacolo dei cieli . L’ordinato movimento degli astri co-stituisce l’”armonia dei corpi celesti” (musica mundana), il modello, l’archetipo, delle consonanze sonore di ottava, quinta e quarta . ”191 .
Nella “musica humana” osserviamo le relazioni esistenti tra corpo e anima mentre
nella “musica instrumentalis” si ha la cosiddetta musica pratica, quella che e’ espe-rita nel cantare, suonare e nel danzare . In effetti la concezione pitagorica, tramite la speculazione boeziana, molta importanza avra’ sul pensiero successivo riguardo l’idea di cio’ che la musica rappresenta. Per quanto questa speculazione altamente teorica sull’importanza della musica puo’ aver portato ad una bassa considerazione del musico pratico rispetto al musico teorico, non si puo’ non osservare che l’alta concezione che si aveva nella scienza per il fenomeno musicale si e’ un po’ persa nella speculazione successiva per cui, in molti ambiti, si e’ quasi opposto la musica (come intrattenimento o evasione) alla scienza. E questo discorso naturalmente sarebbe piu’ ampio se si riferisce al discorso del rapporto fra arte e scienza192 . Quindi certamente questa dimensione “scientifica’ della musica andrebbe recuperata e considerata ri-levante, quindi non solo la musica sotto l’occhio della scienza ma la scienza sotto l’occhio della musica. È un discorso che porterebbe lontano. Ma non possiamo fare a meno di affrontare questo piano speculativo della musica e fortemente contestare questa idea di musica come “non-scienza”, come se fosse solo da assegnarsi al do-minio di forze irrazionali. Come della Rivelazione possiamo dire che non e’ contro la ragione ma la supera, pur se ovviamente non si oppone ad essa, cosi’ della musica possiamo dire che, pur avendo a che fare con dati che possono essere osservati fino ad un certo punto (non differentemente dalla teologia), puo’ pero’ essere investigata secondo certe metodologie e puo’ anche essere una via di conoscenza (anche in questo non diversamente dalla teologia stessa). Non dimentichiamo che riappropriarsi della musica in questo senso non fa che rispondere ad una esigenza che storicamente e’ sempre stata presente:
“Nella civilta’ greca la musica aveva importanza sociale e speculativa primaria; accanto a poesia, ginnastica e danza svolgeva funzioni religiose, teatrali ed era al centro di una complessa cosmogonia, cui partecipavano, fra gli altri, i miti di Orfeo, Apollo, Marsia, Dioniso. Gia’ nei poemi omerici si affaccia la riflessione poetica sull’ispirazione del musico; verso il VII e VI secolo la musica, che era stato codice segreto di pochi adepti, viene ad assumere ad Atene e Sparta una funzione educativa”193 .
191 Raneri E. (2011). L’Antica Musica. Storia della Musica da’’Antichita’ al Settecento . Trento (Italia): Editrice Uni Servide, Pag. 77.
192 Il sottoscritto sta completando un Dottorato in Australia con l’intento di dimostrare che la musica (e l’arte in generale) non dovrebbero essere considerate come accessory del fare storia ma come degni protagonisti che possono, con le dovute caratteristiche che sono proprie alla natura della musica o dell’arte, contribuire alla comprensione del fenomeno storico nella sua interezza .
193 Cavallera G. (1995). Estetica Musicale in Storia della Musica, Vol. I. Edito da Mario Pasi. Milano (Italia): Jaca Book, Pag .380 .
330
E questa sara’ una tendenza che andra’ avanti almeno fino al Barocco nel modo in cui la intendevano i greci . In seguito, diciamo piu’ o meno dall’illuminismo in poi, la musica stranamente abbandona secondo i teorici i regni della ragione per divenire un nobile intrattenimento. Perche’ questo sia accaduto puo’ essere frutto di varie conget-ture. Una possibilita’ certamente e’ quella che la vede ora sconnessa dalla “Scienza”, agganciata piu’ ai regni della fantasia che trovano riparo sotto la definizione di “Arte”. Certamente bisognerebbe riflettere, e a lungo, sulla filosofia della scienza e su come la stessa definisce se stessa. Diverse discipline, specialmente nel secolo trascorso, hanno tentato di accreditarsi come “Scienza”. Questo ha anche portato a suddivisioni come quelle tra scienze “dure” (hard sciences) e scienze “molle” (soft sciences) per cercare di classificare le scienze in base alle loro capacita’ di verificazione e di sottoporsi ad un metodo rigoroso . Ma certamente questi tentativi di delimitazione sembrano creare piu’ problemi di quelli che risolvono. Timothy D. Wilson, per esempio, psicologo e professore nella Universita’ della Virginia (USA) disputa che la sua disciplina, la psicologia, debba essere inclusa fra le scienze194. E come lui, in altre discipline, ce ne sono certamente molti altri .
b) Fenomeno emozionale La musica ha importanza per noi in quanto capace di comunicare un senso, di rive-
lare un senso potremmo dire, ma lo rivela in un modo del tutto speciale, manifestando un’assenza, se posso permettermi di ripetere quanto detto all’inizio di questo scritto . Sotto il profilo emozionale la musica puo’ anche essere studiata da varie discipline, come le neuroscienze, la psicologia, la filosofia (e in questa specialmentre l’esteti-ca), la semiologia, la sociologia, l’antropologia e altre ancora . Certamente potremmo dire che la musica ci interessa piu’ come fatto emozionale che come fatto fisico e in effetti sotto questo profilo la musica viene studiata cercando di rispondere ad alcune domanda fondamentali: in che modo facciamo senso dei segnali acustici provenienti dall’esterno (neuroscienze e psicologia), come questo senso interagisce con quello che noi siamo (estetica e filosofia in generale), come la musica viene compresa nel suo essere sociale (semiotica e sociologia) . Ma le piste di investigazione sarebbero molte di piu’ e certamente potrebbero portarci molto lontano nel nostro cercare di capire cosa e’ la musica e come essa rivela .
Per rivelare qualcosa bisogna usare una via di comunicazione, un medium che possa far passare l’oggetto del messaggio. E allora nasce la questione, anche molto importan-te: in che modo la musica e’ linguaggio. Si badi bene, questa questione e’ centrale nella comprensione del fenomeno musicale ma anche in questo caso potremmo trovarci di fronte piu’ a domande senza risposta che a certezze. Certamente tutti ci dovremmo tro-vare d’accordo a definire la musica un linguaggio, in quanto ci dice qualcosa:
“La musica e’ costituita da un insieme artificiale di stimoli sonori, legati tra loro dal rit-mo e dai rapporti matematici di frequenza (tono) tra i singoli suoni, che vengono emessi e ricevuti dall’uomo per altri uomini a scopo comunicativo; che arrivano alla corteccia
194 Berezow A.B. (2012). Why Psychology isn’t science. Los Angeles Times, 13 Luglio. Consultato online in: articles.latimes.com/2012/jul/13/news/la-ol-blowback-pscyhology-science-20120713.
331
cerebrale dove vengono letti e implicitamente decodificati; e dove producono effetti secondari, prevalentemente di tipo emotivo (considerando tra questi sia l’emozione estetica che le emozioni primordiali, di eccitazione, aggressione, rilassamento, paura), ma anche di tipo motorio (danza), e di tipo cognitivo (lettura)”195 .
In questa definizione abbastanza particolareggiata ma anche questionabile (effetti
secondari?) viene ancora sottolineato l’essere della musica come linguaggio. In effetti la connessione tra musica e linguaggio e’ una delle piu’ interessanti e si dovrebbe ve-ramente andare a vedere in che modo questi due elementi sono correlati.
Musica e linguaggioPrima di tutto dobbiamo accertarci dello status della musica come linguaggio . È
la musica un linguaggio? Sembrerebbe di si’. E in quanto linguaggio e’ portatore di comunicazione e quindi di conoscenza. Certamente si dovrebbe innanzitutto riflettere su come musica e speech (inteso come linguaggio parlato) sono nati . Studi in questo senso sono stati fatti da numerosi studiosi sempre piu’ da un punto di vista interdi-sciplinare . Steven Mithen, un antropologo, ha pubblicato un interessantissimo libro sull’argomento che certamente ha lasciato una traccia importante per gli studiosi che si addentrano in questo argomento spinoso. E nello stesso libro lo studioso spiega come questa ricerca sia dovuto ad un interesse recente all’evoluzione della musica in quanto in precedenza, salvo poche eccezioni, non era questo un argomento ritenuto valido oggetto di studio:
“Anche se la societa’ di Linguistica di Parigi non aveva nulla da eccepire riguardo allo studio delle origini della musica, sembra che gli accademici hanno osservato una restrizione auto imposta, che è continuata in effetti fino al giorno d’oggi. Ci sono state, naturalmente, alcune rimarchevoli eccezioni che vanno riconosciute. Una di queste era Charles Darwin, che ha dedicato poche pagine nel suo libro “The Descent of Man” del 1871, all’evoluzione della musica . Piu’ recentemente, il rinomato etnomusicologo John Blacking il cui libro del 1973, “How Musical is the Man?” ha introdotto l’idea che la musica puo’ essere una inerente e universale qualita’ umana”196 .
È questa naturalmente una ricerca in pieno svolgimento . In un interessante artico-
lo su una rivista di area anglosassone (Adrienne Lafrance, The Atlantic, 19 febbraio 2014) viene riferito di uno studio197 che mette in luce come la musica e la conver-sazione parlata attivano le stesse aree del cervello . Quindi il cervello sembrerebbe
195 Panizon F. (2008). La Musica e i suoi effetti comunicativi e neurofisiologici, e la Musicoterapia. Medico e Bambino 8, 534 .
196 Mithen S. (2006). The Singing Neanderthal. The Origins of Music, Language, Mind, and Body . Londra (Regno Unito): Weidenfeld & Nicolson, Pag . 2 (mia traduzione) .
197 Donnay F .G, Rankin S .K ., Lopez-Gonzalez M ., Jiradejvong P ., Limb C . (2014) . Neural Substrates of Interactive Musical Improvisation: An fMRI Study of ‘Trading fours’ in Jazz. PLoS ONE 9(2): e88665 . doi: 10 .1371/journal .pone .0088665 . See also: Limb CJ, Braun AR (2008) . Neural Substra-tes of Spontaneous Musical Performance: An fMRI Study of Jazz Improvisation. PLoS ONE 3(2): e1679 . doi: 10 .1371/journal .pone .0001679 .
332
predisposto a percepire musica e speech come linguaggi entrambi . Charles Limb, uno dei ricercatori per questo progetto e professore associato del dipartimento di otorino-laringoiatria della Johns Hopkins (USA) osserva198:
“Se il cervello evolve per lo scopo di sviluppare la lingua parlata (speech), e’ strano che anche evolva per sviluppare una capacita’ che va al di la’ della lingua parlata. Cosi’ se abbiamo un cervello che evolve con la capacita’ di gestire la comunicazione musicale, vuol dire che c’e’ una correlazione tra i due (speech e musica). Io ho ragione di sospet-tare che il cervello auditivo che e’ stato progettato per ascoltare musica e lingua parlata sia un felice effetto secondario” .
Lo studio rivela anche informazioni molto interessanti che toccano il tema dell’im-
provvisazione, informazione su cui sara’ necessario ritornare . Insomma, musica e speech sono concepite dal cervello come linguaggio, anche se con differenze fra le due, che vedremo in seguito. Ma di alcune di queste differenze bisogna fare senso in questo momento. Potremmo dire, per tornare alle similitudini che musica e linguaggio condi-vidono tre elementi: comunicativo, grammaticale e semiotico . Non abbiamo problemi nel dire che la musica sia comunicazione, come il linguaggio parlato; allo stesso modo riconosciamo che sia il linguaggio parlato che la musica hanno bisogno di una gram-matica per comunicare un senso all’ascoltatore; anche entrambe si servono di segni (semeion), note o parole, che simboleggiano i concetti musicali o concettuali che si vogliono far arrivare. Dove comininciano le similitudini si annidano anche le differen-ze. La prima e la piu’ grossa e’ proprio quella che riguarda l’elemento comunicativo della musica. In che modo comunica? Cosa in effetti comunica? Io faccio sempre un esempio ai miei studenti per capire come la musica sia attiva in un regno comunicativo diverso rispetto al comune linguaggio parlato . Nello studio di Charles Limb citato in precedenza ci si concentra sulla musica Jazz, fortemente basata sulla improvvisazione . Quando il musicista improvvisa il cervello non processa il significato semanticamente ma solo sintatticamente. Questo significa che non va a cercare un significato ma sem-plicemente un senso di cio’ che sta ascoltando. Lo stesso Dottor Limb avverte:
“La comunicazione musicale, come sappiamo, significa qualcosa per gli ascoltatori, ma quel significato non puo’ essere descritto precisamente. Non ha un elemento assertivo o specificità di significato nello stesso modo di una parola”.
Ecco che torniamo alla mia definizione precedente, come la musica sia una subli-
me forma di conoscenza, ma che per la sua sublimità non comunica. Come gia’ detto, rivela nascondendo o nascondendo rivela .
Per finireIn questo senso, mi sembra evidente da quanto osservato in precedenza che, essen-
do la musica un linguaggio e’ essa atta a comunicare nel suo modo proprio. Essendo questo linguaggio capace di toccarci nel profondo si rivolge a quell’uomo interiore
198 Ringrazio il Dottor Limb che mi ha segnalato l’articolo piu’ recente (le traduzioni sono mie).
333
che e’ anche oggetto della chiamata esplicatosi nell’evento dell’Incarnazione. La stes-sa musica puo’ (e forse, deve) concorrere a quella comprensione profonda del dato rivelato a cui e’ assimilata attraverso quelle dinamiche di presenza/assenza che abbia-mo rilevato nel Cantico dei Cantici e che sembrano tornare nel passo di Matteo citato in precedenza, per cui sono nascoste le cose rivelate a coloro da cui sarebbe lecito aspettarsi la comprensione piu’ profonda che invece e’ rivelata a coloro da cui sarebbe lecito aspettarsi venga nascosta. La musica, questo mistero, si rivela anche nascon-dendosi per aprirsi misteriosamente a coloro che sanno ascoltare, a coloro che sanno aprirsi a cio’ che e’ chiuso ma non esclusivo e non escludente. La musica concorre alla Rivelazione e ne e’ ancella fedele ed operosa .