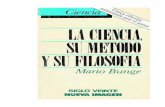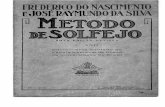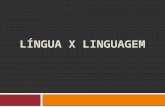La lingua come metodo di analisi in Condillac
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La lingua come metodo di analisi in Condillac
Edizione delle opere filosofiche in 16 volumi, 1821-1822 in-8 a cura di Augustin Théry
1 Saggio sull’origine delle conoscenze umane (1746)
2 Trattato sui sistemi (1749)3 Trattato sulle sensazioni (1754) Trattato
sugli animali (1755)4 Il commercio e il governo (1776)5 Arte di pensare e Arte di scrivere 6 Arte di ragionare e Grammatica7-10 Storia antica11-14 Storia moderna15 Studio di storia e Logica (1780)16 Lingua dei calcoli (postuma)
Corso di studi per l’istruzione del principe di Parma
1 Grammatica2 Arte di scrivere3 Arte di ragionare4 Arte di pensare5-8 Storia antica9-12 Storia moderna13 Studio della storia
ARTE DI PARLARE“In fondo arte di parlare, arte di scrivere, arte di ragionare e arte di pensare non sono che una sola e medesima arte. Di fatti, quando si impara a pensare, si impara a ragionare; e non serve altro, per parlare bene e per scrivere bene, che parlare come si pensa e scrivere come si parla. (…)
L’arte di parlare non è dunque che l’arte di pensare e l’arte di ragionare che si sviluppa con il perfezionarsi delle lingue; e diventa arte di scrivere nel momento in cui acquisisce esattezza e precisione. (…)
Tutte le arti non si riducono che all’arte di parlare”.
(Discorso preliminare, p. 284)
ARTE DI PARLARE“Se un pensiero non è nell’ordine di successione nello spirito, lo è nel discorso, dove si scompone in tante parti quante sono le idee che contiene. A questo punto possiamo osservare ciò che facciamo quando pensiamo, possiamo rendercene conto; possiamo di conseguenza apprendere a condurre la nostra riflessione. Pensare diventa quindi un’arte, e quest’arte è l’arte di parlare”.
(Discorso preliminare, p. 286)
ARGOMENTI1. ANALISI: modo per conoscere
a. ANALISI vs SINTESI2. LINGUA: teoria del segno
a. SEGNO ARBITRARIO o ARTIFICIALE?3. METODO DI ANALISI: necessità del segno
a. ASTRARRE, ORDINARE, COMBINARE4. LINGUA METODO DI ANALISI
a. ANALISI SEGNOb. ANALISI PROPOSIZIONEc. ANALISI RAGIONAMENTO
ORIGINE DELLE LINGUE“Quando parlo di una lingua originaria non pretendo di stabilire che gli uomini abbiano davvero fatto quella lingua; suppongo soltanto che avrebbero potuto farla.
Il linguaggio di un bambino è l’immagine della lingua primitiva la quale, all’origine, doveva essere piuttosto rozza e limitata, e della quale i progressi sono stati lenti, poiché gli uomini avanzano lentamente di conoscenza in conoscenza”.
(Grammatica, n. 1, p. 370)
ANALISI vs SINTESISINTESI
“L’inutilità e l’abuso dei principi appare soprattutto nella sintesi, metodo per il quale sembra che la verità possa apparire solo in quanto preceduta da un gran numero di assiomi, di definizioni, e di altre proposizioni che si pretendono feconde”.
(Saggio, I.II.VII.63.)
ANALISI vs SINTESIANALISI
“consiste nel comporre e scomporre le idee per poter effettuare diversi confronti, per scoprire, in questo modo, i rapporti tra le idee, e le nuove idee che quelle possono produrre”.
(Saggio, I.II.VII.66)
ANALISI vs SINTESIANALISI
“Analizzare è scomporre, comparare e afferrare i rapporti.
Ma l’analisi non scompone che per far vedere, per quel che è possibile, l’origine e la generazione delle cose”.
(Arte di pensare, p. 221)
ANALISI vs SINTESISINTESI
“Le prime scoperte scientifiche furono così semplici e facili che gli uomini vi giunsero senza l’aiuto di un qualche metodo. Non avrebbero potuto immaginare delle regole che dopo aver fatto dei progressi (…). Così coloro che fecero le prime scoperte non furono in grado di mostrare la strada da intraprendere e per la quale proseguire, dal momento che loro stessi non sapevano quale strada avessero percorso”.
(Saggio, I.II.VII.62.)
ANALISI vs SINTESISINTESI
“Le prime scoperte scientifiche furono così semplici e facili che gli uomini vi giunsero senza notare il metodo che avevano seguito. Questo metodo era buono, poiché aveva permesso loro di fare delle scoperte: ma gli uomini lo seguirono a loro insaputa; come oggi molte persone parlano bene, senza avere alcuna conoscenze delle regole linguistiche. Dal momento che non conoscevano la strada che avevano intrapreso, non erano in grado di mostrare la strada che bisognava percorrere (…)”.
(Arte di pensare, p. 121)
ANALISI vs SINTESIANALISI
“Non cerca la verità con l’aiuto delle proposizioni generali ma sempre per mezzo di una specie di calcolo, ovvero scomponendo e componendo le nozioni, per compararle nel modo più favorevole alle scoperte”.
(Saggio, I.II.VII.66)
ANALISI vs SINTESIANALISI
“Nemica delle nozioni vaghe, e di tutto ciò che può essere contrario all’esattezza e alla precisione, non è con l’aiuto delle massime generali, delle definizioni di parole o dei sillogismi, che cerca la verità, ma con l’aiuto del calcolo; somma, sottrae, tende, fin dove è possibile, a esaurire le combinazioni”.
(Arte di pensare, p. 128)
ANALISI = FACOLTA’ NATURALE
“Il metodo della statua per acquisire idee è osservarle in successione, le une dopo le altre; la statua analizza naturalmente le qualità che attribuisce agli oggetti, ma non possiede un linguaggio. Ora, un’analisi compiuta senza segni non può fornire che conoscenze molto limitate; queste sono per forza poche; e poiché non è possibile metterle in ordine, l’insieme sarà troppo confuso”.
(Trattato sulle sensazioni, II.VIII.35.)
ANALISI = FACOLTA’ NATURALE“Ciò che guida la statua è propriamente un istinto, ovvero un’abitudine di muoversi al seguito di idee di cui non sa rendersi conto, abitudine che, una volta contratta, la guida con sicurezza, senza che la statua abbia bisogno di ricordare i giudizi che l’abitudine le ha fatto prendere. In una parola ha acquisito delle idee. Ma, una volta che queste idee hanno cominciato a guidarla, la statua non vi pensa più, agisce per abitudine. Per acquisire delle conoscenze è indispensabile avere un linguaggio; perché occorre classificare e determinare le idee, il che presuppone dei segni impiegati con metodo”.
(Trattato sulle sensazioni, II.VIII.35.)
SEGNI ARBITRARI vs SEGNI ARTIFICIALI
“Cosa sono dei segni arbitrari? Dei segni scelti senza ragione e per capriccio. Che non si possono dunque intendere. Al contrario, i segni artificiali sono segni la cui scelta è basata sulla ragione: devono essere immaginati con una tale arte, che l’intelligibilità ne sia preparata per mezzo di segni che sono conosciuti”.
(Grammatica, pp. 357-358)
ANALOGIA vs CONVENZIONE
“Le lingue non sono un ammasso di espressioni prese a caso, o di cui se ne serve perché si è convenuto di servirsene. Se l’uso di ciascuna parola presuppone una convenzione, la convenzione presuppone una ragione che fa adottare ciascuna parola, e l’analogia, che fornisce la legge, e senza la quale sarebbe impossibile intendersi, non permette che si compia una scelta del tutto arbitraria”.
(Lingua dei calcoli, pp. 1-2)
ANALOGIA“Se, per apprendere una lingua che non conosco, la studio
su opere che trattano di cose che non conosco, devo studiare nello stesso tempo queste cose e la lingua; doppio lavoro che certamente non mi farà fare rapidi progressi. Non accade questo se scelgo opere che trattano cose che conosco, o se studio nuove cose in una lingua che mi è familiare.
Cominciamo come gli inventori hanno cominciato; scopriremo, come loro, ciò che loro hanno scoperto. Ora, non è con le cifre che hanno cominciato a calcolare: ma con le dita e con i nomi; ed è osservando questo modo rozzo di contare che hanno trovato metodi migliori.
Quando dunque hanno immaginato delle cifre, è per fare ciò che già sapevano fare prima; è per dire con nuovi segni ciò che sapevano dire con altri segni”.
(La lingua dei calcoli, pp. 123-124)
ANALOGIA e ANALISI“Le lingue sono state metodi precisi quando non si parlava che di cose relative ai bisogni di prima necessità. (…) In verità avevano allora molti limiti: ma non bisogna credere che, essendo limitate, fossero mal costruite. (…)
Se, volendo perfezionarle, si vuole continuare come si aveva cominciato, si devono cercare nuove parole per mezzo dell’analogia solo quando un’analisi ben condotta ha in effetti prodotto nuove idee; così le lingue, rimanendo precise, sarebbero più estese”.
(Logica, pp. 409-410)
ASTRAZIONE“Abbiamo visto che le nozioni astratte si formano quando si pensa non alle proprietà che distinguono le cose ma alle qualità per cui concordano. (…)
Queste idee non sono che delle denominazioni che diamo alle cose considerate in base agli aspetti per cui somigliano: per questo le si chiama idee generali”.
(Saggio, I.V.1.)
ASTRAZIONE“Ciò che rende le idee generali così necessarie è il limite del nostro spirito. Dio non ne ha alcun bisogno (…). Per noi, la capacità del nostro spirito ha un limite, non solamente quando pensiamo a un oggetto, ma anche quando ne consideriamo alcuni aspetti. Per questo dobbiamo, per mettere ordine nei nostri pensieri, distribuire le cose in differenti classi”.
(Saggio, I.V.4.)
ASTRAZIONE“È dunque per il fatto che la nostra intelligenza è limitata che noi astraiamo e generalizziamo; ma se, nelle astrazioni e nelle idee generali, si procede con metodo, l’ordine supplirà alla limitazione dello spirito. In effetti cosa si deve all’analisi? (…) Ora, analizzare è scomporre, separare; ovvero astrarre, ma astrarre con ordine”.
(Arte di pensare, p.99)
ASTRAZIONE“Tutte le idee generali sono delle idee astratte (…). Ma
qual è in fondo la realtà che l’idea generale e astratta ha nel nostro spirito? Il fatto che non è che un nome (…).
Quando per esempio penso a uomo, non posso considerare in questa parola che una denominazione comune; nel qual caso è ben evidente che la mia idea è circoscritta in questo nome, che non si estende oltre, e che di conseguenza non è che questo stesso nome.
Se al contrario, pensando a uomo, considero in questa parola qualche altra cosa che la sola denominazione, in effetti mi rappresento un uomo; e un uomo, in me come nella natura, non potrà mai essere l’uomo astratto e in generale”.
(Logica, p. 418)
ORDINARE“Per avere una conoscenza di questa campagna, non basta
dunque vederla tutta insieme, occorre vedere ciascuna parte l’una dopo l’altra; e, invece che abbracciare il tutto con un colpo d’occhio, fermare lo sguardo successivamente oggetto per oggetto. Ecco cosa ci insegna la natura. (…)
Questa facoltà [di guardare] appartiene a chiunque. Tuttavia, se in seguito vogliamo parlare di questa campagna, si noterà che ognuno non la conosce ugualmente bene. (…) Ciascuno di noi non ha nemmeno visto gli stessi oggetti; ma gli sguardi degli uni si sono orientati a caso, e gli sguardi degli altri si sono diretti con un determinato ordine.
Di che ordine si tratta? Ce lo indica la natura; è l’ordine nel quale la natura dispone gli oggetti”.
(Logica, p. 332)
ORDINARE“Ora lo sguardo dell’anima è come lo sguardo del corpo; abbiamo detto che i nostri pensieri sono naturalmente dei quadri confusi, di cui non distinguiamo le parti che dal momento in cui apprendiamo l’arte di mettere in successione, con ordine le une dopo le altre, le idee che si offrono a noi tutte insieme.
Quest’arte ha avuto origine con le lingue, e, con loro, si è perfezionata lentamente. E per questo che le abbiamo considerate come dei metodi d’analisi più o meno perfetti”.
(Grammatica, p. 458)
COMBINARE“L’anima è così limitata che non può rievocare una grande quantità di idee per farne tutte in una volta l’oggetto della sua riflessione. Tuttavia le è spesso necessario considerare più idee insieme. È ciò che fa con l’aiuto dei segni che, riunendo le idee, le permettono di considerare queste come se fossero una sola idea”.
(Saggio, I.IV.I.6.)
COMBINARE“Per la natura del calcolo, è sufficiente avere idee dei primi numeri per potersene fare di tutti i numeri che si possono determinare. Una volta assegnati i primi segni, abbiamo delle regole per inventarne degli altri”.
(Saggio, I.IV.I.2.)
COMBINARE“Per la natura del calcolo, è sufficiente avere idee dei primi numeri per potersene fare di tutti i numeri che si possono determinare. Una volta assegnati i primi segni, abbiamo, con l’analogia, le regole per inventare altri segni”.
(Arte di pensare, p. 62)
LINGUA METODO DI ANALISI“Il pensiero, considerato in generale, è lo stesso in tutti gli uomini. In tutti, viene ugualmente dalla sensazione; in tutti, si compone e scompone nello stesso modo. (…) Il metodo che gli uomini seguono è dunque soggetto alle stesse regole in tutte le lingue.
Ma questo metodo si serve, nelle differenti lingue, di segni differenti. Più o meno rozzi, più o meno perfezionati, il metodo rende le lingue più o meno capaci di chiarezza, precisione, energia; e ogni lingua ha regole che le sono proprie”.
(Grammatica, p. 402)
LINGUA METODO DI ANALISIScomposizione azione Scomposizione pensiero
ANALOGIA ANALISI
Nuovi segni Nuove idee
LINGUA METODO DI ANALISI“Ma perché è così difficile determinare le idee? Perché non conosciamo tutti gli usi che possiamo fare delle lingue. Crediamo di non averle costruite che per comunicare le nostre conoscenze, e non sappiamo che sono dei metodi per acquisire conoscenze.
Meno sono imperfette, meno ci disorientano, perché migliori sono le nostre analisi; se fossero condotte al più alto grado di perfezione, ci guiderebbero con sicurezza come ci guida l’algebra: infatti se le lingue non sono che dei metodi di analisi, l’algebra non è che una lingua. Per evitare gli errori non occorre altro che saper usare le lingue che parliamo”.
(Arte di pensare, pp. 185-186)
LINGUA METODO DI ANALISI“Per fare questa scomposizione, abbiamo distribuito con ordine le parole che sono i segni delle idee. In ogni parola abbiamo considerato ciascuna idea separatamente; e in due parole messe in rapporto, abbiamo osservato il rapporto che le due idee hanno tra loro. È dunque all’uso delle parole che dobbiamo la possibilità di considerare le idee ciascuna in se stessa, di effettuare comparazioni per scoprirne i rapporti. Non c’è altro mezzo per compiere l’analisi. Di conseguenza senza l’uso dei segni artificiali non è possibile analizzare”.
(Grammatica, pp. 384-385)
LINGUA METODO DI ANALISI“Ma se non possiamo analizzare, non possiamo considerare separatamente, e ciascuna in se stessa, le idee di cui è composto il pensiero. Restano come avvolte confusamente nella percezione. E se sono in questo stato, è evidente che comparazioni e giudizi non sono che percezioni: di conseguenza non si può articolare la proposizione quest’albero è grande; perché queste idee restano simultanee nell’anima, e non si hanno i mezzi per rappresentarle in successione, il solo ordine che le permette di distinguerle, e che solo il discorso può conferire”.
(Grammatica, p. 385)
LINGUA METODO ANALISIIdea principale Idea secondaria Idea di relazione
NOME AGGETTIVO COPULA
SOSTANTIVO ATTRIBUTO VERBO
LINGUA METODO DI ANALISIx = y + 2; x = 2y – 3
y + 2 = 2y – 3
2 + 3 = 2y – y
“y + 2 = 2y – 3” = “2 + 3 = 2y – y”
LINGUA METODO DI ANALISI“Il linguaggio algebrico fa vedere in modo sensibile come i giudizi sono legati gli uni agli altri in un ragionamento. Mostra come l’ultimo è contenuto nel penultimo, il penultimo in quello che lo precede, e così di seguito risalendo: ciò perché l’ultimo è identico al penultimo, il penultimo a quello che lo precede, ecc.; l’identità è ciò che rende l’evidenza del ragionamento”.
(Logica, p. 443)
LINGUA METODO DI ANALISI“Se vi sono scienze poco esatte, non è perché non parlano l’algebra, ma perché le lingue non sono ben costruite (…).
Tutto conferma ciò che abbiamo già dimostrato, che le lingue sono metodi di analisi, che il ragionamento non si perfeziona che per il fatto che si perfezionano le lingue stesse, e che l’arte di ragionare, ridotta al massimo di semplicità, non è che una lingua ben fatta”.
(Logica, p. 445)
LINGUA METODO DI ANALISI“Vi sono due cose in un problema: l’enunciato dei dati e la soluzione delle incognite.
L’enunciato dei dati è ciò che si intende per lo stato del problema, la soluzione delle incognite è il ragionamento con cui si risolve il problema. (…)
Stabilire lo stato del problema significa tradurre i dati nell’espressione più semplice: è l’espressione più semplice che facilita il ragionamento, ovvero la soluzione delle incognite”.
(Logica, pp. 448-449)