La teoria della mente sociale di Mead come supporto per una filosofia delle lingue
LA FILOSOFIA DI CHARLES PEGUY
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of LA FILOSOFIA DI CHARLES PEGUY
742 Note e rassegnenote e rassegne
Humanitas 70(4-5/2015) 742-757
Paolo Cugini
LA FILOSOFIA DI CHARLES PÉGUY
1. Introduzione
Ci sono autori, soprattutto quando la loro produzione abbracci vari ambiti, che vengono conosciuti a partire da alcuni aspetti delle loro opere, perdendone di vista la struttura integrale, a scapito di visioni parziali e, spesso e volentieri, marginali. Uno di questi autori è Charles Péguy1. Di lui si conoscono in modo particolare le opere poetiche, alcune di prosa, soprattutto quelle di critica socia-le, legate all’esperienza dei «Cahiers de la Quinzaine». Al contrario, la produ-zione filosofica di Péguy, il suo rapporto significativo con la filosofia di Henri Bergson, la sua filosofia della storia, la sua originalissima maniera di abbordare la metafisica, sono pressoché sconosciuti. Eppure tutta la poetica peguyana è segnata da quel metodo intuitivo appreso negli anni della giovinezza dal suo carissimo maestro Bergson. Ciò significa che, senza approfondire la filosofia di Péguy è difficile cogliere la profondità della sua produzione poetica. L’obiettivo del nostro intervento consiste nel presentare alcuni degli snodi centrali del pen-siero filosofico di Péguy, che permettano poi di leggere e di cogliere le profondi-tà della sua prosa e, soprattutto, della sua produzione poetica.
1 Charles Péguy (1873-1914). Libero pensatore e scrittore prolifico, fonda una libreria e una rivi-sta, le «Cahiers de la Quinzaine», che propone quaderni d’informazione e dossier relativi ai problemi e ai fatti del momento, tra i quali si possono segnalare i Congressi Socialisti, l’Affaire Dreyfus e la Separazione Chiesa-Stato. Nell’ottobre del 1901 Péguy installa un piccolo negozio dei «Cahiers» con l’aiuto di pochi amici (Tharaud e Jules Isaac). Se il primo gruppo dei «Cahiers» (1900-1905) è quello del periodo della creazione, dell’organizzazione dell’impresa e della presa di coscienza dei problemi teorici e politici essenziali, il secondo (1905-1909) segna un periodo di approfondimento e di maturazione che condurrà alla tacita riscoperta della fede. In questa atmosfera Péguy sente e riscopre il senso degli Eroi, dei santi, della Patria francese. Nel 1907 Charles Péguy si converte al cattolicesimo. Oltre al famoso Mistero di Giovanna d’Arco scrive altri due “misteri”: Il Portico del mistero della seconda virtù, datato 22 ottobre 1911 e Il mistero dei Santi Innocenti, del 24 marzo 1912. I libri non si vendono, gli abbonati della rivista calano e il fondatore dei «Cahiers», si trova in difficoltà. Inviso ai socialisti per la sua conversione, non fa breccia nemmeno nel cuore dei cattolici, i quali gli rimproverano alcune scelte di vita sospette, come quella di non aver battezzato i figli, per venire incontro al volere della moglie. Nel 1912 il figlio minore Pierre si ammala gravemente e il pa-dre fa il voto di andare in pellegrinaggio a Chartres, in caso di guarigione. Quando essa arriva, Péguy compie, in piena estate, un cammino di 144 chilometri in tre giorni, fino alla cattedrale di Chartres. È la sua più grande dimostrazione di fede. Nel dicembre del 1913, ormai scrittore cattolico, scrive un poema enorme, che sconcerta pubblico e critica. Si intitola Ève ed è composto da 7.644 versi. Quasi contemporaneamente vede la luce uno dei suoi saggi più polemici e brillanti: Il denaro. Nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale: Péguy si arruola volontario e muore al fronte il 5 settembre 1914, il primo giorno della famosa e sanguinosa battaglia della Marna.
Cugini – La filosofia di Charles Péguy 743
Il problema della filosofia, per Péguy, non è quello di imporre il proprio siste-ma, ma di accettare di essere una voce tra le altre nel coro di coloro che cantano, raccontano la realtà. Péguy ha sempre avuto questa idea sia di se stesso che del suo pensiero. Sfogliando le pagine della sua opera ci si rende, dunque, immedia-tamente conto di trovarsi di fronte a una filosofia anomala, diversa. In un periodo culturale – gli inizi del novecento – che vedeva l’affermazione soprattutto negli ambienti accademici del metodo storico-critico, basato su rigorosi procedimenti deduttivi, non poteva che destar dispregio e sdegno un’opera che andava in tutta altra direzione. Nelle pagine di Péguy non si trova né una nota né un paragrafo, né un capitolo: la sua opera è una riga continua dall’inizio alla fine. Il suo metodo consiste nel seguire nelle pieghe della realtà presente la realtà intuita nell’istante, con uno stile fatto di ripetizioni, parentesi, riprese del tema.
Ciò che lo ha appassionato di più sono i problemi della natura e del metodo della filosofia inserita nella quotidianità della sua funzione e immersa nel conte-sto degli altri saperi e dei sempre rinascenti poteri, da quelli della politica, a quel-li del denaro a quelli dell’opinione. La sua filosofia è cosi anzitutto un’attitudine interiore che, confrontandosi con gli eterni problemi del senso della vita, della morte e dell’essere con gli altri, ritrova un rapporto diverso con quel comune sen-so filosofico quale si esprime e si evidenzia, al di là delle pretese di una filosofia professionale e sistematica, negli ambiti della vita quotidiana.
2. Péguy e Bergson
Non è possibile ricostruire il profondo rapporto tra Péguy e Bergson senza far riferimento ad alcuni elementi ormai acquisiti come propri dell’originale con-testo costituito dal ventennio a cavallo tra Otto e Novecento. Prendendo spunto dalla ricerca di R. Arbour si può affermare che
«i contatti personali che possiamo identificare tra Bergson e molti scrittori e i dibattiti che, anche negli ambienti letterari, si sono scatenati intorno al bergsonismo prima del 1914, offrono lo spettacolo ormai insolito di un pensiero che appena formulato, si trova più o meno impegnato nella corrente della letteratura vivente»2.
In questo clima Péguy possedeva comunque una materia troppo nuova e mez-zi di espressione ben precisi per sentire il bisogno di aderire all’una o all’altra scuola in cerca di nuove formule. In effetti per esempio, nell’ambito del clima poetico dell’inizio del secolo, «la sua opera costituisce una specie di affluente dalle sorgenti indipendenti»3. D’altra parte, la sua speranza di liberazione, la sua spontanea reazione di contadino della valle della Loira, la difesa gelosa della propria libertà interiore lo facevano sentire a disagio in un’atmosfera razionalista o determinista da cui Bergson contribuì a liberarlo conducendolo a costruire un
2 R. Arbour, Henri Bergson et les lettres françaises, José Corti, Paris 1956, p. 13.3 Ibi, p. 279.
744 Note e rassegne
pensiero filosofico modellato su quello di Bergson, una psicologia religiosa che intuì, molti anni prima, la famosa distinzione tra religione chiusa e religione aperta a una amicizia come alimento, sostegno, punto profondo di riferimento.
Bergson resterà il maestro: quel maestro che aveva operato nell’ordine del pensiero la stessa rivoluzione che egli voleva promuovere nell’ordine sociale e politico. E Bergson stesso sarà costretto a riconoscere che «Péguy ha conosciuto il mio pensiero il mio pensiero essenziale, tale e quale io non l’ho ancora espres-so, tal quale io vorrei esprimerlo»4.
Il rapporto di discepolato di Péguy nei confronti di Bergson nasce intorno al 1897, così come lo documenta Jacques Viard nella prefazione alla traduzione italiana delle due Note di Péguy pubblicate postume5:
«Ogni venerdì, nel 1903, assiste al suo corso al Collège de France. Sette anni prima, quando lo aveva come professore all’Ecole Normale Supérieure, era felice di avere final-mente quella impressione personale che niente può sostituire: ascoltare direttamente la voce instancabile e sottile che proponeva con la tenuità audace, nuova e profonda che la caratterizza ancora innumerevoli ipotesi nuove»6.
In ogni modo, Péguy non si è limitato a riprendere nel proprio stile le tesi del Maestro: egli ha impresso loro un movimento in discesa verso le situazioni concrete, trovando loro prolungamenti e applicazioni inattesi non per falsare in-tenzionalmente il pensiero di Bergson quanto, soprattutto, per la sua capacità di cogliere le immagini mediatrici che ce ne propongono tanti aspetti complemen-tari pur restando egli sempre un discepolo originale sia nell’incontro con il pen-siero di Bergson che nella costruzione di un particolare bergsonismo letterario7.
È lo stesso Péguy, in un saggio senza titolo apparso il 3 febbraio 1907 nel- l’undicesimo «Cahier» della serie ottava, a tematizzare il significato dinamico e creativo del rapporto che deve intercorrere tra maestro e discepolo:
«Un allievo non significa niente. Il più grande degli allievi, se è soltanto allievo, se ripete solo, se non fa che ripetere, non sa neanche che dire la stessa risonanza, perché allora non è neanche più una risonanza, neanche una eco, è un miserabile ricalco, il grande degli allievi, se è solo un allievo, non conta, non significa assolutamente più niente, è nulla per sempre. Un allievo vale, comincia a contare, solo nel senso e nella misura in cui egli
4 Cfr. «Europe», 15 aprile 1938, p. 488, in A. Prontera, La filosofia come metodo, libertà e plu- ralità in Péguy, Milella, Lecce 1988, p. 32.
5 Note sur H. Bergson et la philosophie bergsonienne, datata 26 aprile 1914 e Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartesienne, datata marzo-luglio 1914 (Gallimard, Paris 1935). Sul rapporto Péguy-Bergson cfr. A. Devaux, La rencontre entre Péguy et Bergson, in AA.VV., Péguy vivant, Milella, Lecce 1978, pp. 561-566.
6 J. Viard, pref. a Ch. Péguy, Cartesio e Bergson, a cura di A. Prontera e M. Petrone, Milella, Lecce 1977, p. xix.
7 «Riconoscere così un’influenza più o meno diretta significa sottovalutare la potenza e il genio creatore di uno scrittore come Péguy? No di certo. [...] Il genio consiste nell’aggiungere ai lasciti del-la tradizione, dopo averli ben situati, una visione originale delle cose, una sensibilità e una capacità immaginativa fresche, procedimenti espressivi e anche una tecnica in accordo preciso con ciò che lo scrittore porta in se stesso... E tale fu il caso di Péguy in rapporto a Bergson» (ibi, p. 310).
Cugini – La filosofia di Charles Péguy 745
stesso introduce una voce, una nuova risonanza, cioè proprio nel senso e nella misura in cui non è più, non è un allievo. Non che vi sia il diritto di discutere da una altra filosofia o da un altro filosofo, ma egli deve discenderne per le vie naturali della filiazione, e non per le vie scolastiche dell’allevamento»8.
È a queste parole che dovremo continuamente andare, proprio perché il bergsonismo sottende a tutta l’opera di Péguy. Nella filosofia di Bergson, Péguy individua quelle intuizioni che diverranno le chiavi ermeneutiche di tutte le sue successive riflessioni, da quelle sul piano politico, a quelle più prettamente re-ligiose e poetiche. Sottolineando che durata, memoria, slancio vitale segnano le grandi tappe della filosofia bergsoniana, e che l’intuizione, come metodo del bergsonismo, “non è un sentimento, né una ispirazione, una simpatia confusa, ma un metodo elaborato, anzi uno dei metodi più elaborati della filosofia, le cuoi re-gole rigorose costituiscono quella che Bergson chiama la precisione filosofica”9 ,Deleuze ci tiene a precisare che in una esposizione del pensiero di Bergson l’intuizione come metodo rigoroso e preciso, va messo in primo piano. In questo senso il bergsonismo, come stile del pensiero stesso e come modo di far filosofia, si rivela soprattutto una questione di metodo dove non si tratta tanto di risolvere i problemi quanto di porli10 evitando sempre di vedere differenze di grado là dove non ci sono differenze di natura per ritrovare le vere articolazioni del reale nella coscienza che è proprio agendo e creando, più che contemplando, che l’uomo può accedere alla totalità creatrice aperta. Anche all’interno della stessa filosofia – continua Deluze – si ammette ancora troppa contemplazione: come se l’intelli-genza fosse già penetrata dall’emozione e dunque dall’intuizione ma in modo in-sufficiente per creare conformemente a questa emozione. In definitiva, le grandi anime non sono quelle dei filosofi, ma piuttosto quelle degli artisti e dei mistici.
«Il filosofo già animato dall’emozione – osserva Deluze – coglieva le linee che si distri-buivano nei misti dati dell’esperienza, ne prolungava il tracciato fino oltre la curva e ne indicava in lontananza il punto virtuale in cui in tutte si incontravano»11.
L’accordo fondamentale tra Péguy e Bergson non è possibile riconoscerlo so-lamente in una istanza metodologica, che è quella del metodo intuitivo. È a diversi livelli che il discepolo, in modo originale, ha fatto risuonare la voce del maestro.
8 In A. Prontera, La filosofia come metodo, cit., p. 78.9 G. Deleuze, Il bergsonismo, Feltrinelli, Milano 1987, p. 7.10 «La verità è che si tratta, in filosofia come altrove, di trovare il problema e quindi di porlo
ancor più che di riservarlo. Infatti un problema speculativo, quando è ben posto, è già risolto. Vo-glio dire che la soluzione esisteva sin dall’inizio, anche se può poi rimanere nascosta, per così dire, coperta: non c’è che da scoprirla. Porre un problema non vuole però dire semplicemente scoprire, bensì anche inventare. Poiché si basa su ciò che già esiste, attualmente o virtualmente, prima o poi la scoperta dovrà venire. L’invenzione, invece, dà l’essere a ciò che non esisteva, e che potrebbe non venire mai. Già in matematica, e a maggior ragione in metafisica lo sforzo di invenzione consiste quasi sempre nel suscitare il problema, nel creare i termini in cui esso sarà posto. Posizione e solu-zione quasi si equivalgono» (H. Bergson, La pensée et le mouvant, Paris 1934, in A. Prontera, La fi- losofia come metodo, cit., p. 15).
11 Ibi, p. 106.
746 Note e rassegne
In entrambi gli autori ritroviamo, allora, lo stesso rispetto del reale in tutta la sua imprevedibile varietà; lo stesso rifiuto dei falsi problemi; la stessa convinzione che filosofare è mostrare più che dimostrare; la stessa diffidenza nei confronti dell’amabile gioco dei concetti; la stessa lotta nei confronti delle idee belle e fatte; la stessa insistenza sull’essere del presente come dono concreto; la stessa esal-tazione della libertà contro tutti i meccanismi e soprattutto contro le abitudini12.
È evidente che questa semplice enumerazione non è esaustiva e non intende nemmeno esserlo. Sta, comunque, a indicare quali e quante consonanze si siano instaurate tra questi due autori, nella considerazione della rispettiva originalità creativa. A proposito di quest’ultima, Devaux sottolinea che l’originalità di Péguy nei confronti di Bergson, si manifesta nella sua attitudine a scoprire delle appli-cazioni inedite del metodo del suo maestro. Così, l’opposizione bergsoniana tra il tempo (spazialità) e la durata (qualitativa) sottintende le famose coppie introdotte da Péguy: periodo/epoca, moderno/contemporaneo13; l’opposizione bergsoniana della qualità alla quantità è trasposta da Péguy a proposito in De Jean Coste14, nelle sue analisi delle distanze tra il ricco, il povero e il miserabile. In questa pro-spettiva, è bene sottolineare anche la presa di coscienza che Péguy ha avuto sulle potenzialità della filosofia di Bergson, una filosofia che secondo il suo modo di pensare non poteva rimanere esclusivamente sul piano teorico, ma doveva avere il coraggio di osare delle applicazioni pratiche15. È a questo livello che, a nostro avviso, è possibile cogliere il punto nodale della differenza di risonanza tra i nostri due autori. Mentre, infatti, Péguy vuole agire, trasformare il mondo e convertire le coscienze nella personale consapevolezza che solo l’uomo di azione può esse-re, nello stesso tempo, un uomo di conoscenza, Bergson, dal canto suo, è essen-zialmente uno speculativo, un filosofo puro per il quale i principi che servono alla spiegazione delle cose non hanno alcun rapporto con le regole che dobbiamo imporre alla nostra condotta16. Così, a un certo momento, è sembrato che Péguy si fosse allontanato da Bergson: in realtà – è questo il parere di Devaux – non ha smesso di porre la propria azione nella luce dell’ispirazione bergsoniana rivelatri-ce della distanza che esiste tra il sognare e l’agire. Péguy avrebbe semplicemente voluto che il bergsonismo osasse spiegare infatti, tutte le proprie potenzialità.
12 Cfr. A. Devaux, Réalité et vérité selon Charles Péguy, in J. Onimus - M. Sanouillet (eds.), Rencontres avec Péguy, Descleé De Brouwer, Paris 1975, pp. 81-118.
13 Ch. Péguy, De la situation faite a l’histoire et à la sociologie dans les temps modernes, in Id., Oeuvres en prose. i. 1898-1908, Gallimard, Paris 1959, pp. 991-1030.
14 Id., Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse, in Id., Oeuvres en prose (1898-1908), cit.; tr. it. La città armoniosa, a cura di L. La Puma, Milella, Lecce 1984, pp. 105-155.
15 A questo proposito, secondo A. Devaux «la ragione profonda di questa differenza è senza dub-bio nell’accentuazione di Péguy dell’importanza del corpo. Per Bergson il ruolo del corpo è soprattutto di “limitazione della vita spirituale per la vita organica». Per Péguy il corpo ha un ruolo molto più positivo, poiché è lui che «porta in un certo senso la memoria e lo spirito», nel senso che «colui che vuole agire non deve dimenticare le condizioni della sua azione» (A. Devaux, La rencontre entre Péguy et Bergson, cit., pp. 563-564).
16 Cfr. Lettera di Bergson al «Figaro» in risposta a un articolo di benda, il 31 luglio 1916, ibi, p. 564.
Cugini – La filosofia di Charles Péguy 747
3. Esperienza e ragione
Come è possibile presentare la concezione che Péguy ha della realtà, quan-do egli stesso sembra continuamente celarla nelle mille pieghe della sua opera? La si trova spesso in filigrana tra le righe della critica al mondo moderno o al partito intellettuale. Come si può comunque parlarne? La tecnica della metafora e dell’immagine17 e quella delle ripetizioni – da alcuni chiamati litanie18 – gli offrono i mezzi stilistici più idonei. Occorre essere delicati – sembra suggerire Péguy – nel trattare la realtà. Occorre lasciare le proprie presunzioni intellettuali nel cassetto. «La realtà è difficile da conoscere»19: queste poche parole dette en passant nella Note conjointe sono quasi un monito austero e allo stesso tempo severo nei confronti di coloro (il partito intellettuale) che intendevano fare della ragione non uno strumento di ascolto e conoscenza, bensì di potere. Proprio per-ché la realtà si presenta con le caratteristiche di ciò che non può essere definito con una serie di proposizioni logiche, che Péguy affida il proprio modo di inten-derla non solo a uno stile descrittivo e non sistematico, ma anche a termini come Madre, Matrigna, Creazione Temporale, Natura, Realtà, Reale, Vita. Va subito chiarito che il Nostro non intende questi termini come indicativi di una sostanza, quanto piuttosto come soli capaci di suggerire una dinamica, una attività. Nella prospettiva di quanto detto sopra Simone Fraisse sottolinea che Péguy
«ha tracciato ne Lo Spirito del sistema un quadro vigoroso. La sovrana realtà non è un mon-do ben ordinato, docile alle Leggi della natura e che si dispone da se stesso sotto le ipotesi dei fisici, ma una creazione di inquietudine e di inconoscibile, di feccia e di ribollimento, mal amalgamato, mal regolare e mal ubbidiente tutta fremente e piena delle sue eterne fermentazioni. Questa Madre-Natura, ricordo di Lucrezio, mai più aggressiva di quella del poeta latino, si riordina un poco nei Misteri, sotto lo sguardo del Dio dei cristiani»20.
La costante sottolineatura, nell’opera e nell’espressione di Péguy, di idee e di immagini come quelle della “fertilità” e della “fecondità” delineano il clima esi-stenziale entro il quale le sicurezze lasciano il posto all’inquietudine. La realtà, a dispetto di come è stata descritta e di come viene descritta degli intellettuali al ser-vizio di un potere – che per Péguy è la Sorbona di Parigi – sfugge per sua essenza a qualsiasi tentativo di classificazione. A detta di Péguy, il problema è grave, in quanto la fissazione in schemi rigidi di ciò che per natura è mobile, sovverte tutte le successive costruzioni intellettuali. È a causa di una generalizzata menzogna colta da Péguy nel mondo moderno, che lo costringe, in un certo senso, a spingere in profondità la critica, per rendere visibile il sovvertimento operato.
È nel tempo presente che Péguy individua il centro fondamentale a partire dal quale è possibile cogliere la realtà. Dipende, infatti, da come lo si ascolta,
17 Cfr. J. Chabot, Morale rigida e morale duttile in Ch. Péguy, in A. Prontera, Ipotesi e proposte esistenziali. Introduzione a Péguy, Milella, Lecce 1990, pp. 147-166.
18 Cfr. J. Barbier, La preghiera negli scritti di Péguy, a cura di G. Auletta, Paoline, Alba 1961, p. 220. 19 Ch. Péguy, Cartesio e Bergson, cit., p. 240.20 S. Fraisse, Péguy, Seuil, Paris 1979, pp. 117-118.
748 Note e rassegne
da come lo si percepisce o – ed è il caso del mondo moderno – da come lo si modifica:
«Tutto proviene da ciò. Tutto deriva da questo punto del presente. Le economie, le civi-che, le morali, le metafisiche sono rette dal modo in cui trattano questo punto del presente. Partendo da ciò esse sono comandate. Ed esse stesse sono determinate. Potranno prospe-rare più o meno, potranno più o meno fiorire ognuna nel proprio senso. Ma il loro stesso senso è determinato e anche esse stesse sono determinate da quel punto di origine. Dimmi come consideri il presente e ti dirò che filosofo sei»21.
Il presente in primo luogo è un punto: «un punto di passata del tempo». È un punto importante perché tutto passa per questo punto.
«(Il presente) è il primo punto non ancora impegnato, non ancora fermato, il punto ancora in corso di acquisizione, in corso di inscrizione, la linea mentre la si scrive e la si inscrive. È il punto che non ha ancora le spalle afferrate nelle mummificazioni del passato»22.
Il presente è dunque il punto nel quale si manifesta la realtà. Cogliere il presente significa afferrare il nuovo, ciò che non era. È nell’immediatezza che occorre, al-lora, situarsi pena l’esclusione subitanea dalla percezione della realtà. Per l’uomo che vive nel tempo non vi sono a disposizione spazi illimitati, ma semplicemente un punto, che per propria natura non può essere irrigidito, fissato, solidificato. Il presente è mobile: è questa la consapevolezza che pone all’uomo la necessità di non sfuggire questo punto prezioso, che è un punto vitale, anzi è il punto vitale. Non c’è tempo da perdere: «Essere in anticipo, essere in ritardo, quali inesattezze. Essere in orario è la sola esattezza»23. La mobilità quale caratteristica peculiare del tempo presente, non può che essere descritta con termini plastici: elastico, libero, vivo, gratuito, fecondo. Nel presente vi è la novità del reale, una novità che è donata gratuitamente24 e che impone all’uomo, sorpreso da un tale gesto, una ricomprensione. Solo se il presente è colto per quello che è, nella sua mobilità, gratuità, fecondità, l’esistenza può essere vissuta in pienezza. Solo nella mobilità del presente è possibile essere autenticamente liberi. Péguy coglie la drammaticità della condizione umana nella volontà che la persona manifesta di cogliere o rifiu-tare la sfida inquietante del presente. Una volta compreso che il presente è mobile, il gioco sembra essere fatto. Da qualunque parti ci si volti, si inizia a comprendere e a scoprire il sovvertimento filosofico che Péguy sta ponendo in atto.
Nel settimo quaderno della seconda serie dei «Cahiers de la Quinzaine» usciti nel marzo del 1901 apparve uno scritto di Péguy di estrema importanza per la
21 Ch. Péguy, Cartesio e Bergson, cit., pp. 227-228.22 Ibi, pp. 205-206.23 Ibi, p. 213.24 A questo proposito A. Prontera, afferma che: «bisogna sottolineare il ruolo che assume in
queste analisi filosofiche di Péguy il senso di termini come “dono” o come “decerner”, preso nel suo senso più pieno e complesso di decidere, decratare, ma anche di accordare, donare, aggiungere, attri-buire utilizzati spesso come elementi propri di un oggetto: il “reale”» (La filosofia come metodo, cit., pp. 186-187).
Cugini – La filosofia di Charles Péguy 749
comprensione del suo pensiero. In Casse-cou25 – è questo il titolo dello scritto in questione – troviamo un’offensiva politico-filosofica contro le incongruenze e le degenerazioni di ogni concezione metafisica (materialistica o spiritualistica che sia), di ogni visione sistematica e monistica della realtà. È in questo contesto polemico – e la polemica nell’opera di Péguy è all’ordine del giorno – che il Nostro precisa la propria posizione identificando una fenomenologia dell’alterità retta dal principio d’individuazione, in base al quale la realtà è il regno della mol-teplicità e delle differenze. «Il reale ci presenta non solo delle dualità, ma delle pluralità [...]. La realtà ci appare e si presenta divisa in molte parti»26. Contro una tradizione di pensiero ostinatamente attenta a elaborazioni sintetiche e uniformi della realtà, Péguy afferma l’esigenza di accogliere il reale per come esso si ma-nifesta nella mobilità del presente, cioè nella sua pluralità.
È una contraffazione del mondo moderno considerare e spacciare la realtà come un’entità a una dimensione. Ma, avverte Péguy, una libera e crescente ar- monia può fare a meno, anzi, a suo modo di vedere, deve fare a meno di una su-periore unità. Tutta la questione sembra sorgere da un pregiudizio. Coloro, infat-ti, che sono mossi da un’irrefrenabile bisogno di unificare il mondo, sostengono l’impossibilità di una realtà molteplice in quanto fomenterebbe solo la tirannia. La risposta di Péguy è tagliente:
«Chi ha detto che la dualità o la pluralità comportano necessariamente la tirannia? Ciò è vero se uno dei due è tirannico e il secondo servile, ma ciò non è vero se il primo ha la modestia e il secondo ha la fierezza dell’uomo libero. Io mi permetto di far intervenire l’uomo libero in queste discussioni metafisiche perché diventa evidente qui che le vostre preoccupazioni metafisiche sono comandate dalle vostre cure politiche. Voi siete moni-sta perché siete unitario, così come lo siete in politica. Anche in politica voi credete che istituendo dei principi si libera necessariamente l’uno dalla tirannia dell’altro. È che nelle vostre valutazioni voi trascurate completamente la considerazione della libertà. L’uomo libero non esercita tirannia e non la sopporta. Il vero anarchico ha inoltre un profondo disgusto soprattutto nell’esercitare l’autorità più che nel subirla»27.
Agli occhi di Péguy non è possibile difendere degli errori di prospettiva sem-plicemente per calcoli politici: c’è di mezzo l’esistenza. In gioco vi è la possibi-lità di esprimere la libertà personale, che si realizza solamente nella varietà. «Più vado avanti – afferma Péguy – più scopro che gli uomini liberi e gli avvenimenti liberi sono vari. Sono gli schiavi, la servitù e gli asservimenti a non essere vari e a essere i meno vari»28. Si tratta, in definitiva, di lasciare alla molteplicità delle energie e degli esseri tutto il loro valore, tutta la loro libera varietà, se si vuole sinceramente una libera e crescente armonia, se si vuole vincere il profondo bi-sogno di unità, che molti ritengono operante ed esistente. Ascoltare e accogliere la pluralità della realtà significa imparare a pensare in modo conseguente al dono
25 Ch. Péguy, Casse-cou, in Id., Oeuvres en prose. i. 1898-1908, cit., pp. 303-30726 Ibi, p. 23.27 Ibi, p. 35.28 Ibi, p. 30.
750 Note e rassegne
accolto, vale a dire in modo libero. Ciò che la realtà, intesa nella sua molteplici-tà, offre all’uomo che non si chiude gli occhi e non si tura le orecchie con facili metafisiche moniste, sembra inimmaginabile.
4. Péguy critico del mondo moderno
Tutta l’opera in prosa di Péguy è lo sviluppo critico e propositivo di un’intui- zione che si può riassumere in una parola: moderno. Pagina dopo pagina si tro-vano le espressioni «mondo moderno», «partito intellettuale moderno», o sem-plicemente «i moderni». La critica radicale del mondo moderno risale già agli anni della prima giovinezza, quelli di Sainte-Barbe e dell’Ecole Normale. Il di-scorso, però, proseguirà lungo tutte le serie dei «Cahiers», per esplodere nelle celebri Situations faites del 1906-1907. Solamente nelle due Note del 1914 la critica al mondo moderno giunge al culmine. Prima di addentrarci nell’analisi della critica operata da Péguy al mondo moderno, occorre almeno abbozzare qualche affermazione sull’oggetto in considerazione. Moderno può essere defi-nito – rimanendo fedeli all’intuizione di Péguy – un atteggiamento, un modo di essere nel tempo che sacrifica tutto ciò che di vitale, autentico, puro, facendo si trova in esso. Moderno è la vittoria della fatalità, dell’ipocrisia, della maschera: il mondo moderno è un mondo che tende a mascherare la realtà. La critica che Péguy rivolge al mondo moderno poggia sull’analisi del modo di concepire il tempo presente. Il mondo moderno ha snaturato il tempo. È questa l’accusa più grave che Péguy rivolge alla sua epoca.
«Si prendeva il presente al rovescio. Si prendeva questo punto del presente dall’altro lato. Perché lo si prendeva come l’ultima linea scritta, lo si prendeva come l’ultimo punto acquisito, come l’ultimo punto dell’iscrizione. Mentre esso è il primo punto non ancora impegnato, non ancora fermato, il punto ancora in corso di acquisizione, in corso di in-scrizione, la linea mentre la si scrive e la si inscrive. [...] Invece di considerare il presente stesso, invece di considerare il presente presente, si considera in realtà un presente pas-sato, un presente fisso, un presente immobile, un presente fermato, inscritto, un presente reso determinato. Un presente storico. Invece di considerare quel punto segreto che è il presente si considerava già una storia del presente, una memoria del presente, cioè si con-siderava l’aspetto che avrebbe esaurito il presente non appena fosse divenuto passato»29.
L’uomo moderno non vive nel presente, o meglio, non vive il presente. Se il presente si manifesta con le caratteristiche della mobilità, fecondità, libertà, allo-ra è troppo rischioso affrontarlo: può destabilizzare, rendere insicuro e, sul piano del pensiero, rendere opinabile ciò che si pensava non lo fosse. Occorreva allora operare in modo tale da rendere inefficace l’affronto del presente:
«Tutta l’operazione ha come punto di origine, tutta l’operazione è consistita originaria-mente nell’indurire, nell’irrigidire questo punto del presente. Finché era elastico, libero,
29 Ch. Péguy, Cartesio e Bergson, pp. 205-206.
Cugini – La filosofia di Charles Péguy 751
vivo, gratuito, grazioso, fecondo, non poteva entrare in conto. [...] Una volta irrigidito, in-durito, una volta divenuto un punto rigido del passato, una volta divenuto un punto inerte e legato, un punto morto, un punto di servitù, un punto oneroso e un punto di disgrazia e di infecondità, poteva cominciare a entrare nel conto»30.
Per poter vivere nel presente il mondo moderno ha dovuto bloccarlo. Solo in questo modo è possibile usufruire del presente come di un oggetto. Una volta indurito il presente è oggettivato: può essere osservato, calcolato, e numerato come qualsiasi altro ente. Soprattutto può essere considerato come se non fosse presente. Il gioco, quindi, è facile. Si tratta solo di bloccare il presente mobile, si tratta cioè di snaturarlo. Il problema del mondo moderno consiste nel creare una situazione in cui non esiste turbamento, in cui l’impatto con la dinamicità destabilizzante possa essere attutito. Il passato offre questa possibilità poiché è fermo, rigido e soprattutto lo si può osservare e schedare. L’uomo moderno ha imparato a narcotizzare il presente trasformandolo (snaturandolo) in passa-to. Basta trasferirsi mentalmente nel futuro e da quella piattaforma artificiale di sicurezza osservare il presente come se fosse passato, che il gioco è fatto. Sono questi i motivi che spingono il Nostro a dichiarare la fondamentale importanza del tempo presente, non tanto come categoria concettuale, quanto piuttosto quale stato esistenziale. Quando il travisamento del tempo presente è in atto allora tutta la storia che ne scaturisce ne subisce le conseguenze. Se, infatti, leghiamo il pre-sente allora tutto è legato. Se conserviamo libero il presente, soltanto allora le al-tre libertà potranno essere risparmiate. Se è vero che il presente è così importante ai fini della realizzazione di una esistenza autentica, che cosa ha spinto l’uomo a deturparlo? Agli occhi di Péguy la risposta alla questione è molto semplice. Si tratta, infatti, di quel bisogno di tranquillità insito nella natura umana che spinge l’uomo a difendersi nei confronti di tutto ciò che può rappresentare una minaccia. Il presente, nella molteplicità di aggettivi attivi suggeriti da Péguy, costituisce senza dubbio la più pericolosa e tenace minaccia alla tranquillità del singolo31. Tutto il meccanismo di quella che Péguy chiama la sostituzione fraudolenta o anticipazione o ancora spostamento arbitrario è retta da un principio psicologico, vale a dire il bisogno di tranquillità. Questo grande bisogno che è espressione di pigrizia intellettuale più che essere un principio è una tentazione psicologica che se attivata produce conseguenze inarrestabili. Péguy intende mettere all’erta il mondo moderno da ciò che ha messo in atto. I segni, infatti, dello spostamento arbitrario sono riscontrabili in ogni manifestazione della realtà:
«In psicologia e in metafisica, in morale e in economia [...] in psicologia, in metafisica sacri-fichiamo il vero presente, il presente reale all’istante di poco fa, all’essere di poco fa, e così
30 Ibi, p. 225.31 «Questo bisogno mostruoso di tranquillità che si manifesta nell’infecondità di tutto un popolo,
nell’annientamento di tutta una razza, è soltanto un ingrossamento enorme di quel bisogno mostruosa-mente comune di tranquillità morale che ci fa sempre pensare al domani e sacrificare l’oggi al domani, e quel bisogno morale è esso stesso soltanto una codificazione di quel bisogno mostruoso di tranquillità che in psicologia e in metafisica ci fa sempre sacrificare il presente all’istante successivo» (ibi, p. 210).
752 Note e rassegne
riduciamo il vero presente, l’essere reale allo stato di passato. In morale sacrifichiamo l’oggi al domani. In economia sacrifichiamo tutta una razza alla nostra tranquillità di domani»32.
Il mondo moderno è dunque un mondo vecchio, che vive nel passato e, quin-di, un mondo di morte. Per meglio comprendere questo dinamismo Péguy utiliz-za le metafore del fiume, dei canali e delle cataratte. Il fiume della realtà è stato dirottato dal mondo moderno in un canale. La forza, la dinamicità, l’impetuosità del presente è stata placata. Il problema maggiore agli occhi di Péguy consiste nell’inganno operato su questo sistema di cataratte. L’uomo moderno, infatti, si illude di vivere nel fiume della realtà, della vita, invece si trova a essere nel canale dell’abitudine, della memoria, della morte:
«È la cateratta che sembra produrre” e “quanto più il presente produce, tanto più il serba-toio della memoria, della storia, dell’abitudine sono pieni»33.
Come il fiume è in funzione del canale, così la realtà è in funzione dell’abi-tudine. Non c’è da meravigliarsi allora – ci avverte Péguy – che l’abitudine sia una seconda natura, e che essa sembri avere la stessa forza e che abbia lo stesso potere della natura. Grazie al meccanismo attivato dal mondo moderno che con-voglia il presente nel passato, tutto ciò che la natura apporta giova all’abitudine. In questa prospettiva l’abitudine diviene la caratteristica peculiare del mondo moderno. Questo non significa che prima, nelle epoche precedenti, non ci fos-sero le abitudini, ma il meccanismo messo in atto ha fatto sì che tutta la realtà subisse un capovolgimento universale.
«Tale è l’iniziale, tale è fondamentale importanza nei meccanismi. Una leva di scambio di ottanta centimetri può convogliare un treno per migliaia di chilometri. Un commuta-tore può dare distese di luce o distese di ombra. Così un certo commutatore del mondo moderno operava incessantemente e istantaneamente un’universale commutazione. Dalle distese di presente otteneva immediatamente distese di passato. Da distesa di libertà otte-neva costantemente distesa di schiavitù. Da distese di fecondità otteneva immediatamente distese di infecondità»34.
Il mondo moderno vive nel tempo dell’abitudine. È questa la propria natura ed è questa la sua propria realtà. In esso non c’è spazio per alcun tipo di fecondità o di libertà, perché il meccanismo che è in atto ha devitalizzato tutti i centri vitali della libertà. Il mondo moderno è come un bosco morto e gli esseri che vi sono, vivono una realtà di morte. Vivere nell’abitudine significa essere nella morte. L’abitudine è il già dato, il già fatto, il già visto: è tutto ciò che si conosce e che, di conseguenza, non disturba. Quando l’anima è ricolma di stati bell’e fatti, allora significa che è sopraggiunta la morte, perché l’impetuosità della vita con-tenuta nel presente è stata bloccata. Del resto, se la vita non scorre più, se la realtà
32 Ibi, p. 215.33 Ibi, p. 38.34 Ibi, p. 237.
Cugini – La filosofia di Charles Péguy 753
non riesce più a trasmettere le proprie energie, l’essere «diviene completamente occupato dalle proprie scorie, dalle immense scorie della propria memoria. La polvere e il rottame, l’immenso rottame della propria abitudine»35. L’abitudine diviene una seconda natura anche per l’essere personale. Come è accaduto per un’intera epoca, quella moderna, così è successo agli essere che vi partecipano. Quando l’abitudine raggiunge il cuore di una persona, qualunque centro vitale viene bloccato. Non è più possibile, allora, parlare di libertà, né tanto meno di creatività come costitutivi ontologici dell’essere umano. In una realtà che è già data, come è possibile essere creativi? Un’anima che si trova di fronte il bell’e fatto è un’anima morta, è un’anima la cui l’intera materia, per così dire, la cui l’intera materia spirituale è stata conquistata a poco a poco dall’irrigidimento, il cui intero essere è stato sclerotizzato a poco a poco dall’indurimento. Nel mondo moderno è venuta meno la materia prima che consente alle persone di esercitare la propria libertà: la vita. Il meccanismo di difesa sorto dal mostruoso bisogno di tranquillità messo in atto dal mondo moderno per controllare la mobilità del presente è giunto sino a irretire totalmente la persona. Una vita guidata dall’abi-tudine non potrà mai giungere ad assaporare il senso autentico della realtà.
5. Contro il metodo moderno
Il pensiero bell’e fatto del partito intellettuale moderno possiede un proprio metodo al quale Péguy dedica delle pagine estremamente ricche e acute. Vi tro-viamo, infatti, argomentazioni sul senso della filosofia e del filosofare. Il mon-do moderno che, agli occhi di Péguy, ha sovvertito il senso della realtà, della ragione, del tempo e di conseguenza dell’esistenza e della vita, è stato in grado di procedere sulla linea di questo travisamento universale grazie a un metodo preciso, articolato. Vi è, in primo luogo, la presunzione di volere esaurire la totalità della realtà. È possibile, allora, riscontrare in Péguy l’esigenza di situarsi nella linea continua di quelle umanità nelle quali, avendo esse il senso dei limiti e della posizione dell’uomo nei riguardi di Dio e dell’universo, lo storico restava un uomo e non credeva nell’ambizione d’esaurire l’indefinitezza, l’infinità del dettaglio nella conoscenza di tutto il reale. Di fronte alla realtà complessa e ricca del mondo dell’esperienza, nella presa di coscienza della forza ma anche dei limite delle nostre capacità di conoscenza, tenuto conto delle servitù naturali che i nostri stessi strumenti ci impongono e infine nella più piena assunzione della condizione umana, Péguy richiama l’attenzione a una rigorosa distinzione tra metodo discorsivo e metodo intuitivo. Bisogna prendere atto della nostra abitu-dine a considerare il metodo intuitivo come sovrumano, orgoglioso, misterioso, agnostico e il metodo discorsivo come
«umano, modesto, chiaro e distinto, scientifico; dimostrerò invece, un giorno nel quale cercheremo di provare più profondamente i nostri metodi, che in storia è il metodo discor-
35 Ibi, p. 100
754 Note e rassegne
sivo che è sovrumano, orgoglioso, misterioso, agnostico, e che il metodo intuitivo quello che è umano, modesto, chiaro e distinto, per quanto lo possiamo, scientifico»36.
Si tratta allora, di non operare trasposizioni meccaniche da un ambito all’al-tro, da un oggetto di conoscenza all’altro, quanto piuttosto di modellare di volta in volta la propria strumentazione in funzione delle pieghe del reale che si cerca di affrontare. Il metodo non procura di per sé e meccanicamente risultati infalli-bili, provoca invece domande, pone istanze, fa percepire problemi e dimensioni nuove. È per questo che Péguy non può sopportare l’atteggiamento borioso del partito intellettuale affermatosi del mondo moderno:
«La tesi essenziale della metafisica intellettuale moderna, che è la nostra antitesi, tutta la metafisica subdola o ufficiale del partito intellettuale moderno si riduce essenzialmente a questa proposizione: che l’uomo, o che l’umanità (non si sa bene quali dei due, né che cosa è l’uno o l’altro, in questo senso) (ma che importa, proponiamo sempre) che l’uomo vago o la vaga umanità, insomma che noi possiamo conoscere, raggiungere e cogliere, abbracciare con una conoscenza integrale, con una stretta esaustiva, reale, metafisica, tutto l’avvenimento della realtà, tutta la realtà dell’uomo e della creazione con dei sistemi di elaborazione di schede appositamente disposte»37.
Ciò che Péguy ricerca è una pluralità anche a livello di metodi conoscitivi nel tentativo di salvare la specificità degli ambiti. Di conseguenza, nessuna ge-rarchia di saperi locali o delle discipline trova in questo contesto spazio; nessuna superiorità pregiudiziale è riconosciuta bell’e fatta a niente e ogni giudizio di va-lore è subordinato all’effettivo contributo che ogni filosofia, ogni metodo porta effettivamente non alla soluzione, ma piuttosto al chiarimento di quella precaria condizione che è la creaturalità dell’uomo in un universo sempre più ampio e mi-sterioso. La realtà, così come la coglie Péguy nella sua molteplicità di possibilità, esige la più ampia costruzione di una ricca pluralità di metodi. Péguy si rivela preoccupato per ciò che costantemente accade nel partito intellettuale del mondo moderno, che non riesce a comprendere che l’avversario non è posto di fronte, ma accanto. Le filosofe e i filosofi si contrappongono e contrastano quando biso-gnerebbe identificare la posizione del proprio sguardo e l’angolatura del proprio approccio al reale, per non misconoscere la legittimità e l’opportunità arricchente di quello dell’altro. In questo contesto e in questo clima di conoscenza e di cono-scenze, i diversi saperi si distinguono per la specificità dei loro oggetti e dei loro strumenti, delle loro stesse intenzioni e dei loro risultati, ma una differenza più profonda li distingue: quella che emerge tra una conoscenza che pretende di far coincidere le strutture del reale vivente con quelle del vero costruito, violentando di conseguenza il reale, e una conoscenza che ritiene solo di poter cercare tracce e sintomi di una verità del reale che le rimane sempre ulteriore nella sua viven-te concretezza. In effetti, come accade nel mondo intellettuale moderno, l’idea
36 Ch. Péguy, Zangwill, in Id., Oeuvres en prose. i. 1898-1908, cit., p. 1415. 37 L. La Puma - A. Pontera (eds.), Metafisiche, filosofie, religioni e... “progresso” moderno, in
Péguy pluralista, Pergola Monsavium, Paris-Lecce 1991, p. 54.
Cugini – La filosofia di Charles Péguy 755
di una scienza come il solo vero del reale, pretende di sostituirsi interamente alla realtà, contro le più modeste e precarie condizioni di quelle filosofie che si percepiscono come un viaggio di esplorazione nel reale. Per liberarsi da questa precarietà la scienza moderna ha voluto troncare il suo rapporto con la filosofia e con la metafisica, perdendo però, secondo Péguy, il senso della sua profondità e della natura. Fra le metafisiche
«le sole che siano pericolose essendo dissimulate, inconfessate, non dichiarate, sono quelle pretese, scientifiche. Le metafisiche aperte, franche, dichiarate, che si dichiarano franca-mente, le metafisiche da pianure, che si presentano per quello che sono, come metafisiche, le metafisiche da passaggio piano non sono pericolose. Quelle che sono pericolose, al con-trario, sono tutte quelle metafisiche, pretese laiche e in realtà confessionali di una certa confessione, che dall’inizio dei tempi moderni, vergognose, si presentano come fisiche»38.
La pericolosità delle metafisiche scientifiche del mondo moderno risiede e poggia sull’incapacità di distinguere tra la pratica e la teoria. Il mondo moderno cerca di mascherare l’essenza di questa fondamentale distinzione nella sua me-tafisica, cercando di sostituirla con distinzioni immaginarie: la distinzione tra il fisico e il metafisico:
«Secondo la quale si chiamerebbe fisico tutto ciò che è percepibile e che riserverebbe all’uomo solo facili trionfi, e secondo la quale inoltre si chiamerebbe metafisico tutto ciò che non si può cogliere e che riserverebbe all’uomo solo ingrate delusioni, una specie di caccia riservata»39.
Nello smascherare questo radicale sovvertimento Péguy traccia alcune linee di ricerca per il futuro:
«Noi mostreremo invece e dovremo mostrare che la metafisica è la sola ricerca di cono-scenza che sia diretta, letteralmente, e che la fisica, invece, può essere solo un tentativo di ricerca di conoscenza indiretta, amministrata grazie alla mediazione dei sensi; mostre-remo e dovremo mostrare che tutte le metafisiche non sono con ciò stesso delle teorie né che tutte le fisiche sono ipso facto delle tecniche, ma che vi sono teorie, pratiche, fatti e avvenimenti fisici»40.
L’idea moderna arroccata sull’altare della scienza, servita da quel metodo dichiarato certo, fatto di schede sulle quali sembra possibile imprimere tutti i dati della realtà conoscibile in virtù di quella fondamentale e altrettanto subdola distinzione tra fisica e metafisica, presenta, secondo Péguy, a questo punto del discorso, alcune defezioni. In primo luogo, l’operazione di isolamento della me-tafisica operata dal mondo moderno per avere da una parte un controllo certo sui dati osservati e, dall’altra, per distanziarsi da tutto quell’insieme di conoscenze superstiziose, legato al mondo del non fisico che la metafisica sembra aver culla-
38 Ibi, p. 247.39 Ibi, p. 53.40 Ibidem.
756 Note e rassegne
to, è per Péguy assai poco convincente. In realtà «è proprio essa (l’idea moderna) che è meravigliosa, miracolosa, prodigiosa, un’idea di miracolo e della supersti-zione del miracolo»41. È lo spirito scientifico che si è mostrato improvvisamente appunto come un miracolo, nella storia dell’uomo quando questi fin dell’eternità non ne aveva avuto bisogno.
In secondo luogo, la presunzione dei moderni si è spinta fino al punto di di-chiarare la novità assoluta delle proprie teorie,
«che si pretendono sottili e si dicono avanzate, rispetto a quelle precedenti. Chi però, sa leggere con attenzione tra le righe non può non accorgersi che tutto ciò che si chiama la scienza pura, cioè il gioco dei sistemi e delle ipotesi, delle spiegazioni e delle teorie, tutto è pieno, è zeppo, è imbottito delle più antiche mitologie fisiche e metafisiche»42.
Tuttavia, questo minuzioso lavoro di trasposizione operato dai moderni non hai potuto celare le macroscopiche differenze di qualità:
«Tutta la differenza che vi è, è che generalmente era molto più intelligente negli antichi che da noi, molto più sottile e più accorto, più acuto, insomma più avventuroso, poiché si trattava degli antichi Elleni perché essi erano Eschilo, Fidia, e che noi pur essendo france-si, siamo solo poveri moderni»43.
In terzo luogo, quella universale pigrizia che permea il partito intellettuale moderno e plasma il suo metodo storico-scientifico, conduce verso grossolani e dannosi errori di prospettiva:
«Niente è così falso, il rappresentarci o il volerci rappresentare la successione delle meta-fisiche e delle filosofie, – delle religioni – come un processo lineare, ininterrotto, continuo discontinuo»44.
È segno di grande pigrizia semplificare a tal punto la storia delle metafisi-che da renderle tutte come una sequenza progressiva. L’intellettuale moderno, quando aziona il proprio metodo storico – scientifico, opera quei vergognosi tra-visamenti che tendono a non riconoscere le diversità (di storia, di prospettiva, di metafisica) al fine di agevolare comodamente il lavoro di schedatura dello scibi-le. È proprio a questo scibile del mondo moderno che Péguy si rivolge, in quanto risulta – sin dall’inizio, sin dal punto di partenza metodologico – contraffatto. I problemi maggiori, avvengono quando il partito intellettuale pretende, in nome della pseudo scientificità propria, di imporre il proprio metodo, la propria visione del mondo. Ecco perché insistentemente Péguy fa appello a quella libertà di pen-siero che conduce ad accettare la diversità, la pluralità delle risposte dell’uomo a una realtà che si manifesta essa stessa plurale:
41 Ibi, p. 63.42 Ibi, p. 59.43 Ibi, p. 60.44 Ibi, p. 80.
Cugini – La filosofia di Charles Péguy 757
«Come le grandi e profonde razze, come le grandi e viventi nazioni, come i popoli e i linguaggi stessi dei popoli, parlati, scritti, come le arti inventate, le grandi metafisiche, le filosofie non sono nientedimeno che i linguaggi della creazione»45.
Questa semplicità di prospettive, che ammette le diversità come costituti-vo essenziale della convivenza umana è proprio ciò che l’intellettuale moderno nega, e negandola s’impegna implicitamente a costruire la cittadella moderna della menzogna.
6. Conclusione
Oggi si guarda al mondo moderno come alla fine di un’epoca: a nostra di-sposizione abbiamo dati, cifre, documenti. Valutiamo il mondo moderno come lo farebbe uno storico, un sociologo. Péguy avrebbe certamente da criticare il nostro metodo di analisi che, a dire il vero, assomiglia molto a quello utilizzato dai moderni così da lui osteggiati. Siamo talmente imbevuti, direbbe Péguy, di mentalità scientifica, che guardiamo tutto come se la realtà fosse un oggetto pas-sato, analizzabile, come se la realtà in definitiva fosse morta. Péguy direbbe che la nostra post-modernità è post nel senso stretto del termine, nel senso cioè che viene dopo qualcosa e niente di più. Siamo post-moderni: dei moderni giunti al culmine della modernità, all’estremo.
Péguy non ha mai criticato il mondo moderno per il semplice gusto della critica. Non ha sferrato i colpi delle sue invettive contro gli intellettuali della Sor-bona, i borghesi, i preti per un puro vezzo stilistico. Non era adirato contro coloro che ai suoi tempi facevano fortuna. La sua polemica, che spesso raggiunge toni aspri si muove in tutt’altra direzione.
Consapevole di essere vissuto in un periodo di trapasso culturale, che vide la Francia perdere nel lasso di pochi anni la propria genuinità, la propria semplicità di vita, di un’esistenza amante della terra e dei suoi frutti, legata alla vita come la cosa più grande che Dio potesse donare all’uomo, non ha fatto altro che indicare ai contemporanei l’errore che stavano inavvedutamente compiendo. L’intento che lo ha guidato nelle polemiche contro il mondo moderno e le sue manifesta-zioni, era il recupero di un’autenticità dell’esistenza che si stava progressivamen-te smarrendo. L’appello che percorre come un fremito tutta l’opera di Péguy, di rimanere legati al presente quale unico punto in cui sia possibile cogliere la real-tà, va cercato in questa direzione. In un periodo in cui tutto sembrava tramutarsi in menzogna, Péguy ha gridato contro di essa testimoniando, in questo modo la sua coerenza che, come sappiamo, ha pagato di persona.
45 Ibi, pp. 110-111.






















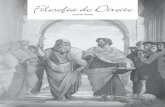




![La filosofia penale di Ippodamo e la cultura giuridica dei Sofisti [ 1989 ]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63294b178d3d6a2bca0e9037/la-filosofia-penale-di-ippodamo-e-la-cultura-giuridica-dei-sofisti-1989-.jpg)









