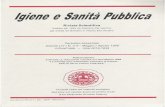Studi in vitro di citotossicità e mutagenicità di inquinanti ambientali
La ceramica a vernice nera d’importazione dello scavo di Place Villeneuve-Bargemon a Marsiglia, in...
Transcript of La ceramica a vernice nera d’importazione dello scavo di Place Villeneuve-Bargemon a Marsiglia, in...
FLORENTIAStudi di archeologia
2
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZEFacoLTÀ DI LETTERE E FILoSoFIa
ScUoLa DI SPEcIaLIZZaZIoNE IN aRcHEoLoGIa
Università degli Studi di FirenzeFacoltà di Lettere e FilosofiaScuola di Specializzazione in archeologia
Comitato di redazioneIl Direttore: Gabriella capecchi; Giovannangelo camporeale,Fabio Martini, Marinella Pasquinucci, Raffaella Pierobon,Vincenzo Saladino, Guido Vannini
Segreteria di redazioneEnrica Boldrini / Scuola di Specializzazione in archeologia
ISBN: 978-88-7970-355-0
© copyright 2007 by Scuola di Specializzazione in archeologia
Realizzazione editorialeEdifir-Edizioni Firenze srlvia Fiume, 8 - 50123 FirenzeTel. +39/055/289639 - Fax +39/055/289478www.edifir.it - [email protected]
Responsabile del progetto editorialeSimone Gismondi
Responsabile editorialeMassimo Piccione
Fotolito, impaginazione e stampaPacini Editore Industrie Grafiche - ospedaletto (Pisa)
5
INDICE
Presentazione Pag. 7
Silvia casciarri, Le produzioni di Sant’Abbondio di Calcinaia - Trincea A (PS) nel quadro dell’evoluzione dei complessi marchigiani tra neolitico ed eneolitico 11
Paolo Giulierini, La pesca in Etruria 43
Barbara Valli, Lupercis nudis lustratur antiquum oppidum palatinum. Alcune riflessioni sui Lupercalia 101
Franca cibecchini, La ceramica a vernice nera d’importazione dello scavo di Place Villeneuve-Bargemon a Marsiglia 155
Marco cavalieri, Il culto imperiale nelle province galliche. L’imago e il suo contesto religioso: santuari, templi e teatri 213
Elisa Pruno, Caratteri e diffusione di un manufatto medievale
da cucina: il testo 257
155
FRaNca cIBEccHINI
La cERaMIca a VERNIcE NERa D’IMPoRTaZIoNE DELLo ScaVo DI PLacE VILLENEUVE-BaRGEMoN
a MaRSIGLIa
I. INTRoDUZIoNE
Il gruppo di materiali preso in esame in questo lavoro proviene da un’area del “chantier Place Villeneuve-Bargemon”, in prossimità del Vieux-Port a Marsiglia, (Fig. 1).1 La scelta dell’area, denominata Zona 10 (Fig. 2), è stata dettata dalla quantità e qualità dei materiali restituiti e dal-l’importanza delle strutture emerse, pertinenti ad uno o più ateliers mone-tali d’epoca ellenistica, installati immediatamente a ridosso di alcuni am-bienti interpretati come navalia per il ricovero d’imbarcazioni militari.2
Lo studio della ceramica a vernice nera è apparso di particola-re interesse per varie ragioni: in primo luogo si tratta di uno dei rari casi, in Provenza, in cui le ceramiche a vernice nera sono inserite entro una sequenza stratigrafica affidabile; in secondo luogo, rappresentano il principale materiale “datante” e permettono pertanto di precisare la cronologia delle varie fasi di vita e di produzione del o degli ateliers mo-netali. Terzo, ma non meno importante aspetto è quello legato al ruolo d’oggetto commerciale rivestito da queste ceramiche, che assumono particolare rilievo entro un grande porto come Marsiglia, di cruciale importanza nel Mediterraneo occidentale dalla sua fondazione fino al-l’età imperiale.
1 Il presente lavoro, che nasce dalla mia Tesi di Specializzazione, s’inserisce nell’ambito di una collaborazione instaurata con antoinette Hesnard (cNRS - Centre Camille Jullian, aix-en-Provence), alla quale va la mia più sentita gratitudine per avermi affidato con grande fiducia lo studio delle ceramiche a vernice nera d’importazione rinvenute nei cantieri di scavo del Vieux-Port di Marsiglia. Desidero ringraziare inoltre tutti coloro che, per la loro cortesia e disponibilità o con preziosi suggerimenti e consigli, hanno contribuito alla realizzazione di questo testo (in rigoroso ordine alfabetico): Patrice arcelin, Giulia Boetto, Helga Di Giuseppe, Philippe Écard, Nino Facella, Martì Grau i Segú, Luc Long, Jean Paul Morel, orazio Paoletti, Jordi Principal, Jean christophe Sourisseau.
2 Si vedano le ultime acquisizioni storiche e archeologiche sulla città di Marsiglia e il suo porto in Hermary et al. 1999; Hesnard et al. 1999, pp. 17-76, con ampia bibliografia precedente.
156
Lo studio dei materiali ha seguito due direttive: un’analisi della sequenza stratigrafica, volta a comprendere la successione delle strut-ture e il grado d’affidabilità delle singole Unità Stratigrafiche; un’ana-lisi accurata d’ogni elemento rinvenuto all’interno dello strato.3 Per co-modità di studio, e di comprensione dei dati stessi, è stata mantenuta la suddivisione in varie fasi e sottofasi, scandite dalla successione dei numerosi suoli messi in luce, indicata nella relazione di scavo (a cura di P. Ecard). Poiché le quantità dei reperti analizzati sono statisticamen-te significative (oltre ottocento frammenti), si è ritenuto opportuno elaborare alcuni grafici al fine di illustrare le proporzioni fra le varie produzioni ceramiche d’importazione attesta-te e la loro evoluzione nel tempo (cfr. Grafico 1). Sebbene questo la-voro sia incentrato sul-la ceramica a vernice nera, è stato necessario in alcuni casi utilizzare anche i dati forniti da altre classi di materiali, come le anfore d’im-portazione.4 Si tratta tuttavia di uno studio
3 Le ceramiche sono state classificate e tipologizzate (quando possibile), nonché quanti-ficate secondo il sistema del Numero Minimo d’Individui (NIM) “corretto”, in modo da poter contare su di una base, la più oggettiva e vicina alla realtà possibile, che permet-tesse un’approssimazione statistica piuttosto standardizzata, confrontabile con i dati noti dai numerosi siti della Provenza e del Languedoc (Bats 1988, p. 79; Py, adroher 1991, pp. 84-85; arcelin 1991). Per la classificazione delle forme si fa riferimento essenzialmente alla classificazione di Nino Lamboglia (Lamboglia 1952) indicata con Lamb. seguito dal numero della forma, e alla successiva risistemazione e classificazione di Jean Paul Morel (Morel 1981b) indicata con M. seguito dal numero della forma o della serie. Tutte le date sono da intendersi come a.c. anche se non specificato. I disegni della ceramica sono a cura dell’autore.
4 Per la classificazione delle anfore si fa riferimento principalmente a: Ramon 1995 e Mañá 1951 per le produzioni d’ambiente punico, a Py 1985 per le anfore etrusche, a Bertucchi 1992 (forme) e a Lattara 6 1993 (tipo di orli) per le anfore massaliote. Per un inquadramen-to generale delle anfore ellenistiche si veda Empereur-Hesnard 1987.
Grafico 1. Distribuzione quantitativa delle produzioni importate, articolate per fasi
157
preliminare e non sistematico, volto ad affinare la datazione dei con-testi maggiormente significativi. La mancanza di dati analitici riguar-do all’ampia gamma di produzioni locali e alle anfore,5 sia d’impor-tazione che di produzione locale, non ha permesso per il momento di sviluppare considerazioni circa le proporzioni tra importazioni e produzioni locali, né di valutare l’impatto del complesso delle impor-tazioni di una determinata area geografica.
i.1. topografia portuale e stratigrafia dell’area indagata6
I due importanti cantieri di scavo, che hanno portato in luce parte del bacino portuale e dell’area adiacente all’antica riva di costa a par-tire dall’età arcaica, si trovavano in corrispondenza della piazza Jules Verne e della piazza Villeneuve-Bargemon, sul lato Nord dell’attuale Vieux-Port (Figg. 1, 2).7 Tra la fine del IV e la fine del II secolo nelle due aree erano presenti delle spiagge, occupate da un ampio cantiere nava-le, che nel III e II secolo viene dotato di vere e proprie cale d’alaggio in legno e di spazi per la costruzione e riparazione delle navi. Nell’area dell’attuale piazza Villeneuve-Bargemon le cale di alaggio conduceva-no a delle strutture, identificate come hangar per navi da guerra, i neoria o navalia (Fig. 2, I). a contatto con il fondo di questi hangar militari, a nord dello scavo, è stata invece rinvenuta una serie d’ambienti destinati alla lavorazione di metalli (Fig. 2, II), che costituisce gran parte dell’area di scavo denominata Zona 10. Le tracce lasciate dalla lavorazione del ferro e, soprattutto, del bronzo sono notevoli ma la loro interpretazione è spesso delicata. I numerosi tondelli monetali di bronzo rinvenuti, a vari stadi di lavorazione, non lasciano tuttavia dubbi sulla presenza in questa zona di uno o più ateliers monetali. Nella fase 3c s’incontrano le prime strutture correlate con certezza alla lavorazione dei tondelli. alcune delle installazioni pertinenti agli ateliers sono facilmente iden-
5 Le produzioni massaliote, di ceramica comune, ceramica a vernice nera e anfore, così come le anfore e le ceramiche comuni d’importazione, sono in corso di studio da parte dell’equipe coordinata da a. Hesnard.
6 I dati stratigrafici qui riportati sono stati ricavati dalla documentazione di scavo, gentil-mente fornita da a. Hesnard, ed in particolare dal Rapporto di scavo della Zona 10 curato da Philippe Ecard.
7 Lo scavo della piazza Jules-Verne si è svolto dall’agosto 1992 al novembre 1993; quello di piazza Villeneuve-Bargemon dal marzo 1996 alla fine di giugno 1997, entrambi sotto la direzione di antoinette Hesnard. Per la topografia e la storia dell’intera area portuale si rimanda alle recenti pubblicazioni di Hermary et al. 1999; Hesnard et al. 1999, pp. 17-45.
158
tificabili, come ad es. quelle relative alla politura dei tondelli, mentre di altre è difficile comprendere la funzione precisa, ad es. di numerose fosse colme di sedimento molto fine. Nel complesso, l’intera area sem-bra aver avuto vari “cicli di vita” che si manifestano con progressive colmature delle strutture precedenti e costruzione di nuovi suoli, sui quali s’installavano di nuovo delle strutture per l’attività metallurgica8, a loro volta colmate e così via. Partendo dal primo edificio costruito nel momento iniziale nella fase 4a (suolo US 10510) sembrano susseguirsi un totale di sei cicli completi, che si concludono con una marcata ri-strutturazione all’inizio della fase 2a.
Questa fase marca l’ultimo periodo d’attività delle officine, mo-mento in cui l’intero complesso viene ristrutturato, con la creazione di nuovi ambienti. Suscita dunque qualche perplessità il fatto che pochi anni dopo, e presumibilmente in un momento di notevole attività, gli ateliers vengano abbandonati, come risulta dalla fase 1 (vedi infra).
all’inizio del I secolo le due cale, di Piazza Jules Verne e Villeneu-ve-Bargemon, vengono colmate e servono da base per l’installazione di nuovi edifici a carattere terrestre. Tutte le nuove strutture vengono rase fino alle fondazioni dalle ulteriori ristrutturazioni d’epoca romana.
Le Unità Stratigrafiche prese in esame in questo lavoro, correlate alle varie fasi e settori dello scavo sono riassunte nella tabella in ap-pendice II.
i.2. cronologia delle fasi distinte
come accennato sopra, si è preferito conservare l’organizzazione della scansione cronologica in quattro principali fasi (1-4), ciascuna sud-divisa in varie sottofasi o periodi più brevi (a, B, c), elaborata per l’intera area da chi ha curato lo scavo. Tale scansione è stata articolata attorno ai numerosi suoli (e relative colmate) messi in luce nei diversi settori dello scavo (cfr. la Tabella in appendice, II). Si ricorda che la stratigrafia com-plessa e i continui rimaneggiamenti subiti dall’intera area, con numero-se colmate e rinterri, hanno posto non poche difficoltà per lo studio dei materiali e per l’elaborazione di una precisa sequenza cronologica.9 Per
8 Da ricondurre verosimilmente sempre a forni e/o forge, trincee per l’installazione degli stampi e vasche con gli annessi necessari per la politura dei tondelli da coniare.
9 Il materiale è infatti molto frammentato e numerosi sono i pezzi residuali e talvolta d’intrusione.
159
questa ragione, le considerazioni espresse qui di seguito si basano so-prattutto sull’analisi dei materiali delle colmature e dei suoli.
La cronologia delle varie fasi è stata rivista e precisata principal-mente sulla base dell’analisi delle ceramiche a vernice nera e della se-quenza stratigrafica rilevata. Di alcuni contesti particolarmente signifi-cativi sono state prese in esame anche altre classi ceramiche, soprattutto le anfore d’importazione, che hanno permesso di confermare, più rara-mente precisare, le datazioni suggerite dalla ceramica a vernice nera. Nell’ottica di fornire un quadro più completo, si è optato per presentare anche le osservazioni relative a questi materiali e la rappresentazione grafica dei pezzi ritenuti più indicativi, ricordando che si tratta comun-que di un’analisi preliminare.
Fase 4C: 325-300 a.C. (Fig. 3)La fase più antica vede la prevalenza delle ultime produzioni at-
tiche a vernice nera (37%), in associazione ad una discreta quantità di coppe dell’atelier des petites estampilles (29%) e di altre produzioni itali-che varie (29%). Tali associazioni e le poche forme individuate in giaci-tura primaria, tra cui un frammento di skyphos assimilabile al “type A: Attic-type” (Fig. 3, n. 4) e tre coppe “Bowl-incurving rim” (Fig. 3, nn. 5, 2), suggeriscono una datazione compresa nell’ultimo quarto del IV secolo per questa fase. Un’anfora di forma Mañá D/Ramon T-4.2.1.5 (Fig. 3, n. 10), e un fondo di brocca punica, forma Lancel 521 a1-c1 (cfr. Lan-cel 1987), associati ad un frammento di pelvis etrusca a impasto chia-ro sabbioso (Fig. 3, n. 11), presenti negli strati iniziali della stessa fase, rafforzano la datazione proposta. Da notare anche la presenza di due orli pertinenti ad anfore etrusche di tipo Py 4 (US 10802) in un contesto chiaramente dominato da anfore massaliote.
Fase 4B: 300-275 a.C. (Fig. 3)I materiali pertinenti a questa fase sono troppo esigui per per-
mettere delle valide considerazioni. La sua datazione si ricava dal momento finale della fase precedente e dall’inizio di quella successiva 4a. Si nota tuttavia la presenza di una Lamb. 21 di produzione attica (Fig. 3, n. 12), di due anse pertinenti ad anfore puniche del gruppo cartagine-Tunisi distinto da Ramon (1995) e di un’ansa di anfora etru-sca Py 3aB, residuale, entro un contesto nettamente dominato dalle produzioni massaliote.
Fase 4A: 275-225 a.C. (Figg. 3-4)La colmatura (US 10729) all’inizio di questa lunga fase, contiene
due individui dell’atelier des petites estampilles (Fig. 3, n. 13), due per-
160
tinenti a produzioni italiche varie, e un fondo con rosetta collegabile alla campana a arcaica (Fig. 3, n. 18). Lo stesso scenario si propone nel successivo suolo (US 10510), con due individui dell’atelier, la prima at-testazione della forma Lamb. 28, vicina a M. 2614c, produzione italica di III secolo (Fig. 4, n. 2).Questi elementi suggeriscono per l’inizio della fase una datazione ai primi decenni del III secolo (280-270 a.c.).
Negli stessi strati si constata la presenza ancora totalmente do-minante delle anfore massaliote (forme Bertucchi 3-5, soprattutto orli a-MaS bd 7-9), con l’eccezione di un’ansa di anfora etrusca Py 3c, re-siduale, e di un frammento d’ansa di un’anfora magno-greca.
La presenza nel riempimento (US 10758) di una fossa antecedente alla colmatura finale (US 10573) delle prime attestazioni in campana a antica, con forme come la kylix Lamb.-Bats 42 Bc e la coppa Morel 68 (Fig. 3, nn. 20, 22 e 19), databile non ante il 230-220 a.c., nonché di un numero crescente d’individui delle officine catalane di Rosas e italiche di III secolo (rispettivamente 9% e il 37 %) negli strati finali, suggerisco-no un termine della fase attorno al 230/220 a.c.
Nello stesso contesto, dominano ancora le anfore massaliote, ma si incontrano anche le prime anfore greco-italiche (due esemplari) assie-me ad un’anfora punica Mañá D/Ramon T-5.2.3.1/2 (fondo ed ansa), forma che sembra comparire poco prima del 225 a.c.
Fase 3C: 225-200 a.C. (Fig. 4)Non ci sono molti elementi per poter datare questa fase: permane
qualche perplessità dovuta alla forte presenza di ceramica attica (15%), dell’atelier des petites estampilles (10%) o di forme arcaiche, come la coppet-ta M. 2714j (Fig. 4, n. 10). Un dato importante appare la maggiore presen-za di ceramiche degli ateliers di Rosas (25%, equivalente alla campana a), inseribile all’inizio dell’ultimo quarto del III secolo, datazione che concorda con quella proposta per la fine della fase precedente. Proba-bilmente la grande ristrutturazione che coinvolge l’area principale degli ateliers monetali (nei settori 2-3) ha portato un notevole sconvolgimento e un apporto di materiali diversificati da fasi precedenti.10 La datazione finale si ricava dai suoli che marcano l’inizio della fase successiva (in par-ticolare US 10534) ed è confermata dalla presenza di un piatto Lamb. 36 e di una coppa Lamb. 28ab (Fig. 4, n. 14) in campana a antica (US 10744).
10 Un’ipotesi che può trovare conferma nel fatto che quasi tutte le ceramiche comprese nella denominazione di “ceramica attica” di questa fase appartengono alla produzione a figure rosse, quindi chiaramente residuali.
161
Nel suolo iniziale (US 10437) e nel sistema di fosse che vi si installa si notano inoltre almeno tre individui di anfora greco-italica, associati alle predominanti anfore massaliote (orli di forma a-MaS bd 5, 8, 9, 10).
fase 3B: 200-150 a.c. (figg. 4-5)La presenza consistente, soprattutto nel suolo iniziale (US 10534),
di campana a e in particolare delle forme Lamb. 49b, 28, 27b e 31 (Fig. 4, nn., 15-17), per lo più in campana a antica, suggeriscono una datazione tra 200 e 190 a.c. Le anfore massaliote dominano ancora largamente, con orli di tipo a-MaS bd 9 e 10. Le anfore puniche sono ben presenti, per lo più con la forma Mañá D -Ramon T-5.2.3.1/2, anche in un mo-mento molto avanzato della fase (ad es. 4 individui nell’US 10741, data-bile post 175, Fig. 5, n. 1), in un contesto che resta dominato dalle anfore massaliote (orli a-MaS bd 9-11) sebbene con una forte presenza di an-fore greco-italiche antiche e tarde. Datare il momento finale di questa fase pone qualche problema per la presenza di elementi chiaramente intrusivi, come anfore Dressel 1 B e c e sigillata aretina (talvolta in as-sociazione a ceramica attica) negli strati di riempimento di alcune fosse (soprattutto nelle USS 10007-8). Tuttavia, le forme ceramiche attestate in campana a classica (Lamb. 36, 31, 27B, 27c), la presenza di numerose greco-italiche (tarde e di transizione) assieme ad un’anfora Ramon T-7.3.1.1. quasi completa (Fig. 5, n. 2), forniscono sufficienti elementi per datare la fine di questa fase attorno alla metà del II secolo a.c.
Fase 3A: 150-135 a.C. (Fig. 6)Questa fase, sebbene molto breve da un punto di vista cronologi-
co, presenta una notevole quantità di materiali. Lo strato di colmatu-ra iniziale (US 10509) è particolarmente significativo: all’interno della campana a, la produzione classica è tre volte più attestata di quella antica e presenta un repertorio di forme (Lamb. 31, 6, 36, 27B, 27b) tipi-co della metà del II secolo. Si assiste inoltre all’apparizione delle prime ceramiche della cerchia della B (cfr. infra II.6.), con un fondo di coppa ed una Lamb. B5a ascrivibile al tipo D di Volterra.
Nella stessa US, le anfore greco-italiche sono ormai predominanti, presentano un tipo di orlo (Fig. 5, n. 23, 25-26) che trova confronti con quelli attestati nelle ultime fasi di cartagine (ante 146 a.c., cfr. Morel 1986) e sono associate a un orlo di tripolitana antica (Fig. 5, n. 27) e, forse, ad un’ansa di Dressel 1a. Lo stesso scenario si ripete nelle USS immediatamente successive, nella quali incontriamo anche una Lamb. 10, probabilmente al tipo B etrusco (cfr. infra II.6.). Queste associazio-ni di materiale, le stesse note negli accampamenti numantini (153-133 a.c.; cfr. Sanmartí-Principal 1998, 201-204; Principal 2000), la presenza
162
di anfore greco-italiche di transizione e di una Dressel 1a, confermano una datazione compresa tra 150 e 135 a.c., nonostante la presenza di greco-italiche antiche sia ancora rilevante.
Fase 2B: 135-120 a.C. (Fig. 6)Gli strati pertinenti alle colmature iniziali (in particolare US 10709)
forniscono alcuni importanti elementi di datazione. Tra quelli più signi-ficativi, l’associazione delle forme Lamb. 36, 27B e 31 (Fig. 6, nn. 11-16), assieme ad una chiara predominanza delle anfore greco- italiche tarde e ad un orlo d’anfora punica attribuibile ad una variante intermedia tra la Ramon T-7.4.2.1. e la T-7.4.4.1. - Mañá c2 (Fig. 6, n. 22). Nei diversi riem-pimenti di fosse e trincee che caratterizzano il momento finale di questa fase, si notano le prime attestazioni di ceramiche di tipo B campano (cfr. infra II.6.), sebbene si tratti di frammenti piccoli e difficilmente classifica-bili (forse una coppa Lamb. B1 o B8) assieme ad una coppa Pasquinucci 127, probabilmente di produzione etrusca. Le stesse associazioni si ritro-vano nel relitto di Filicudi a in Sicilia, di recente datato attorno al 130-125 a.c. (Ribera 2001, p. 296-302; cibecchini 2004, p. 63).
Fase 2A: 120-100 a.C. (Fig. 7)a partire da questa fase, tutte le installazioni degli atelier monetali
individuate nei diversi settori di scavo sembrano essere funzionanti. Nelle colmature individuate in un momento iniziale della fase (USS 10026, 10017, oltre ad US 10627=623) ritroviamo l’associazione delle forme predominanti nella campana a classica, Lamb. 36, 27B, 31, 33, ma anche quattro esemplari della piccola coppa Lamb. 25-Morel 113 (Fig. 7, nn. 10-12) e alcuni esemplari di tipo B campano (una Lamb. B5 e una coppa Sanmartí 166). Le anfore ci forniscono elementi molto significativi: le produzioni italiche coprono in media il 95% delle anfore presenti e si nota un chiaro aumento delle Dressel 1a (Fig. 7, n. 19-21), l’attestazione di due individui pertinenti al tipo Dressel 1 B e 1c e, for-se, di una Lamboglia 2. altri apporti sono testimoniati da un orlo di tripolitana antica (Fig. 7, n. 27), da frammenti di Mañá c2 e di anfore rodie. Una facies simile si ritrova negli strati successivi, dove sono pre-senti due individui di campana a tarda, delle Dressel 1a (Fig. 7, nn. 22, 23, 26) con qualche rara Dressel 1c, un orlo di anfora ovoide (Fig. 7, n. 28), dei frammenti di ceramica a pareti fini italica (Marabini II) e una lucerna di tipo Ricci G. L’insieme dei dati presentati e il predominare di una campana a di buona qualità, che presenta spesso delle decorazioni classiche (palmette, rosette e foglie d’edera), permettono di datare la fine di questa fase attorno al 100 a.c.
163
Fase 1: 100-90/80 a.C. (Figg. 8-9)Stabilire una datazione precisa dell’ultima fase è difficile poiché
sembra di assistere ad una sorta di “compressione”, non percepibile dal matrix, tra l’ultima fase di attività degli ateliers e quella di abbandono. Inoltre, vista la grande quantità di materiali eterogenei rinvenuti negli strati di colmatura o di distruzione, preferiamo limitarci ad un’analisi globale dell’intera fase. Il marcato aumento della campana a (che arriva al 77% del totale delle ceramiche d’importazione), delle ceramiche di tipo B campano (7%) e la presenza crescente della campana a tarda, che resta comunque poco attestata, indicano un’evoluzione condensata in un pe-riodo molto breve. Nei livelli d’abbandono si nota l’apparizione di forme tarde, come le Lamb. 5/7 (Fig. 8, n. 10) e di numerose coppette Morel 113 nella campana a; delle forme Lamb. B3 e Pasquinucci 127 nel tipo B campano (vedi infra). In parallelo, negli stessi livelli, le anfore Dressel 1a sono più numerose che le greco-italiche (Fig. 9, nn. 14-17), associate a qualche individuo di Dressel 1B. L’abbandono degli ateliers sembra dun-que potersi datare entro i primissimi decenni del I secolo a.c.
II. LE PRoDUZIoNI aTTESTaTE (cFR. TaB. 1)11
ii.1. ceramica attica: 7% delle produzioni12
Sono stati inseriti in questo gruppo anche pochi frammenti di ce-ramica a figure rosse (in tutto 4), molto eterogenei, di piccole dimen-sioni e sempre residuali.13 Si segnala un coperchio di pisside (Fig. 4, n. 13) assimilabile a tipo D di Beazley (Beazley, aRV2 1963), con raffigu-razione di un elmo sulla faccia superiore, al momento senza confronti, inseribile nel V secolo.
11 Si rimanda all’appendice per il catalogo delle forme riconosciute e maggiori specifiche sulle caratteristiche tecniche delle diverse produzioni attestate.
12 Si ricorda che le statistiche proposte si riferiscono alle sole ceramiche a vernice nera d’importazione.
13 Si tratta di: un frammento di coppa/kylix tipo “stemless cup” (Sparkes-Talcott 1970, pp. 102-105), uno di coppa/kylix tipo “stemless delicate class” (Sparkes-Talcott 1970, pp. 98-105) e uno di coppa tipo “B” di Beazley (Beazley, aRV2 1963).
164
II.1.1. Ceramica attica a vernice nera (cfr. infra Appendice I.1.)La ceramica attica a vernice nera, importata nel Mediterraneo oc-
cidentale dal VI secolo (cfr. il relitto della Pointe Lequin 1, Long-Volpe 1997), raggiunge il culmine di presenze nel IV secolo. Già dalla secon-da metà del secolo nel Mediterraneo occidentale arrivano quasi solo forme aperte e verso il 330-300 a.c. le importazioni attiche a Marsiglia sembrano ormai minoritarie.14 Nell’area indagata la ceramica attica è maggioritaria solo negli strati iniziali (fase 4c, 37%), associata ai pri-mi esemplari dell’atelier des petites estampilles e ad altre importazioni italiche varie. Le quantità calano rapidamente (fase 4a, dove si equi-valgono all’atelier des petites estampilles, 12%), pur restando elevate fino all’inizio della seconda metà del III secolo (fase 3c ancora con il 15%). Questi dati si accordano con quelli emersi da altri lotti ceramici rinve-nuti a Marsiglia (Gantes 1992, pp. 174-175; Grau i Segu 1997, pp. 289, 292, 345), anche se non si registra la “scomparsa” della ceramica attica dopo la metà del III secolo indicata da Gantes (1992, p. 174). Questa produzione si ritrova, sebbene in quantità residuali, fino all’ultima fase analizzata, alla fine del II secolo. Fenomeni analoghi sono stati segna-lati a cartagine, dove la ceramica attica di IV secolo si trova anche nei livelli di distruzione del 146 a.c., a Lattes, dove arriva fino alla metà del II secolo ed in numerosi siti della catalogna (Morel 1998b, p. 244), e sono forse legati al valore d’oggetto di lusso che questa ceramica ha sicuramente rivestito.15
ii.2. atelier des petites estampilles: 5% delle importazioni (cfr. infra appendice i.2.)
L’atelier, o gruppo di ateliers, identificato e sistematizzato da Morel (Morel 1969), è stato oggetto di numerosi studi che ne hanno precisato la tipologia, le caratteristiche tecniche e l’origine.16 Localizzato nei din-
14 Sparkes-Talcott 1970, oltre le tipologie di Lamboglia (1952) e di Morel (1981b). Sulla situazione marsigliese, cfr. Gantes 1992, pp. 174-175. Vedi anche Py et al. 2001, pp. 343-344.
15 Una coppa attica a vernice nera, dalla necropoli di Sainte-Barbe (Hermary et al. 1999, p. 82), riparata con cinque grappe in piombo mostra il prolungato utilizzo e il valore attri-buito a questa ceramica. Nell’area presa qui in esame il fenomeno è sicuramente connesso anche alla complessa stratigrafia.
16 Tra questi Sanmartí 1973; Bats 1976; Pérez Ballester 1987 e 2003, pp. 219-222; Squarzanti 1994-1995.
165
torni di Roma o nella città stessa (Morel 1969, pp. 59-60; Morel 1981b, p. 48), sembra aver avuto succursali o altri centri produttori, ad esempio a Caere (Melucco Vaccaro 1970, p. 504), Veio (Di Giuseppe 2003, 2005), capena (Roth 2006), Falerii Veteres (Pasqui 1903; Biella 2004; De Lucia Brolli 2006)17 e forse a Populonia (Romualdi 1992, p. 121; Squarzanti 1994-1995, p. 343). Sembra dunque un vero e proprio gruppo d’officine che produce ceramiche dalle caratteristiche molto simili e la cui attività perdura durante quasi tutto il III secolo, con frequenza massima tra 300 e 250 a.c. ca. La cronologia proposta in un primo momento (285 ±20 a.c., Morel 1969, p. 113; Morel 1978, p. 156) è stata modificata dagli ultimi studi, che datano l’inizio dell’attività agli ultimi decenni del IV secolo18 e ne prolungano la produzione e commercializzazione fino al terzo quarto del III secolo.19 L’analisi dei materiali marsigliesi conferma la stretta associazione tra petites estampilles e ceramica attica nella fase più antica (4c, con rispettivamente 29 % e 37%) e anche qui si registra ancora nella fase 3c un 10% di presenze dell’atelier, che diviene poi rapidamente residuale.20
ii.3. produzioni italiche varie: 11% delle importazioni (cfr. infra appendice i.3.)
È stato riunito sotto questa denominazione un insieme eteroge-neo di ceramiche, prevalentemente inseribili nel III secolo, di origine italica o presunta tale, pertinenti a varie produzioni distinguibili per la varietà delle paste. Tra le maggiori presenze già nella prima fase (fase 4c, 29%), la loro massima frequenza si registra in pieno III secolo (fase 4a, 37%), per poi calare drasticamente: a partire dalla fase 3a sono già presenze residuali.
17 Per una raccolta di centri di produzione di ceramica a vernice nera nel lazio, olcese 1998; Di Giuseppe 2003 e 2005.
18 Sopratutto per la loro stretta associazione in molti contesti del sud della Gallia e della Penisola Iberica, con ceramica attica a vernice nera; si veda Py et al. 2001, pp. 1159-1160. Per un recente riesame delle cronologie della ceramica a vernice nera di area laziale si veda Ferrandes 2006.
19 Data la loro permanenza nei contesti di questo periodo di alcuni siti come Lattes (Py 1990a, p. 85; 1990b, 564; Py et al. 2001, p. 1160; Principal 1998, pp. 46-48).
20 La presenza nella fase 1 sembra legata ai problemi di rimescolamento dei materiali accennata sopra.
166
II.3.1. ItalicheMolte delle officine attive nel III secolo lungo la penisola italica
e ben presenti con i loro prodotti in Gallia meridionale non sono sta-te identificate con precisione21. Per semplificare si è deciso, seguendo in parte le orme di M. Bats, di dividere questi materiali in due grossi gruppi generali – a e B – basati essenzialmente sulle caratteristiche tec-niche (cfr. appendice I.3.1), quando non si sia trovata una forma e una produzione più specifica.
II.3.2. Imitazioni atticheSi tratta di pezzi per lo più pertinenti ad imitazioni italiche, forse
d’area campana viste le caratteristiche tecniche. La loro presenza è spo-radica e si concentra nel periodo 4c.
II.3.3. Ceramica con pasta di tipo 5con questa denominazione si vuole semplicemente indicare un
tipo di ceramica che ricorre sporadicamente tra i materiali di III secolo e che presenta caratteristiche tecniche piuttosto distintive. La massima frequenza si registra nel periodo 4a; corrisponde quindi ad una produ-zione di pieno III secolo, la cui origine non è possibile determinare con la sola analisi autoptica, anche se appare molto verosimile che si tratti di una produzione italica, forse più precisamente collegabile alla cam-pania settentrionale. Sono attestate quasi solo coppe.
ii.4. ateliers di rosas e occidentali: 4% delle importazioni (cfr. infra, appendice i.4.)
La situazione degli ateliers occidentali resta complessa, nono-stante i numerosi studi e scoperte degli ultimi anni abbiano chiarito i contorni di questo gruppo di produzioni di III secolo che abbiamo riu-nito come “ateliers di Rosas”.22 oltre ad almeno un atelier a Rosas (Rho-des/Roses), con presenza di scarti di fornace, sono state identificate altre produzioni strettamente connesse a quest’ultimo, distinguibili per le particolari decorazioni e morfologie (cfr. Sanmartí Grego 1978,
21 E si è spesso ricorso a termini quali “protocampane” (Py 1978a, p. 221; 1990b, p. 564), “intermediaire” (Py 1978, p. 66; 1990b, p. 564), o “italiche di III secolo” (Bats 1988, p. 99).
22 La prima identificazione e sistemazione dell’atelier delle tre palmette radiali/ atelier di Rosas si deve a Sanmartí Grego (1978); un quadro esaustivo in Principal 1998, pp. 70-119, con bibliografia.
167
pp. 573-576; Morel 1978, p. 155). In un periodo di proliferazione di produzioni ceramiche nel Mediterraneo, gli ateliers s’inseriscono tra la ceramica attica a vernice nera e la campana a, tra il primo quarto e la fine del III secolo. La maggiore concentrazione si registra nell’ulti-mo quarto del III (fase 3c con il 25%). Gli sporadici frammenti delle fasi 3a-1 sono senza dubbio residuali, eccetto una coppetta (Fig. 9, n. 12, fase 1), una produzione ampuritana di II secolo. Questo quadro conferma quanto già notato a Marsiglia (al Parc des Phocéens e Place des Pistoles), ovvero che l’arrivo di queste ceramiche corrisponde alla seconda ed ultima fase di attività delle officine, nella seconda metà del III secolo, attorno al 220-200 a.c.23
ii.5. ceramica campana a: 62% delle importazioni (cfr. infra, appendice i.5.)
Le caratteristiche tecniche della campana a sono state più volte descritte24 e i numerosi studi degli ultimi cinquanta anni ne forni-scono ormai un quadro pressoché completo.25 L’isola d’Ischia è stata spesso ritenuta il primo centro produttore (olcese-Picon-Thierrin 1996), mentre le uniche officine note con sicurezza si localizzano nella stessa città di Napoli, con una cronologia grosso modo compre-sa tra fine del III e gli inizi del I secolo (scavi di corso Umberto e Vico San Marcellino, accarona et al. 1985; Morel 1986, p. 342). La produzione di Ischia mostra il suo culmine produttivo tra il IV e il III secolo, con un forte calo verso la fine del secolo, quando sem-bra iniziare l’attività delle officine napoletane (Principal 1998, pp. 119-120). Le prime importazioni nel Mediterraneo occidentale sono state recentemente datate attorno alla metà del III secolo: si tratta
23 cfr. Grau i Segú 1997, pp. 289-290, 293. anche a Lattes raggiungono la loro massima fre-quenza nel terzo quarto del III secolo e perdurano fino alla fine del secolo (Py et al. 2001, p. 1218). Sembra questo un periodo particolarmente favorevole per i centri ampuritani, nel momento di calo delle importazioni dell’atelier des petites estampilles e prima dell’arri-vo di grandi quantità di campana a.
24 Lamboglia 1952, p. 140; Sanmartí Grego 1978, pp. 21-22; Morel 1981b, p. 47; Py 1993, p. 146.
25 Per la definizione delle varie fasi della campana a, Morel 1980, p. 102 e da ultimo Prin-cipal 1998, p. 119. oltre ai già citati si vedano, soprattutto per gli studi regionali, arcelin 1978; Dedet 1978; Py 1978; cayot 1984; Bats 1988, pp. 108-148, Py 1990b, pp. 564-579, Py et al. 2001, pp. 435-556, con ampia bibliografia. Per un punto sulle problematiche della produzione e della sua esportazione in Gallia, Morel 1990.
168
di rari esemplari di campana a arcaica in siti come Lattes, Olbia e Marsiglia26 appunto. Nell’area degli atelier monetali, la coppetta M 2714J (Fig. 4, n. 10) e altri due frammenti (Fig. 3, n. 22, Fig. 5, n. 9) sono in campana a arcaica; il fondo di Lamb.-Bats 42 Bb-Bc (Fig. 5, n. 9) in giacitura primaria (fase 3c) può essere datato verso il 250-240 a.c. Le quattro varianti di pasta ceramica distinte in quest’area non sembrano avere una valenza cronologica: le più frequenti sono senza dubbio i tipi 1 e 2, sempre comunque compresenti, e solo gra-nulosità e tessitura all’interno dei vari tipi peggiorano gradualmen-te, fino a raggiungere un aspetto più mediocre.27 Nelle fasi 4a e 3c s’incontrano i primi esemplari di campana a antica (cfr. Grafico 1), ancora in numero modesto (18 e 25%. Si tratta di forme tra le più antiche della produzione: le kylix Lamb.-Bats 42 Bc (Fig. 3, n. 20), la coppa biansata Morel 68 (Fig. 3, n. 22). Il loro arrivo si data tra il 230 e 220 a.c., leggermente antecedente a quanto riscontrato in altri siti della regione.28 Nella fase 3B si assiste all’improvvisa im-pennata di questa produzione (che passa al 58% delle importazioni di ceramica a vernice nera, cfr. Grafico 1), solo in parte giustificata dalla maggiore quantità di materiali analizzati (a partire da questo periodo tutti i settori sono pienamente attivi). L’inizio di questa am-pia fase (200–150 a.c.) è, non a caso, quasi contemporanea all’arrivo di ingenti quantità di ceramica campana a, testimoniato anche dai relitti della Pointe Lequin 2 (205-195a.c.)29 e del Grand congloué 1 (attorno al 194 a.c.)30. Da questo momento la campana a domina in-contrastata fino alla fine dell’attività metallurgica nell’area indagata
26 Py 1993, p. 146; 2001, p. 435. Probabilmente alcuni pezzi sono attestati anche a Glanum (arcelin 1991, p. 209). Per la catalogna, Principal 1998, pp. 119-149.
27 L’ultimo quarto del II secolo sembra caratterizzato da una ceramica visibilmente più mediocre, sebbene sempre nell’ambito della a classica: cfr. Entremont (Morel 1978, p. 158) e Saint-Blaise (cayot 1984, pp. 54-55, 76-77). Non si esclude che nella zona oggetto di studio vi sia stata una sottostima delle attestazioni della campana a antica rispetto alla classica dovuta al cattivo stato di conservazione dei pezzi.
28 come Olbia (Bats 1988, pp. 108-109), La Teste Nègre (Gantes 1978) e Saint-Blaise (cayot 1984, p. 76), ma in linea con Glanum (arcelin 1991, p. 209) e con il centro portuale di Lattes (Py 1990a; 1993; 1994; 2001, pp. 435-438).
29 Long 2004, pp. 149-150; Foy, Nenna 2001, p. 102.
30 Benoit 1961. Un recente studio dei bolli rodii (Finkielsztejn 2001: 192, Tab. 19, periodo IIIa) ha riavvicinato la datazione a quella proposta da Morel (1981b, pp. 62-63) per questo relitto.
169
(fase 1) nella quale raggiunge le massime presenze (77%)31. La rarità d’esemplari in campana a tarda e la prevalenza di forme “classiche” nelle fasi 2a e 1 indicano un termine finale attorno al 100 a.c. Si nota inoltre un prevalente utilizzo di coppe e la presenza di solo tre piatti Lamb. 5/7 e di un frammento di ciotola Lamb. B 8, due delle forme più comuni a partire dal I secolo. anche tra le decorazioni preval-gono nettamente palmette e rosette, per la maggior parte di buona fattura, e sono rare le doppie solcature concentriche (4 esemplari), tipiche dell’inizio della fase più tarda di questa produzione.
Nell’inventario proposto in appendice le forme sono state rag-gruppate nelle quattro ampie categorie d’utilizzo (cfr. Grafico 2), secon-do i criteri definiti da M. Bats a Olbia (Bats 1988, pp. 79-80), con alcune eccezioni che verranno argomentate (cfr. appendice I.5).
ii.6. cerchia della B: 6% delle importazioni (cfr. infra, appendice i.6.)
La complessità dell’origine delle ceramiche tradizionalmente in-dicate come “campana B”, ha portato J. P. Morel, e più recentemente P. arcelin, a qualificare tale gruppo come “cerchia della B” (Morel 1990,
31 In molti siti della Gallia meridionale si arriva alle massime presenze nel terzo e ultimo quarto del II secolo: si vedano in particolare Saint-Blaise (cayot 1984) e Glanum (arcelin 1991).
Grafico 2. Forme e gruppi funzionali della campana a
170
pp. 67-68; arcelin 2000, pp. 296-297). La denominazione comprende le produzioni di due regioni dell’Italia centrale, Etruria e campania set-tentrionale, che hanno esportato dalla fine del III secolo una ceramica a pasta chiara, dalla vernice francamente nera o nero-bluastra e dal re-pertorio morfologico prevalentemente d’ispirazione etrusca. allo stato attuale le maggiori difficoltà sono create dalla “vera B etrusca” la cui origine è da ricercare secondo Morel (1978, p. 162; e soprattutto Mo-rel 1980, pp. 93-94) nell’ambito dell’Etruria settentrionale marittima. In quest’area tuttavia, le ceramiche a vernice nera di alta qualità tecnica vengono riferite quasi sempre alla coeva produzione volterrana di tipo D o a quella aretina a vernice nera. Il problema si poneva già nell’esem-plare classificazione della ceramica a vernice nera di Luni (cavalieri Manasse 1977), dove vengono riconosciute tra le produzioni di buona qualità la volterrana D e una distinta “campana B”, con evidenti coin-cidenze nel repertorio morfologico tra i due tipi (forme Lamb. 2, 3, 5, 6, 8 e 10). altro caso esemplare è quello della coppa Lamb. 1, tra le forme più caratteristiche della “campana B”: gli esemplari noti in Etruria set-tentrionale sono risultati pertinenti a produzioni d’area campana, così come tutti quelli attestati in Gallia sono stati attribuiti alla produzione B-oide, ovvero al tipo B-campano.32 Parallelamente, esemplari di “vera B etrusca” rinvenuti nel Levante spagnolo mostrano una chiara coinci-denza con il tipo volterrano D.33 Il problema non è ancora stato risol-to34 e si è scelto di adottare termini più generici, quali tipo B-etrusco e produzioni dell’Etruria settentrionale (cfr. appendice I.6.2.-3), specifi-cando ulteriormente solo nel caso di produzioni locali note, come la volterrana D o la ceramica aretina a vernice nera (assente nell’area in oggetto).35
32 Per l’Etruria settentrionale, Pasquinucci et al. 1998, pp. 109-110; per una discussione ap-profondita di questi dati cfr. Bianchini, cibecchini, Pasquinucci 2000; arcelin 2000. anche nella necropoli di castiglioncello (LI) le migliori ceramiche a vernice nera a pasta chiara sono tutte riferibili a produzioni di tipo volterrano D oppure a ceramiche calene (cibec-chini 1999, pp. 40-41).
33 ad es. negli accampamenti numantini (Sanmartí-Principal 1997, 41, fig. 27, n. 16; San-martí-Principal 1998, p. 202). Già P. arcelin (arcelin-chabot 1980, p. 176), notava la coin-cidenza tra alcuni esemplari della forma Pasquinucci 127 rinvenuti nella Penisola Iberica e la volterrana D.
34 Per il punto sulle problematiche della “cerchia della B” ed una nuova definizione delle varie produzioni, si veda cibecchini-Principal 2004.
35 E apparentemente anche nelle altre aree indagate a Marsiglia, ma attestata su un relitto presso l’isola di Plane, con la tipica decorazione a ‘c’ contrapposte (Lequément-Liou 1976).
171
Nel caso delle produzioni campane, le “B-oidi” di Morel, sembra ormai accertato che le officine fossero concentrate soprattutto nell’area di cales-Teano,36 ma non è semplice per il momento distinguere tra loro le diverse officine quando non siano presenti alcune caratteristiche ri-tenute proprie di un determinato centro (come, ad es. gli stampigli a cuoricino o la decorazione a losanga nella produzione calena). Queste produzioni vengono dunque qui comprese nella definizione generica di “tipo B-campano” (cfr. appendice I.6.1), sebbene le ceramiche calene siano verosimilmente prevalenti.
La diffusione delle ceramiche della “cerchia della B” separa in maniera netta il Midi francese dalla Penisola Iberica e dal Roussillon. Le prime importazioni, alla fine del III-inizio II secolo, interessano soprattutto la Penisola Iberica e solo pochi siti della Gallia meridio-nale, tra cui arles, Glanum, Ruscino e la stessa Marsiglia, con esem-plari raramente pertinenti a produzioni etrusche.37 Nell’area degli ateliers monetali, 2 individui appartengono a produzioni locali del-l’Etruria settentrionale (Fig. 4, nn. 3, 6 uno all’inizio e l’altro alla fine della fase 4a) e la loro sporadica presenza potrebbe essere legata all’arrivo di altre ceramiche dalla regione (come le coppe della filiale populoniese dell’atelier des petites estampilles?). Più rappresentativi sono i frammenti rinvenuti nella fase 3a (una Lamb. B10 di tipo B-etrusco e una Lamb. B 5a in volterrana D), prima vera testimonianza dell’arrivo di questo gruppo di ceramiche, da collocare attorno al 160-150 a.c.38 La presenza di ceramica di tipo B-etrusco resterà co-munque molto sporadica: solo altri 2 individui nelle fasi successive. La maggior parte delle ceramiche della “cerchia della B” diffuse dal Languedoc orientale alla Provenza a partire dal 140-120 a.c., appar-
36 area suggerita anche dalle analisi archeometriche (Morel-Picon 1994, p. 35) e già da tempo indicata, soprattutto per cales, in numerosi studi italiani e spagnoli. Si veda ci-becchini-Principal 2004: pp. 160-161, con relativa bibliografia.
37 arcelin 2000. Unica eccezione Ruscino, con il suo 38% di frammenti, tra cui compare an-che un lotto di ceramiche di tipo B-etrusco, inseribili nel primo quarto del II secolo (Solier 1980, pp. 228-238, arcelin 2000, p. 297). Si veda inoltre Lattes, dove tuttavia si mantiene un’unica denominazione, campana B, per entrambi le due aree produttive (Py et al. 2001, pp. 557-576). Si veda anche il rapido sunto in Ribera 2001.
38 In netto anticipo rispetto ai siti minori o alle sue colonie. Una Lamb. 10 di tipo B-etrusco è attestata anche nei sondaggi della Bourse (Gaita 1995, p. 15), confermando l’apparizione delle prime produzioni di tipo B attorno al 150 a.c., ibidem, 66. Si vedano i dati di Glanum (arcelin 1991, p. 214), Olbia (Bats 1988, p. 137), Saint-Blaise (cayot 1984, pp. 75-76). La stessa precocità si riscontra a Lattes (arcelin 1991, p. 214; Py et al. 2001, p. 557).
172
tiene al tipo B-campano.39 In Gallia (ad eccezione del Roussillon) re-stano tuttavia fortemente minoritarie rispetto alla campana a fino al secondo quarto del I secolo e la loro frequenza globale rimane sempre inferiore alla produzione napoletana.40 Ben diverso appare il quadro nella Penisola Iberica, dove le ceramiche di tipo B-campano sono già ben attestate nella prima metà del II secolo e aumentano notevolmente dopo la metà del secolo a scapito del tipo B-etrusco e della stessa campana a.41 Il tipo B campano appare alla fine della fase 2B, attorno al 120 a.c., con la forma Lamb. 1 e un orlo Lamb. B 5. Non si riscontra qui la sparizione delle produzioni di tipo B-cam-pano indicata da arcelin (2000, p. 298) per Marsiglia e i siti portuali a lei legati, nell’ultimo terzo del II secolo. al contrario sembra que-sto il loro periodo di maggior concentrazione (fasi 2a-1). La qualità delle vernici e delle paste ceramiche, le decorazioni curate, indicano una datazione ancora entro il 100 a.c. o poco dopo. Nell’area degli ateliers monetali, le ceramiche della “cerchia della B” arrivano al 5%-6% (se vi si sommano anche quelle dell’Etruria settentrionale) delle ceramiche a vernice nera d’importazione, in accordo con una facies degli ultimi decenni del II secolo. Nelle altre aree indagate a Mar-siglia i prodotti della “cerchia della B” si attestano attorno all’1-2% del totale al Parc des Phocéens, area che mostra una facies più antica rispetto alle altre, mentre nel deposito del Fort Saint-Jean (I secolo) si arriva al 13%,42 con percentuali simili ai vicini centri di Glanum e Olbia. L’insieme dei dati disponibili su Marsiglia permette di aggiungere al principale repertorio attestato in Gallia (forme in ordine d’importan-
39 arcelin-chabot 1980, pp. 187-188; arcelin 1991, p. 214; arcelin 2000; Morel 1980, p. 103; 1990, pp; 67-68; Bats 1988, p. 137; Morel-Picon 1994, pp. 33-38, Py et al. 2001, pp. 557-558.
40 con una media che oscilla tra 1 e 18% nei primi sessanta anni del I secolo e da 3 a 20% nei successivi quaranta anni: per Marsiglia sono interessanti le proporzioni stimate per Glanum e Olbia per tutto il I secolo, entrambi del 15 %, cfr. arcelin 2000, p. 297.
41 Pérez Ballester 1996, pp. 343-344; arcelin 2000, pp. 296-299 e in generale i vari contributi degli atti del convegno d’Ampurias (aquilué-García-Guitart. 2000). Il crescente ritmo di acquisizione di ceramica di tipo B-campano viene giustamente collegato alla sempre più pressante presenza romana, militare e non, nella regione.
42 Grau i Segú 1997, p. 298. Tra i materiali del Fort Saint-Jean compare anche un fondo con una decorazione a losanga, tipica del I secolo ma estremamente rara in Gallia (idem, tav. c4, n. 1). Dati simili a quelli della Zona 10 si ricavano dai sondaggi recenti alla Bour-se (Gaita 1995), che in effetti presentano una datazione compresa tra 175 e 100 a.c. La ceramica attribuibile alla cerchia della B sembra appartenere nella quasi totalità al tipo B-campano, eccetto almeno un frammento di Lamb. 10, Gaita 1995, tav. 19, n. 36.
173
za: Lamb. B5, B1, Pasquinucci 127,43 Lamb. B2, B3, B4, B6, B8a e B10) le forme Lamb. B55, B36, B33, B8b (le ultime tre in Gaita 1995).
Tab. 1. Quantità (numero di frammenti e NIM) e percentuali delle produzioni attestate.
Classe ceramica N. frammenti
NIM % ceramiche fini d’importazione
ceramica attica 38 32 7%Atelier des petites estampilles 41 24 5%Produzioni italiche varie 63 50 11%
Italiche 51 38 8%Imitazioni attiche 4 4 1%ceramica con pasta di tipo 5 5 8 8 2%
atelier di Rosas e occidentali 25 19 4%campana a 578 297 62%cerchia della B 35 31 6%
Tipo B campano 22 20 4%Tipo B etrusco 8 6 1%Etruria settentrionale 7 5 1%
Produzioni non determinate 46 25 5%
III. coNcLUSIoNI
iii.1. considerazioni sulle produzioni attestate e il vasellame da mensa44
L’evoluzione delle presenze delle produzioni attestate risulta evi-dente dal Grafico 1: come ad Olbia la ceramica attica a vernice nera, che domina il mercato fino agli ultimi decenni del IV sec., viene sostitui-ta rapidamente dalle importazioni italiche, per lo più composte dalle coppe dell’atelier des petites estampilles (che nelle fasi 4c e 4a coprono rispettivamente il 29% e il 15% delle importazioni). La penisola italica considerata nel suo complesso è il principale “interlocutore” della città focese già nella fase 4c, rappresentando il 58% della ceramica importa-ta. La presenza di importazioni italiche cresce rapidamente con l’arrivo
43 Montagna Pasquinucci 1972, pp. 400-403.
44 In attesa di dati analitici sulle produzioni ceramiche massaliote e sulle anfore, le nostre osservazioni si limiteranno alle importazioni di ceramica a vernice nera.
174
delle prime ceramiche in campana a arcaica e antica, coprendo il 76% delle importazioni ceramiche già nella fase 4a (275-225 a.c.). L’unica al-tra ceramica d’importazione attestata in quantità apprezzabili, oltre la ceramica attica, è quella degli ateliers di Rosas che, pur nettamente mi-noritaria, rappresenta una presenza ben rilevabile, fino alla fase 3c, per poi calare rapidamente alla fine del III secolo (passando dal 25% della fase 3c al 3% nella fase 3B). Una caduta legata quasi sicuramente all’ar-rivo della campana a, che in pochi anni acquisirà un monopolio asso-luto (passando dal 25% nella fase 3c al 58% nella fase 3B). Scarsamente rilevanti sono le importazioni dall’Etruria (ceramiche dell’Etruria set-tentrionale e tipo B-etrusco), che restano sporadiche, sebbene Marsiglia sia uno dei primi centri della Gallia Meridionale a recepire queste pro-duzioni. Isolate attestazioni di ceramiche dell’Etruria settentrionale si hanno nel III secolo (6% della ceramica importata nella fase 4a) mentre nella seconda metà del II secolo, soprattutto con il tipo B etrusco, la loro presenza è più costante (tra 4% e 3 % nelle fasi 3a-2a). Le produzioni campane, soprattutto con la produzione napoletana, restano dominanti (dal 58% della fase 3B all’84% nella fase 1, considerando campana a e tipo B-campano assieme). Si tratta comunque di percentuali meno ele-vate rispetto ad altri siti noti, come Olbia (in proporzione media 94%) e Nages (tra 96 e 100% dopo il 150 a.c.), ma vicine a quelle di centri come Glanum (81,5%). Per quanto riguarda le altre aree della città indagate, al Parc des Phocéens le percentuali, tra le ceramiche fini d’importazione, sono più elevate (90%) a Place des Pistoles sono simili alle nostre (82%), mentre scendono rapidamente al Fort Saint-Jean (intorno al 44%, cfr. Grau i Segú 1997, pp. 299-303).45
Il tasso piuttosto elevato di frammenti non determinati registrato nella zona degli ateliers monetali è legato soprattutto allo stato di con-servazione dei materiali, in particolare alla loro elevata frantumazione, ma anche alle difficoltà d’identificazione di ceramiche dalla provenien-za estremamente eterogenea, data la funzione d’importante porto com-merciale del Mediterraneo occidentale che Marsiglia ha rivestito per tutto il periodo di nostro interesse.
Dal punto di vista delle “forme”, si possono esprimere alcune con-siderazioni circa la composizione ed evoluzione del servizio da tavo-la, basate sui gruppi funzionali creati a partire dallo studio di M. Bats (1988, pp. 201-234), che sono spesso serviti per distinguere diverse aree
45 Nei sondaggi della Bourse la percentuale è del 44,4%, però sul totale della ceramica fine presente (Gaita 1995, p. 51).
175
socioculturali nella Gallia meridionale. Tradizionalmente è stata distin-ta una facies, dal II secolo in poi, della Provenza occidentale (centrata su Marsiglia e forse su arles) dove dominano le grandi coppe/scodelle e dove si registra un’assunzione precoce dei piatti, distinta dalla facies del Languedoc orientale, più “conservatore”, dove tra i prodotti d’im-portazione predominano le coppe per bere e «l’importance des vases à boire souligne la persistance des rapports traditionelles, depuis le VIe s., entre vaisselle non tournée (pour manger) et coupes tournées liées à la dépendance économique et coloniale des produits vinicoles».46
Nell’area degli ateliers monetali questo invece non accade se si in-seriscono le Lamb. 28 e le Lamb. 27c tra le coppe: in questo caso subito dopo il primato dei piatti (e questo appare come un vero dato innova-tivo) si ritrovano le coppe per bere, funzione suggerita dalla presenza esclusiva nelle due forme della taglia medio-piccola (vedi supra). Le differenze sottolineate tra il Languedoc e la Provenza, pur presenti, sembrano dunque da sfumare per quel che riguarda i vasi per bere. a Marsiglia, e più in generale in Provenza, si assiste nel corso del II secolo (soprattutto a partire dal 175 a.c.) all’assunzione di nuove forme, come la Lamb. 31 o la polivalente Lamb. 33b, che andranno sempre più ad intaccare il “monopolio” esercitato dalla Lamb. 27ab, per la quale la re-gione nîmoise e il Languedoc mostrano invece una prolungata fedeltà. Marsiglia sembra quindi il centro d’irradiazione di un’innovazione che riguarda soprattutto l’assunzione precoce delle nuove forme prodotte dalle officine campane e in particolare dei piatti (in particolare la forma Lamb. 36; si veda appendice I. 5).
iii.2. considerazioni storico-commerciali
Nel Mediterraneo occidentale, tra la fine del IV e la metà del III sec., all’uniformità rappresentata dalla ceramica attica a vernice nera si sostituisce dunque un ampio spettro di ceramiche diverse, che testimo-nia la proliferazione di officine locali/regionali con una certa tendenza al commercio transmarino. Tra queste s’inseriscono non solo le produ-zioni italiche in genere, ma anche quelle occidentali, in particolare gli ateliers di Rosas e le produzioni massaliote a pasta chiara, diffuse fino alla metà ca. del II secolo in tutta l’area d’influenza massaliota e in al-cune zone della catalogna. come visto sopra, un posto privilegiato per diffusione e frequenza spetta all’atelier des petites estampilles, la cui di-
46 arcelin 1991, p. 229; considerazioni simili anche in Bats 1988, pp. 219-223.
176
stribuzione permette di seguire un circuito commerciale marittimo set-tentrionale che unisce le coste del Lazio e dell’Etruria meridionale alla corsica, alla Liguria, alla Provenza fino al Golfo del Leone e Ampurias (cibecchini 2004, pp. 58-59). Nella diffusione di queste ceramiche è sta-to letto anche un riflesso della crescente influenza politico-economica di Roma nel Mediterraneo occidentale (Morel 1985, p. 176), mediata ve-rosimilmente dalla storica alleata dell’Urbe, Massalia, che appare chia-ramente il principale centro di re-distribuzione delle ceramiche roma-no-italiche in Gallia e probabilmente anche nel territorio dominato da Ampurias.47 In questo quadro, la città etrusca di Populonia sembra aver rivestito un ruolo importante, probabilmente legata a Roma da vincoli specifici e forse suo avamposto commerciale (come suggerirebbe anche la presenza locale di una succursale dell’atelier), nonché scalo rilevante sulla rotta che collegava Roma a Massalia (Romualdi 1992, p. 202). La presenza d’esemplari dell’ateliers des petites estampilles di probabile pro-duzione populoniese potrebbe suggerire l’esistenza di un rapporto più stretto tra le due città, legato alla lavorazione e al rifornimento del ferro, vista la fama della città focese nella lavorazione di metalli (in particola-re per le armi)48 e non soltanto la traccia di uno scalo commerciale.
Stando alla diffusione delle ceramiche romano-italiche a verni-ce nera, i contatti commerciali tra la penisola centro-italica e Massalia sembrano intensificarsi a partire dalla fine IV secolo; in parallelo, da un punto di vista politico, Marsiglia si rivela uno dei più fedeli al-leati di Roma durante le guerre puniche.49 Non è quindi inverosimile che la sorta di monopolio nella re-distribuzione di merci romano-italiche tenuto dalla città sia legato alle ottime relazioni politiche con Roma. Un’ultima considerazione sul commercio delle ceramiche italiche di fine IV e III secolo nasce dalla constatazione dell’assenza di quantità apprezzabili, almeno fino agli ultimi decenni del III seco-lo, d’anfore d’importazione italica o magno-greca nei siti sud-gallici (cibecchini 2004, pp. 58-59). Sono le anfore massaliote a dominare incontrastate fino alla fine del III secolo in Provenza e nel Languedoc
47 Principal 1998, pp. 214-215; cibecchini-Principal 2002. Si è proposto invece di leggere i ritrovamenti di vasellame italico e dell’atelier des petites estampilles a sud dell’Ebro come conseguenza di una rotta meridionale gestita forse da vettori punici, Pérez Ballester 1994, pp. 193-194; Principal 1998, p. 177.
48 Sull’importanza, anche commerciale, della lavorazione dei metalli, cfr. Bats 1982, p. 264 con ulteriore bibliografia.
49 Si veda da ultimo Hermary et al. 1999, pp. 98-106.
177
orientale.50 Non è dunque scontato interpretare l’arrivo di queste ce-ramiche a vernice nera soltanto nell’ottica di merce “parassitaria” del commercio del vino italico, come avverrà per la campana a. Di pari passo, non si può escludere che nel III secolo alcune ceramiche da mensa siano state oggetto di un commercio “meramente manifattu-riero e mercantilistico” (Morel 1985, p. 73) e che in un’area fortemente ellenizzata, come la Gallia meridionale, la ceramica da simposio possa aver rappresentato una merce di per sé, rispondendo ad una neces-sità tecnica (Bats 1988, p. 233). Tuttavia, nessuno dei relitti noti nel Mediterraneo occidentale tra III e II secolo, sembra supportare l’idea che la ceramica da tavola possa aver costituito il carico principale di un’imbarcazione (cfr. cibecchini 2004, p. 62).
Il quadro cambia con l’arrivo della ceramica campana a, ceramica di tradizione greca ma d’ambito politico-economico ormai chiaramente romano. Dall’ultimo quarto del III secolo si registra la forte progressio-ne di questa produzione, sempre più standardizzata e commerciata a basso costo grazie all’associazione “parassitaria” con anfore vinarie tir-reniche (le greco-italiche seguite dalle Dressel 1), come ormai ben noto e come ben dimostrano anche i relitti della Meloria a (225-200 a.c.) e del Grand congloué 1 (200-190 a.c.).51 L’elevata percentuale delle pre-senze di campana a, che si registra nella fase 3B (200-150 a.c.), può corrispondere alla diffusione e all’utilizzo delle ingenti quantità di ce-ramica arrivata in navi come quelle appena citate. In contemporanea all’arrivo del vino italico si assiste alla progressiva scomparsa delle an-fore massaliote, non solo a Marsiglia, ma anche in tutti i siti dove finora avevano dominato.52
Un nuovo forte aumento della campana a, come visto sopra, si registra a partire dall’ultimo quarto del II secolo, dato che si riscontra in molti altri siti della Provenza e che trova un parallelo nella presenza di questa ceramica quale carico secondario in numerosi relitti compresi tra 150 e 125 a.c.53 In questo periodo, i continui interventi di Roma in Gallia, che si concludono con la fondazione di Aquae Sextiae (aix-en-
50 Py 1990c, pp. 74-78; Bats 1990, p. 211; Py et al. 2001, pp. 129-130.
51 cibecchini 2002; Benoit 1961.
52 Hermary et al. 1999, p. 139.
53 Si vedano ad es. Lattes, dove la campana a tocca le massime percentuali tra 125 e 100 a.c. (Py et al. 2001, p. 435, fig. 59). Sul rapporto tra dati forniti dai siti terrestri e dati forniti dai relitti, cfr. cibecchini 2004, in particolare per le presenze di campana a, pp. 63-65.
178
Provence) nel 124 a.c. e di Narbona nel 118 a.c., hanno reso Marsiglia sempre più dipendente dalla sua potente alleata,54 una dipendenza evi-dente anche a livello commerciale.
Infine, l’analisi della diffusione di alcune forme della campana a (la Morel 68 e la kylix 42Bb-Bc) e, soprattutto, delle ceramiche della “cer-chia della B” (in particolare di forme come il cratere caleno M. 4753a), rende più palese la differenza di distribuzione di questi materiali tra la Gallia e la Penisola Iberica, una diversità in parte già percepibile nella distribuzione delle ceramiche italiche di IV-III secolo (compreso l’atelier des petites estampilles). La Gallia meridionale, ed in particolare Marsiglia e il suo territorio, mantengono un legame privilegiato con le produzioni napoletane fino al I secolo (cfr. supra, I.5), mentre sono toccate in manie-ra sporadica dalla distribuzione di ceramiche della “cerchia della B”, al contrario della Penisola Iberica e di alcune aree del Languedoc-Roussil-lon.55 La diffusione complessiva di questi due gruppi di produzioni e di alcune forme peculiari, ha permesso di evidenziare due distinte rotte marittime (cibecchini 2004, pp. 65-70): una meridionale, che interessa l’africa settentrionale (soprattutto cartagine fino al 146 a.c.) e fa capo all’importante centro economico di cartagena (e forse anche a cadice); una rotta settentrionale che costeggia il Tirreno, e attraverso l’arcipelago toscano e la corsica punta alle coste provenzali, all’altezza delle quali nel caso della campana a si dirige a Marsiglia; nel caso delle ceramiche della cerchia della B, invece, questa rotta salta quasi completamente la Gallia facendo verosimilmente capo ad Ampurias. Sembra quindi trat-tarsi di percorsi prestabiliti che probabilmente collegano direttamente alcuni porti principali, in grado di gestire lo stoccaggio e la re-distribu-zione delle merci in un vasto territorio (cibecchini c.s.). Resta da capire a quali dinamiche economiche e/o politiche sia dovuta tale differen-ziazione. Una prima motivazione è data dalla presenza di eserciti e di vari personaggi legati alla gestione romana delle nuove province, che rappresenta senz’altro un importante motore commerciale e una delle principali fonti di assorbimento di prodotti italici nella Penisola Iberi-ca (Molina 1997, pp. 185-189). L’elemento militare ha però avuto scarsa importanza in Gallia a livello commerciale (Tchernia 1986, pp. 87-90) e non sembra poter spiegare da solo le difformità osservate, ad esempio quelle tra la Provenza e il Languedoc-Roussillon. Sorge spontaneo, da un punto di vista puramente commerciale, chiedersi se possa essere un
54 Hermary et al. 1999, p. 107.
55 cfr. supra, la discussione in II.6.; cibecchini 2004, pp. 66-67 e fig. 3.
179
fattore meramente culturale (il gusto e la domanda dell’acquirente) a determinare questa peculiare distribuzione delle ceramiche, o, piutto-sto, se si tratti di zone commerciali diversificate perché gestite da nego-tiatores e commercianti diversi che si servono di officine distinte, talvolta anche nell’ambito di una stessa produzione. È difficile stabilire quanto nel prolungato attaccamento della Gallia meridionale alla campana a influisca il gusto per una ceramica “greca” e quanto gli stretti rapporti commerciali tra la città focese e l’area campana, o forse più precisamen-te con alcuni commercianti legati alle officine napoletane.
appendice
I. cERaMIca a VERNIcE NERa D’IMPoRTaZIoNE: caRaTTERISTIcHE TEcNIcHE E FoRME INDIVIDUaTE
i.1. ceramica attica a vernice nera (cfr. supra ii.1.1.)
Pasta ceramica nocciola-rosato, che talvolta vira sul rossiccio, dura, compatta e depurata. Vernice nera spessa e coprente, lucente.
Forme individuate:– “Skyphos type A: Attic-type”: 2 fondi, uno in giacitura primaria (Fig.
3, n. 4), attribuibile agli skyphoi serie recente,56 assimilabile alla Lamb. 43, M. 4341-4342, databile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo;
– “Bowl-incurving rim” (Sparkes-Talcott 1970, 131-132): 3 esemplari (Fig. 3, nn. 2, 5, 12). È la forma più caratteristica della produzione di IV secolo. Il nostro n. 5, vicino a M. 2771a, sembra inseribile tra gli esem-plari dell’ultimo quarto del IV secolo, così come il n. 2, simile alla M. 2771j, datata attorno al 300 a.c. Probabilmente più antico invece il n. 12, con confronti anche a Olbia (Bats 1988, Tav. 3, nn. 92, 95, 97);
– “Fish-plate”: 1 esemplare di piatto da pesce (Fig. 3 n. 16). Forma ben attestata a Lattes (Py et al. 2001, pp. 397-398) e a Olbia, sia nella variante più antica che in quella più recente con piede semplice (Bats 1988, p. 82, tav. I) come nel nostro caso.
– Kantharos (Sparkes-Talcott 1970, pp. 122-123): 1 fr. di orlo. assi-milabile alla forma Lamb. 40-M. 3520,3521, rara a Lattes (Py et al. 2001, p. 377) ma presente a Olbia, anche con esemplari tardi (Bats 1988, p. 89). Residuale.
56 cfr. Sparkes-Talcott 1970, pp. 84-85, n. 265; Lattara 1993, p. 121; Bats 1988, p. 89.
180
– Coppa tipo “concave lip”: 1 fr. di orlo, residuale. Sembra pertinente ad una coppa/kylix di tipo Bloesch c, “concave lip”(Bloesch 1940, pp. 135-136; Sparkes-Talcott 1970, pp. 91-92).
i.2. atelier des petites estampilles (cfr. supra ii.2.)
Due sono le paste ceramiche attestate: a. di colore chiaro, camo-scio-rosato, spesso con zone bicolori, dura e compatta, considerata quella “tradizionale” per questa produzione; B. di colore rosso chiaro-arancio, dura e compatta, nota principalmente a Populonia. In entrambi i casi, la vernice può variare dal nero-bluastro al verde, con iridescenze e sfumature di colore, lucente, ben coprente.
L’unica forma presente è la coppa Lamb. 27ab, M. 2783-2784, at-testata in entrambe le principali paste ceramiche. La maggior parte dei frammenti rinvenuti presenta una pasta “tradizionale”, collegata alle produzioni romano-laziali, ma almeno sette individui (cfr. Fig. 3, nn. 7-8, 13; Fig. 8, n. 1) hanno una pasta ceramica decisamente rosso-arancio, forse assimilabile ai tipi B e c di Populonia (Squarzanti 1994-1995, pp. 344-345). Recentemente questo tipo di pasta ceramica è stato riscon-trato anche in Etruria Meridionale57. I diametri degli orli (14 e 15 cm) e quelli dei piedi (tra 4 e 6 cm) rientrano entro la media nota (Bats 1976, p. 74; 1988, p. 103). Decorazioni: rosette e palmette impresse, quest’ul-time nettamente prevalenti (cfr. Fig. 3, nn. 7, 9, 15; Fig. 6, n. 1; Fig. 8, n. 1; Rosette: Fig. 3, n. 6; Fig. 4, n. 9), sempre nella classica disposizione a quattro stampini. Per l’analisi delle decorazioni di questa produzione, si veda Pérez Ballester 2003, pp. 138-182.
i.3. produzioni italiche varie (cfr. supra ii.3.)
I.3.1. Italiche (cfr. supra II.3.1.)Sono state evidenziati, soprattutto tra le coppe, due gruppi princi-
pali di paste ceramiche:gruppo A - Pasta ceramica chiara, dal nocciola-beige al rosa, tal-
volta con sfumature arancio-rossiccie o grigie, dura e ben depurata. Le vernici sono quasi sempre spesse e di buona qualità. Per l’aspetto
57 Si tratta di una pasta diffusa tra le ceramiche dell’atelier des petites estampilles rinvenute nella Media Valle del Tevere, principalmente su coppe M. 2784 e 2621 (per l’informazione ringrazio Helga Di Giuseppe che, nell’ambito del progetto “Valle del Tevere” diretto da H. Patterson, ha riesaminato la ceramica a vernice nera della South Etruria Survey): Di Giuseppe 2003, 2005, 2007, c.s.
181
esteriore sembrano affini all’atelier des petites estampilles o comunque a produzioni dell’Italia centrale (etrusco-laziale?);
gruppo B - Pasta ceramica da rosso chiaro a rosso più bruno o con tono nocciola-marrone, appena granulosa. Sembrano collegarsi, per tecnica e forme, alla campana a arcaica di Morel (Morel 1981b, 102). I frammenti riferibili a questo secondo gruppo sono minoritari rispetto al precedente.
Forme individuate:- Coppe Lamb. 27ab, M. 2783-2784: 12 individui (Fig. 4, n. 1, 4). È sen-
za dubbio la forma più attestata per tutto il III sec., presente con moltepli-ci varianti. Il diam. si attesta tra 13 e 16 cm, come già noto ad olbia (Bats 1988, p. 103), ma sono presenti anche coppe più piccole (diam. 8-10 cm). Un solo individuo appartiene al gruppo B, il resto al gruppo a.
- Coppetta vicina alla M. 2823c: 1 fr. di orlo, pasta ceramica a. La M. 2823c, da Tarquinia, è ritenuta una produzione locale, datata verso la metà del III sec.
- Coppetta vicina alla forma M. 2766a: 1 fr. di orlo, pasta a. La M. 2766a, produzione locale dal Foro Palatino, è datata attorno alla metà del III secolo.
- Piatto da pesce Lamb. 23-M. 1120: 1 fr. di orlo pendulo, pasta cera-mica a. La forma è ben attestata a olbia (Bats 1988, p. 100).
- Kylix Lamb. 42 Bb-Bc: 1 fondo (Fig. 6, n. 3) con decorazione a pal-mette contornate da rotellature di ottima fattura, che trova confronti ad olbia.58 La qualità della vernice e le caratteristiche della pasta ceramica, vicine a quelle della pasta ceramica a, portano ad escludere le produ-zioni del golfo di Napoli e sembrano richiamare piuttosto quelle della campania settentrionale.
- Craterisco Lamb. 40-M. 3500: 1 fr. di parete, decorata con baccella-ture (fase 3c), pasta ceramica a, di probabile produzione etrusco-lazia-le; non sembra superare il terzo quarto del III sec (Bats 1988, pp. 96-97). 1 fr. di parete di un altro craterisco, inseribile tra le M. 3520-3540, è di ot-tima fattura e probabilmente di produzione etrusco-laziale. Residuale.
- Lekythos forma M. 5456b: 1 fr. di orlo con collarino estroflesso (Fig. 6, n. 2), pasta ceramica simile alla B, colore rosso intenso, molto dura. La M. 5456b, attestata a Palermo e datata intorno al 300 a.c.; si attribui-sce a produzioni della Sicilia punica o dell’area punicizzante spagnola. Residuale.
58 Bats 1988, pp. 104-105, tav. 9, n. 272 e pp. 128-129, tav. 19, nn. 554, 559.
182
- Lucerne: 4 individui, tra cui una lucerna quasi completa, una pa-rete e un becco (Fig. 7, n. 16), con pasta rossiccia o arancio, associabili al tipo “biconico dell’Esquilino”, di produzione campano-laziale (Pavoli-ni 1981, pp. 144-149. Pavolini 1990, pp. 101-103).
Forme n.d.: 16 individui. Tra questi, si segnalano 3 fondi partico-lari:
- fondo (Fig. 4, n. 5) decorato all’interno da quattro fasce di rade rotellature, appartiene verosimilmente ad una coppa. Sulla parete est., quasi all’attacco col piede, è stata risparmiata una piccola finestra di forma rettangolare allungata. Vicino al gruppo B;
- fondo modanato, verosimilmente di forma chiusa (Fig. 3, n. 1), con pasta ceramica vicina al tipo B, color rosso vivo, dura e compatta e ver-nice nero bruna. Il tipo di piede trova un cfr. con le ceramiche pseudo-attiche massaliote (Py et al. 2001, pp. 1183-1193), mentre le caratteristiche tecniche potrebbero rinviare ad una produzione della Sicilia punica;
- fondo modanato (Fig. 5, n. 3), pasta ceramica vicina al gruppo a, corrisponde forse ad un cratere di produzione etrusco-laziale (?). Il pro-filo ricorda il cratere F. 4753, prodotto a cales dalla fine del II secolo.
I.3.2. Imitazioni attiche (cfr. supra II.3.2)La paste ceramiche attestate variano dal rossastro al rosa cupo-
nocciola, spesso con buona vernice nera, spessa e lucente; talvolta sem-brano coincidere con la campana a primitiva (cfr. ad es. la Lamb. 22, Fig. 3, n. 3). Per quanto riguarda le forme, è stata identificata solo la coppa Lamb. 22, assimilabile a M. 2646a, presente con 2 individui, di cui uno (Fig. 3, n. 3, fase 4c) trova un preciso confronto nel relitto di ca-pistello, probabilmente pertinente alla campana a primitiva o arcaica, databile tra 300 e 280 a.c. (cavalier 1985, Fig. 36, h).
I.3.3. Ceramica con pasta di tipo 5 (cfr. supra II. 3. 3)Pasta ceramica dal colore nocciola, appena rosato, dura, compatta,
con minutissimi inclusi bianchi frequenti. Le vernici variano per lucen-tezza, ma sono quasi sempre spesse, ben aderenti e talvolta con tono grigio-plumbeo. Si notano evidenti segni di tornitura all’esterno.
Forme individuate:- Coppa Lamb. 33b, vicina a M. 2773: 1 orlo (Fig. 3, n. 17).- Coppa Lamb. 28, M. 2612-2614 : 2 orli (Fig. 4, n. 2, Fig. 5, n. 5).- Coppa Lamb. 27ab, M. 2783-2784: 2 orli.- Kantharos, assimilabile alla Lamb. 40: 1 fr. di parete (Fig. 5, n. 4)
decorato con pseudobaccellature, residuale.
183
i.4. ateliers di rosas e occidentali (cfr. supra ii.4.)
Sono tre le principali varietà di pasta ceramica note: a) pasta cerami-ca arancio-rossiccia, dura, ben depurata (la più comune); B) pasta ceramica rossa, talvolta rosso granato, molto dura e compatta; c) pasta ceramica dal giallastro al beige, morbida, depurata. La vernice è quasi sempre spessa, da lucente a opaca, poco aderente, tende a staccarsi a scaglie.
Forme individuate:- Piatto da pesce Lamb. 23-M. 1120: 1 individuo (Fig. 4, n. 8), pasta cera-
mica B. Un confronto, soprattutto per il piede, si ha con un piatto catalano dell’atelier delle tre palmette radiali (Principal 1998, p. 74, Tav. 5 n. 8).
- Coppa Lamb. 27 ab-M. 2783-2784: 3 individui, tra cui un orlo (Fig. 4, n. 7), pasta ceramica a.
- Coppa Lamb. 33-M. 2150, 2973: 1 fr. di orlo; forma rara per questa produzione.59
- Grande coppa Lamb. 26-M. 2762: 2 frr. di orli (Fig. 8, n. 3, con pasta ceramica B). È la forma più tipica di tutta la produzione degli ateliers di Rosas, fabbricata nelle tre varianti d’argilla note (v. supra). Entrambi gli esemplari appartengono alla fase evoluta e sono di grandi dimensioni (diam. 25 e 28 cm), tra le maggiori attestate. Residuali entrambi.
- Coppetta: un fondo, simile al tipo M 221c, pasta ceramica a.- Kantharos Lamb. 40-M. 3500: 1 fr. di orlo (Fig. 8, n. 2), pasta ce-
ramica a. Trova confronto con numerosi esemplari catalani (Principal 1998, pp. 84-85, Tav. 11). Si tratta di una forma molto diffusa, soprattut-to nella seconda metà del III secolo. Residuale.
- Coppetta M. 2745c: 1 esemplare (Fig. 9, n. 12), solo lontanamente assimilabile alla forma Lamb. 34. Pasta ceramica da rossiccia a beige-gri-gia, molto dura, compatta, con inclusi minutissimi bianchi. Vernice nera spessa, opaca. Trova un preciso confronto ad Ampurias con vasi di produ-zione locale datati al secondo quarto del II secolo (Morel 1981b, p. 217).
i.5. ceramica campana a (cfr. supra ii. 5)
Le varianti di pasta ceramica distinte sono 4: (1) pasta ceramica rossa, talvolta con tono più marrone, da dura a molto dura, piuttosto
59 Un fondo probabilmente attribuibile ad una Lamb. 33a è noto a El Vilar (Principal 1998, p.78). La datazione di questa forma, molto nota tra le produzioni italiche, lascia intrave-dere una possibile cronologia per gli esemplari più antichi compresa nella seconda metà del III secolo che ben si adatta anche alle produzioni catalane.
184
compatta, leggermente granulosa. Vacuoli minuti e medi non frequenti. Le vernici sono piuttosto varie, ma con maggiore frequenza di buona qualità e iridescenti; (2) pasta ceramica rosso vivo con tono arancio, dura, leggermente granulosa, compatta. Vacuoli non frequenti. In ge-nere vi si associano vernici nere di buona qualità, lucenti o semilucenti, spesse; (3) pasta ceramica rosso chiaro o rosa carico, semidura, legger-mente granulosa. Vacuoli minuti e medi piuttosto frequenti. Minutissi-mi inclusi bianchi frequenti. Vernice nera spesso non d’ottima qualità, piuttosto sottile e più opaca; (4) pasta ceramica da rosa carico-vinaccia a grigio-bruno, marrone, semidura o morbida, granulosa. Vacuoli minuti e medi frequenti. Vernici piuttosto variabili ma in genere non di buona qualità, poco spesse e mal conservate. Le virazioni di colore riscontrate sembrano dovute a difetto di cottura.
Forme individuate:Piatti: 35% delle forme individuate- Forma Lamb. 36 – M. 1312, 1313c, 1314, 1315a: NIM = 52. (Fig. 5, n.
12; Fig. 6 nn. 9-12; Fig. 7, n. 8; Fig. 8, nn. 4-6).Rappresenta di gran lunga la forma più attestata (cfr. Grafico 2),
come a olbia di Provenza (Bats 1988, p. 110). La maggior parte degli individui appartiene alla campana a classica (47 contro i 3 in cam-pana a antica, 1 nella tarda e 1 in a arcaica).60 a partire dalla fase 3B cresce fino al picco della fase 1. a Marsiglia è predominante al remblai de la Bourse (Bertucchi-Marangou 1989, pp. 62-63, 69; Gaita 1995, p. 52), mentre è minoritaria al Parc des Phocéens, Place des Pistoles e Fort Saint-Jean (Grau i Segú 1997, 288-303). Tra le varianti individuate prevale la serie Morel 1312, in particolare le M. 1312a-b tipiche del II sec.; sono rari gli orli larghi e orizzontali della fase tarda (arcelin, chabot 1980, pp. 144-145). Predominano i piatti di medie dimensioni (18 ai 24 cm, con una preferenza per i 19-21 cm), come ad olbia e nella regione marsigliese-provenzale in generale (Bats 1988, p. 109, cayot 1984, p. 57).
- Forma Lamb. 6 – M. 1431, 1441b, c, f, 1443: NIM = 7 (Fig. 5, n. 13).Questa forma compare nella fase 3B in uno strato di colmatura da-
tabile non oltre il 150 a.c. (vedi supra), in linea con la datazione più bas-
60 anche a Lattes un esemplare in strati del 225-200 (Py et al. 2001, 497), a differenza della Basse Valle del Rodano dove questa forma è presente regolarmente ma solo a partire dagli inizi del II fino alla metà del I sec (cayot 1984, p. 57; arcelin 1991, p. 210). Presente nell’oppidum de La Teste Nègre (Gantes 1977, p. 35, tav. 11, n. 3) e molto abbondante nel relitto del Grand congloué 1 (Benoit 1961, p. 86).
185
sa attestata per la sua esportazione, e segue poi un andamento irregola-re.61 Le altre attestazioni a Marsiglia ne confermano il ruolo secondario (Grau i Segú 1997, p. 294; Gaita 1995, pp. 53-54). La serie più attestata è la M. 1443; i diametri si concentrano sui 22 cm, misura dominante nella a classica a olbia (Bats 1988, 112).
- Forme Lamb. 5 e 5/7 – M. 2235b, 2252, 2265, 2282-2284b: NIM = 3 (Fig. 7, n. 4; Fig. 8, n. 10)
La forma Lamb. 5 appare nella prima metà del II sec.a.c. ed è at-testata per tutto il secolo nel Mediterraneo occidentale (Py et al. 2001, pp. 438-439). Tende a scomparire alla fine del II sec., a favore della sua variante più carenata e più bassa, la Lamb. 5/7, tipica della a tarda.62 Nell’area indagata la presenza di questa forma è limitata alle fasi più tarde: un solo individuo Lamb. 5 (fase 2B Fig. 7, n. 4) e due Lamb. 5/7 (fase 1, Fig. 8, n. 10), di modulo medio-piccolo (diam. 22 e 24 cm). a Marsiglia si ha una Lamb. 5 nel sondaggio al remblai della Bourse (da-tata al 140 a.c., Bertucchi-Marangou 1989, pp. 69, 83), è poco presente a Place des Pistoles e Parc des Phocées, ma ben attestata (soprattutto Lamb. 5/7) nella fase finale dei sondaggi recenti della Bourse (Gaita 1995, p. 53) e al Fort Saint-Jean (deposito datato verso il 30-40 a.c., Grau i Segú 1997, pp. 288-303).
- Forma Lamb. 55 – 2233a, 2234-2235a: NIM = 2 (Fig. 7, n. 9; Fig. 8, n. 7).
Forma rara in campana a, tranne che a cartagine (Morel 1990, p. 62) e di difficile datazione. assente nei contesti più antichi, dal Grand congloué 1 (Morel 1978, p. 159) alla Teste Nègre (Gantes 1978), po-trebbe tuttavia essere già esistita in campana a arcaica.63 a Nages e a Lattes è attestata non prima del 150 a.c. (Py 1978, pp. 48-49; Py et al. 2001, p. 514) ed è rara già agli inizi dell’ultimo quarto del II sec.64 Entrambi gli individui attestati appartengono alle fase 1; si segnala-no inoltre due fondi decorati con foglie d’edera e rotellature (Fig. 5,
61 a Lattes compare attorno al 150 a.c. (Py et al. 2001, pp. 444-445), è molto rara a carta-gine, ante 146 a.c. (Morel 1990, p. 62), presente sul relitto di Punta Scaletta, (140-130 a.c. Lamboglia 1964; Firmati 1992). anche a Glanum si data tra 150 e 75 a.c. (arcelin 1991, pp. 210-211).
62 Py et al. 2001, pp. 440-441. Per il punto della diffusione e delle problematiche legate alla campana a tarda in Gallia si veda il quadro proposto da P. arcelin (arcelin 2000)
63 Bats 1988, p. 114, nota 55; scetticismo in Py et al. 2001, p. 514.
64 come indicano la qualità degli esemplari noti e la sua assenza a Pollentia, Bats 1988, p. 114; Sanmartí-Principal 1998, 209; Py et al. 2001, p. 514.
186
n. 22, fase 3a e Fig. 9, n. 4, fase 1), motivo raro in occidente e tipico di questo piatto a cartagine (Morel 1990, p. 62). Rara nelle altre aree marsigliesi.65
- Forma Lamb. 23 – M. 1120, 1121, 1122a: NIM = 5 (Fig. 4, n. 20; Fig. 7, n. 16)
Una delle forme più antiche e caratteristiche della campana a antica, importata dalla fine del III secolo fino al 180-175 a.c. ca.,66 pro-babile data della sparizione (Py et al. 2001, pp. 447-448). Nell’area de-gli atelier compare nella fase 3B, in un momento ormai finale della sua diffusione; a partire dalla fase 2B può essere considerata residuale. a Marsiglia è ben attestata solo al Parc des Phocéens (Grau i Segú 1997, pp. 289-290), sempre in a antica; altri due esemplari dal remblai della Bourse (Bertucchi-Marangou 1989, p. 62-63, Gaida 1994, p. 53). Il solco attorno alla cupola centrale e lungo il bordo (M. 1121, Fig. 4, n. 20), ritenuto un particolare tecnico estraneo alla campana a, è attestato viceversa in numerosi casi;67 sembra un tratto arcaico, residuale nella campana a antica.
Grandi coppe/scodelle: 18% delle forme individuate- Forma Lamb. 27B – M. 2824, 2825, 2843: NIM = 27 (Fig. 4, nn. 18-19,
21 ; Fig. 5, nn. 14-17, 18; Fig. 6, n. 13; Fig. 7, nn. 2-3, 5; Fig. 8, nn. 8-9).Nel II e I secolo la Lamb. 27B è una delle forme dominanti in Pro-
venza e nel Golfo del Leone, tanto da far ipotizzare che la sua creazione alla fine del III secolo sia legata alla forte domanda occidentale, per sostituire la popolare Lamb. 26 prodotta dagli ateliers di Rosas (San-martí-Principal 1998, 209-210). Ha un arco di vita molto ampio,68 che
65 Ugualmente rara nel territorio circostante, cfr. Saint-Blaise (cayot 1984, p. 68) e Glanum (arcelin 1991, p. 212, datata tra 175 e 125 a.c.).
66 a Saint-Blaise 34 individui (cayot 1984, p. 65), a Olbia 60 (Bats 1988, p. 114) e a Lattes una cinquantina (Py et al. 2001, p. 448). È scarsa invece nella bassa valle del Rodano: 5 a La Teste Nègre (Gantes 1978, p. 99), uno a Nages (Py 1978, p. 58) e a Glanum (arcelin 1991, p. 212). Il Grand congloué 1 ne ha restituito il lotto più importante (67 esemplari, Benoit 1961, p. 84).
67 ad es. a olbia (Bats 1988, tav. 14, n. 448), a Saint-Blaise (cayot 1984, fig. 17, nn. 85,86,88) e a Lattes (Py et al. 2001, p. 449).
68 La variante 27Ba si trova nell’oppidum de La Teste Nègre (Gantes 1978, p. 99) e a Olbia (Bats 1988, pp. 116-118) in campana a antica, nel relitto del Grand congloué 1 (Benoit 1961, p. 86) e, con la più tarda variante 27Bb, è prioritaria nel relitto di Punta Scaletta (Lamboglia 1964, p. 245, Bats 1988, p. 117). Si veda Py et al. 2001, pp. 465- 473, con biblio-grafia e un’analisi delle due varianti.
187
arriva fino alla prima metà del I secolo (arcelin-chabot 1980, p. 139), con massima diffusione verso la metà-terzo quarto del II secolo. Nel-l’area studiata compare nella fase 3B e in totale si registrano 2 individui in campana a antica, 22 in a classica e uno solo in a tarda. anche nelle altre aree marsigliesi indagate è la forma più attestata dopo la Lamb. 36 e la Lamb. 31 (cfr. Grafico 2). La prevalenza di taglie piccole (diam. tra 20-23 cm), è in contrasto con i dati emersi a olbia, Saint-Blaise e in ge-nerale nella bassa valle del Rodano (diam. 24-26 cm). Si notano alcuni fondi con 4 palmette contornate da rotellature (ad es. cfr. Fig. 9, n. 5), decorazione tipica della Lamb. 27B.
- Forma Lamb. 8B – M. 2855, 2941, 2942, 2943: NIM = 1È una forma esportata fin dal terzo quarto del II sec., ma diffusa in
Gallia meridionale sopratutto nel I secolo nella sua variante più tarda (8Bc).69 La presenza di un solo individuo, nella fase 1, è un indizio per una datazione attorno al 100-80 a.c. dell’ultima fase di vita.
- Forma Morel 2912: NIM=1Talvolta inserita come variante della Lamb. 27B è ben attestata sul
relitto dell’Illa Pedrosa, (140-130 a.c., Sanmartí-Principal 1998, p. 206). L’unico orlo attestato, all’inizio della fase 2B, ci fornisce un importante elemento di datazione.
- Forme Lamb. 33a e 33b – M. 2153a, 2154; M. 2973abc, 2974a, 2977: NIM = 8 (Fig. 8, nn. 11-14)
Si tratta in realtà di due coppe dalla cronologia leggermente diversa; la Lamb. 33a – M. 2153a, 2154, tipica della campana a anti-ca, è una forma rara,70 che sembra sparire entro la prima metà del II secolo. È caratterizzata da un fondo apodo decorato da una grande rosa in rilievo o da bande concentriche sovradipinte in bianco e/o violetto con foglie d’edera. Sono presenti 2 fondi, decorati con foglie d’edera e bande sovradipinte, (nella fase 2B e nella fase 1, residua-le?), decorazione che si ritrova a Ischia, sul relitto della Pointe Le-quin 2 e a Olbia (Bats 1988, p. 125). Gli individui restanti (tutti nella fase 1, Fig. 8, nn. 11-14), sono pertinenti alla forma Lamb. 33b – M. 2973abc, 2974a, 2977, su basso piede, anch’essa già presente nella a
69 Forma definita da Lamboglia nel relitto di Punta Scaletta (Lamboglia 1964, p. 244), e da P. arcelin (arcelin-chabot 1980, p. 149) per gli esemplari più tardi (Lamb. 8Bc – M. 2942- 2943).
70 Sia nei centri indigeni, quali Saint-Blaise (solo 4 fondi, cayot 1984, pp. 68-69), ma anche a Lattes (Py et al. 2001, pp. 488-489). assente a Glanum (arcelin 1991), raggiunge i 28 indi-vidui a Olbia (Bats 1988, p. 122).
188
antica in molti siti della Provenza e del Languedoc.71 Si riscontrano due taglie preferenziali: con diam. di 15/16 cm (Fig. 8, nn. 12-14) e con diam. di 19 cm (n. 11), la più frequente a olbia e Saint-Blaise. attestate entrambi le varianti negli altri contesti Marsigliesi.72
Coppe e coppette: 35% delle forme individuate- Coppetta M. 2714j 1: NIM = 1 (Fig. 4, n. 10)Questa coppetta in campana a arcaica, decorata da tre palmette
convergenti, trova un preciso confronto con un esemplare dal relitto della Secca di capistello (ca. 280 a.c., cavalier 1985, Fig. 36, j) e con uno dalla necropoli di Lilibeo (Bechtold 1999, Tav. I, c2, 4, p. 58).
- Forma Lamb. 28ab – M. 2640: NIM = 16 (Fig. 4, n. 14; Fig. 5, nn. 6-8; Fig. 6, nn. 15-16; Fig. 7, n. 1; Fig. 8, nn. 15-16).
Questa forma è stata inserita tra le coppe, e non tra le scodelle come vorrebbe M. Bats,73 in virtù di una sua probabile funzione per bere suggerita dalla taglia piccola e media (diam. 12-14 cm, Fig. 5, n. 7; Fig. 6 n. 14 ), l’unica attestata in quest’area. È una delle più antiche esportazioni della campana a: nota dalla fine del III sec.74 e tipica del-la prima metà del II sec., sembra rarefarsi rapidamente dopo la metà del secolo.75 compare nella fase 3c in campana a antica (Fig. 4, n. 14),
71 a La Teste Nègre (Gantes 1978, p. 99), nel Grand congloué 1(Benoit 1961, p. 90), a Saint-Blaise (cayot 1984, p.61, dove raggiunge quasi l’8% della campana a), a Glanum (arcelin 1991, p. 212) a Olbia (Bats 1988, pp. 119-120) e a Lattes (Py et al. 2001, pp. 489-490); ancora ben attestata nella seconda metà del II secolo nel relitto di Punta Scaletta (Lamboglia 1964, p. 247; Firmati 1992, p. 21) e dell’Illa Pedrosa (Sanmartí-Principal 1998, p. 206).
72 Unicamente la Lamb. 33b nel remblai della Bourse (Bertucchi-Marangou 1989, pp. 5862-63,69), entrambi (33a e b) nei sondaggi più recenti (Gaita 1995, document 5), al Parc des Phocéens e a Place des Pistols, con singolare prevalenza della Lamb. 33a (Grau i Segú 1997, pp. 288-303).
73 che ha inserito questa forma tra le coppe di grossa taglia/scodelle in virtù della sua derivazione dall’attico “bowls with outturned rim” e della presenza di un modulo medio grande (18-19 cm) e di uno grande (24-25 cm), tuttavia minoritari nella stessa Olbia (Bats 1988, pp. 118-119), così come a Saint-Blaise (cayot 1984, p. 63). La stessa suddivisione vie-ne seguita da P. arcelin a Glanum (arcelin 1991, p. 212). Nel Grand congloué 1 la coppa è presente in vari formati, compresi tra gli 11,5 e i 24,5 cm di diametro (Benoit 1961, p. 90).
74 Morel 1978, 157. Presente a Nages (Py 1978, p. 67), sul Grand congloué 1 (cfr. nota pre-cedente) e alla Teste Nègre, con 11 esemplari (Gantes 1978, p. 99). a Lattes sembra arrivare già alla metà del III sec., cfr. Py et al. 2001, p. 476.
75 Presente a cartagine (Morel 1990, p. 62) ma assente nei relitti di Punta Scaletta e Illa Pedrosa. cfr. Nages e Lattes (Py 1978, pp. 45-47, Py et al. 2001, p. 477) e la catalogna (Sanmartí-Principal 1998, p. 210). Nota a Entremont, oppidum distrutto nel 124 a.c (Benoit 1961, tav. XI).
189
ugualmente a tre frammenti presenti nella fase 3a (Fig. 5, n. 6-8): tutti gli altri esemplari appartengono alla a classica. La Lamb. 28 occupa un posto importante tra le coppe, come al Parc des Phocéens, dove supera addirittura le scodelle Lamb. 27B, e a Place des Pistoles (Grau i Segú 1997, pp. 290-292, 300 e 302), mentre è scarsa negli scavi della Bourse.
- Forma Lamb. 27ab e c – M. 2784, 2787, 2788; M. 2825a, c: NIM = 21 (Fig. 4, n. 17; Fig. 8, nn. 20-21).
Sono state qui riunite le Lamb. 27a-b (17 esemplari) e la Lamb. 27c (4 esemplari), più tarda e inserita da M. Bats tra le scodelle con la Lamb. 27B.76 La coppa Lamb. 27ab, tra le più antiche importazioni in campana a, appare senza interruzione in tutti i giacimenti terrestri e sottomarini tra la seconda metà del III e la fine del II secolo.77 Nella regione marsi-gliese la sua presenza diminuisce rapidamente nella seconda metà del II secolo.78 Nell’area degli ateliers monetali, un fondo in campana a ar-caica (Fig. 3, n. 18, fase 4a) appartiene a questa forma, ben attestata a partire dalla fase 3B, dove si registra la massima frequenza. È la coppa più frequente dopo la Lamb. 31. appartengono probabilmente a questa forma alcuni fondi con rosetta (ad es. Fig. 5, nn. 20-21; Fig. 9, n. 3). Ben nota anche nelle altre aree marsigliesi: in particolare a Place des Pistoles supera le coppe Lamb. 31 e le Lamb. 27B.79
- Forma Lamb. 31ab – M. 2152a, 2574a, 2952a, 2954, 2977 e 2978ab: NIM = 25 (Fig. 5, nn. 10-11; Fig. 8, nn. 17-19).
La coppa Lamb. 31 appare alla fine del III secolo in campana a antica (Lamb. 31a con decorazione graffita e sovradipinta sotto l’orlo) e gode di un successo ininterrotto fino alla prima metà del I secolo (Lamb. 31b, con o senza decorazione sovradipinta).80 Nell’area degli atelier fa
76 Qui inserita tra le coppe in virtù della sua taglia medio-piccola: si veda il commento alla forma Lamb. 28.
77 Si veda l’ampia rassegna delle attestazioni e l’analisi cronologica in Py et al. 2001, pp. 452-455 per la Lamb. 27 a-b e pp. 473-474 per la Lamb. 27c.
78 cayot 1984, p. 57. Nel Languedoc invece resta preponderante per tutto il secolo (Py et al. 2001, pp. 452-455, 473-474).
79 Grau i Segú 1997, pp. 300, 302. al remblai della Bourse i dati sono più prossimi a quelli del-la nostra area, cfr. Bertucchi-Marangou 1989, pp. 58, 63, 69; Gaita 1995, p. 53 e document 5.
80 Ben attestata in Provenza e nel Languedoc; già a la Teste Négre (Gantes 1978, p. 99), nel relitto della Pointe Lequin 2 (gentile informazione di Luc Long) e nel Grand congloué 1, così come nella maggior parte degli oppida della Gallia meridionale; si rimanda all’ampia rassegna in Py et al. 2001, pp. 482-488. Per il punto della situazione nella fase tarda, cfr. arcelin 2000, p. 295, fig. 2.
190
la sua timida apparizione nella fase 3B, per restare una presenza co-stante fino alla sua massima frequenza nella fase 1. Solo 2 pezzi sono in campana a antica, il resto in a classica. Decorazioni attestate: 3 esem-plari presentano sotto l’orlo un tralcio graffito e foglie/frutti d’edera tra due bande bianche (cfr. Fig. 5, n. 10); 14 individui, soltanto una o due fasce bianche sovradipinte sotto l’orlo o sul fondo (Fig. 5, n. 11; Fig. 8, nn. 17-19), in particolare uno con fascia viola tra due fasce bianche sotto l’orlo, i restanti (10 individui) non sono decorati. come a olbia e negli altri siti indagati a Marsiglia è una delle forme più presenti.81 Pochissi-mi i diametri misurabili: sono attestate due taglie (15 e 18 cm) come a Saint-Blaise (cayot 1984, p. 59).
- Forma Lamb. 25 e Morel 113 – M. 2788a-g, 2787g, h, 2983ab: NIM = 9 (Fig. 7, n. 10-12).
Sono state riunite qui le due varianti di questa coppetta: la Lamb. 25 corrisponde alla fase più antica e la Morel 113 alla sua evoluzione, nota soprattutto a partire dalla fine del II sec.82 La Lamb. 25 si diffonde dalla seconda metà del II sec., come indicano il relitto di Punta Scaletta e molti oppida della Gallia meridionale.83 La Morel 113 è invece ben attestata a partire dal I secolo. Fa la sua apparizione all’inizio della fase 2a, con un esemplare intermedio tra la Lamb. 25 e la Morel 113. La maggior parte degli individui sono più prossimi alla forma evoluta Morel 113 (fase 1). I diametri sono compresi tra 8 e 11 cm (cfr. Fig. 7, nn. 10-12). Quasi assente nelle altre aree di Marsi-glia (un frammento al Parc des Phocéens, Grau i Segú 1997, p. 300), arriva qui al terzo posto tra le coppe, sebbene nettamente inferiore alle Lamb. 27 e 31.
- Forma Lamb. 34b – M. 2737, M. 2744b: NIM = 2.Questa coppetta è ben attestata fin dalle prime importazioni84 e la
sua presenza resta regolare per tutto il II sec., sebbene sempre in quan-
81 al Parc des Phocéens supera addirittura i piatti Lamb. 36, cfr. Grau i Segú 1997, p. 300.
82 come nota a. cayot le numerose forme intermedie tra le due varianti testimoniano a favore di una stessa forma che si evolve (cayot 1984, p. 64). Lo stesso raggruppamento si trova in arcelin 1991 e arcelin 2000. Per un’analisi della forma e una rassegna delle atte-stazioni si rimanda a Py et al. 2001, pp. 450-451 per la Lamb. 25 e p. 519 per la Morel 113.
83 Si vedano ad es. Saint-Blaise (cayot 19984, p. 64), Glanum (arcelin 1991, p. 212), e arce-lin 2000, con ulteriore bibliografia.
84 Presente verso la fine del III secolo a La Teste Nègre (Gantes 1978, 99), a Lattes (Py et al. 2001, pp. 495-496) e sui relitti delle Iles Sanguinaires (alfolsi-Gandolfo 1997, p. 59) e del Grand congloué 1 (Benoit 1961).
191
tità ridotte. I due individui attestati (fasi 2a e 1) rientrano nell’unica taglia nota dal diametro di 7-8 cm.
Coppe ansate : 9% delle forme individuate- Forma Morel 68 – M. 3131: NIM = 7 (Fig. 3, n. 19; Fig. 8, n. 22).considerata a lungo una forma tipica della prima metà del II sec.,85
sembra invece già esportata alla fine del III secolo.86 Tra i più antichi, gli esemplari decorati con bande bicolori sotto l’orlo, ben noti nella Penisola Iberica, dove rappresenta una delle forme più utilizzate fino alla prima metà del II secolo (Principal 1998, pp. 129-130). In Gallia mantiene sempre una posizione secondaria, forse per la “concorrenza” di un’altra forma bi-ansata tipica della produzione più antica, la kylix Lamb.–Bats 42Bc: si veda, ad es., il caso di Lattes, dove questa kylix ottiene un enorme successo, men-tre la Morel 68 è poco attestata. Nell’area analizzata compare molto presto (fase 4a) con un esemplare (Fig. 3, n. 19, con le due bande bicolori sovra-dipinte sotto l’orlo) che non può essere datato oltre il 225 a.c.87 Si ritrova poi nelle fasi 3B-3a, sempre in campana a antica, per poi sparire fino alla fase 1, dove si trovano tre esemplari di buona qualità, forse residuali. Il solo diametro misurabile è quello standard (11 cm). Decorata costantemente sul fondo da bande bianche sovradipinte concentriche (Fig. 8, n. 22). Poco pre-sente nelle altre aree indagate a Marsiglia.88
- Forma Lamb.-Bats 42Bc, in parte accostabile a M. 4152a-4153a: NIM = 10 (Fig. 3, nn. 20-22; Fig. 4, n. 16; Fig. 7, nn. 13-14).
Non ci sono ormai più dubbi sulla pertinenza di questa forma, definita nelle sue peculiarità da M. Bats (1988, pp. 128-129), alla campa-na a. Tra le prime importazioni campane,89 è frequente in Provenza e
85 Periodo in cui registra la massima frequenza nei siti della Gallia meridionale (Morel 1978, p. 160; 1981a, pp. 249-250). Si vedano Olbia (Bats 1988, pp. 130-131), Saint-Blaise (cayot 1984, pp. 65-66) e la regione del Languedoc (Py 1990, p. 565; PY et al. 2001, pp. 515-516).
86 Sul relitto del Grand congloué 1, alla Teste Nègre (Gantes 1978, p. 99), Glanum (arcelin 1991, p. 213), ad aleria (Jehasse e Jehasse 1973, p. 126), Nages (Py 1978, pp; 57-58 ) e a Lattes (Py et al. 2001, pp. 515-516).
87 Sulla base della sequenza stratigrafica e dei materiali associati: 3 frammenti di kylikes Lamb.-Bats 42Bc. Si tratta di una delle più antiche attestazioni di Morel 68 in Gallia.
88 Bertucchi-Marangou 1989, pp. 62-63, n. 81, e altri due frammenti dai recenti scavi, Gaita 1995, 53.
89 Presente sul relitto della Pointe Lequin 2, materiali visionati direttamente grazie alla gen-tile cortesia di Luc Long, appare a Lattes tra 250 e 225 a.c., per raggiungere la massima frequenza attorno al 200 a.c. e scendere poi progressivamente dal 175 a.c. (Py 1990a; 1993, p. 146; e infine Py et al. 2001, pp. 505-506, con ampia rassegna delle attestazioni e bibliografia).
192
nel Languedoc90 fino alla catalogna, dove scompare già all’inizio del II secolo (Principal 1998, p. 128). La sua presenza quasi esclusiva in Gallia ha portato J.P. Morel a definirla “un mystére”.91 In un momento iniziale della fase 4a appaiono i primi esemplari, tra cui un fondo in campana a arcaica decorato da grosse palmette (cfr. Fig. 3, n. 22), databile attorno alla metà del III secolo (250-240 a.c.). Il Grafico delle presenze segnala una massima frequenza attorno al 200 a.c. (fase 3B), come attestato a Lattes92. Solo due pezzi in campana a antica (Fig. 3, n. 20, 22); gli al-tri cinque in a classica. L’unico diametro misurabile corrisponde alla taglia preponderante attestata a olbia (13-14 cm). altri due esemplari sono noti a Marsiglia, al Parc des Phocéens (Grau i Segú 1997, p. 300).
- Forma Lamb. 49b – M. 3311: NIM = 1 (Fig. 4, n. 15).È una forma tipica della prima metà del II sec., molto rara sia in
Provenza93 che nella Penisola Iberica (Principal 1998, pp. 128-129). Un solo esemplare in campana a antica, dal diametro di 12 cm. a Marsiglia è attestata al Parc des Phocéens e a Place des Pistoles (Grau i Segú 1997, pp. 300, 302, per un totale di 7 individui).
Lucerne: NIM = 4. 2% delle forme individuate (Fig. 8, n. 23).Tutte le lucerne rinvenute (fase 2B e 1), sono pertinenti al tipo “bi-
conico dell’Esquilino” (fine III-I sec.).94
FondiPochi tra i fondi rinvenuti sono attribuibili ad una forma precisa.
La maggior parte appartiene alla campana a classica (36 esemplari), 2 alla a arcaica (Fig. 3, n. 18; Fig. 5, n. 9), 1 in campana a antica e 7 nella variante tarda.
90 alla lunga lista di attestazioni riporatta da Py (2001, pp. 506-507) si deve aggiungere Glanum (arcelin 1991, p. 213).
91 Morel 1990, p. 59. Un mistero ora sfumato dal rinvenimento in un relitto al largo di Livorno di kylikes che possono essere considerate le immediate progenitrici della Lamb.-Bats 42Bc (Bargagliotti-cibecchini-Gambogi 1997, pp. 45-46, cibecchini 2002, pp. 218-219).
92 La sua presenza nelle fasi finali (2a e 1), potrebbe essere dovuta ad un perdurare del-l’uso e non ad una continuità d’importazione.
93 ad es a La Teste Nègre (Gantes 1978), a Saint-Blaise (cayot 1984, p. 68), a olbia (Bats 1988, pp. 130-131), a Glanum (arcelin 1991, pp. 212-213) e a Lattes (Py et al. 2001, p. 513): copre una cronologia compresa tra la fine del III e il 175 a.c.
94 Pavolini 1981; 1990, pp. 101-103. Vedi anche Bémont-Lahanier 1985, pp. 223-225.
193
- Coppe: 19 esemplari. Spesso decorati con rosetta centrale.Diam. entro 5,5 cm. I pezzi classificabili fanno capo ai “piedi a
facce rettilinee” M. 210 - 220: 8 esemplari (Fig. 3, n. 18; Fig. 4 nn. 11; Fig. 5, n. 9); “piedi con bombatura centrale” M. 320: 10 esemplari (Fig. 5, n. 21, Fig. 6, n. 17; Fig. 9, n. 3).
- Grandi coppe e piatti: 22 esemplari.Diam. compreso tra 6 e 8 cm, fino ai 10 cm. I pezzi classificabili
fanno capo ai “piedi a facce rettilinee” M. 200 - 220: 16 esemplari (Fig. 6, n. 6; Fig. 9, n. 4); e ai “piedi con bombatura centrale” M. 320 - 330: 2 esemplari (Fig. 6, n. 5).
i.6. cerchia della B (cfr. supra ii.6)
I.6.1. Tipo B- campanoPasta ceramica nocciola/avana-rosato, dura, leggermente granu-
losa e vernice nera spessa, per lo più opaca, ben aderente.
Forme individuate:- Coppa Lamb. B1a – M. 2320: due frr. di pareti dello stesso vaso
(colmatura finale fase 2B). Dopo i piatti di forma Lamb. B 5 è una delle forme più diffuse a Olbia (Bats 1988, pp. 139-140), Glanum (arcelin 1991, p. 215) e Lattes (Py et al. 2001, p. 558).
- Pisside Lamb. B3 – M. 7541a, 7553?: una parete con traccia del fon-do (fase 1). È tra le forme più attestate in Gallia meridionale a partire dalla fine del II sec.95
- Piatto Lamb. B5 – M. 2257-2258: 2 individui. Senza dubbio la for-ma più diffusa, ben presente sia a terra che nei relitti:96 la sua esporta-zione in occidente appare compresa tra 150 e 25 a.c. (Py 1993, p. 152; 2001, p. 566; arcelin 1991, p. 214). Su di un fondo (Fig. 9, n. 10) è visibile la decorazione tipica della Lamb. B 5. Il frammento d’orlo (Fig. 9, n. 8) è più vicino alla forma M. 2252a.
- Coppa bi-ansata Pasquinucci 127 – M. 3121: 2 orli. (Fig. 9, n. 9). Ter-za forma del tipo B per diffusione in Gallia (arcelin 2000, p. 299), questa
95 Presente ad Olbia (Bats 1988, p. 142), a Glanum (arcelin 1991, p. 215), a La cloche (ar-celin-chabot 1980, p. 12), Lattes (Py et al. 2001, pp.563-564), etc. Per un quadro generale si veda arcelin 2000.
96 Si vedano i sunti proposti da M. Bats (Bats 1988, p. 138), P. arcelin (arcelin-chabot 1980, pp. 177-178; arcelin 1991, pp. 214-215; arcelin 2000) e Py et al. 2001, pp. 566-567 Tra i relitti basti citare quello di Spargi (Pallarés 1986) e la Madrague de Giens (Tchernia et al. 1978, tav. XVIII).
194
coppa d’antica origine etrusca, ma prodotta soprattutto a cales nel II e I sec., è stata ampiamente analizzata.97 I due frammenti (fase 1) sono di produzione calena. Per la loro datazione, 100-90/80 a.c., s’inseriscono tra le prime importazioni di questa coppa nel Midi francese.
- Piatto accostabile alla Lamb. 55 – vicina a M. 2234c, 2233. Un orlo (Fig. 9, n. 7). Pertinente alla produzione calena (Morel 1998a, p. 18; Ri-bera 2001, 282), e non a quella punica denominata Byrsa 661 (Morel 1986, pp. 31-33), questa forma rappresenta una delle prime esportazio-ni della ceramica calena liscia.98 Un altro esemplare è noto a Marsiglia,99 stesse dimensioni (diam. 23 cm). assente, a mia conoscenza, in altri siti della Provenza e della bassa valle del Rodano, può rappresentare una conferma della precoce importazione delle produzioni B-campane nel-la città focese.
- Coppa accostabile alla Lamb. 33b – M. 2974, 2977: un orlo. Forma derivata dal repertorio della campana a, piuttosto rara.
- Coppa Sanmartí 166 : un orlo (fase 2a). Definita da Sanmartí (1978, p. 592, Tav. 99, n. 166) e datata alla fine del II. Inserita nella “calena anti-ca” (Pedroni 1986, Tav. 38, n. 171; Escriva et al. 1992, pp. 457-458; Ribera 2001, p. 283).
- Fondi: un individuo assimilabile a M. 142a (cfr. Fig. 9, n. 11).
I.6.2. Tipo B- etruscoPasta ceramica beige- rosato, dura, appena granulosa, talvolta con
minutissimi inclusi bianchi poco frequenti. Vernice nera coprente, lu-cente con riflessi bluastri.
Forme individuate:- Piatto Lamb.B 5a – M. 2252a: 1 fr. di orlo (Fig. 7, n. 2). Forma atte-
stata a Luni, per lo più inserita nella produzione volterrana D, e negli accampamenti numantini, dove viene inserita nella campana B etru-
97 Si rimanda all’ampia dissertazione sugli esemplari de La cloche (arcelin-chabot 1980, pp. 179-187) ripresa recentemente (arcelin 2000, p. 299) e di Lattes (Py et al. 2001, pp. 573-574). Sulla produzione calena, cfr. inoltre Pedroni 1986, pp. 363-364; Morel-Picon 1994, p. 37.
98 La presenza in quantità elevate a cartagine suggerisce per la questa forma una datazio-ne attorno alla metà del II secolo. Presente anche a cartagena , con datazione ante quem al 125 a.c. (Pérez Ballester 1996, pp. 343-344).
99 al remblai de la Bourse (Bertucchi-Marangou 1989, p. 63, fig. 12, n. 83), attribuito appunto alla classe Byrsa 661.
195
sca100 (cfr. infra). Non si esclude una produzione volterrana di questo pezzo.
- Olletta Lamb. B 10 – M. 3451: 1 fr. di parete con l’attacco di un’an-sa. Un altro esemplare è attestato nei più recenti sondaggi della Bourse (Gaita 1995, p. 15, Tav. 19, n. 36)
- Coppa bi-ansata Pasquinucci 127 – M. 3121(?): 1 fr. di orlo, fase 2B. Esemplari della forma 127 di produzione etrusca sono noti nella Peni-sola Iberica nel corso del II sec., ma non in Gallia (cfr. supra).
I.6.3. Produzioni dell’Etruria settentrionale
Forme individuate:- Piatto Lamb. B 5a – vicino a M. 2255c: 1 fr. di orlo (Fig. 4, n. 3), con
pasta ceramica rosso-chiaro, dura, appena porosa, con vacuoli minuti non frequenti e vernice nera bluastra, spessa, mal conservata. attribui-bile a produzioni locali di III-II secolo dell’Etruria settentrionale (come la volterrana F), attestate soprattutto lungo la fascia costiera.101
- Piatto Lamb. B 5a – M. 2255: 1 fr. di orlo, nella fase nella 3a, si data attorno al 150 a.c. Pasta ceramica nocciola-rosato, dura, compatta, ben depurata e vernice nera bluastra, spessa, opaca. ceramica volterrana di tipo D. Numerosi sono gli esemplari di questo tipo attestati a Luni, databili nel II secolo102 ed è assai probabile che a questa produzione ap-partengano alcuni degli esemplari rinvenuti nella Penisola iberica.103
- Ciotola inseribile nella serie M. 1300: 1 fr. di orlo (Fig. 4, n. 6) che richiama i piatti Lamb. 36, ma dalla maggiore profondità. Pasta ceramica nocciola-bruno, molto dura, compatta, probabilmente troppo cotta. La vernice è coprente, nera a tratti lucente, ben conservata. Evidenti segni
100 Per Luni, cfr. cavalieri Manasse 1977, p. 86, tav. 61, in particolare n. 6-7. Per gli ac-campamenti numantini, che presentano un periodo di occupazione tra 153-133 a.c., cfr. Sanmartí-Principal 1997; Sanmartí-Principal 1998, p. 202.
101 Si ringrazia Susanna Bianchini per le informazioni fornite sulle produzioni locali a pa-sta rossiccia. Su queste produzioni si vedano le considerazioni espresse per la necropoli di castiglioncello, cibecchini 1999, pp. 41-42 e Pasquinucci et al. 1998.
102 cavalieri Manasse 1977, p. 86, tav. 61, in particolare n. 8; cfr. anche Bianchini 1996, p. 182.
103 Si vedano ad es. alcuni pezzi rinvenuti tra i materiali degli accampamenti numantini, classificati come campana B etrusca (Sanmartí-Principal 1997, 41, fig. 27, n. 16; Sanmartí-Principal 1998, p. 202) e che presentano le stesse caratteristiche tecniche nonché la tipica decorazione a palmette e fiori di loto alternati.
196
di tornitura sulla parete interna. Le caratteristiche tecniche richiamano le produzioni di III secolo dell’Etruria settentrionale, dove questa forma è attestata in numerose varianti (cfr. Pasquinucci et al. 1998, Tav. I e tav. II).
- Ciotola assimilabile a M. 2538: 2 orli dello stesso vaso (cfr. Fig. 9, n. 13). Pasta ceramica rosso chiaro, più scuro in periferia, molto dura, compatta e vernice nera spessa, semilucente, ben aderente. Forme uguali sono note a Luni (cavalieri Manasse 1977, p. 99, Tav. 73, nn. 4-8) con maggiore concentrazione tra la seconda metà del II e gli inizi del I secolo e classificate tra le produzioni locali (tipo F di Volterra?). Si tratta di una ciotola ben nota per le produzioni etrusco-laziali di III se-colo (Pérez Ballester 2003, p. 34), che presentano però di norma un orlo meno allungato e taglie di minori dimensioni. a Marsiglia è noto un al-tro frammento della stessa forma (Gaida 1995, Tav. 29, n 53, produzione non determinata). Diametro 17 cm.
- Cratere: 1 fr. di orlo decorato con ovoli (Fig. 7, n. 17). Pasta ce-ramica nocciola-rosato, dura, compatta, ben depurata e vernice nero-bluastra, spessa, lucente. L’esemplare trova le maggiori similitudini con gli orli dei crateri ad anse verticali della serie M. 3561 e forme M. 3685a, 3552a, ma anche con quelli dei crateri ad anse orizzontali M. 4621, 4632 e M.4933a. Si tratta di forme di produzione volterrana, per lo più del gruppo Malacena, datate tra la fine del IV e gli inizi del III secolo (ri-spettivamente forme Pasquinucci 140-141 e 139, 40a e 135, cfr. Monta-gna Pasquinucci 1972). Da notare tuttavia che un fr. di orlo con caratte-ristiche simili al nostro è attestato a Luni nello strato H (seconda metà del II secolo), per il quale si propongono stretti confronti con esemplari attestati a Bolsena e a Sovana, sempre in contesti della seconda metà del II secolo (cavalieri Manasse 1977, p. 98, Tav. 73, n. 1). Inoltre il nostro esemplare proviene dall’US 10063, che non presenta né intrusioni né altri elementi chiaramente residuali.
197
II. TaBELLa RIaSSUNTIVaDELLE UNITÀ STRaTIGRaFIcHE aNaLIZZaTE
(I suoli sono in grassetto; le colmature principali sono sottolineate)
Fasi USS Settore 1 Settore 2 Settore 34 C USS ------------------ 10857;10864; 10863;
10862; 10812; 10804; 10801; 10802; 10806; 10805; 10803; 10807; 10809
10852
4B USS ------------------ ------------------ 10830; 107194 A USS 10510; 10607;10612;
10758; 10573 (=10712)
10729; 10548;10712 (=10573)
3 C USS 10328; 10381;10250; 10744 10437; 10450; 10443; 10447; 10439; 10452;
------------------
3 B USS 10741; 10765; 10763; 10354; 10409; 10391; 10390; 10007; 10430;
------------------
3 A USS 10509; 10205; 10658; 10656; 10703; 10639; 10616; 10263;10129;
10310; 10262; 10079------------------
2 B USS 10653; 10384; 10215; 10036; 10201; 10182; 10650; 10697; 10686; 10684; 10672; 10678; 10674;
10169 = 10193; 10286; 10211
10709; 10545
2 A USS 10017; 10204; 10195; 10015;10138=10094=10055=10063; 10116; 10627=10623; 10121; 10670; 10126; 10624; 10014;10112; 10124;
10079; 10026; 10019; 10291; 10142; 10191; 10024;
10339; 10525
1 USS 10777; 10084; 10002; 10003; 10035; 10098; 10089; 10080; 10037; 10049; 10085; 10064; 10066; 10119; 10051; 10001
10177; 10118; 10151; 10006;
10475; 10345; 10341; 10368; 10367; 10351; 10699=10244; 10244=10699; 10206
198
Fig. 1. Marsiglia, Vieux-Port: l’area dei cantieri di scavo è evidenziata dal cerchio. (Riela-borata da Hermary et al. 1999, p. 17).
Fig. 2. I cantieri di Place Jules Verne (I) e Villeneuve-Bargemon/Musée césar (II); l’area degli ateliers monetali (b) è evidenziata dall’ellisse. (Rielaborata da Hesnard et al. 1999).
199
Fig. 3. Produzioni attestate. Fase 4c. ceramica a vernice nera: italiche varie, n. 1, 3; petites estampilles, n. 6-9; attica, n. 2, 4, 5. anfora punica, n. 10; pelvis etrusca, n. 11. Fase 4B. ce-ramica a vernice nera: attica, n. 12. Fase 4a. ceramica a vernice nera: petites estampilles, n. 13-15; attica, n. 16; italiche varie, n. 17; campana a, n. 18-22.
200
Fig. 4. Produzioni attestate. Fase 4a. ceramica a vernice nera: italiche varie, n.1-2, 4-5; Etruria settentrionale, n. 3, 6; ateliers occidentali, n. 7-8. Fase 3c. ceramica a vernice nera: petites estampilles, n. 9; campana a, n. 10-11, 14; ateliers occidentali, n. 12 ; attica, n. 13. Fase 3B. ceramica a vernice nera: campana a, n. 15-21.
201
Fig. 5. Produzioni attestate. Fase 3B. anfore puniche, n. 1-2. Fase 3a. ceramica a vernice nera: italiche varie, n. 3-5; campana a, n. 6-22. anfore: greco-italiche, n. 23-26, tripolitana antica, n. 27.
202
Fig. 6. Produzioni attestate. Fase 2B. ceramica a vernice nera: petites estampilles, n. 1; itali-che varie, n. 2-3; campana a, n. 4-18. anfore: greco-italiche, n. 19-21, punica, n. 22.
203
Fig. 7. Produzioni attestate. Fase 2a. ceramica a vernice nera: campana a, n. 1, 2-15; tipo B etrusco, n. 2; italiche varie, n. 16; Etruria settentrionale, n. 17. anfore: greco-italiche, n. 18, 24-25; Dressel 1, n. 19-23, 26, tripolitana antica, n. 27, anfora ovoide n. 28.
204
Fig. 8. Produzioni attestate. Fase 1. ceramica a vernice nera: petites estampilles, n. 1; ateliers occidentali, n. 2-3; campana a, n. 4-23.
205
Fig. 9. Produzioni attestate. Fase 1. ceramica a vernice nera: campana a, n. 1-6; tipo B campano, n. 7-11; ateliers occidentali, n. 12; Etruria settentrionale, n. 13. anfore Dressel 1, n. 14-17.
206
Riferimenti bibliografici
accarona F. et al. 1985, La fornace di Corso Umberto, in Napoli antica, Napoli, pp. 378-385.
adroher auroux a. M. 1993, Céramique attique à vernis noir, in Lattara 1993, pp. 117-130.
alfonsi H.-Gandolfo P. 1997, L’épave Sanguinaires A, cahaSubaqu 12, pp. 35-55.
arcelin P. 1978, Note sur les céramiques à vernis noir tardives en Provence occidentale, aLang 1, pp. 105-125.
arcelin P. 1991, Céramiques campanienne et dérivées régionales tardives de Glanum (Saint-Rémy-de Provence, B.-de-R). Questions culturelles et chronologiques, DocaMerid 14, pp. 205-238.
arcelin P. 2000, Les importations de vaisselle italique à vernis noir au Ier siècle avant J.-C. sur la façade méditerranéenne de la Gaule, in aquilué-García-Guitart 2000, pp. 293-332.
arcelin P.-chabot L. 1980, Les céramiques à vernis noir du village préromain de la Cloche, MEFRa 92, pp. 109-195.
aquilué X.-García J.-Guitart J. (a cura di) 2000, La ceràmica de vernís negre dels s. II i I a.C: centres productors mediterranis i comercialització a la Península Ibèrica, Matarò.
Barberà J. 1975, El cargamento de ceramica barnizada de negro del pecio de Isla Pedrosa (L’Estartit, Gerona), Imersión y ciencia 8-9, pp. 79-85.
Bargagliotti S.-cibecchini F.-Gambogi P. 1997, Prospezioni subacquee sulle Secche della Meloria (LI): alcuni risultati preliminari, in Atti del Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea, Bari, pp. 43-53.
Bats M. 1982, Commerce et politiques massaliètes aux IVe et IIIe siècles av. J.C. Essai d’inter-pretation de faciès céramique d’Olbia de Provence (Hyères; Var), PP 204-207, pp. 256-267.
Bats M. 1988, Vaiselle et alimentation à Olbia de Provence (v. 350-v. 5 av. J.-C.): modèles culturels et catégories céramiques, RaNarb 18, suppl., Paris.
Bats M. 1990, La diffusion des amphores massaliètes en Provence oriental, in M. Bats (a cura di), Les amphores de Marseille grecque. Chronologie et diffusion. Actes de la Table Ronde de Lattes, (Lattes 1989), Études Massaliètes 2, Lattes/aix-en-Provence, pp. 207-213.
Bechtold B. 1999, La necropoli di Lilybaeum, Trapani.
Bémont c.-Lahanier c. 1985, Lampes tardo-répubblicaines à Glanum: essai de détermi-
207
nation typologique et physico-chimique, RaNarb18, pp. 221-261.
Benoit F. 1961, L’épave du Grand Congloué à Marseille, Gallia 14, suppl., Paris.
Bertucchi G. 1992, Les amphores et le vin de Marseille VIe s. avant J.-C.-IIe s. après J.-C., RaNarb 25, suppl, Paris.
Bertucchi G.-Marangou a. 1989, Le remblai hellénistique de la Bourse a Marseille. Résul-tats d’un sondage, RaNarb 22, pp. 47-87.
Bianchini S. 1996, La ceramica a vernice nera di Lucca, RSTLig 72, pp. 169-210.
Bianchini S.-cibecchini F.-Pasquinucci M. 2000, Aspetti e problemi della ceramica a ver-nice nera del II-I sec. a.C. in Etruria nord-occidentale, in aquilué-García-Guitart 2000, pp. 7-17.
Biella M.c. 2004, Falerii Veteres: alcune novità tra archeologia e archivistica, acl 4, pp. 325-362.
cavalier M. 1985, Il relitto della Secca di Capistello, in Archeologia Subacquea 2, Bda 29, suppl., pp. 53-61.
cavalieri Manasse G. 1977, Ceramica a vernice nera, in Scavi di Luni II, Roma, pp. 78-113.
cayot a. 1984, La céramiques campanienne de Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts,B.-du-Rh.), DocaMerid 7, pp. 53-78.
cibecchini F. 1999, Economia e società, in P. Gambogi-S. Palladino (a cura di), Casti-glioncello. La necropoli ritrovata. Cento anni di scoperte e scavi (1896-1997), Rosignano Solvay, pp. 38-52.
cibecchini F. 2002, Il relitto della Torre della Meloria (Li), in Archeologia Subacquea. Stu-di, ricerche e documenti III, Università della Tuscia, pp. 209-226.
cibecchini F. 2004, Convergenze e differenze nella diffusione dei materiali ceramici tra siti terrestri e relitti; alcuni problemi d’interpretazione dei dati provenienti da relitti e dei flussi di distribuzione in età repubblicana, in atti del III seminario aNSER, “Méditerranée occidentale antique: les échanges”, Marseille 14-15 maggio 2004, cosenza, pp. 57-74.
cibecchini F. c.s., Tonnellaggi e rotte in età repubblicana: il contributo dei relitti del Mediter-raneo occidentale, in Comercio, redistribución y fondeaderos. La navegación a vela en el Medi-terráneo, V Jornadas de arqueología subacuática, (Gandia, 8-10 Novembre 2006).
cibecchini F.-Principal J. 2004, Per chi suona la campana B?, in E. De Sena-H. Dessales (a cura di), Archaeological Methods and Approaches: Ancient Industry and Commerce in Italy (Rome April 18-20, 2002), BaR Series 1262, oxford, pp. 159-172.
Dedet B. 1978, La céramique à vernis noir dans les Garrigues du Languedoc oriental, aLang 1, pp. 75-96.
208
Empereur J.Y.-Hesnard a. 1987, Les amphores hellénistiques, in P. Lévêque-J. P. Morel (a cura di), Céramiques hellénistiques et romaines, II, Paris, 1987, pp. 9-71.
Escrivá V.-Marín c.-Ribera a. 1992, Unas producciones minoritarias de barniz negro en Valentia durante el s. II a. JC., in Estudios de arqueologia ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, Valentia, pp. 443-468.
De Lucia Brolli M.a. 2006, Dalla tutela alla ricerca: recenti rinvenimenti dall’area urbana di Falerii, in M. Pandolfini angeletti (a cura di), Archeologia in Etruria meridionale. Atti delle giornate di Studio in onore di Mario Moretti (civita castellana, 14-15 novem-bre 2003), Roma, pp. 65-89.
Di Giuseppe H. 2003, La ceramica a vernice nera, in H. Patterson et al., Le produzioni ceramiche nella media Valle del Tevere tra l’età repubblicana e tardoantica, Reicretacta 38, pp. 161-170.
Di Giuseppe H. 2005, Un confronto tra l’Etruria settentrionale e meridionale dal punto di vista della ceramica a vernice nera, BSR 53, pp. 31-84.
Di Giuseppe H. 2007, La ceramica a vernice nera nella media Valle del Tevere, in F. coa-relli-H. Patterson (a cura di), Mercator Placidissimus: the Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley. (Proceedings of the conference held at the British School at Rome, 27-28 Feb. 2004), Roma, pp. 819-833.
Di Giuseppe H. c.s., La ceramica a vernice nera, in H. Patterson-R. cascino-H. Di Giu-seppe (a cura di), Veii. The Historical Topography of the Ancient City. A re-study of John Ward Perkins’ Survey, The archaeological Monograph of the British School at Rome.
Ferrandes a. F. 2006, Produzioni stampigliate e figurate in area etrusco-laziale tra fine IV e III secolo a.C. Nuove riflessioni alla luce di vecchi contesti, acl 57, pp. 115-174.
Finkielsztejn G. 2001, Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens, de 270 à 108 av. J.-C. environ, BaR International Series 990, oxford.
Firmati M. 1992, Il relitto della nave romana di Punta Scaletta, a Giannutri (GR), ann-Siena 13, pp. 13-33.
Foy D.-Nenna M. D. 2001, Tout feu, tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France, aix-en-Provence.
Gaita c. 1994, Etude d’un lot de matériel céramique hellénistique provenant du sondage B505/B509 de La Bourse à Marseille (fouilles de 1993), Mémoire de Maîtrise, archéolo-gie, aix-en-Provence, Université de Provence.
Gaita c. 1995, Le Remblai hellénistique de La Bourse à Marseille: étude du sondage D 614/1, DEa, archéologie, aix-en-Provence, Université de Provence.
Gantes L.F. 1978, Note sur les céramiques a vernois noir trouvées sur l’oppidum de la Teste-Négre aux Pennes (Bouches du Rhone), aLang 1, pp. 97-103.
Gantes L.F. 1992, L’apport des fouilles récentes à l’étude quantitative de l’économie mas-saliète, in Actes du Colloque international d’Histoire et d’Archéologie et du Ve Congrès ar-
209
chéologique de Gaule méridionale (Marseille 1990), Études Massaliètes 3, Lattes/aix-en-Provence, pp. 171-178.
Grau i Segú M. 1997, Evolució de la vaixella de vernís negre a l’arc nord-occidental de la Mediterrània (s. II-I aC.): aproximació a partir dels materials de Marsella, l’Illa d’en Reixac i Iesso, Tesi di Laurea, Barcellona, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Hesnard a. et al. 1999, Le Port, in a. Hesnard-M. Moliner-F. conche-M. Bouiron (a cura di), Marseille: 10 ans d’archéologie, 2600 ans d’histoire, Marseille, pp. 16-76.
Hermary a. et al. 1999, a. Hermary-a. Hesnard-H. Tréziny (a cura di), Marseille grecque. La cité phocéenne (600-49 av.J.-C.), Paris.
Indagini archeometriche 1998, P. Frontini-M.T. Grassi (a cura di), Indagini archeometri-che relative alla ceramica a vernice nera: nuovi dati sulla provenienza e la diffusione. atti del Seminario Internazionale di Studio, Milano 22–23 novembre1996, como.
Lamboglia N. 1952, Per una classificazione preliminare della ceramica campana, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, pp. 139-206.
Lamboglia N. 1964, La campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta all’Isola di Giannutri, RSL 30, pp. 229-257.
Lancel S. 1987, La céramique punique d’époque hellénistique, in P. Lévêque-J. P. Morel. (a cura di), Céramiques hellénistiques et romaines, II, Paris, pp. 99-137.
Lattara 1993, M. Py (a cura di) Lattara 6. Dicocer. Dictionnaire des céramiques antiques en Méditerranée nord-occidentale, Lattes.
Lequement R.-Liou B. 1976, Céramique étrusco-campanienne et céramique arétine, à propos d’une nouvelle épave de Marseille, in L’Italie préromaine et la Rome républicaine, Mélanges offerts à Jacques Heurgon, II, Roma, pp. 587-603.
Les fàcies ceràmiques d’importació 1998, Les fàcies ceràmiques d’importació a la costa ibèri-ca, les Balears i les Pitiüses durant el segle III aC i la primera meitat del segle II aC, arqueo Mediterrània 4, Barcelona.
Long L., 2004, Les épaves protohistoriques de la côte gauloise et de la Corse (VIe-IIIe siècle avant J.-C.), in La circulació d’àmfores al Mediterrani occidental durant la Protohistòria (segles VIII-IIIaC): aspectes quantitatius i anàlisi de continguts, arqueo Mediterrània 8, 127-164.
Long L.-Volpe G. 1997, Un decennio di ricerche nelle acque delle isole di Hyères (Francia), in Atti del Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea, Bari, pp. 91-108.
Mañá J. 1951, Sobre la tipologia de las ánfora púnica, in Chronica del VI Congreso Ar-queológico del Sudeste Español, VI (Alcoy 1950), cartagena, pp. 203-210.
Melucco Vaccaro a. 1970, Le ceramiche a vernice nera e ceramiche ellenistiche varie, in Pyrgi, scavi nel santuario etrusco (1959-1967), NSc, suppl. 2, pp. 468-504.
210
Molina J. 1997, La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior, (siglos II a.C.-II d.C.), alicante.
Montagna Pasquinucci M. 1972, La ceramica a vernice nera del museo Guarnacci di Volterra, MEFRa 84, pp. 269-498.
Morel J. P. 1969, Etudes de céramique campanienne I: l’atelier des petites estampilles, ME-FRa 81, pp. 59-116.
Morel J. P. 1978, A propos des céramiques campaniennes de France et d’Espagne, aLang 1, pp. 149-168.
Morel J. P. 1980, La céramiques campanienne: acquis et problèmes, in Céramiques hellénis-tiques et Romaines, annales Littéraires dell’Université de Besançon 242, pp. 85-122.
Morel J. P. 1981a, La produzione della ceramica campana: aspetti economici e sociali, in a. Giardina-a. Schiavone (a cura di), Società romana e produzione schiavistica II, Roma-Bari, pp. 81-97.
Morel J. P. 1981b, Céramique Campanienne, les formes, Roma.
Morel J. P. 1985, La ceramica e le altre merci d’accompagno nel commercio da e per Roma in età repubblicana, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio, materiali da Roma e dal suburbio, Roma, pp. 172-179.
Morel J. P. 1986, La céramique à vernis noir de Carthage, sa diffusion, son influence, cEa 18, pp. 25-68.
Morel J. P. 1990, Aperçu sur la chronologie des céramiques à vernis noir aux II et I siécles avant J.-C., in Gaule interne et Gaule méditerranéenne aux IIe et Ier siecles avant J.-C., RaNarb 21, suppl, pp. 54-71.
Morel J. P. 1998a, L’étude des céramiques à vernis noir, entre archéologie et archéométrie, in Indagini archeometriche 1998, pp. 9-22.
Morel J. P. 1998b, Les importations de céramiques du IIIe siècle et de la première moitié du IIe siècle: quelques remarques à propos de l’Ibérie, in Les fàcies ceràmiques d’importació 1998, pp. 243-249.
Morel J. P.-Picon M. 1994, Les céramiques étrusco-campaniennes: recherches en laboratoire, in G. olcese (a cura di), Ceramica Romana e archeometria: lo stato degli studi, Roma, pp. 23-46.
olcese G.-Picon M.-Thierrin Michael G. 1996, Il quartiere ceramico sotto la chiesa di Santa Restituta a Lacco Ameno d’Ischia e la produzione di anfore e di ceramica in età elle-nistica, Bda 39-40, pp. 7-30.
olcese G. 1998, Ceramiche a vernice nera di Roma e area romana: i risultati delle analisi di laboratorio, in Indagini archeometriche 1998, pp. 141-152.
Pallarés F. 1986, La nave romana di Spargi. Campagne di scavo 1958-1980, Bda 37-38, suppl., pp. 89-102.
211
Pasqui a. 1903, Civita Castellana. Nuove scoperte di antichità dentro l’abitato, NSc, pp. 453-459.
Pasquinucci M. et al. 1998, Ceramica a vernice nera dall’Etruria settentrionale costiera. Primo contributo alla caratterizzazione delle produzioni locali e delle importazioni in Inda-gini archeometriche 1998, pp. 101-118.
Pavolini c. 1981, Le lucerne nell’Italia romana, in a. Giardina-a. Schiavone (a cura di), Società romana e produzione schiavistica, II, Bari, pp. 39-184.
Pavolini c. 1990, Les lampes romaines en Gaule aux IIe et Ier s. av. J.-C., in Gaule interne et Gaule méditerranéenne aux IIe et Ier s. av. J.-C., RaNarb 21, suppl., Paris, pp. 99-112.
Pedroni L. 1986, La ceramica a vernice nera da Cales, 1, Napoli.
Pedroni L. 1990, La ceramica a vernice nera da Cales, 2, Napoli.
Pedroni L. 2001, Ceramica calena a vernice nera,. Produzione e diffusione, Napoli.
Pérez Ballester J. 1987, El taller de las Pequeñas Estampillas: revisión y precisiones a la luz de las cerámicas de barniz negro de Gabii (Latium). Los últimos hallazgos en el Levante y sureste español, archEspa 60, pp. 43-72.
Pérez Ballester J. 1994, La cuestión de las importaciones itálicas al sur del Ebro anteriores a las Guerras Púnicas. A propósito de un vaso de Gnathia procedente de Ibiza, Saguntum, 27, pp. 189-196.
Pérez Ballester J. 1996, La actividad comercial y el registro arqueologico en la Carthago Nova repubblicana. Los hallazgos del area del anfiteatro, Verdolay 7, pp. 339-349.
Pérez Ballester J. 2003, La céramica de barniz negro del santuario de Junio en Gabii, Roma.
Principal J. 1998, Las importaciones de vajilla fina de barniz negro en la Cataluña sur y occidental durante el siglo III aC, BaR 729, oxford.
Py M. 1985, Les amphores etrusques de Gaule méridionale, in Il commercio etrusco arcaico, atti dell’incontro di studio (Roma 1983), Roma, pp. 73-94.
Py M. 1978, Apparition et développement des importations de céramique campanienne A sur l’oppidum des Castels (Nages, Gard) d’après les fouilles du dépotoir J1, aLang 1, pp. 43-70.
Py M. 1978a, L’oppidum des Castels a Nages (Gard), Gallia 35, suppl., Paris.
Py M. 1990a, La céramique de l’ Îlot 1, in Lattara 3, Lattes, pp. 71-98.
Py M. 1990b, Culture, économie et société protohistoriques dans la région nîmoise, collec-tion de l’Ecole Française de Rome 131, Roma.
Py M. 1990c, La diffusion des amphores massaliètes sur le litoral du Languedoc oriental, in M. Bats (a cura di) Les amphores de Marseille grecque. Chronologie et diffusion. Actes
212
de la Table Ronde de Lattes, (Lattes 1989), Études Massaliètes 2, Lattes/aix-en-Pro-vence, pp. 27-41.
Py M. 1993, Campanienne A, in Lattara 1993, pp. 146-150.
Py M.-adroher a.M. 1991, Principes d’enregistrement du mobilier archéologique, in Lat-tara 4, pp. 83-100.
Py et al. 2001, Py M.-adroher a.M.-Sanchez c., Lattara 14, 1-2, Lattes.
Ramon Torres J. 1995, Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental, Barcelona 1995.
Ribera a. 2001, Perspectiva de las cerámicas calenas de barniz negro en las Galias, in Pedroni 2001, pp. 279-295.
Romualdi a. 1992, La ceramica a vernice nera, in a. Romualdi (a cura di), Populonia in età ellenistica, Firenze, pp. 110-151.
Roth R. 2006, Black-gloss wares from the acropolis of Capena (La Civitucola, provincia di Roma), BSR 74, pp. 119-162.
Sanmartí Grego E. 1973, El taller de la pequeñas estampillas en la Península Ibérica, ampurias 35, pp. 136-176.
Sanmartí Grego E. 1978, La cerámica campaniense de Emporion y Rhode. Monografies Emporitanes, IV, Barcelona.
Sanmartí E.-Principal J. 1997, Las cerámicas de importación itálicas e ibéricas, procedentes de los campamentos numantinos, RaPon 7, pp. 35-75.
Sanmartí E.-Principal J. 1998, Cronologia y evolución tipologica de la Campaniense A del siglo II aC: las evidencias de los pecios y de algunos yacimentos históricamente fechados, in Les fàcies ceràmiques d’importació 1998, pp. 193-216.
Solier Y. 1980, La céramique campanienne de Ruscino, in Ruscino (Château-Roussillon, Perpignan, P.-o.-I.), RaNarb 7, suppl., pp. 117-243.
Sparkes B.a.-Talcott L. 1970, Black and plain pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B.C., The Athenian Agora, XII, Princeton.
Squarzanti S. 1994-1995, L’atelier des petites estampilles, RassaPiomb 12, pp. 343-385.
Taylor D.M. 1957, Cosa: black-glaze pottery, Memamac 25, pp. 66-193.
Tchernia a. et al. 1978, L’épave romaine de la Madrague de Giens (Var), Gallia 34, suppl. Paris.
Tchernia a. 1986, Le vin de l’Italie romaine. Essai d’histoire économique d’après les am-phores, BEFaR 261, Paris.