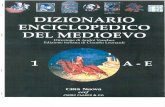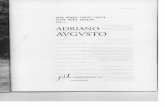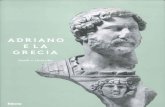Inquisitori ed inquisiti: a proposito del Dizionario storico dell’Inquisizione curato da Adriano...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Inquisitori ed inquisiti: a proposito del Dizionario storico dell’Inquisizione curato da Adriano...
1
Inquisitori ed inquisiti: a proposito del Dizionario storico dell’Inquisizione curato da Adriano Prosperi. Con una nota sugli inquisiti nella Diocesi di Feltre e nel Tesino,1 di Luciano Osbat La proposta di un incontro nella sede del Centro studi alpino dell‟Università della Tuscia nel corso del mese di agosto sta diventando una consuetudine – per me è ormai la quarta volta – e risponde ad una doppia finalità:
- far constatare come diversi ambiti, settori di studio di questa Università si stiano interessando e stiano indagando la realtà e i problemi del Tesino (non solo quindi i Dipartimenti che si occupano di scienze forestali ed agrarie);
- presentare alcuni risultati di ricerche in qualche modo che si legano alla importante documentazione bibliografica, archivistica, materiale presente in questa Valle e alla sua storia in particolare dell‟età moderna e contemporanea.
Mi riferisco alle attività che si muovono intorno all‟Ecomuseo del viaggio, al Museo Casa Alcide De Gasperi, al Museo per Via (Museo tesino delle stampe e dell‟ambulantato) e alla documentazione conservata negli archivi ecclesiastici e civili della Valle o che si riferiscono alla Valle e sono conservati altrove. L‟incontro di questa sera, all‟apparenza, è quanto di più distante si possa immaginare dai temi che questi istituti-musei sviluppano al loro interno e studiano. Parliamo infatti di inquisiti e di inquisitori. E l‟occasione è data dalla pubblicazione (avvenuta alcuni anni fa) dei quattro poderosi volumi del Dizionario storico dell’Inquisizione diretto da Adriano Prosperi e pubblicato dalla Scuola Normale di Pisa.2 Come dice lo stesso Prosperi nella Presentazione, nei quattro volumi vi è stata la raccolta di “informazioni su donne, uomini, istituzioni, luoghi, tempi, idee e tecniche che regolarono lo svolgimento delle indagini e dei processi” dell‟Inquisizione nel corso dei secoli. Sono presentate oltre 1300 voci che comprendono dai personaggi più famosi processati dall‟Inquisizione, alle istituzioni che le davano vita, dai papi e cardinali che la promossero e la sostennero fino agli inquisitori e ai componenti i tribunali che la disciplinavano, dalle modalità del procedere di quei giudici alle idee e alle norme che regolavano il loro comportamento, dalle eresie e dalle colpe che erano perseguite ai nomi delle persone e ai luoghi dove si sono svolti i processi. E tutto questo grazie alle ricerche e al lavoro di oltre 300 studiosi di tutto il mondo che hanno offerto il loro tempo e le loro conoscenze per costruire un “dizionario storico [che] non è la sistemazione ne varietur dello scibile ma è l‟occasione per guardare al cammino percorso e trarne orientamenti e informazioni per procedere più speditamente e raggiungere livelli di conoscenza più ricchi e completi”, come aggiunge ancora Prosperi.3 Nel corso di questo Incontro emergeranno i collegamenti tra questo Dizionario e la storia già nota e quella ancora da studiare di questa Valle e così quell‟Inquisizione che è al centro di quei volumi diventerà un invito ad approfondire ancora di più quello che già conosciamo della storia del Tesino e dei Tesini nei secoli passati. Torniamo ora agli inquisiti, agli inquisitori, all‟Inquisizione. Come si spiega il rinnovato interesse per la storia dell‟Inquisizione? E da quando la possiamo datare?
1 Testo per la conferenza tenuta il 5 agosto 2015 a Pieve Tesino (Trento) presso il Centro studi alpino dell‟Università della Tuscia. 2 Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da Adriano Prosperi, con la collaborazione di Vincenzo Lavenia e John Tedeschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, 4 voll.+ 1 inserto iconografico 3 Ivi, p. VII.
2
Il ruolo dell’Inquisizione: un problema storiografico e religioso aperto Gli studiosi della materia sanno che negli anni tra il 1970 e il 1980 importanti documenti erano stati individuati negli archivi delle diocesi di Napoli, Udine e Siena che affiancavano quelli già noti presenti negli Archivi di Stato di Modena e di Venezia dove erano giunti dopo le vicende delle soppressioni di enti ecclesiastici seguite all‟Unità.4 Nel 1998 l‟apertura degli archivi del Sant‟Ufficio – nel frattempo divenuto Congregazione per la dottrina della fede – ha dato l‟avvio ad una nuova stagione di studi che è tutt‟ora in corso e che ha fatto registrare già importanti risultati e coinvolgenti iniziative di censimento di documentazione inquisitoriale ancora non indagata e presente in Italia soprattutto negli archivi ecclesiastici.5 Non c‟è solo la curiosità del grande pubblico che sorregge le ricerche degli specialisti: ci sono anche una serie di questioni cruciali che riguardano la storia della Chiesa e della società civile in Italia e che interessano più direttamente i professionisti della ricerca storica. E in particolare: - il funzionamento dell‟istituzione ecclesiastica nel suo complesso e il suo ruolo nell‟amministrazione della giustizia; - i caratteri che ha avuto la Controriforma nel nostro paese e i ritardi che la nostra cultura ha fatto registrare in genere nei confronti delle coeve culture europee; - gli aspetti che hanno segnato la religiosità nel corso dell‟età moderna e della prima età contemporanea quando si possono collegare alle forme di controllo capillare esercitate dalla Curia romana (anche attraverso i tribunali dell‟Inquisizione) e dalle Chiese locali attraverso gli organi delegati al trattamento della giurisdizione ecclesiastica. Nella crescita di attenzione per l‟Inquisizione una parte molto importante l‟ha avuta anche la Chiesa a partire dai documenti approvati nel Concilio Vaticano II, poi dai mutamenti introdotti da Paolo VI (il cambiamento del nome e della ragion d‟essere della Congregazione del Sant‟Ufficio ora divenuta Congregazione per la dottrina della fede), da ultimo le riflessioni di Giovanni Paolo II sugli errori e manchevolezze della Chiesa nell‟ultimo millennio, infine la decisione di Joseph Ratzinger di aprire gli archivi dell‟ex Sant‟Ufficio nel 1998.6 Fin dall‟età più antica della storia della Chiesa, sono stati i vescovi ad avere la competenza ordinaria in materia di fede; nel corso del medioevo i vescovi sono stati affiancati dagli inquisitori nominati da Roma che talvolta si sono sostituiti agli stessi vescovi (mentre in Spagna e in Portogallo i vescovi erano quasi completamente esautorati dall‟azione della “Suprema y general Inquisiciòn” come si era definita e dell‟analogo organismo che operava in Portogallo. Dopo la creazione della Congregazione del Sant‟Ufficio, alla metà del XVI secolo, anche in Italia si assiste ad una più decisa azione di stimolo e di controllo della Congregazione romana sull‟attività di molti tribunali locali quando operavano in materia di fede. Ma non c‟è una regola generale sempre valida: la Congregazione era più incisiva con le piccole diocesi, soprattutto dell‟Italia centrale; aveva molte difficoltà ad operare nel territorio del Regno di Napoli e anche nelle Diocesi dell‟Italia del nord (Repubblica di Venezia, Ducato di Milano, Stato sabaudo, Repubblica di Genova) e per conseguenza spesso l‟autorità dei vescovi riusciva a gestire in proprio anche questo vitale settore della giustizia ecclesiastica. Oggi siamo in presenza di una quantità considerevole di documentazione relativa ai processi in materia di fede, in parte già individuata in parte ancora da scoprire. Il fondo più importante è certamente quello che è stato reso disponibile agli studiosi a partire dal 1998 ed è l‟Archivio del Sant‟Ufficio nella sede dell‟attuale Congregazione per la dottrina della fede. Ma sono importanti anche i documenti presenti negli archivi diocesani e in alcuni Archivi di Stato per le ragioni sopra ricordate.
4 Sulle fonti per la storia dell‟Inquisizione romana prima dell‟apertura dell‟Archivio del Sant‟Ufficio rimane fondamentale L’Inquisizione romana in Italia nell’età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991. 5 “Cambiamenti istituzionali e rinnovamento storiografico” in Andrea Del Col, L’Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo, Milano, Oscar Mondadori, 2006, pp. 8-10. 6 Dizionario storico, op. cit., p. V.
3
E‟ una documentazione che, una volta individuata, deve essere inventariata analiticamente secondo una griglia di lettura dei dati che consenta di collocare i processi dell‟Inquisizione (come anche tutti quelli che riguardano in genere il ripristino di una regola che è stata infranta) in una più corretta e completa prospettiva. Per qualsiasi organo di amministrazione della giustizia – sia laica che ecclesiastica, sia in materia civile che criminale che in cause di fede – vale la regola che il tribunale che giudica e che ha come prima finalità quella del ripristino dell‟osservanza della norma che il trasgressore ha infranto, non solo agisce nell‟interesse superiore (Dio, il sovrano, il feudatario, il vescovo, lo statuto, la legge) ma è anche come espressione di quell‟insieme di interessi, culture, obiettivi che caratterizzano il gruppo sociale dominante in un determinato periodo storico. Ogni processo, in questa ottica, è espressione di questo ampio intreccio costituito da interessi di parte, culturali, economici, religiosi, sociali. E i processi in materia di fede sono parte di questo universo ampio e complesso all‟interno del quale non si possono solo studiare gli accusati e le ragioni delle accuse ma è necessario anche rilevare i denuncianti, i testimoni, la composizione del tribunale, le procedure seguite, le influenze esterne al procedere del tribunale, le conclusioni delle cause e le loro conseguenze. C‟è un sistema di controllo sociale, culturale, religioso che è stato messo in atto in ogni epoca (con analogie e differenze da momento storico all‟altro) del quale indubbiamente i tribunali che giudicavano in materia di fede hanno fatto parte. Ed è in questo contesto che i processi vanno studiati perché altrimenti si rischia di appiattire l‟indagine solo sugli inquisitori e sugli inquisiti, finendo per fare della storia dell‟Inquisizione una storia ideologica dove si tende a dimostrare che la Chiesa era lo strumento della repressione, era la negazione della libertà e tutti gli inquisiti erano invece campioni del progresso delle idee. E‟ questa la logica corrente quando si polemizza intorno ai processi a Giordano Bruno, a Campanella, a Galilei. I tribunali competenti in materia di fede. E‟ importante studiare i processi conservati negli archivi diocesani per rimettere l‟indagine sull‟Inquisizione in Italia nei binari più corretti di una ricerca storica senza pregiudizi ideologici. Questo perché una parte molto rilevante di tutta l‟amministrazione della giustizia, nel corso del medioevo e della prima età moderna, era di competenza dei vescovi, compreso tutto ciò che aveva a che fare con la preservazione della fede e con la morale. Erano i tribunali vescovili, normalmente affidati ad uno dei Vicari generali del vescovo, che amministravano gran parte della giustizia che riguardava gli ecclesiastici ed anche molti laici: dalle cause per danni dati a quelle civili, da quelle criminali a quelle in materia di fede. E spesso, a conferma di questa competenza estesa, le carte giudiziarie sono comprese in un unico fondo con al più la distinzione tra “Atti civili” e “Atti criminali” o addirittura i giudizi sono confusi all‟interno di serie come gli “Acta varia” o le “Visite pastorali” che si riferiscono alle competenze più diverse che i vescovi e la curie diocesane gestivano ordinariamente. A partire dal XIII secolo accanto ai vescovi compaiono gli inquisitori che sono nominati direttamente da Roma, prima dallo stesso pontefice poi, dal XVI secolo, quando si costituisce il Sant‟Ufficio, dalla stessa Congregazione. Negli anni del Concilio di Trento, in particolare tra il 1542 e il 1588, i pontefici intervennero più volte per dare nuova organizzazione agli interventi dei tribunali dell‟Inquisizione. Paolo III (1534-1549) con la costituzione Licet ab initio istituì una commissione di sei cardinali con compiti di sovraintendere a tutte le questioni in materia di fede. Con Giulio III (1550-1555) e Pio IV (1559-1565) la commissione divenne un vero e proprio dicastero denominato da Sisto V (1585-1590) “Congregazione della Santa Inquisizione” mentre in seguito prevalsero i nomi di “Congregazione della Romana ed Universale Inquisizione” e di “Congregazione del Sant‟Offizio o del Sant‟Ufficio”: quest‟ultimo nome rimase in vigore sino alla riforma promossa nel 1965 da Paolo VI quando la nuova denominazione di
4
“Congregazione per la dottrina della fede” venne a precisare le nuove competenze riservate a quell‟ufficio.7 La Congregazione ebbe a lungo una duplice funzione: di stimolo e di coordinamento degli interventi nelle questioni di fede; di tribunale di prima istanza per i giudizi nella stessa materia. Dapprima furono immediatamente soggetti solamente i tribunali dei ministri delegati, cioè di quegli inquisitori che erano nominati dalla stessa Congregazione ma in seguito anche molti dei tribunali vescovili rientrarono sotto il suo controllo. Copia delle abiure e delle condanne che venivano emesse da ogni collegio giudicante, a livello diocesano o dai ministri delegati dovevano essere inviate a Roma e talvolta gli atti completi di un processo venivano richiesti per una più attenta valutazione della causa; in alcuni casi - ma tale comportamento rimase eccezione e non divenne regola - vi fu avocazione della causa e trasferimento dell‟accusato a Roma. E‟ in questo periodo di ristrutturazione dell‟Inquisizione che le competenze dei giudici furono conferite sulla base di quella interpretazione amplissima del concetto di eresia e di sospetto d‟eresia già avvenuta nei secoli precedenti e che portò all‟affidamento a quei tribunali della punizione non solo dei delitti di eresia e di sospetto d‟eresia ma anche dei delitti riguardanti l‟abuso dei sacramenti, dei precetti riguardanti la santificazione delle feste, i digiuni e l‟astinenza, l‟inosservanza dei voti per i chierici, la magia, i sortilegi, il concubinato, le bestemmie ereticali, l‟ebraismo. Nei primi anni del sec. XVI e più ancora negli anni successivi al Concilio di Trento tutta la materia trovò sistemazione in una serie di opere a stampa: erano manuali di procedura o “formulari” o “direttorii” o “prassi” come si intitolavano che fecero da guida ad ogni passo dei giudici che dovevano operare sia in materia di fede che in ogni altro settore della competenza ecclesiastica. E‟ probabilmente questa la ragione che spiega la mancanza di riferimenti alla lotta agli eretici nello stesso Concilio di Trento: tutta la materia era stata già ampiamente regolata. La competenza dei vescovi a conoscere in materia d‟eresia non fu mai seriamente contestata da questi manuali, nemmeno nel XIII secolo quando maggiore era stata la diffusione dei tribunali affidati ai ministri delegati. Ma chi erano questi inquisitori? Nei tribunali che dipesero dalla Congregazione del Sant‟Ufficio in Italia furono quasi sempre domenicani o francescani conventuali. Le regole dicevano che dovevano essere di età matura (40 anni, poi scesi a 30), con una preparazione canonistica conseguita nelle migliori università, con un curriculum che li aveva visti prima operare all‟interno di un tribunale inquisitoriale come consultori o procuratori fiscali; e l‟incarico di inquisitore preludeva spesso ad una importante carriera ecclesiastica (da un tribunale ad un altro più importante, oppure divenivano vescovi, in alcuni casi cardinali). Tra XVI e XVII secolo vi furono più di dieci pontefici che erano stati anche inquisitori agli inizi della loro carriera come Paolo IV (Carafa), Pio V (Ghisleri), Sisto V (Peretti), PaoloV (Borghese), Innocenzo X (Panfili), Alessandro VII (Chigi), Clemente X (Altieri), Alessandro VIII (Ottoboni), Innocenzo XII (Pignatelli).8 E chi erano gli inquisiti? I tribunali che giudicavano i materia di fede intervenivano in un numero molto ampio di casi e la loro competenza, inizialmente legata ai delitti d‟eresia e di sospetto d‟eresia, divenne ancora più estesa dopo gli interventi pontifici che nel XVII e XVIII ampliarono considerevolmente le competenze dei tribunali dipendenti direttamente da Roma a discapito di quelli vescovili. Nelle pagine dei trattati più diffusi nell‟epoca che stiamo considerando, come il Sacro arsenale ovvero pratica dell’officio della S. Inquisizione 9 di Eliseo Masini o nel Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis10 di Cesare Carena, l‟esposizione delle cause nelle quali si procede in materia di fede è particolarmente minuziosa. Ecco cosa dice il trattato del Masini:
7 Voci “Congregazione del Sant‟Ufficio” e “Congregazione per la Dottrina della Fede” in Dizionario storico, op. cit., pp. 389-394. 8 Voce “Inquisitore”, in Dizionario storico, op. cit., pp. 800-802 e “Inquisizione romana”, Ivi, pp. 815-827. 9 Eliseo Masini, Sacro arsenale ovvero pratica dell’officio della s. Inquisizione, Genova 1621. 10 Cesare Carena, Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis, Cremonae 1655.
5
“Contro a quai persone proceda il Santo Officio. Sicome cinque generalmente sono i casi, e i delitti appartenenti a questo Santo Tribunale, cioè Primo, l‟Herezia formale, la sospitione d‟essa. Secondo la Fautoria de gli Heretici, e sospetti d‟heresia. Terzo, la Negromantia, Maleficij, Stregarie, e Incanti. Quarto, la Bestemmia hereticale. Quinto, l‟Offesa, e la resistenza al Santo Officio. Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio. Prima, contro gli Heretici, o sospetti d‟heresia. Seconda, contro i Fautori loro. Terza, contro i Maghi, Melefici, e Incantatori. Quarta, contro i Bestemmiatori. Quinta, contro quelli, che s‟oppongono ad esso Santo Officio, e suoi Officiali.” Questi trattati riflettono una situazione già mutata rispetto al secolo XVI quando gli interventi dei tribunali del Sant‟Ufficio e dei vescovi sembrano essere volti soprattutto contro gli eretici e i sospetti d‟eresia. L‟estensione della competenza dell‟Inquisizione romana alla stregoneria e alle pratiche magiche, alle bestemmie ereticali, alla sollecitazione in confessione era già avvenuta con Paolo IV e Pio V alla metà del XVI secolo. Poi Paolo V con la costituzione Universi dominici gregis del 30 agosto 1622 inasprì le pene contro i sollecitatori in confessione.11 Gregorio XV con la bolla Omnipotentis Dei del 20 marzo 1623 inasprì le pene per i delitti di stregoneria12 quando si mirava a procurare la morte di qualcuno L‟Inquisizione infine divenne competente anche nei delitti di bigamia perché interpretata come delitto contro la fede. La bolla di Urbano VIII del 1627 Magnum in Christo formalizzò la competenze dell‟Inquisizione su questo reato.13 Urbano VIII con la costituzione Inscrutabilis iudiciorum del 1 aprile 1631 estese la condanna a morte anche ai condannati per divinazione e stregoneria colta.14 Questi delitti in materia di fede che erano già compresi nelle competenze dei vescovi ora divengono materia d‟intervento anche dei tribunali dipendenti da Roma con conseguenti frizioni tra vescovi e inquisitori. Come si sviluppava un processo in materia di fede? Il processo davanti un tribunale dell‟Inquisizione poteva prendere l‟avvio da una denuncia o da iniziativa degli stessi giudici. La denuncia, raccolta dal notaio e in presenza di un ufficiale del tribunale, doveva contenere tutti gli elementi necessari all‟identificazione dell‟accusatore (nome e cognome, luogo di nascita, paternità, professione, età, residenza), la registrazione dei nomi e delle qualifiche di coloro che la ricevevano, la narrazione circostanziata di ciò che aveva da riferire. Dovevano essere indicati inoltre il luogo ove il fatto era avvenuto, il giorno e l‟ora, le parole precise che erano state pronunciate, le persone che erano in grado di confermare il racconto, L‟accusato era necessario fosse individuato con precisione: anche qui si chiedevano le generalità ed una descrizione fisica della persona. Prima d‟essere licenziato, a colui che aveva proposto la denuncia si doveva chiedere se avesse ragioni di contrasto, se fosse nemico dell‟accusato e se avesse assolto il precetto pasquale. Dopo di che il verbale era riletto al denunciante e questi, oltre agli altri presenti, lo sottoscriveva. L‟iniziativa autonoma del tribunale era prevista tutte le volte che, mancando una denuncia, si spargeva la voce dell‟esistenza di un eretico o di un fatto perseguibile dall‟Inquisizione. In quel caso il giudice, dopo aver indicato da quali persone gli fossero giunte le notizie, poteva iniziare convocando testimoni e raccogliendo le loro deposizioni secondo il formulario già segnalato per l‟accusatore, I testimoni però, anche quando fossero giunti a confermare le notizie ricevute dal tribunale, non diventavano per questo accusatori. Perciò, se le prove non erano sufficientemente precise, il tribunale non avrebbe potuto procedere oltre e il reo (o presunto tale), se già individuato, non poteva essere perseguito. Quando la denuncia o le testimonianze avevano configurato l‟esistenza di un delitto punibile dal Sant‟Officio, il reo era catturato e condotto in carcere. Questa procedura diventava obbligatoria
11 A. Del Col, L’Inquisizione in Italia, op. cit., p. 616. 12 Ivi, p. 589. 13 Ivi, p. 618. 14 Ivi, p. 590.
6
quando gli indizi raccolti erano sufficienti per sottoporlo a tortura nel caso non avesse voluto confessare. Le persone di “ottima fama e di nobiltà insigne” potevano essere carcerate solo dopo che era stato chiesto ed ottenuto l‟assenso della Congregazione a Roma. Una volta carcerato, il reo veniva interrogato. Talvolta, quando i giudici ritenevano di non avere ancora un quadro completo e dettagliato della situazione, potevano procedere a sentire prima nuove testimonianze e poi a convocare l‟accusato. Il suo interrogatorio, seguendo un formulario rigido, partiva dalla richiesta di tutti i dati che avrebbero permesso la sua identificazione Poi tendeva a scoprire se egli conoscesse la ragione del trattamento subito, se egli avesse mai incontrato eretici o colpevoli del delitto per il quale era stato condotto in carcere, quindi se egli stesso fosse incorso in tali errori. A questo punto i giudici lo ponevano di fronte alle accuse emerse dai verbali degli accusatori e dei testimoni, omettendo ogni particolare che avesse permesso al reo dì individuare i loro nomi: va notato però che la fase preliminare, quando ancora al reo non si muovevano accuse precise, poteva durare per tre, quattro e più sedute, secondo il giudizio del tribunale che evidentemente si aspettava dal prolungamento dei preliminari un affievolirsi della resistenza. Se il reo, dopo tutto ciò, avesse continuato a negare qualsiasi partecipazione agli avvenimenti narrati, il tribunale gli chiedeva se avesse dei nemici, chi fossero, quali le ragioni del contrasto, se tali inimicizie fossero conosciute da altri e da chi. Si apriva a questo punto una fase nuova nel dibattito processuale. Sulla base delle ultime dichiarazioni del reo, il tribunale, qualora avesse constatato la coincidenza dei nomi dei nemici dell‟accusato con quelli degli accusatori e dei testimoni, poteva condurre un‟indagine riservata (utilizzava normalmente “prelati prudenti ed esperti”, come si esprimevano i manuali) della quale spesso non rimaneva traccia nelle carte del processo. Se le dichiarazioni erano confermate, il tribunale doveva verificare la buona fede degli accusatori e dei testimoni, interrogandoli nuovamente; oppure mettersi alla ricerca di nuove prove da raccogliere attraverso testimonianze inattaccabili. Inoltre, se l‟accusato aveva rigettato ogni responsabilità, dietro sua richiesta gli erano messi a disposizione sunti (emendati di ogni possibile elemento di identificazione) dei verbali resi dai testimoni e poteva essergli affiancato un avvocato per la difesa (“l‟avvocato dei poveri” com‟era chiamato) con il quale elaborava uno schema di interrogatorio per un nuovo ascolto di tutti i testimoni (quelli che avevano accusato il reo e anche coloro che non avevano fornito prove contro di lui o avevano finito per scagionarlo). L‟avvocato fiscale procedeva di persona a interrogare nuovamente tutti e forniva l‟estratto delle nuove testimonianze al reo. Costui poteva allora presentare una memoria difensiva con la quale contestava le accuse e citava testimoni a difesa, per dimostrare -con affermazioni di segno contrario- l‟inconsistenza di quelle che lo accusavano. Quando tutta questa fase si fosse conclusa lasciando nei giudici la convinzione di trovarsi dinanzi un colpevole, per acquisire la prova che sarebbe stata decisiva, cioè la; confessione, essi potevano passare alla tortura. I sistemi usati più frequentemente erano il fuoco (acceso sotto i piedi), la stanghetta (il tallone del piede veniva stretto tra due lamine concave e sempre più forzato), la corda (legata attorno ai polsi, che erano uniti sopra la testa poi si sospendeva l‟imputato alle travi del soffitto; strattoni improvvisi lo innalzavano da terra e poi lo facevano ricadere). La confessione estorta in tal nodo non costituiva prova valida. Doveva essere confermata successivamente dall‟accusato durante un nuovo normale interrogatorio. Si giungeva così alla fine del processo. Nel corso di una riunione di tutti i giudici che avevano avuto parte nel procedimento, alla presenza dell‟ordinario o del ministro delegato, si valutavano i dati emersi e si decideva. Il reo poteva essere scagionato di tutte le accuse e liberato dal carcere. In tal caso veniva emessa una sentenza nella quale il tribunale spiegava in base a quali indizi avesse iniziato il procedimento e come avesse avuto modo di mostrarli falsi o inconsistenti e si chiudeva con la completa assoluzione dell‟accusato. A Napoli spesso anziché seguire questa procedura, il tribunale semplicemente interrompeva il processo e mandava libero il reo. Talvolta si trova tra le carte del processo il decreto di scarcerazione.
7
Un secondo modo di concludere il processo era quello della “purgatione canonica”, non usato però frequentemente. Nel caso che il reo non potesse essere dichiarato colpevole per mancanza di indizi e se il giudice non si fosse convinto della sua innocenza, il primo era invitato a giurare la propria innocenza davanti ad un certo numero di testimoni, suoi conoscenti e di grado sociale pari al suo. Costoro dovevano confermare, sempre con giuramento, che il reo aveva detto la verità. Dopo di che, se in carcere, veniva liberato e il processo si chiudeva con il verbale di quella cerimonia. Tutti gli altri procedimenti si concludevano con l‟abiura. Questa poteva essere “de levi” o “de vehementi” a seconda che il reo fosse stato giudicato leggermente sospetto o colpevole e gravemente sospetto e colpevole d‟eresia o di altri errori puniti nel tribunale del Sant‟Ufficio; poteva svolgersi nella sede del tribunale o in altro luogo privato ma anche in pubblico, in una piazza o in una chiesa. I giudici, nella loro sentenza, indicavano gli indizi in base ai quali si erano formati la convinzione della colpevolezza dell‟imputato, gli chiedevano di abiurare appunto tutte le sue colpe, di accettare le penitenze salutari e le pene. Seguiva la lettura dell‟atto di abiura da parte del reo: egli riconosceva l‟esistenza della colpa contestata e dichiarava di voler togliere ogni dubbio ai giudici sulla sua fede ed obbedienza alle leggi della Chiesa, perciò abiurava, malediceva e detestava tutte quelle proposizioni eretiche (o tutti quegli atti o atteggiamenti colpevoli) per le quali era stato accusato, si impegnava a non dar più occasione a nuovi sospetti, a denunciare eretici e loro fautori. Accanto a questa dichiarazione di rinnovata sottomissione – che non rappresentava ancora una pena, un castigo - il reo si impegnava ad assolvere le “penitenze salutari” che i giudici gli avevano imposto e che consistevano normalmente in visita di chiese, confessioni e comunioni in giorni e per un numero di volte prestabilito, preghiere personali giornaliere o periodiche anche per più anni, digiuni, pellegrinaggi, servizi da rendere a chiese o comunità religiose. Queste “penitenze salutari” rimanevano l‟unica riparazione chiesta al reo nel caso in cui le sue colpe fossero state giudicate non gravi e incerta o assente l‟intenzione “malvagia” di compiere gli atti dei quali era stato accusato: questa conclusione del processo era frequente solo quando l‟abiura era stata “de levi”. Quando invece la gravità del fatto o l‟intenzionalità della partecipazione portavano all‟abiura “de vehementi”, accanto e prima delle “penitenze salutari” vi erano le pene. L‟abiura rappresentava la riconciliazione del colpevole con la Chiesa, la pena era la conseguenza delle colpe commesse. Le pene variavano a seconda dei giudici, del luogo dove operava il tribunale, delle circostanze temporali. La pena di morte, per gli eretici il fuoco, fu praticata per tutto il tempo d‟attività di questi tribunali pur se in proporzioni sempre decrescenti rispetto al numero dei casi esaminati. Assai più frequenti erano le pene del carcere, dei remi, dell‟esilio, della fustigazione, della confisca dei beni. Il carcere poteva durare tutta la vita o un tempo più breve; quando il numero dei condannati era superiore alla capienza dell‟edificio adibito a quell‟uso, si potevano indicare altri luoghi (il convento per un religioso, la propria casa per un laico) che dovevano essere considerati “loco carceris”; talvolta il carcere era collegato a particolari ulteriori sofferenze (catene ai polsi e alle gambe, celle particolarmente piccole) mentre in altre occasioni quella pena si riduceva all‟obbligo di una visita giornaliera del „carcerato‟ ai responsabili del tribunale. La condanna alla galera per gli uomini non durava più di dieci anni e veniva scontata sulle imbarcazioni dello Stato della Chiesa. L‟esilio poteva riguardare l‟allontanamento da una sola città, da una intera diocesi o da tutto lo stato e durava da un anno a tutta la vita: solo in apparenza era pena minore poiché l‟essere costretti a vivere lontani dall‟ambiente naturale poteva costringere a gravissime difficoltà economiche fino a costringere alla mendicità, e lasciava in una situazione non migliore i famigliari rimasti sul luogo i quali spesso subivano la confisca di tutti i beni quale corollario della condanna all‟esilio dell‟accusato. Talvolta il collegamento tra colpe e pene era indicato già nei trattati di procedura ed allora i giudici si limitavano ad applicarle senza innovare nulla. Così era prescritto per gli eretici penitenti il carcere duro e il carcere perpetuo, come pure per i gravemente sospetti d‟eresia, per i casi più gravi di sollecitazione in confessione, per i nobili colpevoli di gravi bestemmie ereticali (che normalmente conducevano al
8
rogo); la condanna ai remi, per tre, cinque o sette anni, per i concubini, i bestemmiatori, i sollecitanti in confessione, per coloro che oltraggiavano le immagini sacre, per i falsi testimoni, per i sortileghi. La fustigazione per le concubine, per le accusate di sortilegio e ancora per i testi falsi; l‟esilio per le donne accusate di incantesimi e di sortilegi, i chierici che si erano dedicati a pratiche magiche, i detentori di libri proibiti. L’Inquisizione nella Repubblica di Venezia e nella Diocesi di Feltre Dopo aver parlato di inquisitori, di inquisiti e di procedure – e le voci del Dizionario affrontano con grande ricchezza di particolari questi temi – veniamo a parlare della Repubblica di Venezia e poi della Diocesi di Feltre e del Tesino. A seguito della creazione della Congregazione del Sant‟Ufficio la presenza degli inquisitori nominati da Roma si diffuse, in particolare nell‟Italia settentrionale e nelle Marche, Umbria e Toscana. Nella Repubblica di Venezia l‟archivio dell‟inquisizione (oggi presso l‟Archivio di Stato di Venezia) conserva documenti a partire dal 1541; in questo territorio fu spesso prevalente come inquisitore il ruolo del Nunzio papale rispetto all‟Inquisitore nominato da Roma come si era visto chiaramente negli anni 1518-1520 a proposito della repressione della stregoneria in Valcamonica.15 La Repubblica non ostacolò l‟azione dei tribunali inquisitoriali ma nominò tre deputati scelti tra i senatori più importanti per controllare l‟attività degli inquisitori (chiamati i “Savi dell‟eresia”) e per ottenere che Venezia divenisse la sede competente anche per i processi che erano avviati nelle diverse diocesi della terraferma. Dopo il 1548 l‟attività di repressione dell‟eresia protestante fu il motivo centrale dell‟azione dei tribunali inquisitoriali nel territorio della Repubblica, anche in collegamento con la pubblicazione del primo catalogo del libri proibiti che fu stampato a Venezia nel 1549.16 A partire dagli anni Sessanta del XVI secolo a giudicare in materia di fede a Venezia fu un tribunale che era composto dal Nunzio apostolico, dall‟Inquisitore nominato da Roma e da un Vicario del Patriarca di Venezia. Il ruolo dei tre “Savi dell‟eresia” era di controllo dell‟attività di questo tribunale. Nei territori di terraferma tra i tribunali più attivi vi fu quello di Aquileia e quello di Concordia. Ma furono presenti e operarono inquisitori anche a Belluno, a Feltre, a Bergamo e ad Adria-Rovigo. Nella Diocesi di Feltre, che comprendeva fino alla seconda metà del XVIII secolo anche la Valsugana e il Tesino, furono soprattutto i vescovi ad agire come inquisitori, talvolta avendo accanto come collaboratore proprio l‟inquisitore nominato da Roma. La prassi risulta verificata alla metà del Cinquecento quando il vescovo Filippo Maria Campeggi, per giudicare sulle accuse che erano state mosse ad alcuni presunti eretici, utilizza la visita pastorale che compie in tutta la diocesi e anche nella Valsugana e nel Tesino durante la quale si fa accompagnare dall‟Inquisitore nominato da Roma e procede contro alcuni preti accusati di simpatie per gli eretici come il pievano e il vice pievano di Strigno e un‟altra quindicina di persone tra artigiani e burocrati. Nel 1559 nel corso di un‟altra visita pastorale, lo stesso Campeggi fu a Strigno e nella Valle del Tesino anche per proseguire un processo per sospetto d‟eresia contro un cappellano di Bieno che si concluse con un nulla di fatto. Tutti i processi di Feltre sono stati schedati e in parte studiati. Una informazione dettagliata è nella pagina Internet di Siusa delle Soprintendenze archivistiche italiane che pubblica l‟inventario di quei processi che riguardano il periodo 1530-1633.17 I processi inquisitoriali sono raccolti, assieme ad altri documenti vescovili, entro 41 volumi dei 347 (o 476) componenti la serie "Acta varia", rilegati in modo cronologicamente disomogeneo. I fascicoli si riferiscono a i processi per eresia celebrati dal tribunale vescovile di Feltre e in parte dall'inquisitore di Feltre a partire dal 1530. E‟ possibile che dallo spoglio degli altri volumi che compongono la serie “Acta varia” e da quelli delle “Visite pastorali” emergano altri documenti che si riferiscono ad interventi in materia di fede, dato che
15 Voce “Valle Camonica”, in Dizionario storico, op. cit., p. 1646. 16 Voce “Indici dei libri proibiti. Cinquecento”, in Dizionario storico, op. cit., p. 775-778. 17 Vedi ora in Appendice 1.
9
la prima serie (“Acta varia”) con i suoi 476 volumi arriva al 1900 e le “Visite pastorali” giungono fino al 1985. Gli “Acta varia” dell‟Archivio diocesano di Feltre – ringrazio don Mario Cecchin, cancelliere ed archivista, per avermeli fatti vedere – sono volumi che risultano dall‟unione di decine di fascicoli poi legati insieme e cartonati o ricoperti di cuoio. Non hanno un indice e quindi vanno sfogliati carta per carta per individuare quelle che contengono riferimenti a giudizi in materia di fede. Questo è accaduto perché in passato gli scrivani che hanno vergato quelle carte erano spesso contemporaneamente i cancellieri e i notai della Curia diocesana e del Tribunale vescovile e quello che hanno scritto in quei fascicoli poteva riguardare le materie più diverse (da qui la denominazione di “Acta varia”), dato che il fattore unificante non era il contenuto ma era l‟autore, l‟estensore dello scritto e in secondo ordine la successione cronologica dei documenti. Quello che ho detto per gli “Acta varia” vale in buona parte anche per le “Visite pastorali”. Anche in questo tipo di documenti possiamo trovare, accanto alla descrizione locale (ai luoghi di culto), reale (alle suppellettili liturgiche e decorazioni delle chiese) e personale (agli ecclesiastici e a coloro che gestivano beni ecclesiastici), atti di contabilità, statuti, regolamenti, ordinazioni sacre, registrazioni di matrimoni e di cresime, giudizi in cause civili, criminali e in materia di fede. E‟ per questa ragion e che ritengo che sia ancora tutto da scoprire il possibile rapporto tra Inquisizione e procedimenti vescovili in materia di fede e gli abitanti della Valle del Tesino, rapporto che può essere ricostruito sulla base dei documenti sopra citati e dell‟altra documentazione ecclesiastica conservata a Feltre e qui a Pieve Tesino (spesso copia delle decisioni che venivano prese in occasione delle “Visite pastorali” rimaneva negli archivi delle parrocchie). E‟ probabile che nel XVII e nel XVIII secolo, quando i Tesini vanno in giro per il mondo a vendere santini, stampe, opuscoli, calendari, l‟Inquisizione si sia interessata di loro e i vescovi di Feltre abbiano nutrito qualche preoccupazione per questi ambulanti che giravano l‟Europa, soprattutto nei paesi dei Riformati, e che quando tornavano, non portavano a casa solo esperienza e qualche soldo ma anche idee, costumi, usanze, credenze che avevano appreso nei paesi attraversati. Quando i Vescovi di Feltre parlano della Valsugana e del Tesino nel XVI secolo li descrivono come luoghi nei quali l‟eresia ha fatto breccia. Ci sono funzionari dell‟amministrazione pubblica che sono accusati di essere dalla parte dei Riformati come il capitano di Ivano Fracena, di Strigno, di Caldonazzo, il Podestà di Borgo Valsugana. Nei frammenti di denunce e di processi che sono finora emersi dalle carte dell‟Archivio diocesano di Feltre non ci sono testimonianze che l‟eresia avesse già fatto proseliti tra la popolazione del Tesino ma gli elenchi che sinora sono venuti alla luce nemmeno escludono questa possibilità. Si può immaginare poi con quale preoccupazione i vescovi e gli inquisitori dovessero vedere il Tesino del Settecento, con tutta quella gente che andava e veniva. Chi ha studiato l‟ambulantato del Tesino ha registrato qualche episodio di venditori di stampe messi sotto processo per il materiale che offrivano.18 Ora si tratta di indagare non solo più da vicino le vicende dei venditori nei diversi paesi ma anche i comportamenti quotidiani degli stessi venditori una volta ritornati a casa, per capire in che modo il mondo culturale, religioso, spirituale dei Tesini sia stato influenzato dal mestiere che molti di loro hanno svolto e che li ha resi famosi in Europa. E i processi in materia di fede e le denunce, anche se non seguite da processi, potrebbero fornire importanti elementi in proposito.
18 Accenni a procedimenti giudiziari contro venditori di stampe del Tesino sono in E. Fietta Ielen, Con la cassela in spalla: gli ambulanti del Tesino, Ivrea, 1987. Intorno a processi per una stampa discussa che offendeva il re di Spagna è costruito il romanzo di Paolo Malaguti, I mercanti di stampe proibite, Treviso, Santi Quaranta, 2013 che ha per attori principali la stamperia dei Remondini di Bassano, una famiglia di ambulanti di Pieve Tesino, i Gecele, Carlo III di Borbone, i Gesuiti e papa Clemente XIV. Nella sua Storia dei Papi dalla fine del Medioevo L. Pastor parla di una stampa che fu sequestrata a Roma nell‟aprile del 1772 (e che si scoprì era stata prodotta dai Remondini e certamente anche distribuita dagli ambulanti del Tesino) che raffigurava Carlo III tra i dannati in una rappresentazione del “Giudizio universale” (vol. XVI, Parte II, Roma 1933, pp. 172-174).
10
Verso alcune conclusioni provvisorie alla luce dei dati del Dizionario La pubblicazione del Dizionario è avvenuta dopo un decennio dall‟apertura dell‟archivio del Sant‟Ufficio a Roma. E‟ stato un decennio molto ricco di convegni e di pubblicazioni che hanno riguardato l‟Inquisizione vista però soprattutto sulla base dei documenti romani (di quelli che sono rimasti o sono stati rintracciati dopo che Napoleone aveva fatto trasferire a Parigi quasi per intero l‟archivio del Sant‟Ufficio). Siamo in grado oggi di conoscere molto bene il funzionamento della Congregazione del Sant‟Ufficio, lo stato dei rapporti tra Roma e gli inquisitori locali, tra Roma e i nunzi e i vescovi diocesani. E sono stati fatti approfondimenti e scoperte sulla base della documentazione originale che è stata rintracciata in quell‟archivio per quei processi che erano in parte già noti dal materiale archivistico rintracciato negli Archivi di Stato e in alcuni archivi ecclesiastici e per la bibliografia che aveva riguardato quei processati. Resta ancora in ombra la definizione dei rapporti tra vescovi e inquisitori e quale parte della lotta all‟eresia sia stata svolta dai tribunali vescovili. Così come resta da capire se il più significativo prodotto uscito dal Concilio di Trento sia stata la lotta all‟eresia (la Chiesa dell‟Inquisizione e della Controriforma) o il tentativo di adeguare la Chiesa alle trasformazioni che erano avvenute al suo interno (in termini di nuova sensibilità religiosa) e nel mondo (scoperte geografiche, colonizzazione, aumento del costo della vita e della popolazione, etc.). L‟Inquisizione e l‟Indice dei libri proibiti sono stati strumenti straordinari per arginare l‟ingresso in Italia di credenze eretiche. La Chiesa uscita da Trento ha utilizzato però anche altri strumenti che possiamo chiamare ordinari come una nuova disciplina della vita sacramentale, un nuovo modello di prete e di parrocchia, nuovi ordini religiosi e nuove confraternite devozionali e assistenziali che hanno contribuito in maniera decisiva a cambiare la quotidianità della vita religiosa dei cristiani. Di questi cambiamenti siamo stati e siamo noi stessi testimoni. Mancano però ancora oggi studi adeguati che ci aiutino a capire come ci siamo arrivati. Appendice 1 Processi inquisitoriali nella Diocesi di Feltre. Estremi cronologici: 1530 – 1633 Consistenza: Unità 104: Fascicoli processuali, con altra documentazione, in bb. 41 Storia archivistica: I processi inquisitoriali sono raccolti, assieme ad altri documenti vescovili e curiali, entro 41 volumi dei 347 (476?) componenti la serie "Acta varia", rilegati in modo cronologicamente disomogeneo. Descrizione: I fascicoli si riferiscono a i processi per eresia celebrati dal tribunale vescovile di Feltre e in parte dall'inquisitore di Feltre (e più tardi da quello di Belluno?) a partire dal 1530. In particolare: Vol. IV, cc. 391-392: 1569, pre Domenico Casanova, Giacomo e Giovanni osti (cc. 2) Vol. VIII, cc. 129-136: 1530, Tirolesi inosservanti a Lamon (cc. 8) cc. 753-757: 1543, pre Stefano Macaneo di Primiero (cc. 5) cc. 763-767: 1543, Ludovico di Feltre (cc. 5) Vol. XVI, cc. 29-31: 1549, Liga malignantium Levigi (cc. 3) Vol. XXI, c. 170: 1546, A. Rippa e fatti d'osteria a Grigno (c. 1) Vol. XXIII, cc. 273-276: 1537, fra Eligio Siculo (cc. 4) Vol. XXIV, cc. 634-637: 1557, Rocco Grifferio (cc. 4) cc. 643-646: 1557, Bono da Cavorzo, Urbano del Monte, Perazzolli (?) (cc. 4) cc. 850-851: 1558, Monitorio di F.M. Campeggi contro gli eretici (cc. 2) Vol. XXVIII, cc. 616-627: 1555, Francesco dal Casono (cc. 12)
11
Vol. XXXI, cc. 75-77: 1557, duo laborantes lanarum (Antonio e Peregrin) (cc. 3) cc. 77-80: 1557, pre Fabrizio Musocco, Gregorio oste et alii (cc. 4) cc. 82-83: 1558, pre Agostino Anconitano (cc. 2) cc. 155-164: 1559, Matteo Copazudei, G. Vaccaro et alii (cc. 10) cc. 167-168: 1559, pre Ludovico Mantovano (cc. 2) cc. 168-174: 1559, fra Benedetto Secco (cc. 7) cc. 180-181: 1558-59, pre Thomio Boso (cc. 2) cc. 189-191: 1559, Francesco veneto mendicante (?) a Feltre (cc. 3) cc. 196-197: 1559, pre Zuane (cc. 2) c. 198: 1559, fra Giacomo (c. 1) c. 199: 1559, don Antonio Fontana (c. 1) cc. 200-201: 1559, Giovanni Battista Rippa e Piero Bagin (cc. 2) cc. 208-218: 1559, Giacomo questuante (cc. 11) cc. 233-234: 1558, Giovanni (Zan) Nicola Villabruna (cc. 2) cc. 237-239: 1558, Non confessati e non praticanti (cc. 3) cc. 240-251: 1558, fra Bernardino del monastero di San Vittore (cc. 12) cc. 265-318: 1558, pre Thomio Boso, M. e A. Castelrotto, pre Andrea Genetti (cc. 54) cc. 408-409: 1558, Monitorio di F.M.Campeggi contro gli eretici (copia) (cc. 2) cc. 409-410: 1558, nomina di fra Antonio dal Covolo (10.12.1558) (cc. 2) cc. 410-442: 1559, fra Fulgenzio Graziani, Apollonia Zotta, Giovanni Pellegai (cc. 33) Vol. XXXII, cc. 2-8: 1556, Giacomo de Malenck ambulante valtellinese (cc. 7) cc. 17-19: 1556, Battista Floriani, Thomio Granello, Matteo Copazudei (cc. 3) c. 33: 1556, Andrea Paladino, Giacomo Rigolo (c. 1) cc. 42-43: 1556, Gaspare Zaut (cc. 2) c. 66: 1558, pre Agostino Anconitano (c. 1) cc. 72-77: 1557, Bono, Domenico, Leon.Guielmini, Donato e Jo. Ianesello (cc. 6) cc. 78-85: 1557, Maddalena ostessa (cc. 8) c. 352 ?: 1559, Litterae super heresi (c. 1) cc. 531, 566: 1578, A. Cerra Vol. XXXIV, cc. 7-10: 1558, pre Francesco Popo, R. Grifferio, G. Genetti, Cosner d'Ivan (cc. 3) cc. 17-19: 1558, G.B. Zulian, Bono di C., Urbano del M., R. Grifferio (cc. 3) cc. 20-23: 1557, Giovanni Rippa, Gasparo Genetti (cc. 4) cc. 42-43: 1558, Th. Boso, G.B. Rippa, capitano d'Ivano, Castelrotto, Noero' (cc. 2) c. 43 bis: 1559, libri di pre Thomio Boso (cc. 2) c. 44: 1558?, libri di Gaspare Tolentino (c. 1) c. 289: 1561, combustio librorum (c. 1) c. 346: 1562, sost. inquis. fra Antonio dal Covolo (25.09.1562) (c. 1) cc. 481-515: 1566, pre G. de Bolis, pre V. Cavasoto, Giacomo Jechol (cc. 35) cc. 634-637: 1557, Rocco Grifferio (cc. 4) Vol. XXXV, cc. .61-91: 1558, pre Thomio Boso (copia) (cc. 31) cc. 197-220: 1559, fra Fulgenzio Graziani, Apollonia Zotta e Giov. Pellegai (cc. 24) cc. 537-558: 1558-59, R. Grifferio, Gasp. zaut, T. Coradini, B. Facin, GB. Rippa (cc. 22) Vol. XXXVII, c. 326: 1563, pre Giovanni Fezio (c. 1) Vol. XXXVIII, cc. 218-220: 1558, fra Bernardino, monastero di S. Vittore (cc. 3) Vol. XXXIX, cc. 495-497: 1558, T. Corradino et alii (cc. 3) cc. 506-514: 1567, Leonardo zaut (?)(cc. 9) Vol. XL, cc. 228-233: 1560, Giacomo Baldruck (cc. 6) Vol. XLI, cc. 522-545: 1569, Giacomo Voltolina (cc. 24) Vol. XLII, c. 615: 1568, Editto di F.M.Campeggi a Lamon contro ambulanti eretici (c. 1)
12
Vol. XLIII, c. 125: 1570, Abiura di pre Giovanni Molinaro (c. 1) c. 641: 1571, pre Girolamo Ferrari (c. 1) cc. 697-700: 1569, Cavaletto oste (cc. 4) Vol. XLIV, cc. 24-31: 1571, Bernardino Gobbi, Giorgio Bruna (cc. 8) c. 755: 1558, Gasparo zaut (c. 1) Vol. XLV, cc. 56-76: 1573, Filippo e Giovanni ugonotti (cc. 21) c. 782: 1573, pre G.B. Peropulo (c. 1) Vol. XLVI, cc. 1-15: 1571, pre Antonio Fontana (cc. 15) c. 608: 1576, Antonio Cerra (c. 1) Vol. XLVII, cc. 39-52: 1575-77, Zaut (Gaspare Georgio detto Zanuto) (cc. 14) cc. 571-575: 1575, capitano di Caldonazzo (cc. 5) cc. 748-759: 1575, A.Cerra (cc. 5) Vol. XLVIII, cc. 59-65: 1576, Antonio Bruno (cc. 7) c. 522: 1576, Gaspare Genetti capitano di Strigno cc. 697-700: 1576, A. Cerra (cc. 4) Vol. XLIX, cc. 1-22 (?), A. Cerra (cc. 22) cc. 84-87 (?), A. Cerra (cc. 4) cc. 543-570: 1578, A. Cerra (cc. 28) cc. 672-676: 1577, Pietro da S. Maria (cc. 5) Vol. L, c. 78: 1577, Andrea Ducato (c. 1) cc. 164-167: 1558, Gasparo Zaut (cc. 4) cc. 375-380: 1577, Pietro da S. Maria (cc. 6) cc. 630-632: 1577, Gasparo Zaut, T. Corradino (cc. 3) c. 835: 1577, Abramo Partel e altri (c. 1) Vol. LI, cc. 434-435: 1581, Alberto del Cappello (cc. 2) Vol. LII, cc. 389-575: 1570-78, A. Cerra (cc. 187) Vol. LIII, cc. 372-373: 1570, A. Cerra (cc. 2) c. 475: 1581, Alberto del Cappello (c. 1) cc. 532-533: 1581, Alberto del Cappello (cc. 2) Vol. LVII, cc. 1-12: 1581, Giovanni Grandi, podestà di Borgo Valsugana (cc. 12) Vol. LXI, cc. 454-467: 1588, A. Cerra (cc. 14) Vol. LXVII, cc. 63-77: 1591, Alberto Scudella (cc. 4) Vol. LXXIII, c. 296: 1591, Zuane Althaner Vol. LXXVII, cc. 63-97: 1592, Leonardo Visintainer (cc. 35) Vol. LXXX, c. 836: 1597, Nicola De Mathé (c. 1) Vol. LXXXVII, cc. 123-147: 1588, Libri (cc. 25) Vol. XCV, cc. 513-516: 1603, Officium Sanctae Inquisitionis contra Sebastiano Vellaio (cc. 4) Vol. XCVI, cc. 41-43: 1607, Giacomo Zotta (cc. 3) c. 130: 1608, Libri di Giovanni Antonio Bettini. Processioni a Grigno (c. 1) c. 248: 1597, Non praticanti di Lamon (c. 1) Vol. CV, c. 569: 1611, G. Grando e Caterina sua figlia (c. 1) Vol. CIX, cc. 683-685: 1612, Benedetto Vetturino, apostata in Calceranica ? (cc. 2) Vol. CXI, c. 188: 1613, Pietro della Ca', apostata in Feltre? (c. 1) Vol. CXXXVII, cc. 217-219: 1633, pre Fachinello pievano di Telve (cc. 3)