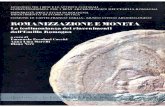In senso palestinese Realtà socioculturale e visione di genere nella narrativa di testimonianza...
Transcript of In senso palestinese Realtà socioculturale e visione di genere nella narrativa di testimonianza...
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNAFACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
LAUREA SPECIALISTICA IN DISCIPLINE SEMIOTICHE
In sensopalestineseRealtà socioculturalee visione di genere
nella narrativa di testimonianzacontemporanea palestinese
Relatrice Prof. Patrizia Violi
Correlatrice Prof. Giovanna Cosenza
Presentata da Giuditta Bassano
Anno accademico 2009/2010
Indice
Introduzione Dalla prova alla narrativa p. 4
PRIMA PARTEQuestioni teoriche
1. Finzioni testimoniali1.1 I concetti di referenziale ed autentico nella prospettiva semiotica1.2 Autenticità enunciazionale ed enunciativa nella testimonianza1.3 Etica e narrazione nelle recensioni1.4 L’autobiografia alla Lejeune1.5 Dalla tassonomia agli effetti1.6 Finzione e autobiografia nei testi1.7 Una proposta
2. La memoria palestinese narrata2.1 Ricordo, memoria, evocazione.2.2 Sensi collettivi2.3 La scomparsa dei luoghi2.4 Note sul trauma2.5 Fra trauma e nostalgia
3. Guardare al genere3.1 Il genere e il contesto palestinese: laicismo e segregazione 3.2 Il modello della scena femminile3.3 L’abito di genere3.4 La firma di una donna?3.5 Ripensare l’idea di contro-memoria
p. 7p. 10
p. 11p. 15p. 16p. 19p. 25
p. 27p. 27p. 30p. 33p. 37p. 39
p. 41p. 42p. 45p. 48p. 50p. 52
SECONDA PARTE
2
Dal testo all’archivio culturale
4. Terra e figli: memoria dell’infanzia4.1 Sanzioni4.2 Un’ipotesi culturale4.3 I figli della terra4.4 il discorso nazionalista e i comunicati dell’OLP4.5 Memoria infantile
5. Narrazione politica e mancanza di aggressività5.1 Il controllo dello spazio e l’aggressività5.2 Complicare il concetto di Intifada5.2.1 L’Islam5.2.2 Il progetto antimperialista e l’attenzione internazionale5.2.3 Gli Stati arabi5.2.4 Sovrapporre gli israeliani agli inglesi5.2.5 Resistenza polemica e strategia contrattuale5.3 Rappresentazioni dell’’altro5.3.1 Martiri5.3.2 Gli israeliani5.3.3 Arafat e Bush5.4 Straniamento e orientamento al passato
p. 55
p. 56p. 58p. 59p. 60p. 63
p. 69p. 71p. 73p. 74p. 75p. 76p. 77p. 77p. 78p. 79p. 81p. 83
TERZA PARTE
6. Tirare le somme, riparlare di genere6.1 Conclusioni6.2 Limiti6.3 Il progetto di ricerca sul conflitto mediorientale
p. 84 p. 85p. 89p. 92p. 95
3
6.4 Questioni aperte: l’onore e i ruoli di genere6.4.1 Tracce di stile: lo sguardo strabico e l’ornamento6.4.2 Oblio, sesso e memoria
p. 97
AppendiceEstratti p. 99
Appendice 2.Le autrici e gli autori p. 103
Bibliografiap. 105
4
IntroduzioneDalla prova alla narrativa
In un saggio scritto nel 2001, John Peters ricorda quale fossel’opinione di Aristotele sulla verità testimoniale. “Aristotle …considers dead witnesses more trustworthly, since they cannot bebrided. To witness as if you were as dumb and indifferent as thedead is the obvious ideal, since you would be free from interest,interpretation, care and spin1”.
Nel 2010 - nel contesto ormai vastissimo degli studi sullamemoria - il campo di riflessione sulle tematiche dellatestimonianza traumatica si apre verso prospettive che ribaltanoquella aristotelica. L’interesse per i valori iscritti nel corpodel testimone, che porta un segno ed è quindi legittimato afissare un’esperienza traumatica nella memoria collettiva, vainsieme allo studio dei modi in cui, oltre a questa iscrizioneradicale, l’atto di testimoniare possa essere preso in carico daun soggetto e assumere una forma. E’ posto ormai per certo che lamemoria è un fenomeno dinamico, che sta in mezzo fra lasoggettività e la cultura e che coinvolge direttamente lepratiche, le performance, le rappresentazioni e leinterpretazioni di un gruppo.
E’ chiaro oggi che il legame fra concetti come quello diverità, di memoria e di testimonianza è una questione complessa.Il testimone anonimo in questo senso non è più la figura cardinedella memoria: si aprono interrogativi sul modo in cui anche iprodotti culturali codificati, testi letterari, visivi,cinematografici, possano contribuire alla produzione di sensomemoriale. Spostandosi dalla storiografia e dalla testimonianza -dai fatti - si guarda a un campo semiotico che all’estremoopposto considera le possibilità della finzione come altrettantorilevanti per la memoria culturale. Dai fatti alla finzione, daltestimone al testo. Fino a generare proprio un problema testuale:quello dei limiti e delle caratteristiche di un genere - lanarrazione di vita “auto” o “biografica” - nella letteraturacontemporanea.
1 Peters, 2002.
5
L’opposto del corpo muto del testimone è la testimonianzanarrata, romanzata: ne è esempio emblematico quella dell’autricececa Zdena Berger, ebrea sopravvissuta alla Shoà, che scriveaffidandosi a un personaggio finzionale, la quattordicenne Tania.Berger spiega di aver: “scelto la forma narrativa e non quella diun semplice diario per poter raccontare la verità in tutte le suesfaccettature e dare spazio alle emozioni2”. Il panoramacontemporaneo vede una grande proliferazione di macchine testualiche sfruttano questa strategia, e sono oggetti di analisi tantopiù interessanti quanto più alta è la posta in gioco dellatragicità della testimonianza.
Proprio di un esempio di questo tipo si cerca di discutere inqueste pagine, concentrandoci sulla narrativa testimoniale di ungruppo implicato in un conflitto. Il fuoco è l’archivio culturaledella società palestinese, e proprio per l’idea che possa esserefruttuoso esplorare spazi finzionali di testimonianza,consideriamo testi di letteratura contemporanea. In una ricercache s’interessi delle forme di memoria e dei modi in cui gliagenti del conflitto israeliano palestinese producono narrazioniidentitarie, la memoria culturale palestinese narrata offre unversante d’esplorazione inedito e - per questo ci sembra -fruttuoso.
Lavoreremo su un corpus d’analisi di sei testi: Sharon e miasuocera e Niente sesso in città della scrittrice Suad Amiry, La svergognatae Una primavera di fuoco di Sahar Khalifa, Memoria di Salman Natur eDentro la notte di Ibrahim Nasrallah. In un’appendice che seguel’analisi, abbiamo riportato undici estratti dai vari testi,luoghi narrativi importanti, che costituiranno riferimentitestuali a cui ci richiameremo in più parti.
Si tratta di testi che implicano tutti esperienze direttedelle autrici e degli autori come “testimoni etnici” delconflitto mediorientale: questa espressione viene utilizzata daGianfranco Marrone, nell’introduzione a un convegno tenutosi adUrbino nel 2008, centrato sulle nuove forme di scritturaautobiografica nel contemporaneo, per riferirsi ai casi in cui ildiritto alla biografia, l’autorevolezza di una narrazioneautobiografica, viene dal contesto particolare dell’esperienza divita dell’autore o dell’autrice, come nel caso appunto in cui èrappresentante di un gruppo etnico, sociale o politico vittima disofferenze e traumi derivati da un conflitto.
Eppure le forme testuali sono molto diverse fra loro, eoffrono una serie di gradienti della narrazione del sé, da quella
2 Berger, 2008, bandella di copertina.
6
di diario autobiografico in Sharon e mia suocera a quella di romanzotradizionale narrato in terza persona in Una primavera di fuoco.
L’analisi si comporrà di sei capitoli. Nei primi trediscuteremo altrettante questioni teoriche a livello generale ecercheremo nello stesso tempo di ancorarne degli aspetti adesempi nei testi che esaminiamo. Otterremo alcuni punti diriferimento per quello che riguarda la forma dell’esperienzapalestinese narrata. La seconda parte invece propone dueosservazioni sulle dinamiche della cultura palestinese partendodirettamente dallo spazio dei testi. L’ultimo capitolo è unariflessione critica sui limiti dell’analisi e sui possibiliapprofondimenti di alcuni aspetti particolari.
La questione della testimonianza autobiografica è l’oggettodel primo capitolo: qui discuteremo innanzitutto il rapporto fratestualità ed extratestualità, il modo in cui l’analisi semioticariflette su una narrativa di testimonianza rispetto ai concettidi effetto referenziale e autenticità. In seguito cercheremo dichiarire alcuni aspetti dello spazio narrativo considerato per ilsuo valore di testimonianza, attraverso la sanzione etica di unpubblico che si avvicina a questi testi. Passeremo poi aintrodurre le teorie che riguardano l’idea della traccia del séin senso autobiografico e autoriale. Vedremo così man mano iquattro testi di Khalifa e Amiry – quelli che saranno centralinell’analisi – discutendone i punti più significativi rispetto aquest’ultimo problema. Concluderemo con un’osservazione rispettoall’effetto di autenticità in un testo testimoniale.
Il secondo capitolo riguarda le possibilità espressive dellanarrativa rispetto alla fissazione del ricordo. Evidenzieremo lospecifico della cultura palestinese per la sua origine recente.Ci soffermeremo sull’importanza della dimensione spaziale perquesto gruppo sociale, segnato da una sottrazione per cui non c’èpiù recupero possibile e infine proporremo di pensare a una formadi memoria rivolta verso il passato e priva di prospettiva versola costruzione del futuro.
Nel terzo capitolo guarderemo ai quattro testi come testi diautrici e accenneremo alle costruzioni teoriche che leganol’identità femminile a una precisa posizione di genere nellesocietà islamiche. Proporremo che per molti aspetti la culturapalestinese sia narrata come una cultura laica e che in essa unasemantica dei generi sessuali passi non attraverso la religionema per un senso consuetudinario e orienti così la segregazioneper genere. Discuteremo il punto di vista dell’enunciazionedefinito dal gender sessuale e la presenza di temi femminili nei
7
testi. Analizzeremo l’idea di abito proposta dal femminismocontemporaneo; infine sottolineeremo come una scrittura femminilepassi per scelte molto diverse di un’autrice rispetto a quelledell’altra, tanto da rendere forse necessario ripensare unconcetto come quello di contro memoria.
I concetti teorici discussi nei primi tre capitolicostituiranno la base interpretativa per alcune osservazioninuove nel quarto e nel quinto. Ai quattro testi in esameaffiancheremo in questa seconda parte gli altri due, di SalmanNatur e Ibrahim Nasrallah. Questo servirà a vedere meglio quellivello macrosemantico dei testi come prodotti dello stessoorizzonte culturale; poi nel capitolo finale, rispetto a unadomanda che riguarda il gender, sfrutteremo invece il confrontofra enunciazione femminile e maschile in questa cultura.
Nel quarto capitolo sottolineeremo uno specifico orientamentodelle narrazioni in esame verso gli antenati. Vedremo come neitesti ricorra un rapporto onnipresente fra personaggi e figuregenitoriali, poi affronteremo quest’aspetto anche nell’ideologiapolitica del patriottismo palestinese, che fonda una suanarrazione fra una madre e dei figli e infine vedremo come lasoggettività enunciativa sia segnata da un tratto infantile, nelricorrere tematico nella narrazione dell’infanzia. Questi treelementi suggeriscono la possibilità di pensare al gruppo socialepalestinese rappresentato nei testi come ad un’unica generazionedi figli.
Nel quinto capitolo suggeriremo che la fissazione e lasanzione del dolore nella memoria collettiva palestinese rivelinoun senso di smarrimento identitario e in un’idea del propriogruppo che manca di connotazione aggressiva verso il popoloantagonista: i racconti che esamineremo infatti rimandano a unanarrativa sociale priva di propositi di vendetta.
Guarderemo ai modi e alle differenze della narrazionedell’altro nello spazio dei testi, considerando anche l’effettocombinato di diverse prospettive di rappresentazione dellasituazione politica in questo archivio culturale.
Chiuderemo l’analisi con una parte critica, il sestocapitolo. Qui riassumeremo alcuni punti e chiariremo i limiti dellavoro rispetto al problema della traduzione linguistica da unaparte e rispetto al filtro del mercato editoriale sulla narrativadi autrici ed autori palestinesi dall’altra.
Poi indicheremo alcune possibili direzioni per approfondireil problema della memoria nella testualità palestinese rispetto aun progetto del Centro di Studi interdisciplinare su Memorie e
8
Traumi Culturali dell’Università di Bologna. Infine accenneremo auna questione aperta: quella del ruolo di genere, nellaconnessione fra struttura sociale ed enunciazione testuale.Sottolineeremo in questo senso una differenza significativa delmaschile dal femminile e proporremo che si possa teorizzarel’esistenza di agenti diversi - e diversi agentidell’elaborazione della memoria - nel gruppo culturalepalestinese.
9
1. Finzioni testimonialiI primi quattro testi narrativi di cui parliamo - La svergognata eUna primavera di fuoco di Sahar Khalifa, Sharon e Mia Suocera e Niente sessoin città di Suad Amiry – sono scritti da autrici palestinesi chehanno vissuto e vivono tuttora immerse nella realtà delconflitto.
Ora, in questo senso, scegliere testi letterari peranalizzare un contesto culturale potrebbe essere considerato unparadosso: per sapere qualcosa della cultura palestinese bastaaprire un libro di storia. Poi bisogna pensare a cosa significhicultura in un contesto caratterizzato da un conflitto in atto eallora si potrebbe obiettare che la metodologia semiotica poneun’alternativa fra semiotica del testo e semiotica sociale: percultura nel senso del romanzesco ci sono tutte le risorseanalitiche della narratologia e si può fare un’analisi semioticadei testi in questione dai valori profondi alla sintassidiscorsiva; per considerare l’oggetto di una semiotica sociale,invece, è più utile recarsi a Ramallah e fare uno studio, adesempio, del modo in cui sono costruiti i telegiornalipalestinesi.
Ma la direzione attuale della ricerca semiotica ci invita adosare: sia perché in senso generale, come abbiamo detto, è moltocambiata l’idea della testimonianza e delle sue possibili forme,sia perché la semiotica ha iniziato a confrontarsi dal suo punto divista con l’esperienza, con l’esperienza traumatica e con certiproblemi testuali legati alla testimonianza traumatica.
In particolari circostanze culturali di scrittura, comequesta, c’è un concetto letterario, quello di autobiografia, chesfocia in un altro, quello di testimonianza. Parlare di sé assumeuno scopo di secondo ordine: si tratta di parlare di sé rispetto aqualcosa e per qualche ragione. Seguono, dunque, una serie diproblematiche che riguardano i due elementi intersecati: quellodel sé e della sua costruzione ed attendibilità con quello deltestimone, con gli stessi aspetti di costruzione e attendibilità.
Prima di vedere i testi che vogliamo esaminare dobbiamoconsiderare un versante particolare di questa questione, perché,nell’orientamento di un’analisi semiotica, la credibilità di unatestimonianza espressa in un testo narrativo è di per sé unconcetto problematico.
10
Infatti nel momento in cui identifichiamo l’elementotestimoniale in queste narrazioni nel modo in cui è resa la realtà delconflitto ci troviamo a dover discutere almeno due nozioni di naturadiversa. Una è quella di ‘referenziale’ – che costituisce untassello determinante dell’apparato concettuale della semiotica eche ha attraversato la storia di questioni fondamentali con cuila disciplina si è confrontata negli ultimi decenni; un’altra èquella di ‘autentico’, che diversamente da quella di referenzialenon è una nozione che riguarda solo il regime di costruzionedell’enunciazione testuale e presenta un intrinseco problemaideologico, o etico.
Cerchiamo di spiegarci meglio.
1.1 I concetti di referenziale e di autentico nella prospettiva
semiotica
Innanzitutto, guardare al rapporto fra testi narrativi e uncontesto culturale definito e difficile, per il modo in cui inquesti testi si racconta il conflitto arabo israelianopalestinese, significa condurre un’analisi che in senso semioticolega la dimensione testuale a quella extratestuale. Occorredunque chiarire sia l’impostazione teorica della semioticaattuale rispetto ad una teoria del riferimento sia il concetto di‘effetto referenziale’, attraverso il quale la ricerca semioticasi orienta connettendo gli elementi di un piano testuale a quellidi un piano di realtà extratestuale.
A monte della ricerca semiotica infatti c’è l’intenzione disganciare il testo dal referente, attribuendo alla dimensionetestuale uno spazio definito di ‘autonomia’, contro il vincolo diuna ‘aderenza’ alla realtà extrasemiotica, che viene ripensata intermini controreferenzialisti.
La determinazione del bisogno di liberarsi da un’impostazionefilosofico-linguistica che relegava il linguaggio a merostrumento di riflessione di una realtà già data, ha indottoalcuni rischi di una lettura errata del rapporto così rivisto fratestualità e mondo.
In una certa direzione ad esempio3 il linguaggio e lanarratività sono state intese come le uniche realtà pensabili:non ci sarebbero altro che storie che circolano, tutteequivalenti dato che tutte originate da una strategia di‘autoproduzione’ del senso.
3 Vedi per esempio Ricoeur, Greimas, 2000.
11
In realtà l’idea della ricerca semiotica che ha seguito ilsolco dello strutturalismo è piuttosto lontana da posizionisimili. In uno studio riassuntivo degli ultimi sviluppi delladisciplina, Fabbri e Marrone fanno alcune osservazioni utili ariflettere sul rapporto fra testualità ed extratestualità.Affermando che “tutto significa, insieme e a prescindere dallalingua verbale: gesti, azioni, comportamenti, riti, ma ancheoggetti, paesaggi, immagini scientifiche”, gli autori intendonoriconoscere che le cose sono già significanti e che “compito deivari linguaggi non è dunque quello di rappresentarle, e nemmenodi significarle, ma di tradurle al proprio interno, dirisignificarle con altri mezzi espressivi, di trasferirle nelproprio piano di contenuto”. Proseguono osservando che “su questoprincipio teorico di fondo, anche se con terminologie diverse, sitrovano a convergere diverse prospettive teoriche dell’attualescienza delle significazioni. Quando ad esempio Greimas parla di‘mondo naturale’, questo va inteso nello stesso modo in cui siriferisce a ‘lingue naturali’: dove naturale vuol dire né più némeno che abituale, ordinario, socialmente condiviso e irriflesso.Come non c’è niente di naturale nelle lingue così la naturalitàdel mondo è il suo essere significativo prima di ogni nostro attodi riferimento ad esso. Parlare o scrivere è tradurre in un altroinsieme di segni quel che è già stato detto. Anche il semiologorusso Jurij Lotman ha insistito su quest’idea: la cultura è unintreccio dinamico tra linguaggi e mondo, tra cultura edextracultura, laddove il mondo e l’extracultura non sono altroche il contenuto di un’altra realtà linguistica e culturale. Seci sono almeno due livelli di oggettività (uno interno e unoesterno a un dato linguaggio) è perché ci sono sempre, ineffetti, almeno due linguaggi4”.
In questa prospettiva della traduzione, la semiotica attualelegge in una luce produttiva la problematica che, in una faseprecedente, aveva originato la ‘teoria del riferimento’.
Il fatto che la testualità sottenda strutture di senso nonviene messo in dubbio, così come non viene messo in dubbio chetali strutture siano legate al senso del mondo espresso in untesto. L’interesse della disciplina è proprio quello di indagarele complesse strategie ed i vari gradi attraverso cui latestualità produce, per traduzione semiotica della realtà, uneffetto referenziale5.
4 Fabbri, Marrone, 2000, p. 179.5 La definizione di ‘effetto’ è stata l’approdo finale di un percorso che ha vistodiversi interventi teorici, attorno alle nozioni di effetto, di illusione e di impressione
12
Rispetto all’argomento di cui discutiamo, allora, sonoprodotti culturali analizzabili nei termini di un loro effetto direaltà non solo tutti i testi artistici che concernono il temapalestinese - cinematografici, letterari, fotografici - ma anchele interviste alle vittime, i reportage di giornalismo sullasituazione, i libri di storia sul Medio Oriente; questi, tutti,sono testi costruiti in una data semiosfera culturale che nemotiva le modalità di costruzione del senso. Ma si presentaproprio a questo punto la questione legata al concetto diautenticità, di cui abbiamo detto di voler discutere.
Nei casi dei testi che analizziamo infatti esiste unacondizione imprescindibile, legata alla testimonianza: il sensodi queste narrazioni è basato sulla considerazione di fondo chenessuno si sentirebbe mai libero di negare la realtà della vitaquotidiana palestinese narrata e di ricondurla a un’invenzionedelle autrici.
Quindi il problema riguarda la plausibilità del narrato einsieme l’attendibilità dell’istanza che narra, perchè latestimonianza può essere riferita sia all’autenticità dei fatti,cioè alla convinzione di leggere un resoconto fedele di certiavvenimenti, sia all’autenticità dell’esperienza dell’autricecome persona reale.
Proprio rispetto a quest’ultima idea, quella di ‘autricereale’, possiamo notare che ci sono nella storia della disciplinaquestioni emerse ben prima del confronto contemporaneo con lanarrativa di testimonianza.
Al tempo in cui la narratologia, soprattutto con gli studi diGenette negli anni Settanta, ha guardato alla teoriadell’enunciazione elaborata da Benveniste6 riflettendo sullacomunicazione interpersonale orale e l’ha volta al problema dellatraccia di chi parla nella testualità scritta7.
referenziale. L’accento sul simulacro di illusione, posto inizialmente da Barthes è corretto daRastier in impressione, che rimanda al lavoro interpretativo; l’idea di effetto è rispettoalle altre due la più dinamica ed è anche quella attualmente più usata, anche rispetto alpunto più delicato della questione referenziale: l’effetto referenziale nelle strategiediscorsive che mirano a una trasparenza rispetto al reale. Per la trattazione di unconcetto limitrofo, soprattutto psicologico-cognitivo, come quello di opacità refenziale, siveda Bruner, 1991.
6 Vedi la trattazione della teoria benvenistiana in Bertrand, 2002, capitolo terzo.7 Manetti, che compie una disanima approfondita delle teorie dell’enunciazione dalla suaformulazione ad oggi, interpreta la trattazione del concetto da Benveniste a Greimas aGenette, come il passaggio dall’interesse per una dimensione intersoggettiva a quellodell’inserzione testuale dei delegati di parola nei testi letterari. Secondo ManettiGreimas e Genette sono responsabili di una ristrutturazione completa della problematicaenunciativa, offrendo, rispettivamente, una prima teoria del simulacri, risultato di atti
13
Lo sforzo della semiotica narratologica era quello didistinguere e organizzare in senso schematico un modello dellevarie istanze della coppia narratore/narratario nella circostanzadi scrittura/lettura di un testo; in questa direzione, il lavorodi Genette e di molti altri8 è approdato a definizioni destinatea una lunga fortuna, come quelle della tripartizione frapossibilità di focalizzazione della voce narrante, o come quelladella collocazione del narratore in senso intro/extro e omo/eterodiegetico.
Ad esiti meno felici è approdata la ricerca di linee didemarcazione delle istanze di parola su diversi piani di realtà,che esulano da quello strettamente narrativo: un problemaimportante ad esempio riguarda la definizione di autoreimplicito9 e la sua specificità rispetto all’esistenza, appunto,di un autore reale. Senza addentrarsi nelle complesse sfumaturedel dibattito che ha coinvolto numerosi teorici è sufficientenotare che un problema etico è già a monte, nella scelta diammettere o meno la pensabilità di un’istanza extratestuale comemembro legittimo di una teoria della narratività.
Non a caso infatti il problema porta gli studiosi che nediscutono a considerare casi narrativi particolari, ad estendereil terreno di verifica della pensabilità delle istanze di autore
di debrayage ed embrayage, e una trattazione approfondita dei problemi di voce in untesto. 8 Molti contributi importanti vengono da studi anglosassoni, come quelli condotti daDorrit Cohn, Wayne Booth e Seymour Chatman. 9 La nozione era stata elaborata da Wayne Booth nel 1961, nella forma inglese di impliedauthor, ed era destinata ad indicare l’immagine dell’autore ricostruita dal lettore apartire dal testo. Booth distingueva fra autore implicito e narratore, ma anche fraautore implicito ed autore reale. L’idea è vicina a quella di Eco di autore modello: unastrategia di produzione testuale ricostruita dal lettore proprio come simmetricamente illettore modello è l’immagine che l’autore fa del suo destinatario, trasformandola in unaserie di mosse introdotte nel testo. I teorici che discutono in seguito questa ideasviluppano una gamma eterogenea di posizioni, fra le quali quella di Genette èesplicitamente opposta alla teoria di Wayne e presenta in modo chiaro anche alcuni altriconcetti connessi a questo: “la mia posizione riguardo all’autore implicito resta dunque,in un certo senso essenzialmente negativa. Ma in un altro senso mi piacerebbe definirlaessenzialmente positiva. Tutto dipende in effetti dallo statuto che vogliamo attribuire atale nozione. Se vogliamo dire che al di là del narratore, anche extradiegetico emediante vari indizi, puntuali e globali, il testo narrativo induce una certa idea(termine preferibile a immagine) dell’autore, diciamo un’evidenza lapalissiana, che possosolo ammettere e persino rivendicare. L’autore implicito: ecco quanto il testo ci dà aconoscere di un autore. Ma se vogliamo erigere una tale idea dell’autore a istanzanarrativa non sono più d’accordo, essendo sempre del parere che non bisogna moltiplicarele istanze senza necessità. Esiste nel racconto qualcuno che racconta: il narratore. Aldi là del narratore esiste qualcuno che scrive, responsabile di tutto il ‘suo al di qua’.Costui è, udite udite, l’autore: mi pare, come già diceva Platone, che basti”., inManetti, 2008, p. 154.
14
implicito e di autore reale oltre quello del genere del romanzodi finzione tradizionale.
Così Genette arriva ad indicare tre casi specifici in cui ledue istanze sono entrambe presenti e separate fra loro: il caso“dell’apocrifo, frutto di un’imitazione perfetta, e privo dielementi paratestuali che denuncino l’operazione”; il caso “deicosiddetti ghostwriters, ovvero scrittori che elaborano un testo perun personaggio dello spettacolo, dello sport o della politica,che se ne assumerà la paternità” e infine il caso “delle operecollettive, come per esempio i romanzi dei Goncourt o di Frutteroe Lucentini, in cui il lettore ricostruisce l’immagine di unautore unico, mentre in realtà sono più di uno10”.
In questi ‘esempi’ non si parla solo di stile narrativo, dimodi di istallare figure nel discorso, ma si fa riferimentoappunto a un problema etico, perché si confrontano il piano dellarealtà narrativa con quello di una realtà extranarrativa in basea un criterio di fedeltà.
Questa eticità, che riguarda il gesto di chi scrive un testo,è marginale rispetto al testo narrativo ‘puro’, il romanzo, che èl’oggetto degli studi di Genette; ma è un problema centralerispetto a una narrativa di testimonianza, come quella chetrattiamo in queste pagine.
1.2. Autenticità enunciazionale ed enunciativa nella
testimonianza
In un intervento recente sulla narrativa di testimonianzaVioli riflette sull’importanza appunto della ‘verosomiglianza’per quei testi che costruiscono isotopie referenziali rispetto alreale. In particolare appunto torna a proporre la doppiaspecificità della narrativa testimoniale come forma che si basasulla plausibilità dei fatti narrati e in aggiunta, o inalternativa, sulla credibilità di un soggetto testimone-autore.Nei termini del problema benvenistiano possiamo rinominare i dueaspetti come un’autenticità enunciativa e un’autenticitàenunciazionale.
Si deve notare che la seconda, l’etica dell’identitàdell’autore di cui scrive anche Genette, sembra fra le due quellapiù importante per il caso della narrativa testimonialecontemporanea.
In effetti, anche rispetto ai testi che intendiamo analizzarese venissimo a scoprire che una delle autrici non corrisponde
10 Manetti, 2008, p. 153.
15
alla ‘persona reale’ segnalata dal romanzo, sarebbe compromessaseriamente la legittimità testimoniale della narrazione.
Il primo romanzo che vedremo, Sharon e mia suocera - è l’operaprima, in forma di diario autobiografico, di un’affermataarchitetto palestinese: a livello enunciativo, non occorre che lepagine siano una riproduzione esatta della vita di Suad Amiry,purchè appunto a livello enunciazionale si possa ritenere cheesiste davvero l’architetto che vive in Cisgiordania e che hascritto un diario.
Ma anche l’autenticità enunciativa può giocare un ruoloimportante. A proposito Violi11 riflette che queste due vie dellareferenzialità sembrano rispondere a posizioni filosofichecontrapposte, e parla di un romanzo edito nel 1995, Fragments12,che fu presentato come il racconto autobiografico di un’infanziatrascorsa in un campo di concentramento. Dopo anni ed un vastosuccesso editoriale, le vicende biografiche dell’autore BenjaminWilkomirski – e persino il suo nome – si rivelarono esserediverse da quelle narrate nel romanzo. La testimonianza quindi fuconsiderata falsa e attorno all’autore dilagò una vera e propriaondata di indignazione. Per difendersi dallo scandalo,Wilkomirski si appellò alla reale tragicità dei suoi trascorsipersonali, pur diversi dall’esperienza della Shoà, e invocò unasorta di diritto ad esprimere dolore legittimo. La difesadell’autore tuttavia non era priva di ragioni: l’effetto di realein Fragments era stato ottenuto grazie anche alla minuziosadocumentazione di Wilkomirski, che possedeva un archivioletterario e documentale molto ampio sui campi di concentramento.Questo episodio è emblematico per il confronto fra un’etica dellatestimonianza enunciazionale e quella, altrettanto plausibile,dell’autenticità enunciativa di Fragments.
Per i narratologi che guardavano alla finzione pura dellospazio romanzesco, l’autentico, come questione della continuitàfra il ‘reale extranarrativo’ e il reale narrato, era ancora unproblema marginale: nel caso della narrativa testimoniale invecela questione si sposta al centro, attiene al senso stesso dellamotivazione testimoniale. La scrittura del sé è un atto dienunciazione che chiama direttamente in causa il concetto della‘verità’ e lo complica secondo le due direzioni che abbiamoappena discusso: un’etica della traccia testuale di chi scrive e
11 Giliberti, 2008, p. 205.12 Wilkomirski, 1996.
16
un’etica della traccia testuale di fatti reali, ovvero una“verità del singolo” e una “verità della vita13”.
Per chiarire in che modo rilevino nel nostro caso queste duedimensioni guardiamo adesso per la prima volta ai quattro romanziche vogliamo prendere in esame: traendo spunto dal curioso casodel testo di Wilkomirski - uno scandalo originato da una sanzioneculturale - consideriamo ora come i testi in analisi possanosollevare una questione di etica testimoniale agli occhi del loropubblico.
1.3 Etica e narrativa nelle recensioni
Per capire che cosa si intenda per effetto testimoniale in uncorpus testuale narrativo è utile guardare alle recensioni deilettori, di quanti cioè sono deputati alla sanzione etica checoncerne una testimonianza autentica.
Vediamo dunque alcune recensioni di Sharon e mia suocera, Nientesesso in città, La svergognata e Una primavera di fuoco tratte da uno spaziopopolare sul web, un blog di dibattito di temi narrativi fra ipiù frequentati. Non guardiamo a queste forme di scrittura nelsenso echiano di interpretazione – che non risponde, innanzituttoa livello filosofico, all’idea della semiotica del testo, diderivazione strutturale, che abbiamo deciso di adottare. Ciinteressa invece il problema dell’etica rispetto ai concetti ditestimonianza, di autobiografia e di narrativa di finzione:chiedendoci se e quanto l’autenticità è considerata importantenei romanzi e cercando di chiarire l’effetto referenziale dato alivello enunciativo e quello dato a livello enunciazionale.
Sharon e suocera, Se questa è vita:
(1) “Fra un coprifuoco e l’altro” Forse perché si parla sempre di scrittori israeliani, ma sonocontenta di aver letto un libro in cui per la prima voltasento anche la “voce” dei palestinesi. E la protagonista (lascrittrice stessa), non cerca mai di auto commiserarsi, maanche nei momenti di tensione fa dell’ironia. La copertinadal punto di vista marketing è perfetta: incuriosisce ecattura l’attenzione. Grimilde.
(2) “Vivere grazie all’ironia”
13 Violi, in Giliberti, 2008, p. 207.
17
Senza ironia non si potrebbe vivere sotto occupazione, eanche con quella non è facile, si tende spesso asopravvivere. La visione mi è sembrata comunque parecchioedulcorata, forse troppo. Sono stata solo una settimana neiTerritori (e nemmeno durante azioni di guerra) e lasituazione mi è parsa molto più dura. Anche il checkpoint diQualandia l’ho trovato molto più tosto di quanto raccontiSuad. Per non parlate di Gaza : ((( Da leggere, per farsialmeno un’idea si.ro.
(3) Premessa 1: se mai ha avuto senso in passato,l’equidistanza nel conflitto a bassa (?) intensità in MedioOriente è oggi una scelta a sostegno dei crimini control’umanità perpetrati dal Governo israeliano (diciamo almeno apartire dall’assassinio di Rabin). Premessa 2: esserecontrari , anche in modo molto acceso, alle politiche di ungoverno e denunciarle in quanto criminali non vuol dire averepregiudizi nei confronti della Nazione che quel governorappresenta. In quanto italiani governati da gente comeBerlusconi, ci conviene tenere separati i due concetti. Ciònon toglie però che ci siano delle responsabilità politiche.Questo libro ci dà solo un piccolo assaggio della situazionenella striscia di Gaza. La frammentarietà e la prospettivaschierata non potrebbero davvero essere state diverse, vistala genesi del libro (si tratta di un diario scrittodall’autrice per i suoi amici, ripulito e “aggiustato” per lapubblicazione.) Niente d’impegnativo: il tono è tenutoleggero e i fatti sono rapidamente collocati con riferimentialla storia recente. Alla fine resta una letturainteressante, ma niente di più. Nota curiosa: la quarta dicopertina spaccia questo testo come “scoppiettante di humour”e “irresistibile”. E’ vero che ciò che è divertente èsoggettivo, ma qui mi pare che il marketing Feltrinelli abbiaun po’ esagerato. GhostSwann
(4) Riesce ad essere esilarante e angosciantecontemporaneamente! Fantastico! Guya B.
Niente sesso in città
(5) Sono sempre attratta da un libro quando a raccontare sonodonne di una cultura diversa dalla mia…chi sono questesconosciute? Sentono come me?, amano come me?, hanno le
18
stesse passioni?, soffrono per le stesse ingiustizie?, vivonoe si raccontano alle amiche? In questo libro l’autriceracconta dieci storie di donne che periodicamente siritrovano in un ristorante di Ramallah, con in comune lamenopausa e il profondo legame con la Palestina. Raccontanodi amore, politica, guerra, sesso, famiglia con un punto divista privilegiato dovuto alla loro condizionesocioculturale, ed è un vero peccato che nonostante ciò, perstessa ammissione della scrittrice, i pensieri e leesperienze legate al sesso non possano essere narrati perchél’argomento è tabù. Il risultato è comunque piacevole edinteressante, dietro al pretesto frivolo del ritrovo per lechiacchiere di donne si cela uno scorcio di storia e diingiustizie che non hanno tempo. Schitina
(6) “donne d’eccezione ma non eccezionali”viaggiatrici, ricche, colte e intellettuali formano un gruppoche si riunisce saltuariamente in un ottimo ristorante,ovvio. Le accumuna la Palestina e la menopausa. Dellaseconda, se l'autrice non l'avesse detto apertamente, non neavrei saputo più di tanto, quando leggo un libro non mipiacciono "le istruzioni per l'uso"e la prima parte ècompletamente dedicata alle infanzie delle protagoniste permezzo di storie carine ma frammentate. Il motivo d'unione, laPalestina, della quale avrei voluto sentirne parlare con vocedi donna vissuta in prima linea, ha uno spazio riservatoall'èlite e se ne è data una spolverata zuccherosa, tipo latorta al cioccolato per il quarto compleanno. Infine non miha soddisfatta. Nut45
(7) Insieme ai racconti delle protagoniste sulla menopausa,la descrizione di una realtà tragica, di infanzie negate,vite distrutte, odio e violenza. Tuttavia non si ha l'idea dileggere un libro senza speranza. Consigliato! LaLaura
La svergognata
(8) Il precedente La porta della piazza mi era piaciuto dipiù. Sicuramente è ben resa la problematica femminile, checostituisce il motivo d'interesse del libro. Non bisognaaspettarsi molto dallo stile e dalla scrittura in sè. Tabathua
19
(9) oppressivo, angoscioso, una grande rabbia per lacondizione delle donne in molti paesi Semola
(10) Mi ha un po’ deluso. Non c’è un racconto vero e proprio,è più che altro una raccolta di pensieri e sensazioni.*Chiara*
Una primavera di fuoco
(11)“Io, palestinese, cerco pari dignità”“Una primavera di fuoco”, racconta la storia di una poverafamiglia palestinese che abita nel campo profughi di" Ein alMurgian", vicino a Nablus. Il romanzo è ambientato nellaprimavera del 2002, durante la seconda “intifada” e ha comeprotagonisti un padre e due figli che vivono in manieradiversa la resistenza e la capacità di capire il mondoebraico. Dice Sahar Khalifah «Israele deve imparare atrattarci alla pari. E gli arabi devono dimostrare al restodel mondo che sono capaci di una via concreta e moderna allademocrazia. Entrambi devono imparare troppe cose perdimostrare agli altri e a se stessi di riuscire a sostenersida soli. È un circolo "vizioso". Chi cambierà atteggiamentoper primo? Gli israeliani o gli arabi? Non ci sono risposte aquesto proposito. Lo dirà solo il tempo».E ancora: «Le vecchie generazioni hanno scelto il"fondamentalismo" come strumento di difesa della loroidentità dall’occupazione israeliana. Da qui la reazione e lalotta. Ma dalla violenza nasce solo violenza. Per questo lenuove generazioni sono ancora più arrabbiate. Vivere inPalestina è come vivere in una immensa prigione, dove non c’èmodo per risalire da un’economia in "picchiata": nella"Striscia di Gaza" abbiamo il tasso di povertà più alto,l’80%. Ma non credo che le nuove generazioni di israelianisiano meno esasperate: la differenza tra i nostri ragazzi e iloro sta nel fatto che i nostri usano le pietre, e loro learmi tecnologiche. C’è una cosa da sottolineare, però: lafede islamica per molti di questi giovani è più forma chesostanza. È più un’"apparenza", che non una fede. Gli uominie le donne nei paesi arabi spesso amano dimostrare, anchenell’abbigliamento, la loro aderenza religiosa: e in questosono alla ricerca dell’identità. Voglio dire che l’Islam èdiventato una "merce". E centinaia di sceicchi, facendo presasu questo, hanno usato la scarsa educazione di alcuni e i
20
"pregiudizi" nei confronti dell’Occidente di molti peremergere, arricchirsi, acquisire potere».… Abbiamo un paese che è di parole. E tu parla che io possafondare la mia strada su pietra di pietra. Abbiamo un paeseche è di parole, e tu parla così da conoscere dove abbiatermine un viaggio. Mahmud Darwish Babayaga
(12) “da leggere!”E’ stato uno dei pochi libri che ultimamente mi è davveropiaciuto. Sahar Khalifa, autrice palestinese, scriveveramente bene, in modo accattivante, in una storia dovetragedia, ironia, quotidianità e descrizioni paesaggistichesi fondono perfettamente. Non fatevi bloccare dalle vostreidee politiche, filo israeliani o filo palestinesi che siate,è un libro che merita di essere letto e in cui le ideedell'autrice vengono esposte in modo da non diventare verapropaganda. Estrelladelnorte
(13)“1 stellina e ½”Le storie narrate, sullo sfondo dell’escalation che portaall’assedio della residenza di Arafat e alla costruzione delmuro (con un occhio di riguardo ai ruoli sociali che spettanoalla donna), sarebbero molto belle, il finale doloroso.. maproprio non sono riuscita a farmi piacere lo stiledell’autrice. Non trasmette la tempesta di emozioni cheinvece potrebbe scatenare: troppe elucubrazioni enfatiche,ripetizioni di frasi ed esclamazioni a fronte di descrizionie contestualizzazioni quasi nulle, per cui gli avvenimentisono presentati solo attraverso le reazioni emotive deipersonaggi, che liquidano velocemente i momenti più gravi conqualche esclamazione addolorata e nulla più. Sarà questionedi gusti, ma davvero io ho trovato questa scelta stilisticapoco coinvolgente: la forza dei sentimenti ci sarebbe ma nonpassa, secondo me il lasciar descrivere quello che accadeunicamente ai concitatissimi pianti e alle invocazioniimpedisce una piena comprensione (e partecipazione) di chilegge, che spesso non si raccapezza. Aliena
Queste ‘sanzioni’ presentano diversi elementi d’interesse. Ilettori parlano innanzitutto di storie di realtà: Sharon e Mia
21
suocera14 è un “diario scritto dall’autrice”(GhostSwann), Niente sessoin città è “la storia di dieci donne”(Schitina), La svergognata è “piùche altro una raccolta di pensieri e sensazioni”(*chiara*), e Unaprimavera di fuoco è “la storia di una povera famiglia palestinese”(Babayaga).I lettori non hanno dubbi sia sul fatto che si tratti di unaserie di testimonianze sulla reale situazione di vita deipalestinesi, sia - dove i testi lo indicano - che si tratti dinarrativa autobiografica, di esperienze fatte dalle autrici.
Per quanto riguarda l’aspetto finzionale, cioè la cornice diuna scrittura letteraria, con uno stile enunciativo specifico,questo non sembra affatto ostacolare la ricezione d’informazioniche i lettori riferiscono a una realtà, semmai la scrittura ègiudicata criticamente: apprezzata o disprezzata per lepossibilità di veicolare certi effetti.
Sembrano venire fuori a proposito due tipi di atteggiamenti:in alcuni commenti si punta a parlare dell’autrice (la personareale) come testimone etnica palestinese: per esempio Grimilde(1)spiega che la scrittrice/protagonista “non cerca mai dicommiserarsi” e “anche nei momenti di tensione fa dell’ironia”.E’ chiaro qui l’ancoraggio a un’esperienza extratestuale di base,che sembra quasi quella principale: tanto che dalla recensionesembra di capire che Amiry ha composto il diario nella “tensione”della circostanza - come indica anche il titolo - sembra cheabbia scritto fra un coprifuoco e l’altro. Anche Si.ro(2) si rivolgedirettamente all’autrice, quando spiega che ha visto ilcheckpoint di Qualandia con i suoi occhi e gli è sembrato “moltopiù tosto di quanto racconti Suad”. Anche qui si ha l’impressionedi un confronto fra due persone reali; la lettrice istalla un piano diconfidenza per il quale l’aspetto narrativo ha una rilevanzasecondaria: importa prima di tutto che Suad Amiry, che vive inCisgiordania, non abbia detto la verità su qualcosa che la lettriceconosce. E’ interessante anche la scelta di Babayaga(11), che percommentare un romanzo di Sahar Khalifa usa parti di un’intervistarilasciata dall’autrice, in cui Khalifa non parla affatto dellibro, ma riflette sulla condizione di vita dei palestinesi;Babayaga riporta anche una poesia del poeta nazionale palestineseMahmud Darwish: in sostanza colloca il libro che ha letto in unorizzonte socio culturale generale dell’esperienza palestinese.
14 Esaminiamo l’edizione più recente del romanzo, che è stato ripubblicato insieme aun’altra parte di diario, scritta due anni dopo la prima stampa. Il titolo completo èSharon e mia suocera. Se questa è vita. Le informazioni biografiche sull’autrice e sulle suepubblicazioni sono in Appendice 2.
22
In altri commenti c’è una direzione opposta: si guarda allostile del romanzo, si considera cioè se sa trasmettere emozioni,se è ‘scritto bene’, e in questo senso l’autrice reale non ha troppaimportanza, è la scrittrice a contare, come responsabile del modoin cui il libro è scritto. Per Estrelladelnorte(12) ad esempioSahar Khalifa “scrive veramente bene”, in “una storia dovetragedia, ironia, quotidianità e descrizioni paesaggistiche sifondono perfettamente”. La lettrice cita l’origine palestinesedell’autrice, ma sembra essere davvero solo uno scrupolo di formaper quella che Estrelladelnorte ritiene sia il modello di unarecensione letteraria. Tabathua(8) è delusa da La svergognata,perchè “non bisogna aspettarsi molto dalla scrittura in sé”.Anche *Chiara*(10) trova che non ci sia “un racconto vero eproprio”. Invece GuyaB(4) fa una recensione entusiasta dellostile di Amiry, perché il libro “riesce ad essere esilarante eangosciante contemporaneamente”.
Il commento di Schitina(5) è sui generis, perché si concentrasull’identificazione a livello tematico: il libro è preso amodello di un confronto identitario femminile e il piacere dello staredalla parte dei personaggi si sente bene; infatti non poterne leggereracconti più intimi è un “vero peccato”: il sesso “per ammissionedell’ autrice” è “tabù”. La realtà palestinese è colta “comescorcio di storia e di ingiustizie che non hanno tempo”: perquesto non avere tempo consideriamo il commento di Schitina come ilpiù estremo fra gli apprezzamenti a livello stilistico,supponendo che la scrittrice sia stata così abile da farla perdere dentro itemi narrativi.
In tutti i commenti però i due aspetti del sentire lo stile edel guardare a com’è resa la realtà del conflitto collaborano ele due polarizzazioni sono solo possibilità. Infatti ci sonorecensioni in cui sono espressi entrambi gli aspetti, comequella, complessa, di GhostSwann(3) e quella di Nut45(6). (E c’èaddirittura chi come Schitina non sembra sentire né l’uno nél’altro aspetto).
GhostSwann fa una riflessione sull’etica politica di unlettore italiano che si voglia approcciare alla questionemediorientale mantenendosi imparziale, però parla anche dellostile “leggero” e disapprova le scelte di marketing dell’editoreitaliano. Cioè dice molto su Amiry e sul conflitto ma nontrascura il senso letterario. Nut45 fa lo stesso, criticandol’impianto narrativo e le scelte tematiche di Niente sesso in città main una specie di cornice sovraordinata di rapporto con laquestione palestinese. Nella prima riga commenta con sarcasmo che
23
è “ovvio” che delle donne (non dei personaggi) ricche e colte siriuniscano in un “ottimo ristorante” e poi dichiara che avrebbevoluto “sentir parlare della Palestina con voce di donna vissutain prima linea”.
In conclusione sembra possibile confermare che l’autenticitàè un problema rilevante anche in una testimonianza romanzata: piùvolte la sanzione culturale rispetto ai testi riguardadirettamente la loro fedeltà alla realtà storico politica, quandosi trattano spazi di scrittura narrativa solo per il loro ‘valoreinformativo’ e ci si confronta criticamente con l’autrice, comesi potrebbe fare con il regista di un reportage giornalisticosulla situazione di Gaza o con un politologo che scrivesse unsaggio sul Medio Oriente. Ancora oltre possiamo notare unelemento su cui torneremo nell’ultimo paragrafo: le dueproblematiche dell’autobiografico e del realistico, cioèdell’autenticità enunciazionale e di quella enunciativa,risultano come due aspetti di una medesima fiducia contrattuale,che si contrappone alla possibilità di guardare agli elementi difinzione letteraria ‘pura’.
1.4 L’autobiografia alla Lejeune
Una volta confermato che esiste un pubblico che culturalmenteassegna un senso testimoniale intrinseco a questa narrativa, cioèun senso etico, torniamo a occuparci dei modelli teorici che siconfrontano criticamente con tale possibilità.
Quando abbiamo accennato alle teorie di Genette sull’autorereale siamo rimasti nel campo strettamente semiotico: ma inrealtà anche la critica letteraria si è interessata di questoaspetto.
Se facciamo un passo indietro nel concetto di genereautobiografico vediamo che la narrazione del sé è un genereletterario, un oggetto di pertinenza storica delle speculazionidella critica.
Un testo a cui guarda anche Genette e che ha avuto grandediffusione proprio rispetto al modo di pensare all’autobiografiaè Il patto autobiografico di Philippe Lejeune, pubblicato in Francianel 1973 .
Qui ci sono tutti gli elementi forti di un’impostazionerappresentazionista del genere nella letteratura. Secondo Lejeunel’autobiografia si può riconoscere da un patto che il lettore facon l’autore, attraverso una forma precisa, per cui l’autore, ilnarratore e il personaggio sono la stessa persona.
24
Così l’enunciato fa riferimento in modo inequivocabile aqualcuno che vive nel mondo fuori dal testo: “Perché ci siaautobiografia (e più generalmente letteratura intima), bisognache ci sia identità fra l’autore, il narratore e ilpersonaggio15”. Poi da questa clausola Lejeune stila un elencodelle caratteristiche sostanziali del genere e dei generi adiacentiall’autobiografia: nella forma ideale un autore che voglia direqualcosa di vero su di sé deve scrivere in prosa; deve raccontarela sua storia, il percorso di una sua evoluzione; ovviamente lapersonalità narrata deve essere la sua, non quella di altri; ilpunto di vista temporale deve essere retrospettivo, uno sguardoindietro sul proprio vissuto; infine perché quest’operazione siacredibile bisogna che l’autore narri la sua voce e attraverso unpersonaggio che è ‘lui con il suo nome’.
Esistono, rileva Lejeune, altre produzioni testuali cheottengono risultati contrattuali limitrofi ma che non si assumonole stesse responsabilità. Si tratta “delle memorie”, “dellebiografie”, “dei poemi autobiografici”, “dei diari intimi”,“degli autoritratti o saggi”, “dei romanzi personali”.
Le memorie mancano del filo conduttore, del centro di unapersonalità narrata; le biografie hanno sì un soggetto unico, manon si tratta dell’autore; il poema rinuncia spontaneamenteall’effetto di realtà della lingua in prosa; nel diario intimol’autore non si preoccupa del percorso della sua coscienza neltempo; un autoritratto rinuncia al fluire sequenziale dellastoria; sopra a tutti, il romanzo personale non aspira piùall’identità fra autore e personaggio.
È interessante come nell’elaborare questo quadro Lejeuneinsista sul concetto di rigidità: ci sono condizioni più importantidi altre, in grado di offrire al lettore un metodo sicuro perrintracciare la verità del sé dell’autore di cui legge il testo.Si ammette che in questo senso ci siano degli effetti per i qualiin certi casi è possibile avvertire tracce di referenzialità.Casi per esempio in cui il lettore può “sospettare” l’identitàfra narratore e personaggio, mentre l’autore ha scelto dinegarla. In sostanza Lejeune è costretto ad ammettere che ci siauna gradualità nella narrazione del sé: ma lo fa per poter porrefuori dall’autobiografia tutti i casi simili a quelli citati, pertrattarli come falsi che assomigliano al vero.
Oltre al nome in copertina, il segno autobiografico idealeper Lejeune forse sarebbe una firma per impronta digitale, comesuggerisce il proclama referenzialista che chiude la prima parte
15 Lejeune, 1986, p.13.
25
del saggio: “Identità non è somiglianza. L’identità è un fattoimmediatamente assunto – accettato o rifiutato a livello dienunciazione; la somiglianza è un rapporto soggetto a discussioni ea infinite sfumature, stabilito partendo dall’enunciato16”.
1.5 Dalla tassonomia all’effetto
Il modello di Lejeune ha sicuramente un’utilità operativa, datoche riduce il problema ‘imbarazzante’ della realtà a una piùplausibile clausola contrattuale fra autore e lettore; pure, essosi basa su postulati filosofici classici, che il Novecento hasotto molti aspetti superato.
Di fatto il panorama critico sull’autobiografia è evoluto infretta rispetto al punto di vista di Lejeune, anche per icontributi offerti dal confronto con la narratologia: nellostesso decennio in cui usciva Il patto autobiografico, lo scrittore ecritico letterario Serge Doubrovsky conia per un proprio romanzoil termine “autofiction”: neologismo - oggetto dal 1977 di accesediscussioni - che non introduce tanto un genere letterario quantopiuttosto una nuova considerazione critica della scrittura delsé. L’idea è che un autore possa scegliere alcune strategie dellascrittura finzionale e metterle in pratica per dire qualcosa divero di se stesso.
Nel caso del suo romanzo, Fils – quello per cui Doubrovsky coniala definizione - la strategia è la rinuncia alla forma dell’‘io’per narrare in terza persona le vicende di un ‘lui’. Ma è unprocedimento analogo anche quello di sdoppiare le istanzedell’autore e del personaggio. Occorre sottolineare che si trattapur sempre di modelli teorici con cui ordinare o interpretare unaserie di fenomeni, di casi letterari che non sono certo databiliagli anni Settanta del Novecento: la scrittura finzionale esistepresumibilmente da quando esiste la scrittura; a noi interessa ilprocedere nel tempo di un orizzonte critico. In questo senso ilpunto d’origine della teoria di Doubrovsky è il collegamento conil pensiero psicanalitico post-freudiano e post-lacaniano.
In questa prospettiva l’autobiografia non può più esserevista come produzione sincera di una coscienza che ricorda; alcontrario, può solo affidarsi alla scrittura: L’Io deve lasciarsiparlare dal linguaggio, per gettare luce su un inconscio cheproprio come il linguaggio è strutturato.
Possibilità messa in pratica, fra gli altri, da un testotestimoniale fra i più forti della Shoà: Raccontami un altro mattino,
16 Lejeune, 1986, p. 37.
26
edito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1961. Qui lateoria della falsa auto narrazione di Doubrovsky dà conto dellascelta compiuta dall’autrice. L’ebrea polacca Zdena Berger,internata fra il 1941 e il 1945 nei campi di Terezin, Auschwitz eBergen Belsen, appena sedicenne, sceglie di raccontare questaesperienza in prima persona, ma attraverso la voce di unpersonaggio, che si chiama Tania. In un’intervista l’autricespiega: “Ho scelto la forma narrativa e non quella di un semplicediario per poter raccontare la verità in tutte le suesfaccettature e poter dare spazio alle emozioni17”. L’autofictionoffre un’opportunità importante al bisogno di testimoniare, nelmomento in cui svincola i contenuti psichici dall’obbligo delconfronto con la coscienza del sé; con le parole di JaquesLecarme: “affranchie des ‘censures interieures, l’autofictionlaisse une place prepondèrante a l’expression de l’incoscientdans le rècit de soi. La fiction devient ici l’outil affichèd’une quete identitarie18”. Questa definizione cioè mette in giocodei problemi che sono molto più a monte della relazionecontrattuale che fonda la teoria di Lejeune, e ha una portata cheinteressa direttamente la ricerca e la concettualizzazione delrapporto dell’autore con se stesso, in quanto soggetto psicanalitico.Infatti non mancano contribuiti di altri teorici, in particolareper quanto riguarda l’estensione del concetto. Laouyen19 adesempio lega le risorse dell’autofiction alla “discrezione totaledella vita altrui” e alle possibilità che offre al superamentodell’opposizione psicanalitica fra “reale” e “vissuto”. Lecarme,di cui abbiamo citato la definizione metaforica del finzionalenella scrittura del sé come strumento di una questua identitaria,introduce invece una distinzione fra un “senso proprio” e uno“lato” del termine: nell’autofiction in senso proprio i fatti delsé narrati sono reali, ma la tecnica narrativa e la costruzionediscorsiva s’ispirano alla finzione – mentre in senso lato si puòparlare di autofiction ogni volta che il narrare mescola memoriae immaginazione. Per Colonna20 il punto è la possibilità diproiettare il sé in un universo “in cui avrei effettivamentepotuto trovarmi, ma nel quale non sono mai vissuto”. Ma nota poiche, in effetti, sono in qualche modo autofiction tutte leautobiografie, perchè “nella confessione c’è sempre una parte difinzione”.
17 vedi Introduzione.18 Lecarme, 1992.19 Laouyen, su www.fabula.org.20 Colonna, 1989.
27
Ancora oltre nel dibattito, la critica anglosassone oppone aquella francese il termine faction21, che in qualche modo èsovraordinato a quello di autofiction. Con faction, infatti, sidesignano i testi in cui un registro finzionale si mescola a unorealistico: non solo rispetto alla verità della vita di un individuo, ma anche rispettoa fatti storici.
Però l’idea più radicale è quella di Genette22. Per lui si puòparlare di “vera autofinzione” solo quando il narrato ègenuinamente finzionale – come nel caso della Divina commedia, odell’Aleph di Borges: “i testi che si basano su avvenimenti realinon sono dunque che false autofinzioni”.
E’ interessante considerare anche un lavoro più recente, nelquale uno studioso a cavallo fra semiotica, critica letteraria ecognitivismo critica l’impostazione di Lejeune. Nel lavoro diEakin23 si considera l’autobiografia per il suo valore diperformance del sé: per l’autore la “scrittura di vita” serve aconfermare un dato tutt’altro che scontato dell’esperienza: la propria unicità. PerEakin allora l’io narrativo che funziona come cerniera per ilreperimento della persona reale nel patto autobiografico è soloun’“illusione ottica”, una “creatura della finzione”.
Citiamo la considerazione per esteso: “Given the face-offbetween experimental account of the I, on the one hand, anddecostructive analyses of the I as illusion on the other, my owninstinct is to approach autobiography in the spirit of ananthropologist, asking what such text can teach us about the ways in whichindividuals in a particular culture experience their sense of being I [..]24”.
21 Il termine compare nei primi anni Settanta, insieme allo scandalo del romanzo cult diTruman Capote, A sangue freddo (è lo stesso Capote a introdurlo, con un neologismo chefondeva i termini fact e fiction). Da qui entra nell’uso comune della critica letteraria,per dare un nome a forme di narrativa che rispondono all’idea – nel corrispettivoitaliano – di “romanzi – verità”. Per una trattazione recente nella critica anglosassonesi vedano Olin-Sheller, Tentberg, 2010, e ConollyBashshar Haydar, 2008. Per un buonriassunto del tema e del problema di A sangue freddo e dell’intenzione di Capote rimandiamoal blog “Critica Letteraria”: http://criticaletteraria.blogspot.com. Oggi il concetto è usato anche nella discussione delle forme ibridate dei prodottitelevisivi; uno dei primi impieghi in campo visivo, non per la televisione ma per ilcinema, è stato per Shindler’s list di Steven Spielberg. Nella narrativa italiana possiamo pensare a Gomorra, di Roberto Saviano, come un esempiodi faction contemporanea. Un fatto degno di nota, però, è anche che il web pullula diblog in cui si trova una certa sensibilità ‘stanca’ nei confronti della riflessione dellacritica letteraria, anche negli orizzonti più recenti; il lato critico teorico sarebbeun’orticaria accessoria a un’irriducibile libertà creativa del gesto di scrittura. Uno fra molti, chemotiva in modo ironico e intelligente questa posizione è “Letturalenta”:http://letturalenta.net/2006/06/cosa-deve-essere-la-narrativa/#more-136. 22 Genette, 1991, p. 22. 23 Eakin, 1999, p. 12.24 Eakin, ibidem.
28
L’idea dell’identità costruita grazie alla sua narrazione è unapprodo molto vicino alla riconsiderazione semioticadell’autobiografia, che si può seguire negli Atti di convegno del2008, centrato proprio sul rapporto semiotico fra testualitàfinzionale e testimonianza. Nell’introduzione Gianfranco Marroneriflette sulla necessità di ripensare il rapporto fraautobiografia e verità: “se in linea di principio si dà il casodi testi autobiografici che programmaticamente costruiscono uneffetto di finzione, qualcosa come una costitutiva inautenticità,occorre andare in cerca di quelle narrazioni nelle quali, inlinea di fatto, il narratore si pone più o meno esplicitamentenella posizione di chi scrive di sé dando a vedere, in un modoqualunque, che non proprio di sé si tratta – e forse, anche, nonproprio di scrittura25”.
Ora il fatto è che una visione simile non è priva di aspettiproblematici. Rimossi i confini di una tassonomia, ma pur semprenell’interesse di un’analisi di valore applicativo sul mondoreale, quello del senso prodotto dai testi, il nuovo quesitodiventa definire i confini delle diverse strategie.
L’idea più attuale è quella di “narrativa di testimonianza”.E’ anche l’idea più adatta per considerare i testi di Khalifa eAmiry come testi simili, o equivalenti - in un senso molto diversoda come intende Lejeune - visto come sono intesi nei commenti deilettori. Si tratta di pensare a un continuum referenziale su cuicollocare testi autobiografici espliciti insieme ad altriimpliciti, ambigui, ammiccanti e indefiniti. Questo concetto dinuance in sostanza supera sia la problematica di cui abbiamodetto rispetto al confine fra le strategie, sia ancora primal’orizzonte teorico della rigidità lejeuniana. Marrone propone distudiare il senso abbandonando l’idea di opere autobiografichevere e false e guardare semmai a testi autobiografici, che “produconoentro contesti culturali e assetti sociali dati di volta involta, ora un effetto di senso ‘verità’, ora un effetto di senso‘finzione’ sul loro pubblico26”.
1.6 Finzione e autobiografia nei testi
Sharon e mia suoceraOra però dobbiamo ripercorrere la teoria, guardando finalmente aitesti: discutiamo per ognuno aspetti dei ‘sensi autobiografici’di cui abbiamo parlato.
25 Giliberti, 2008, p. 12.26 Giliberti, 2008, p. 11.
29
Hanno un tratto comune i romanzi di Suad Amiry, Sharon e miasuocera e Niente sesso in città.
In tutti e due la clausola dell’identitàautore/narratore/personaggio sembra rispettata: il narrato è ilvissuto dell’autrice, Suad Amiry ed è sua anche la voce narrante.Il lettore trova un’identità esplicita: c’è una persona che sichiama Suad Amiry, questa come si può leggere nel paratestobiografico in quarta di copertina è architetto e vive a Ramallahin Cisgiordania; quella donna è l’autrice del testo, lo dichiarala firma sulla copertina.
Il collegamento fra autrice e personaggio è la prima personanarrativa: la prima frase di Sharon e mia suocera è infatti “Hoscritto ‘Sharon e mia suocera: diari di guerra da Ramallah,Palestina’ durante le ripetute invasioni di Ramallah da partedell’esercito israeliano, tra il 17 novembre 2001 e il 26settembre 2002, data in cui gli israeliani si sonodefinitivamente ritirati dalla Muqataa, il quartier generale diArafat”. Ugualmente autobiografico l’incipit di Niente sesso in città.“Quando mio padre è morto – il 15 dicembre 1978 – mi sono sentitamolto triste, ma anche turbata, al pensiero che non fosse vissutoabbastanza da fare ritorno nella sua casa di Giaffa, Palestinapre-quarantotto”.
Se stabiliscono un collegamento enunciazionale forte, però idue testi si caratterizzano per una costruzione discorsivatutt’altro che canonica. Nelle recensioni sul blog, di cuiabbiamo riportato alcuni esempi, Sharon e mia suocera spesso èdefinito con aggettivi come ludico, leggero, ironico; questodipende dalla scelta di uno stile informale. Qui la tipicastruttura temporale progressiva del diario è sparita: i capitoli,tutti segnati dalla data, costruiscono una serie di salti neltempo e l’autrice dal presente torna a un passato remoto, perdedicare subito dopo una parte ampia alla cronaca serrata dipochi mesi d’assedio, e poi nuovamente saltare indietro, aricordi precedenti di un decennio.
Inoltre nella formula classica del diario c’è una sola vocenarrante, mentre qui l’enunciazione spesso è a carico di altripersonaggi: Amiry riporta lunghi dialoghi con amici, con vicini,con il marito.
Un caso particolare è il monologo del padre di Suad, cheriportiamo in appendice, in cui l’uomo ricorda il tentativo dientrare nella vecchia casa della famiglia a Jaffa, abbandonatanel 1948 e rioccupata da una famiglia israeliana27. In questa
27 Estratto 1. In Appendice.
30
parte la forma del dialogo offre la percezione della coscienza diun altro soggetto. Una percezione così vivida che la voce delpersonaggio quasi sostituisce quella dell’autrice. Si è moltovicini cioè ad evadere dalla scelta della narrazione afocalizzazione interna28.
L’informalità riguarda anche lo stile: se il diario prevedeun registro inner, basato sul dirsi, sulla riflessione con sestessi, qui troviamo innesti di moduli comunicativi di tipo moltodiverso; moduli che sembrano mutuati in certe pagine da modelliteatrali, come quelle in cui il testo è costituito da unasequenza serrata di scambi di battute punteggiati da fulmineicommenti dell’autrice; o mutuati dall’informazione giornalistica,come ad esempio quelle in cui Amiry racconta dellamanifestazione, in piena Intifada, delle donne di Ramallah percelebrare la festa della donna per l’8 marzo: pagine cioè chedocumentano in modo dettagliato eventi ed epoche della storiapolitica e militare del conflitto.
Amiry sfrutta l’ironia per sovrapporre ininterrottamente ivari codici.
In appendice riportiamo un passaggio particolare, in cui Suadparla con una leonessa nello zoo di una città lungo il muro diseparazione israeliano dalla Cisgiordania29.
Abbiamo l’innesto di un elemento di finzione pura su un’isotopiareferenziale, su una serie di luoghi e persone ancorati alcontesto extratestuale della vita di Suad Amiry in Cisgiordania.
L’autrice ha aperto parlando di un luogo reale: “Kalkilya, unacittadina a circa cinquanta chilometri a nord di Ramallah”, dovesi trova per un motivo storico-politica reale, “scortare LeilaShashid”, “la delegata generale della Palestina in Francia” che“voleva vedere con i propri occhi il peggiore degli scenariprodotti dal muro si separazione”.
L’effetto referenziale è rafforzato ancora, perché undelegato del municipio indica alle due donne i quattroinsediamenti ebraici che cingono Kalkilya - Egal Alef, Egal Beit,Sufin e Alfeh Manashesh - costruiti prima dell’edificazione delmuro, in quella che adesso è la parte palestinese; e le informache “il 45 per cento dei terreni e 19 dei pozzi d’acqua dellacittà sono ormai irraggiungibili”, perché “dall’altra parte delmuro”.
Ma nel paragrafo successivo a questo rapporto si apre lospazio magico della conversazione fra l’autrice e la leonessa.
28 Genette, 1986, p. 31.29 Estratto 2. In Appendice.
31
Questo innesto ci porta fuori dal quadro della giusta rappresentazionedella realtà.
Si può dire che il valore testimoniale è svalutato dalfantastico? Dall’effetto sui lettori del blog di Anobii sembraproprio di no; la descrizione del paesaggio intorno alla città,punteggiato di insediamenti israeliani, non è meno vero perchéseguito da una scena irreale.
Niente sesso in cittàIl rapporto con la clausola identitariaautore/narratore/personaggio di Lejeune si complica per Niente sessoin città. Anche qui c’è narrazione in prima persona, ecorrispondenza fra personaggio principale e autrice, ma lacostruzione discorsiva mette in scena una serie di altre vocinarranti, incastonate a interrompere il fluire di quellainiziale.
La prima parte di Niente sesso in città è una sorta di autoritrattolibero in cui Suad riflette sulle motivazioni che l’hanno portataa scrivere delle amiche: “perché in loro si esprime in parte ciòche sono e in parte ciò che mi sarebbe piaciuto ma non sonoriuscita ad essere30”. Il libro parte dal dato politico dellavittoria elettorale del partito di Hamas alle elezioni del 2006,che per Amiry è altamente drammatico; è la fine di un’epoca e diuna generazione di donne politicamente attive, laiche edemocratiche, della quale Suad si sente parte assieme alle amichedi cui scrive. Qui la motivazione testimoniale è programmaticatanto quanto - e forse ancor più che in Sharon e mia suocera. Ma comeha fatto per il dialogo con la leonessa e la situazione diKalkilja, qui Amiry tiene insieme: “le mie inquiete amiche inmenopausa e la mia non più amichevole Palestina, ovvero quellache di proposito ho deciso di chiamare ‘Palestina climaterica’31”.
Poco dopo la voce narrante di Suad è sostituita in modoabbastanza brusco da quella di un’amica, che comincia araccontare storie della sua infanzia. Il passaggio apre uncapitolo che ha per titolo il nome della protagonista, Olga. Ascandire il flusso delle immagini, una serie di date, come in undiario. La struttura si ripete, dando voce a seguire a Jamileh,Lena, Ann e Reem.
L’unico elemento di discontinuità è nella storia di Ann,perché è narrata in terza persona. Per il resto tutti i raccontisono saldati a livello tematico; in tutti c’è la specificità
30 Niente sesso in città, pagina 11.31 Niente sesso in città, pagina 13.
32
dell’essere bambine, nel racconto dell’educazione da femmine, e intutti c’è il conflitto mediorientale che si abbatte in modoimprevedibile sulla vita personale dei personaggi.
Guardiamo due passaggi. Nel primo32 Maya, architetto come Suade direttrice del Dipartimento Costruzioni di un’aziendainternazionale, ricorda il ricevimento per sole donne dato da suamadre nella casa di Nablus, all’epoca in cui era adolescente. Loscopo di questa riunione era permettere alle donne adulte diselezionare la sposa più adatta per i propri figli maschi,valutando la bellezza e l’abilità nel ballo delle figlie portateda ogni madre. Se la giovane sposa potenziale aveva successo, erala suocera stessa ad avviare dopo poco il fidanzamento dellaprescelta con il proprio figlio.
Nel secondo, il tema è ancora un matrimonio, ma un matrimonioimpedito da un attentato terroristico con esiti drammatici33.Fadia è ad Amman per il matrimonio della giovane nipote, quandoun attentatore suicida si fa esplodere nell’atrio dell’hotel dovesono raccolti gli invitati: il futuro sposo perde la vitanell’esplosione.
Poi Amiry riprende la parola e apre un terzo tempo dellanarrazione. Si tratta della cronaca di una scena d’insieme, lacena mensile a cui le amiche prendono parte in un eleganteristorante di Ramallah. La narrazione ci informa dei pensieri diSuad, fra un frammento e l’altro delle conversazioni dellecommensali. Una costruzione discorsiva già molto sofisticata siarricchisce ancora: in un contrappunto marcato alcune parlanodegli acciacchi dell’età mentre in un'altra parte del tavolo c’èun dibattito politico su Hamas. Le amiche sono membri dell’eliteculturale palestinese, con uno status socioeconomico elevato e iltratto comune di un impegno politico ventennale.
Bisogna notare una differenza con Sharon e mia suocera, perchéoltre una narrazione informale del sé qui il gioco è il passaggiocontinuo da una dimensione pubblica ad una privata: dai modi edalle forme standardizzate del saggio a quelle introspettive deldiario, dal presente a una scomposizione di passati. Dal datopolitico del risultato elettorale alla caricatura di temifemminili come la moda, la chirurgia plastica, l’instabilitàemotiva.
32 Estratto 3. In Appendice.33 Estratto 4. In Appendice. Il riferimento storico è quello dell’ attentato suicida diAl Queda in Giordania: il 9 novembre 2005 ad Amman tre terroristi si fecero esplodere inaltrettanti affollati hotel del centro, uccidendo circa sessanta persone e ferendonediverse centinaia.
33
L’ambiguità riguarda anche nella chiusura del testo. L’ultimapagina s’intitola “Ringraziamenti” e sembra un paratestostandard, ma in realtà è lo spazio di una confessioneenunciazionale: Amiry spiega che a scrivere è sempre stata lei,con le voci delle amiche: “Alcune mi hanno dato via libera pur nonessendo del tutto a loro agio con il mio modo di distorcere le loro storiepersonali e quelle dei loro cari…mi scuso in particolare con le mie amichele cui storie, per ragioni di spazio, non sono state incluse inquesto libro. Ma non c’è il tre senza il quattro…34”.
Come consideriamo queste infrazioni, questi movimenti liberifra le forme, per il problema teorico della testimonianza?Affermiamo che la costruzione discorsiva in Sharon e mia suocera e inNiente sesso in città accentua l’effetto di reale: all’opposto dellaverità rappresentazionale, è proprio il letterario a svolgere unafunzione chiave.
Diciamo che il letterario nei due testi ha il potere di faredella narratrice una testimone caricata, cioè enfatizzata. In Sharone mia suocera l’esperienza della protagonista nella Cisgiordaniaoccupata viene evidenziata dalla performance enunciativa dellascrittrice: si fondono le modalità di un /essere soggetta a/ e diun /essere capace di/, abbiamo un’eroina-testimone.
In Niente sesso in città, invece, il punto è il respirotestimoniale; la messa in voce di più soggettività si salda conla doppia tematica politica/femminile: ne risulta una realtàtestimoniale allargata, nell’incrociarsi di numerosi soggetti con unvolere condiviso, sembra di leggere la storia di tutti i palestinesi.
Ritornando alle prospettive teoriche che abbiamo toccatoquesti sono esempi di autofiction; in particolare sono esempi diquello che Lecarme chiama dimensione dell’autofiction in sensoproprio, perché i fatti del sé narrati sono reali, ma la tecnica narrativa e lacostruzione discorsiva s’ispirano alla finzione e richiamano anche leosservazioni di Colonna sulla possibilità di proiettare il sé inun universo in cui avrei effettivamente potuto trovarmi, ma nel quale non sono maivissuto.
La svergognataQui le cose stanno in modo molto diverso. Innanzitutto laclausola autobiografica di Lejeune non è più valida: laprotagonista non si chiama Sahar, è un personaggio di nome“Afaf”.
34 Suad Amiry sta parlando di tre testi perché considera Sharon e mia suocera e Se questa è vitacome pubblicazioni distinte, mentre, come abbiamo sottolineato nella nota 3 a pagina 8,qui viene analizzato come unico testo l’edizione recente che li contiene entrambi.
34
Eppure le vicende narrate riproducono sotto molti aspettil’esperienza di vita dell’autrice: quella della segregazionedomestica della protagonista, lontana dai suoi affetti in unpaese straniero, dove vive per tredici anni, dopo aver sposatoper volere della sua famiglia un uomo gretto e violento; e poiquella di una nuova autonomia, dal momento in cui riesce adottenere il divorzio e torna in Cisgiordania, per la prima voltapadrona di se stessa e delle proprie scelte.
Diversamente dal caso di Amiry qui manca la corrispondenzafra identità della protagonista e nome con cui è firmata lacopertina; ci sono dei segnali negli apparati testuali però chepossono chiamare a una fiducia referenziale. Il primo è il sottotitolodel romanzo: il nome completo recita “La svergognata. Diario diuna donna palestinese”. Ci viene data un’informazione sul generedel diario..genere che di solito sfrutta il materiale offerto dauna vita reale.
Bisogna dire anche che fra i tre testi questo ha la forma piùclassica, nell’ordine proprio di un diario: la narrazione èintima, interrotta solo di rado da dialoghi con altri personaggitutti peraltro sfuocati rispetto alla soggettività di Afaf, verofilo conduttore del procedere del racconto. Questo stilediscorsivo risponde a uno dei requisiti di Lejeune, la funzioneautobiografica come “la storia di una personalità”. C’è anchequella di una visione retrospettiva; anche se lo svolgimento nonè lineare, progressivo - ma anzi è quello di una riflessionedisarticolata che in certi punti si basa sulla reiterazioneossessiva di certe immagini, Afaf scrive dal presente, ricostruendogli eventi del passato. Oltre a questa traccia didascalica di“diario” un altro segnale è nel sommario in quarta di copertina:qui chi legge può notare gli elementi comuni fra narrato evicende biografiche di Sahar Khalifa. Diciamo che questo è unromanzo, ma con elementi non finzionali, per i quali è plausibileimmaginare che ogni lettore senta trattarsi, almeno in parte, discrittura autobiografica.
Questa ambiguità referenziale sarebbe per Lejeune pur sempreun inganno da parte di Sahar Khalifa – o del suo editore – neiconfronti di chi legge; ma se si lasciano gli schemi di Lejeune esi guarda all’orizzonte della critica letteraria definita post-moderna, la prospettiva si ribalta proprio rispetto a questo frai quattro testi. Infatti, è proprio la ‘questua identitaria’ dicui parlava Lecarme a strutturare il senso in La svergognata. Unaricerca di sé autorizzata dal finzionale, nell’ordine della
35
cancellazione fra reale e vissuto in senso psicanalitico, comesuggerisce Laouyen.
E’ centrale l’effetto di straniamento dalle regole e dalleconvenzioni stabilite: la protagonista narra con una stranaprospettiva a rovescio, o meglio narra quelle convenzioni comeschiacciate sullo sfondo di un reale confuso e molteplice. Afafnon può aderire al quadro normativo che le è destinato in quantodonna e si racconta nella ricerca ininterrotta di una sanzionealternativa. Il passaggio riportato in appendice35 è una dellemolte riflessioni sul passato e sull’infanzia che costituisconoun flusso per tutta la prima metà del testo. Qui è difficileparlare di coscienza. In una sequenza sconnessa Afaf rievoca lecircostanze della sua nascita e le lega a un altro raccontoprecedente di molte pagine: quello dell’invito rivolto dallalevatrice ai bambini di casa ad aspergersi con l’urina di unbambino maschio appena nato. Una rappresentazione surreale rendecioè il senso dell’inferiorità femminile. Il sentire di Afaf èbizzarro e scorretto per la comunità, che la scomunica dallacondivisione valoriale, “vomitandole addosso”. Afaf è bloccatanell’impossibilità di liberarsi dalla condanna ed è quindicostretta a richiamare la violenza delle “loro azioni” su di lei,al punto che ‘essere ciò di cui è accusata’ diviene l’unico modopossibile di pensare a se stessa.
Alla fine del romanzo la voce è ancora quella di unasoggettività tutt’altro che univoca, ancora ‘mal funzionante’,che però ha compiuto un percorso significativo scagionando leproprie percezioni e arrivando a considerare la moraletradizionale altrettanto bizzarra.
Anche l’osservazione di Eakin che abbiamo citato ha un incisofinale che interessa il caso di Afaf: asking what such text canteach us about the ways in which individuals in a particularculture experience their sense of being ‘I’ – and in some instructivecases that prove the role, their sense of not being ‘I’ ”. Il fatto che ilpersonaggio non sia mai del tutto cosciente di sè, chel’inconscio continui a mantenere aperto il canale del dubbio, faparte della strategia finzionale della narrazione, nel senso chesembra quasi che sia la scrittura a dare questa forma particolareal sé. Per i testi precedenti si è parlato di un dispositivo incui la finzione carica la testimonianza: possiamo pensare quiall’opposto a una narrazione scaricata, o depotenziata. L’effettoreferenziale, l’attendibilità del narrato come vera vicendabiografica dell’autrice, non è inferiore a quello che Amiry
35 Estratto 5. In Appendice.
36
ottiene in Sharon e mia suocera e Niente sesso in città, solo, se in quellila strategia discorsiva è basata sull’enfasi della voce narrantequi Khalifa fa una scelta simile a quella di Zdena Berger.
La coscienza del personaggio non si può mai identificare concertezza nell’autrice stessa; questo genera un realismodell’evanescenza: è come cioè se l’elemento di finzione aprisseuno spazio in cui la verità della vita si fa più cruda, perchéallucinatoria. La coincidenza mancante fra la firma sullacopertina e il nome della protagonista è uno spazio virtualeaperto, dentro cui la verosimiglianza continua a echeggiare.
In sintesi, in una prospettiva semiotica contemporanea checonsideri il senso autobiografico come una direzione particolaredell’efficacia comunicativa di un testo – in questi tre casi ilnarrativo sostiene il reale. Il sé è una scelta strategica cheproduce effetti, effetti di vero, esattamente come sono effettiquelli ottenuti scomponendo il carico enunciativo fra narratore,autore e personaggi.
Una primavera di fuoco Qui arriviamo a un versante diverso del problema, comesuggeriscono anche le definizioni dei lettori del blog, cheparlano sempre di “storie” o di una “storia”, cogliendo lacornice di riferimento di un testo finzionale. Questo infatti pertutti i punti toccati finora non è un’autobiografia, ma anzi hal’impianto di un romanzo tradizionale e il punto di vista èquello di un narratore onnisciente.
Una primavera di fuoco è una sorta di saga familiare attraversole vicende di due fratelli, nell’arco degli anni precedenti esuccessivi all’erompere della seconda Intifada del 2002. Lanarrazione è divisa in due parti: la prima narra vicende dellafase iniziale della sollevazione popolare, la seconda quelle delmomento di massima aggressività della reazione israeliana, conl’assedio del quartier generale dell’Autorità Palestinese aRamallah. I due protagonisti - il timido Ahmad e l’irruento Magid– sono, con le parole di Khalifa, “artisti”. Ahmad affianca allapassione per il disegno il talento per la fotografia, grazie aduna macchina fotografica digitale regalo del padre giornalista.Magid è il cantante di talento di una band che ha fondato conamici studenti all’università: sogna di ‘arrivare’, di far partedi un mondo di agio e di successo, magari sfondando sul mercatodiscografico occidentale. Entrambe le prospettive subiscono unostravolgimento: Ahmad nelle ultime pagine è fedayn suicida, Magidun politico in carriera nelle file corrotte della dirigenza
37
dell’Autorità palestinese. La narrazione intreccia i due destinia quelli di un’altra serie di personaggi – familiari e amici deiprotagonisti - con un’attenzione specifica per i personaggifemminili.
Il romanzo ha una trama molto densa e un incedere narrativoincalzante; sequenze narrative complete s’inseriscono l’unanell’altra in una costruzione complessa di prove greimasiane, conuna quota di azione per cui potremmo parlare di un classicoromanzo di avventura.
Eppure un congegno finzionale regolato come questo non èprivo di valore documentale, perché c’è comunque lo spazio dilegittimità per due domande che non hanno senso al di fuori diuna narrativa di testimonianza, domande sul valore di autenticitàdel narrato.
Viene da chiedersi, infatti, a chi appartenga la vocenarrante in Una primavera di fuoco e viene da chiedersi poi a qualescopo questa istanza narri: il peso di questi interrogativi èraccolto da una breve postfazione.
In una pagina intitolata “Ringraziamenti”, Khalifa scrive“Sono riconoscente alle donne di Hush al- ‘At’ut della cittàvecchia di Nablus che mi hanno spalancato le loro memorie comefinestre da cui affacciarmi sull’esperienza e sulla realtà deifatti. Se non fosse stato per i loro racconti, colmi diparticolari e di sentimenti profondi, non sarei stata in grado dicogliere l’atmosfera e di rappresentare la tragedia”. Ora ilcentro d’interesse di questo inciso non è l’autenticità – in unaverifica secondo il precetto lejeuniano – dell’intervista diSahar Khalifa alle donne di Nablus; verifica, che, in quantopreclusa al lettore, ricondurrebbe il testo all’idea ditestimonianza ‘falsa’. E’ rilevante lo stesso attoenunciazionale: un richiamo che l’autrice rivolge al lettoreagganciando la realtà alla finzione.
Riprendiamo il dibattito che è seguito alla definizione diDoubrovsky: se volgiamo il concetto di faction e il punto divista di Genette al problema della testimonianza, non èinappropriato parlare di un valore testimoniale anche per Unaprimavera di fuoco. L’autenticità dell’intento documentario diKhalifa infatti non è in questione, perché è garantita dallaricongiunzione fra l’istanza della narratrice e quelladell’autrice, che troviamo nei ringraziamenti.
E’ vero che paratesti sono frequenti anche nei testigenuinamente finzionali come quelli di Borges: postfazioni,glosse, note, spazi collaterali che il narratore usa per
38
accreditare la verità dei fatti che racconta. Ma in quei casi ilriferimento è a un piano di pura realtà narrativa: l’enunciazione finzionaledispiega un potere fantastico - quello della produzione didimensioni sur-reali potenzialmente infinite – di cui Una primaveradi fuoco è invece privo. Quest’ultimo è una falsa autofiction allaGenette, perché quello che lo contraddistingue è l’ancoraggioalla testimonianza etnica della biografia della sua autrice.
Lo possiamo allora opporre ai tre testi precedenti per unaspetto: qui il dato storico si sovrappone al letterario, e nonviceversa.
In Sharon e mia suocera il lettore sa di leggere la storianarrata dell’architetto palestinese Suad Amiry, che in unpassaggio immagina di parlare con una leonessa; in Niente sesso incittà al lettore si apre l’esperienza della vita tragica delleamiche dell’architetto palestinese Suad Amiry, che probabilmentesono state romanzate dall’autrice; in La svergognata il lettore èpiuttosto certo di trovarsi di fronte alla confessione dellascrittrice Sahar Khalifa sul suo matrimonio, anche se questascrive senza usare il suo nome. In Una primavera di fuoco la finzioneromanzesca è pura, fin dalle prime pagine, e la voce di chi narranon ha nessun rapporto con l’identità dell’autrice del romanzo.E’ solo attraverso la postfazione che l’autenticità di SaharKhalifa come testimone in prima persona di quello che c’è nellibro riceve la prima convalida.
Però rispetto al loro valore di testimonianza i testi sono tuttiin grado di produrre un l’effetto di realtà: dalla tassonomia di Lejeune cioèle cose si sono in qualche modo semplificate.
1.7 Una proposta
Concludiamo con un interrogativo che riguarda la differenza dicui abbiamo detto, fra autenticità enunciazionale ed enunciativa.Ne abbiamo parlato come di due prospettive filosofichedifferenti.Ma la questione, forse, è meno spinosa di come sembri: nonpotrebbe trattarsi di due dimensioni di senso che si organizzanonel caso di qualsiasi testo referenziale rispetto alla realtà, diqualsiasi testo realistico – non potrebbero essere i dueattributi dello spazio della narrazione di faction?
Quando abbiamo parlato del caso di Wilkomirski non abbiamodisgiunto la questione in due problemi diversi, non ci siamochiesti cioè se l’autenticità enunciativa del suo testo
39
risultasse da un’efficace espressione del dolore o dal fatto chel’autore fosse molto ben documentato.
E quando parliamo di autenticità enunciazionale ci riferiamoal fatto che Khalifa è palestinese o al fatto che ha soffertocome palestinese? E quanto all’uno o all’altro?
Ritroviamo la percezione di questo problema, ad esempio, nelcommento di Aliena(13). La lettrice si lamenta dell’autenticitàenunciativa in Una primavera di Fuoco: indica una descrizioneeccessiva del sentimento del dolore, che secondo lei era superflua, eche sarebbe stato più efficace sostituire con una maggiore quantità di dettagli.Ovvero con un’autenticità enunciazionale? Non proprio. Aliena nonchiede che Sahar Khalifa parli di più di sé come testimone delconflitto (autenticità enunciazionale) ma solo che parli più delconflitto e meno del dolore che questo provoca: chiede qualcosache è ancora solo sul piano enunciativo.
L’aspetto a cui probabilmente si riferiva Aliena si coglienel passaggio topico di Una primavera di fuoco36, la conclusione.
E’ la scena in cui uno dei protagonisti, Ahmad, prende partea una dimostrazione pacifista che si svolge ai piedi del muroeretto dagli israeliani per separare la Cisgiordania da Israele.Con una strategia che esclude mezzi termini gli israelianidemoliscono le case palestinesi sul perimetro destinatoall’avanzamento del muro.
Una ragazza inglese, che partecipa alla manifestazione, muoretravolta dal bulldozer israeliano a cui cerca di opporsi; Ahmad,che lavora come autista di un’ambulanza, tenta inutilmente disoccorrerla e dallo shock viene un raptus suicida: nelle ultimerighe il protagonista si scaglia con l’ambulanza contro i soldatidel posto di blocco israeliano.
Il nome del personaggio della ragazza uccisa è “Rachel”; ilrichiamo è, con ogni probabilità, alla persona di Rachel Corrie,giovane pacifista inglese, che nella primavera del 2002 subì unasorte analoga a quella narrata mentre partecipava a unamanifestazione in Cisgiordania contro il muro. Questo è unriferimento biografico che Sahar Khalifa fa alla vita di qualcunofuori dal testo - non alla sua – ed ha un valore testimonialeequivalente ai dati narrativi che Wilkomirski era in grado difornire traendoli dalla propria documentazione sulla Shoà.
Ma nel paragrafo che precede questi eventi - lo riportiamo inappendice - Khalifa rende la mostruosità delle ruspe israelianecon lo sguardo sconvolto di Ahmad. E’ un passaggio di fortelirismo: Khalifa si rivolge con un ‘noi’ alla sensibilità di
36 Estratto 6. In Appendice.
40
tutti i palestinesi; di quanti dall’esilio hanno sognato labellezza degli aspri paesaggi di quel territorio e di quanti “acausa della Storia37” sono stati privati di tutto e che nonpossono trovare nessun senso nei valori che animano i pacifistioccidentali; per i palestinesi la sofferenza satura l’orizzonteesistenziale e non esiste nessun’altra dimensione, “né ambiente,né ozono, né umanità”.
Rispetto a Sharon e mia suocera dove l’effetto di verità è datodal riferimento alla vera vita di Amiry, e quindi è enunciazionale, inUna primavera di fuoco l’effetto è passato ad essere offertodall’intensità delle vicende narrate, su un livello enunciativo.
Ma questo riformula la differenza fra il referenziale deidati del conflitto e il narrativo delle vicende narrate, perchéquesti due elementi riguardano solo l’enunciato (perlomeno fino allapagina dei ringraziamenti): dato che non c’è nessun personaggioche corrisponda alla persona dell’autrice Sahar Khalifa, si possonocredere solo le cose narrate, come testimonianze in sé di quelloche dicono.
I testi possono parlare del conflitto con un aggancioreferenziale (sul piano enunciativo), per esempio ammiccando allavera storia di Rachel Corrie, oppure possono descrivere in modoefficace il dolore che provoca, come avviene con la storia delraptus suicida di Ahmad e con l’inno alla bellezza del paesaggiodistrutto dai bulldozer.
Ora la questione può essere riproposta così: se c’è un gradozero referenziale - pur sempre culturalizzato38- ma dato, seassumiamo che ci siano il conflitto, la menopausa, la societàmusulmana e le donne, perché non ammettere che la distinzione fra‘vero’ e ‘falso’ è una categoria ineliminabile di qualsiasi testoreferenziale, e che l’autobiografico introduce solo un piano in più sucui proiettare il riferimento? Infatti abbiamo visto che anchedove non c’è autobiografia, gli effetti di vero e falso sibiforcano di nuovo sul piano enunciativo, nella distinzione coltada Aliena fra referenziale e letterario emotivo.
Ma allora i tipi di effetto di un testo sono davvero unproblema da cui si origina un’alternativa filosofica?
Forse occorre tornare indietro alla differenza fraautenticità enunciazionale ed enunciativa e superarla. Se siosservano a confronto le strategie discorsive di Sharon e miasuocera, Niente sesso in città, La svergognata e Una primavera di fuoco, sfumal’importanza di questa contrapposizione.
37 Una primavera di fuoco, p. 347.38La discussione sul grado zero della referenza è in Eco, 1997.
41
In questi quattro testi il “contratto autobiografico” diLejeune si contamina e si arricchisce di continuo degli elementidi quello che il critico definiva, all’opposto, un “contrattoromanzesco”.
L’aspetto interessante è la possibilità stessa dellacompresenza delle due cornici contrattuali e la potenzialitàrealistica che ne deriva. Se si tengono insieme le duealternative e si considerano l’autenticità enunciazionale equella enunciativa come strategie entrambe possibili, si puòcontinuare a guardare dritto l’idea della verità come effetto disenso in termini semiotici: nei termini cioè di una disciplinache considera questo aspetto anche per discorsi molto diversi daquello letterario, quali il discorso giornalistico e quelloscientifico.
42
2. La memoria palestinese narrata
Abbiamo concluso il primo capitolo decidendo di considerarequesti testi esempi di testimonianza a tutti gli effetti. Checosa pur in forma narrativa testimoniano lo vediamo adesso.L’esperienza di Khalifa e Amiry è un’esperienza etnica39: e questodato riempie, se non satura del tutto40, lo spazio delriconoscimento sociale rispetto al loro diritto a narrare.L’esperienza del dramma palestinese percorre tutti e quattro itesti; o meglio, si può dire che li anima attraverso un’esigenzaurgente di scriverne. Per capire che cosa mettano in campodell’esperienza palestinese riconsideriamo alcuni approdi dellariflessione teorica ventennale sulla memoria culturale.
2.1. Ricordo, memoria, evocazione
L’antropologa Zelda Alice Franceschi riflette disambiguandoalcuni concetti chiave a livello generale. Anche se la praticadella scrittura con lo scopo di riportare al presente deglieventi del passato è un modo di ri-vivere le proprie esperienze –un atto dunque estremamente soggettivo - Franceschi propone diindividuare modalità distinte per la testimonianza, il ricordo, lamemoria e l’evocazione.
Il testimone si caratterizza perché è capace di ammonire - daqui la radice monitus - “incanalando e dirigendo la fissazione diun sapere41”. Il ricordo presuppone un atto che Franceschidefinisce “centripeto” e soggettivo e ricorda che nella radiceetimologica “recordari, cor è cuore e il suffisso re indica ilmovimento al contrario, per cui si ha letteralmente un rimetterenel cuore”. L’evocazione per Franceschi è invece “centrifuga”perché “chiama, raduna e raccoglie tutto quanto non è statodepositato nel cuore ed è divenuto sapere condiviso ecomunitario; l’evocazione coinvolge il dialogo con gli altri”.
39 vedi Introduzione, p. 5.40 In questo senso,un versante del problema rimane, se si considera la mediazione delmercato che diffonde testimonianze etniche di esperienze drammatiche offrendole alpubblico occidentale. Le dinamiche per le quali certi testi sono diffusi a scapito dialtri, nonché il limite d’analisi che deriva dalla traduzione linguistica dall’araboall’italiano, sono questioni che non possono essere discusse qui per ragioni di spazio.La consapevolezza di questi limiti e un loro breve elenco sono argomento del sestocapitolo. 41 Franceschi, La memoria negli studi antropologici, in Agazzi, 2007, p. 594.
43
Per ultima la memoria, che come ricorda anche Aleida Assman“indica l’atto mnesico legato non tanto alla soggettività quantopiuttosto alla formale esposizione di una istoria/memoriaculturale”. Si tratta quindi, nei termini antropologici diFranceschi, di una “formalizzazione della tradizione oralecosiddetta formale” di una collettività, nell’arco di “almeno tregenerazioni”. Ora nel caso di Khalifa e Amiry questa collocazionemodale s’iscrive nella cornice di una scrittura di tipoletterario: le implicazioni sembrano essere diverse.
Tralasciamo per adesso l’idea del testimone come chi ha lacapacità di fissare un sapere, perché pone nel caso di Amiry e di Khalifaproblemi particolari, che saranno l’oggetto del prossimocapitolo.
Venendo al concetto di ricordo, che Franceschi individua inbase ad un movimento centripeto della coscienza, la dimensioneletteraria complica questa definizione. Ricorrono certamente intutti e quattro i testi passaggi nei quali un personaggio sivolge verso se stesso - è l’impostazione della voce narrante inLa svergognata - oppure nei quali l’orientamento al sé è ottenutoaffidando a uno dei personaggi la competenza di una memoriaspecifica, come nel caso riportato in appendice, in cui Amiryricorda il proprio padre ricordare; ma l’orizzonte dellascrittura è marcato - come sottolineato nel paragrafo precedente– da un gesto per cui una soggettività del cuore s’iscrive semprein un intento comunicativo.
Un problema generale si presenta per il caso palestineserispetto alla definizione di memoria.
Il dramma del conflitto mediorientale infatti ècaratterizzato da una precisa data di nascita, il 1948: anche sefocolai di scontro fra gli agenti poi coinvolti possono essererintracciati a partire dai primi anni del Novecento, è laproclamazione dello Stato d’Israele - e l’esodo drammatico dimolti palestinesi che ne fu la conseguenza - a segnare l’originedella contrapposizione.
Per la connotazione dell’identità palestinese come quella diun popolo in conflitto, se non proprio di un popolo oppresso daun altro oppressore, si deve considerare l’arco degli ultimisessantadue anni. Mancano, allora, quelle tre generazioni che sarebberonecessarie secondo Franceschi perché una collettività produca ilsuo deposito di memoria. E’ quindi interessante pensare a questeforme di testimonianza in tutto il loro potere dinamico, in tuttala forza che questi testi hanno nel descrivere un’identità ancora recente.
44
La società palestinese si distingue infatti tutt’oggi in duegruppi maggioritari: gli individui che hanno vissuto la sconfittadel 194842 e l’occupazione del 196743 attivamente, da adulti, ed ipalestinesi nati intorno a quegli anni o più tardi, in molti casigià esuli e rifugiati in uno stato arabo limitrofo, come laSiria, la Giordania e il Libano. E’ a questa seconda generazioneche appartengono Khalifa e Amiry ed è a questa secondagenerazione che si deve la fissazione dei due momenti storici, il
42 “La notte fra il 14 e il 15 maggio 1948, a seguito della dichiarazione unilateraled’indipendenza da parte di Israele, gli eserciti della coalizione araba invasero il nuovoStato. Ne facevano parte i contingenti di Egitto, Transgiordania, Siria, Libano, Iraq,Arabia Saudita e Yemen, affiancati da gruppi armati irregolari palestinesi. Nella memoriaebraica questo episodio viene celebrato come “la guerra d’indipendenza”, mentre nellamemoria degli arabi, e soprattutto dei palestinesi, è ricordato come la naqba, lacatastrofe. A causare il disastro degli eserciti arabi furono la mancanza dicoordinamento dei comandi militari, la carenza di armi ed esperienza e le tensioni fragli stessi Stati arabi sul futuro del territorio che avrebbe dovuto ospitare lo Statopalestinese in base al piano di spartizione dell’ONU del 1947. A favore di Israelegiocarono invece il fattore psicologico (combatteva per la sua sopravvivenza), unamaggiore conoscenza del territorio, abbinata a un miglior servizio d’intelligence, el’esperienza militare in un conflitto moderno, maturata nel corso della seconda guerramondiale a fianco delle forze alleate. L’unico contingente arabo che si dimostrò capacedi combattere con tecniche e logistiche moderne fu la Legione araba della Transgiordania,addestrata dall’inglese sir John Glubb, ribattezzato Glubb Pasha”. In Emiliani, 2008, p.40.43 “Dal 14 al 30 maggio 1967 Egitto, Giordania, Siria, Libano, Iraq e Arabia Sauditamobilitarono i propri eserciti in direzione del confine israeliano. L’allora segretariodelle Nazioni Unite Thank, accolse la richiesta dell’Egitto allontanando i Caschi Blu dalpresidio di Sharm el Sheik, fra Golfo di Suez e Mar rosso, che l’ONU presidiavastabilmente. Con questo gesto lasciò che Israele interpretasse la chiusura del Golfo diAqaba come una dichiarazione di guerra. Il governo israeliano, prima di intervenire,cercò invano l’avallo degli Stati Uniti. Il presidente Johnson, già impegnato in un durobraccio di ferro con l’Unione Sovietica in Vietnam, non voleva infatti aprire un altrofronte nello scontro Est – Ovest. Decisiva fu la nomina in qualità di Ministro dellaDifesa del generale Moshe Dayan, che ruppe ogni indugio e il 5 giugno 1967 lanciò unattacco preventivo contro l’Egitto, mettendo sull’avviso la Giordania di non intervenirenelle ostilità. Re Hussein non ascoltò il monito israeliano e passò al contrattacco dallaCisgiordania, mentre la Siria continuava le proprie aggressioni alle Alture del Golan. Loscopo di Israele non era conquistare territori, ma evitare di essere attaccata su tutti ifronti. Il 10 giugno il conflitto si concludeva con una schiacciante vittoria israelianae con la conquista di una vasta porzione di territorio”. In Emiliani, 2008, p. 52.
45
48’ e il 67’, come eventi decisivi, con i nuovi nomi di nakba44 –‘la catastrofe’ e naksa45 – ‘la disfatta’.
Non sorprende che nei testi siano frequenti forme di evocazionedel passato tragico: se evocare è una modalità intersoggettiva,nel caso palestinese le autrici sfruttano lo spazio narrativo perchiamare a raccolta la coscienza ancora parzialmente informedella loro comunità.
Questo però con modalità differenti. Le evocazioni di Khalifasono veri e propri lamenti; come quella del passaggio di cui si èparlato, in cui le rocce sono simbolo di un patrimonio emotivo epercettivo perduto, richiamato con l’enfasi di una figura poeticametonimica. Le descrizioni evocative nei due testi di Amirypresentano tratti più originali perché sono giocate soprattuttosull’ironia e su domande aperte.
44 “Le ostilità del 1948 provocarono un vero e proprio esodo di palestinesi fuori daIsraele, verso i vicini Stati arabi. E’ ancora controverso fino ad oggi il loro numero:la storiografia sionista ufficiale parla di 520.000 persone, la nuova storiografiaisraeliana di 700.000, la storiografia palestinese di 900.000 – un milione. Il grosso deiprofughi palestinesi (circa 400.000) trovò rifugio in Cisgiordania, annessa dallaTransgiordania (l’unico Stato arabo ad aver concesso loro il diritto di cittadinanza);190.000 si ammassarono nella Striscia di Gaza, finita sotto il controllo egiziano,175.000 tra il Libano e la Siria, 4.000 in Iraq. In Israele rimase meno della metà dellapopolazione palestinese originaria, ossia circa 150.000 persone. L’ONU affrontòl’emergenza profughi con la risoluzione n. 194 dell’11 settembre 1948, che ne sancì ildiritto al ritorno, o, in alternativa, il diritto a un compenso per le proprietà perdute.Nel 1949, inoltre, venne creata l’UNRWA (United Nation Relief and Work Agency), con lo scopo diorganizzare ed alleviare la vita dei palestinesi all’interno dei campi profughi. Laguerra del 1948 significò anche la persecuzione e l’espulsione delle numerose comunitàebraiche insediate da secoli nelle ex province dell’ Impero ottomano, ora Stati arabisovrani. Nel giro di un biennio (1949 - 51) circa 680.000 ebrei si trasferirono inIsraele, più che raddoppiando la sua popolazione”. In Emiliani, 2008, p. 42.45 “Con la conquista della penisola del Sinai (61.000 kmq) e della Striscia di Gaza (363kmq), strappate all’Egitto, della Cisgiordania (5.700 kmq), Gerusalemme Est compresa,sottratta alla Giordania, e delle Alture del Golan (1.170 kmq), conquistate alla Siria,Israele aumentò di tre volte tanto la propria estensione. Dai territori acquisiti nelcorso della guerra fuggì una nuova ondata di profughi palestinesi (circa 300.000persone), mentre 1.300.000 venivano a trovarsi sotto occupazione militare israeliana.Israele, in altre parole, era il paese con la popolazione palestinese più numerosa ditutto il Medio Oriente. L’intenzione del governo israeliano era di trasformare iterritori occupati in una carta di scambio con i paesi arabi, era cioè di restituirli incambio del loro riconoscimento ufficiale del diritto all’esistenza dello Statoisraeliano. I paesi arabi rifiutarono decisamente la proposta nel corso del vertice diKhartum (agosto – settembre 1967), in cui dissero no al riconoscimento, a trattative ealla pace con Israele. Dal canto suo Israele non intendeva annettere i medesimi territoriper almeno due ragioni: per non compiere una palese violazione del dirittointernazionale, che vieta acquisizioni territoriali attraverso conquiste militari, esoprattutto per il timore che lo Stato degli ebrei si ritrovasse con una popolazione amaggioranza araba. Nel 1967 si stimava che il “sorpasso demografico sarebbe avvenutoentro il 2010. I territori furono perciò mantenuti nel limbo giuridico dell’occupazionemilitare, ad eccezione di Gerusalemme Est e delle Alture del Golan, che vennero annessenel 1980. Nel 2005, perlomeno formalmente, la striscia di Gaza è stata restituita nonall’Egitto, ma ai palestinesi”. Emiliani, 2008, p. 60.
46
Sharon e mia suocera si apre con una scena incisiva: Suad rientraa casa dopo una vacanza e viene fermata in aeroporto dallapolizia israeliana, che la trattiene per sottoporla a uninterrogatorio estenuante. Amiry rende il contrappunto fra ledomande concise e del tutto illogiche dell’addetto alla sicurezzaisraeliano e le risposte di Suad: mentre cerca di fornire ilminor numero di informazioni possibile, perché sa che la poliziaisraeliana potrebbe adottare una strategia di ritorsione eaccusarla di qualsiasi infrazione anche per l’affermazione piùneutra, la voce narrante si rivolge al lettore e richiama intereparti della sua storia e di quella della sua famiglia. Questesessioni di memoria seguono ogni breve turno di dialogo fraufficiale e protagonista; Suad rievoca quello “che non ero invena di dire all’addetto della sicurezza”: descrizioni degliscenari della Palestina degli anni Venti, la vita in Siria deiparenti della madre, la complicata genealogia della sua famigliae la dispersione degli affetti in una rete di dislocazioni fra iterritori occupati, la Siria, il Libano e La Giordania; la mortetraumatica del padre mentre prendeva parte a un convegno con loscrittore palestinese Emil Habibi46, fino alla storia delle normeisraeliane sempre più restrittive per rilasciare i permessi dispostamento dei palestinesi in Cisgiordania, fuori dallaCisgiordania e poi verso i paesi arabi confinanti o verso meteeuropee ed extracontinentali47.
Molte pagine oltre Suad segue sul canale televisivo AlJaazera gli aggiornamenti del bombardamento israeliano dellacittà di Nablus, scattato per reprimere le rivolte dell’Intifadadell’aprile del 2002.
Dalla tv Suad apprende la notizia della distruzione di unaserie di edifici storici, fra cui un’antica fabbrica di saponeche esisteva dai tempi della sua infanzia. Allora Suad rievoca leimmagini e l’odore della sua visita alla fabbrica, in un excursuspercettivo che si interrompe perché in lei, architetto diprofessione, si scatena la rabbia per la perdita del patrimonioarchitettonico palestinese e per le tredici vittime rimasteuccise nel crollo della fabbrica. La chiusura è una lista: Amiryconta le cifre di quello che è stato distrutto e si rivolgedirettamente a chi considera responsabile: “complessivamentel’esercito israeliano ha raso al suolo quattrocentoventi villaggi
46 Emil Habibi, (1922 – 1996) è uno dei maggiori autori palestinesi; il suo romanzo, il Pessottimista, ha avuto un vasto successo internazionale ed è tradotto in più di dieci lingue.47 Sharon e mia suocera, pp. 13 – 21.
47
palestinesi” “nonché il quartiere Al Manshhyyeh a Jaffa, ilquartiere marocchino nella città vecchia di Gerusalemme,centinaia di abitazioni illegali attorno a Gerusalemme Est,decine di case a Khan Younis, centinaia di migliaia di ulivi epalme, adesso il quartiere al-Yasmineh a Nablus, e domani,chissà, forse i quartieri storici della città di Hebron. Sharon,stai risvegliando i nostri peggiori incubi48”.
Esempi di evocazioni vivide costellano anche la narrazionedell’altro romanzo di Amiry. Fra i molti c’è il passaggio diNiente sesso in città dei ricordi di Jahmileh, che ha passatol’infanzia in Marocco. Jahmileh narra come l’identità etnicapalestinese fosse un tratto del tutto irrilevante nell’esperienzadei suoi anni di scuola a Rabat e come invece all’improvviso lofosse divenuta, dopo la vittoria israeliana della guerra del1967. Il 5 giugno di quell’anno, alla notizia della sconfittadegli eserciti arabi, nel quartiere di Jamileh, abitato inprevalenza da famiglie palestinesi di ‘emigrati del 1948’,scoppia una feroce sollevazione contro i vicini ebrei con i qualila popolazione musulmana fino a quel momento ha convissuto inmodo sereno. Mentre lo zio e il fratello si precipitano adifendere la sinagoga che rischia di essere data alle fiamme, laprotagonista vive per la prima volta la consapevolezza traumaticadel conflitto etnico ed è costretta ad assistere al rapidomutamento del suo scenario di vita, perché la popolazione ebraicafugge dal Marocco alla volta di Israele o della Francia. Con leparole di Jamileh: “In men che non si dica, tutto cambiò; tutti imiei amici, la mia classe e i miei compagni di scuola, i vicini,i negozi, per non dire l’intero Marocco, erano diventatiinteramente marocchini e interamente musulmani49”.
Tre brani che riguardano direttamente la memoria collettiva.E proprio sotto questo aspetto emerge anche l’efficacia delladimensione narrativa. In una serie di ricerche svolte fra il 2004e il 2006 Astrid Erll50 ha mostrato come le finzioni letterariepossano diventare uno strumento potente e assolvere funzioni divitale importanza nelle culture storiche del ricordo. Per lastudiosa tedesca le opere letterarie sono un medium, al pari diun film o di un documentario, in grado di dettare codici esteticicon cui una società stabilizza l’organizzazione condivisa delpassato rappresentato.
48 Sharon e mia suocera, pp. 88 – 89.49 Niente sesso in città, p. 167.50 Bode, 2004, pp. 335 – 353; Erll, 2005; Erll, 2006.
48
Si può dire a ragione che questi passaggi narrativi in cuiAmiry evoca il passato hanno un valore funzionale: l’autricechiama a raccolta la coscienza laica e democratica della suacultura, da una parte fissando, da un’altra ricreando alcunimomenti salienti della storia palestinese. In Sharon e mia suoceraSuad Amiry semantizza il concetto di prigionia: insistendo sul poteredistruttivo e sulla mancanza di misura delle politiche e delletattiche israeliane rende viva e centrale la condizionedrammatica del perpetuarsi della repressione a cui sono soggettii palestinesi. In senso foucaultiano si potrebbe dire che reagiscecon un diritto di scrittura alla reale mancanza di diritti: la logica di Amiry èsimmetrica all’illogicità dei funzionari israeliani, il bisognodi parlare ed enumerare proporzionale ai danni arrecati daibombardamenti. In Niente sesso in città il ricordo di un’epoca diconvivenza pacifica fra israeliani e dei palestinesi è un altroatto di memoria importante.
Oltre all’episodio marocchino, lungo tutta la narrazione,Amiry evoca il dato storico e geopolitico di una realtà etnicacomposita com’è quella palestinese: leggere la situazionemediorientale applicando il filtro dell’antagonismo fraisraeliani e palestinesi è una semplificazione rischiosa perchéda questa non ha speranza di scaturire alcuno sviluppo per ilfuturo.
2.2 Sensi collettivi
La disanima di Franceschi ci porta al contributo teorico delsociologo francese Maurice Halbwachs. Ad Halbwachs si deve ilconcetto di memoire collective51, ovvero il concetto che ha ri-orientato nell’ambito degli studi sulla memoria l’interesse perlo psichico verso la dimensione sociale. Secondo questa idea, lamemoria si sviluppa in noi per impulso di stimoli esterni e siforma grazie al linguaggio, all’azione, alla comunicazione e ailegami affettivi nella costellazione della vita sociale.Ricordarsi è un processo ordinativo che permette all’individuo dioggettivarsi e strutturarsi. Se si adotta questa visione èdifficile o quasi impossibile mantenere la distinzione fra unamemoria ‘individuale’ e una ‘sociale’.
Anche perché gli affetti svolgono il ruolo decisivo: amore,interesse, partecipazione, sentimenti di unione collettiva, ildesiderio di appartenenza, ma anche odio, inimicizia, diffidenza,dolore, colpa e vergogna danno ai nostri ricordi pregnanza e
51 Pethes, 2002, p. 314 - 315.
49
orizzonte. Senza pregnanza i ricordi non si imprimerebbero, senzaorizzonte non assumerebbero alcuna rilevanza e significatoall’interno di un dato momento culturale. La teoria di Halbwachsci permette di dire molte cose della cultura palestinese cosìcome è raccontata. Il senso identitario di questa collettivitànasce nell’evoluzione drammatica del conflitto mediorientale.Questa prospettiva fonda il senso di sé delle autrici, al puntoche è molto difficile pensare a una forma narrativa palestinesesenza la cornice degli eventi del conflitto. Così una coscienzasempre fluida fra l’intimo e il collettivo attraversa questonarrare: Amiry ne fa la risorsa principale della scrittura mentreil caso dei testi d Khalifa mette in luce scelte più specifiche.
Una primavera di fuoco è una vera e propria cronaca della storiapalestinese recente; i protagonisti sono immersi nella vita dellaCisgiordania occupata, dove abitano, in un campo profughi checonfina con un insediamento israeliano. A plasmare il concetto di memoriacollettiva qui è il confronto, amaro, fra la nuova generazione palestinese e quellaprecedente. In passaggi ripetuti il padre dei due protagonistiriflette su quella che ai suoi occhi è la prospettiva dissolutadi Ahmad e Magid. A esasperare il vecchio giornalista sonoaspetti molto diversi dei due figli: del primo, Ahmad, lo turbala deviazione da un comportamento virile, la scarsa estroversionee l’approccio passivo alle circostanze della vita; di Magid losconvolge l’ambizione per il successo e il valore che assegnaalla ricchezza. Si tratta di un confronto generazionale arduo,probabilmente cieco a un possibile riconoscimento reciproco. Perla prima generazione palestinese, infatti, il sogno panaraboincarnato dal simbolo di Nasser è stato la matrice di un senso divita profondamente ‘morale’; un senso di vita guidato da idealidi fede e rispetto, istituzionalizzati dai concetti di Patria,Popolo, Rivoluzione. Questa valorizzazione è crollata in mododrastico a seguito degli eventi della guerra del 1967, a cui ipalestinesi hanno visto seguire l’occupazione israeliana dellaCisgiordania e di Gaza e la sconfitta degli eserciti arabi, latragica realtà del fallimento completo degli idealirivoluzionari. La generazione successiva non ha potuto ereditareche un orizzonte senza speranza, in cui l’entusiasmo ideologicosi era ormai trasfuso in una rassegnazione disillusa. Fra i nuovigiovani palestinesi il riempimento di questa dimensione valorialeormai devitalizzata ha comportato, in termini lotmaniani, larivitalizzazione di alcune icone dell’estetica occidentale. Ipalestinesi degli anni Novanta del Novecento e del Duemila sono,nelle parole del padre di Magid e Ahmad, “una generazione
50
disorientata, una generazione viziata, corrotta a suon diridicolaggini come la Coca Cola e gli stivaletti italiani52”. E’interessante che l’approdo di questi trend, sovrapposti allamorale tradizionale della cultura palestinese, si realizza in unaforma piuttosto ‘antiquata’: sia l’apatia di Ahmad che leambizioni di Magid sono anacronistici rispetto alle aspirazionidei gruppi generazionali di adolescenti occidentalicontemporanei, di cui pure esprimono alcuni segni caratteristici.
In Una primavera di fuoco l’esperienza storica collettiva tocca ilproblema della trasmissione generazionale, su cui già Freud notava:“che nessuna generazione è in grado di nascondere allagenerazione successiva i processi psichici di una certaimportanza”. Il sé dei due protagonisti, figli di un sistema divalore entrato in crisi, risente del problema: la ricerca di unsenso esistenziale non è soddisfatta da quello morale eideologico della generazione del loro padre. Però lavalorizzazione di nuove ambizioni di status, di ricchezza, disuccesso rientra nell’orizzonte dei dai giovani palestinesi senzacolmarlo perché la loro vita è un dramma quotidiano che tieneaperta la critica di qualsiasi valore.
In Una primavera di fuoco i protagonisti passano attraverso unagamma di ruoli sociali, in una specie di catalogo delle vitevivibili in Cisgiordania nel 2002: da cantante di successopromosso alla protezione di un notabile locale, Magid passa avivere un periodo fra i guerriglieri della resistenza armataanti-israeliana, per decidere infine di dedicarsi alla carrierapolitica fra le file dei funzionari corrotti dell’AutoritàNazionale Palestinese; Ahmad si trasforma da giovane promessadella fotografia di reportage a volontario, autista diun’ambulanza della Croce Rossa, per fare alla fine una scelta chefa sentire la traccia delle posizioni dei gruppi islamicifondamentalisti.
Khalifa si confronta anche con questa questione sul senso delmartirio: sembra molto semplicemente dire che con l’orizzonte delfuturo sbarrato i giovani palestinesi sono esposti alle icone delsacrificio ‘del combattente’, come una scelta fra tante, tuttepossibili.
Per questo testo si può parlare a ragione di un sé e di unamemoria collettivi, na non in La svergognata. Per converso ancherispetto a Sharon e Mia suocera e Niente sesso in città, questo è il testomeno attraversato da problemi collettivi - perlomeno da quelliidentitari che riguardano il conflitto. Afaf ricorda di rapporti
52 Una primavera di fuoco, p. 92 - 93.
51
con gli altri, delle relazione con il padre, la madre, lesorelle, il marito e una compagna di scuola dell’infanzia,rapporti che rivive per la maggior parte come drammatici.
In questa dimensione così intima però il sociale è un motivosoggiacente. Si è già detto che Khalifa costruisce il proprio séestraniata dalla morale collettiva: i ricordi rimandano allanascita come femmina in una famiglia tradizionale e chiusa cheeducava le bambine sul cardine della morale sessuale. Per leforme della memoria che anche in questo testo legano il livelloindividuale a quello collettivo, sfruttiamo il suggerimento diAssman di pensare a format di memoria interrelati, per cui ilpassato assume pregnanza in più livelli, collocandosi in: “unamemoria individuale, una memoria sociale, una memoria politica euna culturale”.
In La svergognata c’è un aspetto importante, la presenza di unaserie di ricordi che riguardano l’ambito sociale e sonoindipendenti da quelli dell’appartenenza al gruppo palestinese.Khalifa offre una visione originale perché polarizza questi due lati del sérispetto a due linee di memoria differenti. Da una parte c’è il ricordo delleingiustizie subite come femmina e la sequenza delle immaginidella condanna e del rifiuto da parte della sua famiglia. Afafricorda per esempio come i genitori svalutassero il suo talentonel disegno, servendosene come vanto per competere con lo statussociale di una famiglia più facoltosa della loro; ricorda lavergogna che il padre la indusse a provare per se stessa, dopoaverla sorpresa, a sei anni, insieme a un compagno di giochi disesso opposto; ricorda inoltre come i suoi interessiintellettuali in casa fossero derisi, perché erano inutili nelquadro della condotta corretta prescritta per le ragazze dallasocietà.
Dall’altra parte c’è il percorso di Afaf verso l’autonomiapersonale, il divorzio, il ritorno a casa della madre. Al secondofilone si collegano i ricordi della partecipazione politica ascuola, quando insieme con alcune compagne aveva i primi contatticon l’ideologia rivoluzionaria.
Sottolineiamo che per la maggior parte dei palestinesiappartenenti al ceto medio la rivoluzione nazionale seguiva lelinee del marxismo militante; con una saldatura ideologica lariscossa del popolo palestinese sarebbe avvenuta sulla scia di uncambiamento globale, di una liberazione di tutti i popoli dalnemico fascista e oppressore. Lo storico palestinese Ilan Pappenota la distribuzione sociale del discorso marxista come inopposizione a quello fondamentalista: “La forma politicamente
52
connotata di Islam, presente sia nella striscia di Gaza che inCisgiordania - scrive Pappe - fu l’unica organizzazione ad avereun certo seguito nei campi profughi nel corso degli anniCinquanta, dove riuscì a creare una rete di collegamento apartire dagli orientamenti tradizionali di contadini e stratiinferiori della classe media. Per la classe media vera e propria,al contrario, l’Islam connotato politicamente non potevarappresentare una possibilità: i palestinesi di estrazione urbanaerano maggiormente attratti dalle ideologie marxista e di estremasinistra53”.
Ora, sia Amiry che Khalifa sono a tutti gli effettirappresentati del ceto sociale medio palestinese urbano: questotipo di coscienza influenza la strutturazione del sé. Infattialcuni dei ricordi positivi di Afaf sono legati all’immaginedella partecipazione rivoluzionaria marxista, ricordi di cui si riappropria - questo è ilpunto – solo quando rompe il cerchio della condizione di moglie schiava.
Afaf ricorda il ricongiungimento, in Cisgiordania dopo ildivorzio, con la vecchia amica dell’infanzia, che ora militanell’ OLP: le due donne hanno un confronto piuttosto duro,l’amica cerca di convincere Afaf che la liberazione nazionale èla strada per raggiungere anche la loro emancipazione femminile.Afaf è critica di fronte della fede assoluta dell’altra nelsocialismo rivoluzionario; ma questo soprattutto per lariluttanza a fare suo un altro quadro normativo, l’ennesimo dopoaver dovuto subire quello del codice morale tradizionale.
Notiamo che questo filone etnico di memoria e identità èdistinto da quello femminile: il sentirsi palestinese riguardaAfaf come soggetto liberato, responsabile che può agire verso ilriconoscimento e la difesa della sua condizione etnica, contro lacondizione tradizionale di moglie e donna sottomessa. ConHalbwachs: “Ricordare vuol dire lasciare sullo sfondoqualcos’altro, rimarcare differenze, mettere in dissolvenza moltecose e illuminarne altre. In tal modo agiscono orizzonte eprospettiva nell’ambito dei ricordi individuali; e questeprospettive si stabiliscono affettivamente e socialmente”.
2.3 La scomparsa dei luoghi
Altro contributo importante è quello di Aleida Assman. Negli anniNovanta del secolo scorso il suo lavoro evolve dalla teoria diHalbwachs alla proposta di “luoghi della memoria”; la definizione
53 Citazione da Pappe, 2005, nell’articolo di Calderon, 2007.
53
che usa per parlare di precisi spazi di sedimentazione del sensoculturale è mnemotopi54 .
Si tratta di pensare a luoghi che agiscono come testi dellamemoria, spazi ampi - città o paesaggi – utili al ricordocollettivo. La loro struttura secondo Assman viene costruitaapplicando codici culturali ad una data topografia, in modo chequesto spazio venga letto come iscrizione di segni della memoria:così possono essere contrassegnate formazioni di senso anchemolto complesse, sempre grazie allo schema offerto da un codice.Dei due tipi più comunemente eletti a questa funzione, le prime,le città, sono spesso deputate a mnemotopi attraverso ladistinzione in luoghi sacri e profani; i secondi, i paesaggi,sono piuttosto frequentati in particolari occasionicommemorative, in cui s’incrociano una coincidenza spaziale e unatemporale rispetto a un evento fissato nella memoria. Assmanrileva come il senso della comunità si rafforzi attraverso imnemotopi, perché i luoghi hanno il potere di durare nel tempo:questa durata offre agli individui che compongono un gruppol’illusione di potersi paragonare ai propri predecessori e aipropri discendenti.
Negli studi più recenti questo concetto si sviluppa nell’ideadi mnemotopi conflittuali55: secondo Rossi infatti Assman è interessataa discutere: “la minaccia dell’oblio, perché cancellare ha anchea che fare con nascondere, occultare, depistare, confondere letracce, allontanare dalla verità, distruggere la verità. Si èvoluto spesso impedire che le idee circolino e si affermino, si èvoluto (e si vuole) limitare, far tacere, consegnare al silenzioe all’oblio. Qui l’invito o la costrizione alla dimenticanzahanno a che fare con le ortodossie, con il tentativo dicostringere ogni possibile pensiero entro un’immagine irrigiditae paranoica del mondo56”. Più spesso che non, infatti, intorno ailuoghi si coagulano i ricordi di diversi gruppi sociali, facendosedimentare memorie divergenti, o addirittura giustapposte:allora occorre ripensare il potere dell’assegnazione di un sensotopografico al ricordo; c’è una dialettica di potere fra memoriaed oblio, con la doppia possibilità che si cristallizzino da unaparte mnemotopi e dall’altra relitti. I primi sono luoghi che in unconflitto di attribuzione valoriale sono usciti vincenti,riuscendo ad emergere e a rimanere significativi; i secondi sono
54 Pethes, 2002, p. 352 – 353.55 Assman, 1999.56 Rossi, 1991, p. 21.
54
luoghi desemantizzati, abbandonati, depositari di una memoria chenon è più significativa per la collettività.
Questa liminalità costitutiva fra perdita e mantenimento deiluoghi della memoria, chiama in causa un punto filosofico focale,esplorato per esempio dall’analisi di Ricoeur: la duplicità delladimensione del tempo che struttura le nostre narrazioni,dimensione indissolubilmente paradossale perché durativa easpettuale insieme. Sintetizzando aspetti delle posizioni diRicoeur e Augè, Raul Calzoni osserva che “un luogo della memoriapuò sempre trasformarsi nel suo opposto e rimpiazzare il ricordo.La riproduzione infatti finisce per sostituirsi totalmente alricordo che abbiamo di qualcosa, anzi, si potrebbe addiritturadire che lo distrugge57.”
Queste riflessioni su luoghi salienti di conservazione – ocancellazione – ci fanno notare un aspetto importante: al centro delconflitto mediorientale c’è proprio la contesa, anche simbolica, di un diritto allaterra: i due gruppi si giustappongono rivendicando l’identità diabitanti legittimi di una precisa area geografica. Segue che iltema dei luoghi è il cardine della memoria palestinese, nelrivestimento simbolico della parte che ha perduto il senso legato al controllo edall’uso dello spazio.
Dei quattro testi due in particolare, Sharon e mia suocera e Unaprimavera di fuoco, sono centrati sulla messa in racconto delrapporto palestinese con i mnemotopi. Vediamo da vicino.
In Sharon e mia suocera c’è un nucleo di racconto che ritornaanche in altri testi di letteratura palestinese, e checostituisce una sorta di performance identitaria: potremmoparlare di un tentato riconoscimento della casa. Abbiamo già accennato aquando Suad ricorda suo padre e le parole con cui lui descrivevala desolazione del viaggio a Jaffa, occasione in cui si eraspinto davanti alla casa in cui un tempo abitava, occupata da unafamiglia israeliana. La visita è un’esperienza traumatica: l’uomonon riesce a riprendere la foto della madre, scopo con cui avevagiustificato il viaggio a livello razionale, ma soprattutto èrespinto malamente dai nuovi abitanti che non sono dispostineppure a credere che un tempo fosse proprietario della casa.
Tentativo amaro che deve aver riguardato un gran numero dipalestinesi: tutti quelli che fuggendo nel 1948 si sono lasciatialle spalle un’abitazione o dei possedimenti di terreno - i beniimpossibili da far espatriare. Le modalità del primo e piùimportante esodo palestinese del 48’, e quelle con cui il governoisraeliano si appropriò di quanto era stato lasciato sono oggetti
57 Calzoni, Luoghi della memoria, in Agazzi, 2007, p. 542.
55
di contesa fra la narrazione della storiografia palestinese e diquella israeliana. Per la seconda si è trattato di un abbandonovolontario, disinteressato delle case da parte dei proprietari, el’uso da parte dello Stato è dipeso dal bisogno concreto difornire una sistemazione al sempre crescente numero di ebrei cheimmigravano in Israele dall’Europa, dall’Unione Sovietica e damolte altre parti del mondo. La storiografia palestinese fornisceuna giustificazione meno pacifica all’abbandono: con unastrategia di rappresaglia e un episodio esemplare di strage alvillaggio di Deir Yassin58 i militari israeliani avrebbero indottoil panico nella popolazione che sarebbe fuggita perché inpericolo di vita. L’appropriazione israeliana è un sopruso, ancheper il fatto che Israele non ha mai più permesso ai fuggiaschi diriprendere possesso di quello che avevano lasciato.
In effetti non si può discutere sull’ irrimediabilità dellaperdita59: gli espatriati hanno conservato una frattura traumatica
58 “L'organizzazione paramilitare Irgun, guidata da Menachem Begin, attaccò il villaggioarabo di Deir Yassin incontrando una strenua resistenza, che portò il reparto israelianoad avere 41 feriti e 4 caduti. Eliminata la resistenza, circa 70 donne e bambini delvillaggio furono consegnati ai britannici, quando, in base ad alcune ricostruzioni,alcuni arabi che si erano arresi aprirono il fuoco sulle truppe ebraiche, che reagironomassacrando indiscriminatamente sia soldati arabi, sia civili. Le stime sul numero dellevittime variano da 100 - 120 a circa 250, a seconda delle fonti.Inizialmente fonti giornalistiche parlarono di 254 vittime tra gli abitanti delvillaggio. Secondo alcune analisi, indicare un elevato numero di vittime poteva serviresia agli arabi ed ai britannici, per mettere in cattiva luce i gruppi ebraici, sia aquesti ultimi, per cercare di terrorizzare la popolazione araba e incentivarne la fugaspontanea dal territorio assegnato al futuro stato ebraico. Il comandante dell'Irgun, unadelle prime fonti di questa stima data ai giornalisti, affermò successivamente di averlavolontariamente esagerata, contando sul fatto che la pubblicazione di una simile notiziaavrebbe portato la popolazione araba in una situazione di panico. Un'indagine condotta dalla università palestinese di Bir Zeit ha rilevato che tutte lefonti del tempo citano un numero di vittime tra le 250 e le 254, ma anche questo studioritiene che la cifra fosse stata volontariamente esagerata. Secondo lo studiodell'università, le vittime non avrebbero superato le 120, di cui 107 identificate. Lascoperta della strage indusse lo Yishuv ebraico ad esprimere pubblicamente orrore e disgusto.Ben Gurion scrisse di persona a Re Abd Allah I di Giordania per manifestargli il proprioshock per quanto accaduto; inaspettatamente (ma abbastanza logicamente) fu Begin stesso aconvocare rappresentanti della Croce Rossa e giornalisti per raccontare quanto erasuccesso. Non risulta, al contrario di quello che fu diffuso inizialmente, che alcuna delle donnedel villaggio sia stata violentata dalle truppe ebraiche. In una intervista rilasciataalla BBC cinquant’anni più tardi, Hazam Husayni, che nel 1948 lavorava presso ilPalestinian Broadcasting Service, ammise di aver completamente inventato quella storia suistigazione di Husayn Khalidi, un leader palestinese, nella speranza di spingere glialtri arabi ad unirsi e ad intervenire in Palestina per liberarla dagli Ebrei: - Quellofu il nostro più grande errore. Non capimmo come la gente avrebbe reagito. Come sentironoche le donne erano state violentate, i Palestinesi cominciarono a fuggire”, In Codovini,2009, p. 134.59 “Dopo il 48’ le altre guerre del conflitto arabo-israeliano (soprattutto la guerra deisei giorni del 67’ e quella del kippur del 73’) hanno provocato altre ondate di sfollati
56
fra la vita in quelli che prima del 48’ erano territoripalestinesi e l’esperienza di un nuovo inizio nel paese in cui sisono stabiliti. In molto casi l’abbandono è stato così repentinoche ai proprietari è rimasta la chiave della casa in tasca. Nellevisite di tentata riconciliazione molti raccontano di essersi portati lechiavi: come se poter sentire una continuità fra il passato e ilpresente fosse più importante del dato razionale; infatti sarebbestato improbabile ritrovare a distanza di decenni60 la casacom’era stata abbandonata, senza violazioni, senza ulteriorioccupanti, pronta per accogliere i legittimi proprietari.
Sugli edifici da ritrovare c’è un altro passaggio in Sharon emia suocera. Ad un certo punto della sua vita Suad decide ditrasferirsi e vivere in Cisgiordania: la protagonista non è mairisieduta qui, perché i suoi genitori nel 1948 si sono trasferitiin Giordania e lei è nata ad Amman. Suad conserva però i raccontidei ricordi che i genitori hanno rievocato infinite volte, oltrealla memoria delle visite a Gerusalemme da piccola negli anniprecedenti al 1967, prima cioè che l’annessione ebraica sbarrasseai palestinesi la libera circolazione nella parte Est dellacittà.
In questo gesto di riappropriazione con il trasferimento neiTerritori Occupati, Suad per prima cosa vuole vedere con i suoiocchi la casa di famiglia di Jaffa: in pratica cioè compie nel1981 lo stesso tentativo che il padre ha fatto nel 1968. Laricerca non avrà esito: l’urbanistica di Jaffa è statatrasformata in modo radicale dall’amministrazione comunaleebraica61 e Suad non riesce a trovare il punto in cui un tempo si
palestinesi, ma il diritto al ritorno, per l’ONU (non per l’OLP), riguarda solo irifugiati del 48’. Israele non ha mai voluto considerare questo diritto: ha preso inconsiderazione solo rari casi di ricongiungimento familiare. Oggi i discendenti deirifugiati del 48’ sarebbero 3 milioni e permettere il loro ritorno nelle terrepalestinesi divenute israeliane, nell’ottica di Israele, significherebbe snaturare lanatura ebraica dello Stato”. In Emiliani, 2008, p. 124.60 Dopo diciannove anni, il 5 giugno del 1967 fu aperta per la prima volta la frontierafra la Palestina del 1948 e la Cisgiordania. Dato il prevedibile esito della guerra deisei giorni, alla luce delle schiaccianti vittorie conseguite nelle prime battaglie, conquesto gesto lo Stato di Israele si preparava all’occupazione della Cisgiordania.61 La città di Tel Aviv fu costruita nei primi anni Sessanta con l’intento di fornire aIsraele un centro urbano che sfruttasse il controllo marittimo della costa. Nel suosviluppo edilizio Tel Aviv ha lentamente inglobato la città araba adiacente di Jaffa cheoggi è considerata un quartiere antico di Tel Aviv, come spiega la brochure web del sitoitaliano per il turismo in Israele: “La storia di Tel Aviv ha inizio a Jaffa (Yafo), adiacente e antica di 3000anni, situata a sudovest. L’attuale città vecchia di Jaffa risale al periodo ottomano, e le sue case di pietra e gli strettivicoli ospitano oggi il pittoresco quartiere degli artisti e il centro turistico. Tra le sue attrazioni, vi è Gan HaPisga, ilSummit Garden, con i suoi ristoranti, gallerie, negozi dall’atmosfera unica, la passeggiata lungo il mare e le mura dellacittà vecchia, il porto di pesca, il centro turistico nella vecchia corte”, dahttp://www.tourism.gov.il/Tourism_Ita/HomePage.htm.
57
trovava la casa. Amiry confessa il senso di sollievo che provadavanti alle circostanze per le quali è portata a non poter vedere larealtà della casa cara nella nuova prospettiva della Jaffaebraica del presente. La stessa cecità che è grata di poterconservare in un’altra occasione, quando parla dei danni deibombardamenti israeliani dopo aver ritirato l’assedio dal centrodi Nablus; Amiry vuole vedere con i propri occhi quanto degliedifici della città vecchia di Nablus sia sopravvissuto alleesplosioni, e parte insieme ai colleghi del Centro d’Architetturadell’università di Birzei. Però è costretta a desistere, perchésulla strada sulla quale stanno viaggiando parte una raffica dispari nel fuoco aperto insieme dai soldati di un presidiomilitare e dai coloni di un insediamento poco distante.
Oltre alle narrazioni dedicate alla perdita materiale degliedifici, sia in Sharon e mia suocera che in Una primavera di fuoco c’è ladenuncia per il modo in cui la memoria palestinese viene minatacon l’oblio dei nomi. La politica israeliana di colonizzazione delterritorio, inaugurata da Sharon62 nella prima metà degli anniOttanta, prevede una disseminazione capillare di presenzaisraeliana anche nelle aree che saranno assegnate all’AutoritàPalestinese nel piano di spartizione di Oslo: vige la pratica didare ai nuovi insediamenti nomi ebraici. Tutte e due le autricidescrivono la frustrazione profonda per la cancellazione della memoriatopografica: i nomi arabi scomparsi uno ad uno in pratica rendonoimpossibile parlare del territorio palestinese.
In Sharon e mia suocera si rileva la rabbia e l’amarezza delsentire comune davanti alla realizzazione della perdita, ma inUna primavera di fuoco la percezione è quella di una vera e propriacrisi rispetto ai mnemotopi. Khalifa usa i luoghi come simbolidel rischio di non avere un orizzonte per l’ultima generazionepalestinese. Connettendo perdita della terra e disgregarsi dellastruttura sociale l’autrice costruisce il dispositivo tragicodella fine di Ahmad e Magid. La coscienza dei due protagonisti
62 “Il cosiddetto Piano Sharon, che risale al 1983, aveva lo scopo primario di collegaretra loro gli insediamenti ebraici e di costruire vie di scorrimento fra gli insediamentie Israele che tutelassero la sicurezza dei coloni, permettendo loro di evitarel’attraversamento d aree densamente popolate da palestinesi. Le bypass road che Sharoniniziò a costruire - e in virtù delle quali meritò il soprannome di “bulldozer” –portarono a ulteriori espropri del territorio palestinese, che cominciava a configurarsicome una serie di insulae a macchia di leopardo. I palestinesi commentarono con rabbia chel’intenzione di Sharon era quella di creare dei bantustan, cioè delle riserve separate,sull’esempio di quanto era stato fatto in Sudafrica dai governi dell’apartheid. Tra il 1984e il 1988 la popolazione dei coloni passò da 44.000 a 67.000 unità, mentre nella solaGerusalemme Est l’incremento netto della popolazione ebraica fu addirittura di 70.000abitanti”. In Emiliani, 2008, p. 98.
58
evolve in una crescente disgregazione del senso: nelle primepagine troviamo i due ragazzi intenti alla rappresentazione delleproprie aspirazioni e alla riflessione sui loro affetti e sulleloro relazioni con i propri familiari, nell’evolversi dellevicende la loro immaginazione si chiude eliminando tutto quelloche non è immediatamente significativo. E va di pari passo ladescrizione degli scenari naturali, per cui una ricchezza didettagli ambientali via via diminuisce fino a ridursi a unascarna serie di coordinate spaziali. Nella parte finale la vocedella coscienza di Magid sparisce, mentre quella di Ahmad diventauna sorta di balbettio, che spesso è incapace di connettere fraloro l’insieme delle sue percezioni al punto che le restituiscein lunghi elenchi sconnessi, o continuando a chiedersi “se ètutto vero”. Si fa sempre più insistita la descrizione deglistrumenti della riduzione, prima, e poi della cancellazione dellospazio: i cingolati, i carri armati e le ruspe israelianeguadagnano un’importanza crescente, attorializzandosi in veri epropri personaggi. Il presente si dilata e la dimensionetemporale si sfilaccia, in modo tale che è sempre più difficilecollocare le vicende narrate in una successione ordinata e in unospessore diacronico. Questa spirale verso la distruzione, che èuna vera e propria discesa di tipo spaziale, connota Una primaveradi fuoco in un senso che permette di parlarne come di una saga deldolore.
2.4. Il concetto di trauma
Proviamo a offrire un quadro concettuale entro cui collocare laforma di questa memoria del dolore. Non possiamo non toccare ilconcetto di trauma, al centro degli studi interdisciplinari sullamemoria degli ultimi vent’anni. Questo termine è stato originatodalla psicanalisi e designava l’occorrere di un evento psichicocapace di ostacolare, fino a impedire del tutto, il consuetoprocesso d’immagazzinamento delle impressioni nel ricordo. Lalacuna mnestica che seguiva era descritta - senza una differenzaunivoca sul piano delle definizioni – come il risultato di unfenomeno di dissociazione della memoria o di uno di rimozione.
Più tardi nella storiografia sono stati gli studi sullaviolenza subìta dalle vittime del Terzo Reich a evidenziareconvergenze formali fra traumi individuali e traumi collettivi,trasfondendo il lemma nell’orizzonte dell’analisi socioculturale.Negli anni Novanta del Novecento il concetto ha avuto un impiegocrescente, con il merito di divulgare alcuni temi tabù, ma nello
59
stesso tempo esponendosi al rischio di essere generalizzato e diperdere la sua forza di enunciazione. Un problema particolarenasce con un saggio di Feldman del 1992, in cui si comincia ateorizzare la scomparsa del testimone nella storia contemporanea. L’analisiguarda alla Shoà, definita come punto di “crisi storica radicaledella testimonianza e come il caso storico senza precedenti,inconcepibile, di un evento senza testimoni - un evento cheelimina i suoi stessi testimoni63”. Attorno a questo possibilevuoto si struttura per esempio una delle riflessioni piùsignificative nel panorama della ricerca statunitense, quella diCathy Caruth. Secondo Caruth64 la vera memoria, letterale, cheripete e mette in scena il ricordo traumatico, interrompe tuttele norme del rappresentare. I ricordi traumatici emergono comestati d’animo, sensazioni somatiche o immagini visive, incubi eflashback senza tempo, non modificati da esperienze ulteriori. Incontrasto con la memoria narrativa, che implica un’azionesociale, i ricordi traumatici riemergono sotto forma disensazioni fisiche e di immagini terrificanti, oppure vengonorimessi in scena dagli incubi. Il crollo del confine soggetto-oggetto dà luogo a ripercussioni somatiche, spesso descritteanche come sensazione della presenza di un corpo estraneo nelproprio corpo o “ricordo incarnato”.
Il paradigma della Caruth cioè si spinge a teorizzare ivalori-limite dell’esperienza traumatica, ma così corre unrischio, come dice Walter Busch, quello: “di dar forma a unaconcezione completamente astratta del trauma, per la quale unaformulazione efficace si stempera in concetti già ampiamenteindagati come quelli di inconscio, agire istintivo, iterazione65”.
La critica europea ha risposto a queste teorizzazioni,sviluppate nell’ambito americano del dibattito, accogliendone glispunti originali ma senza replicarne il paradigma. Studi digrande interesse sono, ad esempio, nel contesto italiano quellodi Traverso sul rapporto fra gli eventi traumatici e la loropermanenza in una cultura come blocchi ritmici66, o quello delfrancese Mesnard, che si occupa dei processi di formazione deitopoi e dei clichè sulla memoria del dolore67, respingendo l’ideache si debba sacralizzare l’inenarrabile.
63 Feldman,1992.64 Caruth, 1995. 65 Busch, Testimonianza, trauma e memoria, in Agazzi, 2007, p. 551.66 Traverso, 2000.67 Mesnard, 2001.
60
Ma esistono anche ricerche sul trauma che non si riferisconoall’esperienza della Shoà68: criticando alcune posizioni diAlexander – autore di uno degli studi più determinanti per lateoria del trauma culturale di scuola americana69 - Anna Lisa Totaper esempio sottolinea come in certi contesti nazionali illivello di violenza costante, le vittime sono vittimeincessantemente e quindi diventa difficile immaginare l’emergeredi un carrier group, cioè di un soggetto collettivo che si prendecarico della testimonianza traumatica70”, come lo teorizza lateoria del cultural trauma.
Tota coglie il lato critico di una teoria centrata sulcontesto occidentale; su un contesto, cioè, in cui la Shoà èsignificante - oggi - in qualità di enorme bacino simbolico,oggettivato in una fissazione storica molto forte e infine
68 Per riferirsi solo ad alcuni degli studi più famosi a livello internazionale: Bennett,KennedyBasingstoke, 2003; Gilroy, 1993; Krog, 1998. E, a livello italiano, i lavori delCentro Studi su Memoria e Trauma Culturale dell’università di Bologna riguardo allastrage di Ustica e quella di Bologna.69 Jeffrey Alexander pubblica nel 2004 insieme ad altri autori un saggio che ha avutorisonanza internazionale nella comunità teorica – sociologica e non solo. In Cultural traumaand Collective Identity lo studioso sviluppa un’ipotesi originale rispetto alla fissazione deltrauma del secondo conflitto mondiale nella memoria collettiva europea a partire daidecenni centrali del secolo scorso.La Shoà è divenuta il simbolo di un moderno metro morale del male, orientando lavalutazione di tutti gli eventi che gli sono seguiti nel corso della storia recente ericondizionando in qualche modo anche tutti quelli precedenti: come ‘grado zero’ dellapensabilità della malvagità nello scenario della vita sociale. Dice Alexander che: “nonfurono né la repressione delle emozioni né il buon senso morale a dar vita alle primereazioni allo sterminio degli ebrei. Fu, piuttosto, un sistema di rappresentazionicollettive che focalizzò il suo fascio di luce narrativa sulla trionfante espulsione delmale”(p. 51). L’idea del sociologo è interessante soprattutto per una visione generale,rispetto alla quale anche il dolore, la sofferenza e la sua sedimentazione collettivaattraverso una narrativa e delle forme di valutazione, entra in campo come oggetto diun’arena culturale che elabora chiavi di lettura e modelli secondo cui si può persinoricreare – questo Alexander crede sia accaduto con la Shoà – lo spazio della sanzionesociale rispetto alle condotte devianti e definire una nuova idea assoluta di male, dallaquale ripartire nella considerazione di qualsiasi altro avvenimento. “Nella misura in cuil'Olocausto è giunto a definire la disumanità nel nostro tempo, esso ha dunque svolto unafunzione fondamentalmente morale. La ‘moralità post-Olocausto’ ha potuto svolgere questoruolo, tuttavia, solo attraverso una forma sociologica: è diventata una metafora dicollegamento che gruppi sociali di diverso potere e legittimità hanno utilizzato perdefinire logicamente come bene o come male gli eventi storici in corso. Ciò chel'Olocausto ha identificato come il male più profondo è l'impiego sistematico edorganizzato della violenza contro i membri di un gruppo collettivo stigmatizzato, siaesso definito secondo criteri primordiali o ideologici. Questa rappresentazione non soloha identificato come male radicale i colpevoli e le loro azioni, ma ha interpretato comemale anche i non-attori. Secondo i criteri della moralità post-Olocausto ad ogniindividuo è ora richiesto, normativamente, lo sforzo di intervenire contro qualsiasiOlocausto, al di là di ogni considerazione di costi e conseguenze personali” (p. 91).70 Tota, 2003, p.7.
61
pubblico, perché condiviso dagli spettatori di una plateamediatica sterminata.
Se si esce da un quadro simile e ci si volge a fenomeni piùrecenti, o dislocati in aree differenti del pianeta, sembra piùproduttiva la ricerca che coniuga gli studi sul trauma con quellidi orientamento post-coloniale. Infatti c’è un vasto novero distudi filosofici, letterari e sociologici, prevalentemente diarea anglosassone, che guarda ai fenomeni sociali – e di memoria– legati al multiculturalismo, nel senso dei dilemmi che questopone alle dinamiche sociali della modernità71.
Con le direzioni degli studi postcoloniali si possono tenereaperte questioni di stretta pertinenza per i modi del soffrirenel contesto del conflitto mediorientale e per la loro percezioneda parte palestinese, questioni che le teorie del trauma inqualche modo scavalcano.
La sedimentazione nella memoria collettiva di eventialtamente traumatici, insieme all’attuale realtà di unacondizione di vita durissima ha generato nel caso palestinese unacostruzione identitaria peculiare, che è molto lontana da quellaprodotta, nelle vittime della Shoà, dalla cancellazione quasiinenarrabile provocata dallo sterminio nazista.
Questo significa che non si può parlare di un trauma per questo gruppo?Si, se si abbandona l’idea di assegnare quote traumatiche, e siriconosce la vitalità di una cornice culturale tuttora esistente,di cui i testi che prendiamo in analisi sono un’ espressione.Prima ancora del come si possa parlare del dolore nella storiapalestinese, sembra più utile chiedersi qual è il rapporto fra laregistrazione del dolore nella memoria individuale e la suatrascrizione in forme di rappresentazione della sofferenzacollettiva.
71 “Le radici degli studi postcoloniali sono diverse, ibride e transnazionali. Èdifficile definirne l’ambito con un unico approccio perché rappresentano un insieme diposizioni eterogenee. Anche all’interno del pensiero postmoderno, comunque, possiamoindividuare approcci diversi. Possiamo fare una distinzione tra un postmodernismo banale,conciliante con la logica del mercato, poco radicale nella critica del capitalismo esostenitore di un antagonismo puramente estetico. Dall’altra parte esiste anche unpensiero postmoderno radicale, impegnato politicamente, in buona parte confluito neglistudi postcoloniali. Mi riferisco ad autori come Barthes, Foucault, Lyotard, Derrida eDeleuze. Questo radicalismo insito nel post strutturalismo ha favorito moltissimo losviluppo degli studi postcoloniali. Ma non sempre si è tradotto in posizioni altrettantoradicali. In ogni caso negli ultimi anni si assiste a una politicizzazione crescenteall’interno degli studi postcoloniali. Ciò che è successo nel mondo negli ultimi anni hadato una scossa non indifferente ad un campo di studi dove la spoliticizzazioneletteraria e gli accademicismi più perversi non avevano certo un ruolo minoritario. Inquesto senso, il futuro degli studi postcoloniali dipenderà dalle posizioni cheemergeranno all’interno dei conflitti del mondo attuale”. Miguel Mellino, inun’intervista al suo saggio.
62
Poi bisogna aggiungere che ci sono anche idee interessantinella ricerca psicoanalitica che si muove nell’ambito tangentealla definizione di trauma collettivo. Ad esempio, in uno studiodel 2003, dal titolo Knowing and not knowing about massive psychic trauma:forms of traumatic memory, Laub e Auerhahn introducono l’idea di unagamma di reazioni traumatiche, per la quale la memoriatraumatica può variare anche molto: da forme di non conoscenza,in cui l’esperienza del trauma da cui partono la difesa el’adattamento è disconnessa, inaccessibile al ricordo, a stati didissociazione in cui il trauma viene rivissuto piuttosto chericordato, con dei frammenti di ricordo decontestualizzati erelazioni con gli oggetti e i temi di vita ripetute, fino allapossibilità si sciogliere il trauma in racconto, in unatestimonianza, nella metaforizzazione72.
2.5 Fra trauma e nostalgia
I quattro testi sono attraversati da elementi che richiamano unamemoria traumatica - modalità narrative centrate sul vissutostorico della perdita, sulla violenza con cui si è verificata esulla percezione di un orizzonte senza speranza; ma accantotroviamo delle dinamiche che ripetono l’idea di ritorno, con ungusto immaginifico per la terra e il richiamo di un tempo d’oroche è vividamente ‘qui’ nel presente narrativo.
Questa linea di memoria evocativa, diversa da quellatraumatica, ci fa considerare il concetto di nostalgia. Questolemma ha per certi aspetti un’origine simile a quella del trauma:è nato in ambito clinico, e in stretto rapporto con il corpo, poiha subìto nei secoli uno slittamento semantico progressivo percui oggi appartiene all’orizzonte di una generica critica dellaciviltà nella visione sociologica, di un certo modo di aderire allarappresentazione del passato. Nella patologia nostalgicateorizzata da un medico svizzero a metà del Seicento, ipazienti:73 “vivono l’effetto di una lontananza impossibile da
72 Barbieri, Marino, 2003.73 “La parola accosta nostos, ritorno e algos, dolore, secondo l’uso secentesco di comporreneologismi che andavano ad allargare il Dizionario clinico. Comparve per la prima volta cometitolo di una dissertazione presentata da un giovane alsaziano, studente di medicina,Johannes Hofer, all’università di Basilea nel 1688. Presiedeva Johann Jacob Harder,professore di retorica, botanica, anatomia. La dissertazione trattava in latinoaccademico, eziologia, sintomi e terapie della malattia che colpiva in particolare isoldati svizzeri mandati presso guarnigioni straniere. La malattia era detta, nelle Alpibernesi, Heimwehe e aveva già una sua storia clinica. Ancora per alcuni decenni saràchiamata con quel nome, che designa lo Heim, il domestico, il familiare e il desiderio diun ritorno vissuto come impossibile, perchè assediato dalla lontananza, dall’estraneità,
63
diradare, di una distanza dal paese di provenienza vissuta comeirreversibile. Un suono, una voce, un motivo musicale,sopravvenendo nel tempo e nel luogo della lontananza possonorichiamare violentemente il profilo di un’immagine dalla quale cisi è un giorno staccati: lo stato di malattia sopravviene dinanziall’energia di quel richiamo, accompagnato dalla certezza che ilritorno è impossibile”. Il movimento perturbante della nostalgiaè l’innesto per cui qualcosa di noto e nostro torna attraversoqualcosa che non conosciamo. Nel Dizionario della memoria e del ricordogli autori colgono altri aspetti sottili, come quello per cui nonsi può parlare di un desiderio di fuga dal presente ma, piuttostodi un presente trasformato, in cui sbucano oggetti, suoni, immagini,sapori e gusti che noi sentiamo venire dal passato: “lereminescenze costruiscono un’atmosfera diffusa di sano mondopassato come oasi di pace, da cui la personalità frammentatariceve un senso di equilibrio interiore, di continuità e diidentità coesa. Oppure il fatto che la nostalgia serve a mettere inordine qualcosa, è una conoscenza empirica che “reagisce allamutevolezza del mondo esterno, usando una semanticanaturalistica”.
Per circoscrivere l’ambito dell’elaborazione individuale epoi socialmente istituzionalizzata di questa esperienza diperdita palestinese sfruttiamo la coppia dei concetti di trauma e di nostalgia: inquesti testi la memoria sta nel mezzo, in un passato che non passa.
Se in Sharon e mia suocera si trovano molti esempi di scritturadi una memoria nostalgica, è Una primavera di fuoco che meglio mettein scena alcuni tratti di una memoria traumatica: quelli cheriguardano soprattutto l’impossibilità di articolare ladimensione del tempo ma anche quelli che concernono il carattereallucinatorio, perchè nelle ultime pagine la scrittura èossessionata dal bisogno di ripetere un ricordo assente. Questotesto rappresenta proprio la mancanza di un orizzonte futuro, peril peso con cui la realtà quotidiana grava sulla possibilità chel’identità culturale palestinese evolva.
Mettiamo insieme questi elementi insieme basandoci sulladistinzione di Jurii Lotman fra culture “modellizzatesull’inizio” e culture “modellizzate sulla fine”: per ilsemiologo russo le prime si rintracciano perlopiù in contesticulturali giovani, e si caratterizzano per il mito dell’origine, diun’età dell’oro, mentre le seconde sono perlopiù storicamentemature; mentre le culture modellizzate sull’inizio collocano ilconflitto all’esterno del limite del noi della comunità, quelle
dallo spaesamento”. Antonio Prete, in Mengoni, 2009, p. 142.
64
modellizzate sulla fine percepiscono il conflitto come interno esi presentano strutturate secondo una “coscienza tragica”.
Per il fatto che l’identità di questo gruppo ha una nascitarecente e per il gusto dell’evocazione del passato in sensonostalgico, la cultura narrativa palestinese può probabilmenteascriversi al primo tipo. Nello stesso tempo è fondamentale ilcontatto quotidiano e perpetuo della società con una situazionetalmente critica che rischia di avere gravi ripercussioni sulrapporto integrativo del passato.
Si delinea una struttura lotmaniana in due blocchi temporali:il primo costituito da un passato mitico, un mondo perduto eidealizzato, il secondo che fonde la rappresentazione delpresente e del futuro. Una struttura cioè mozza di orizzonte, in cuiperò rimane la vitalità dell’evocazione che distingue laprospettiva palestinese da quella di culture orientate sullafine.
65
3. Guardare al genere Abbiamo scelto di parlare principalmente di questi quattro
testi perché sono scritti da donne. Discutendo di memoria,evocazione, ricordo e testimonianza, si è detto che per parlaredi un testimone che ammonisce la collettività e indirizza lafissazione di un sapere avremmo dovuto considerare aspetti piùspecifici dei testi di Khalifa e Amiry: lo facciamo ponendo laquestione del gender.
Questo termine è al centro di un filone di studi di scuolaoriginariamente anglosassone che si occupa del problema dellecategorie identitarie ricevute dai soggetti in un sistemasocioculturale.
In generale si può dire che l’impostazione checontraddistingue questa area di ricerca è tangente a quella dellacritica femminista: l’assunto da cui entrambe partono infatti èche ogni società definisce quali valori additare alle varieidentità di genere e, in primis, in che cosa consiste essere uomoo donna; maschilità e femminilità quindi devono essere pensaticome concetti relativi.
I termini women studies e gender studies però non sono sinonimi:la ricerca femminista ha senza dubbio contribuito alla nascitadei gender studies e hanno ancora luogo scambi tra le diversecorrenti; ma la ricerca sul gender non è focalizzata solo sullastoria delle donne e guarda alla costruzione socio culturale deigeneri - femminile e maschile – nelle relazioni che intercorronotra loro.
Per capire come si possano articolare semiotica e genderstudies assumiamo proprio questo concetto: l’identità sociale èprodotta da una struttura che genera relazioni. E quindi abbiamoun concetto già semiotico in sè, perché appartiene allasociologia critica quanto allo strutturalismo puro della lezionegreimasiana.
Nello stesso tempo gender studies e semiotica sono separatida una netta linea di demarcazione, per il progetto politico cheguida i primi. Come ricorda Demaria: “pur essendosi sviluppatanegli anni Sessanta e Settanta come una disciplina a vocazionecritica, la semiotica ha come oggetto lo studio dellasignificazione e della comunicazione in ogni sua forma testuale,senza che la maggior intelligibilità o l’efficacia descrittivacui dovrebbe condurre, comporti un progetto politico dichiarato o
66
esplicito74”. Oltre la differenza, rimane il piano semiotico sucui l’analisi delle pratiche significanti non può evitare diconfrontarsi con un oggetto complesso quale il genere: per itesti che consideriamo allora è utile un confronto con categoriee oggetti al centro degli studi di genere e con alcune posizionidella teoria femminista recente. C’è un passaggio, nelle primepagine di Niente sesso in città, in cui Suad Amiry ironizza suglistereotipi occidentali, per i quali le viene spesso fatto notareche non è la tipica donna araba e musulmana. Suad riflette: “sonotipica di ciò che sono: una donna in una certa epoca, in un datoluogo, in una determinata classe sociale”. La questione che sipone a una semiotica del testo in un’ottica culturale è propriola definizione della traccia testuale di questa tipicità.
Per discutere di genere mutuiamo modelli concettuali75 da trecontributi principali: gli studi dell’antropologa Ruba Salihsull’identità sociale femminile nei paesi arabo musulmani, quellidi Cristina Demaria sulle relazioni possibili fra semiotica ecritica di genere e femminista e quelli transdisciplinariraccolti da Vita Fortunati, Gilberta Golinelli e Rita Monticellisul tema della memoria culturale femminile. Come nei due capitoliprecedenti intrecciamo le riflessioni teoriche con considerazionispecifiche sul corpus testuale in analisi.
3.1. Il genere e il contesto palestinese: laicismo e segregazione
Riconsiderando la proposta di Assman su più format di memoriadifferenti, “uno individuale, uno sociale, uno politico e unoculturale”, bisogna pensare al fatto che Khalifa e Amiry scrivonoe ricordano nel contesto di una cultura arabo musulmana; questocomporta anche la consapevolezza che esistono alcuneprecomprensioni da abbandonare: proprio quelle della donna araba emusulmana tipica.
C’è una tradizione che dall’inizio dell’epoca moderna haportato in più discipline analitiche ad opporre i concetti diOccidente e di Oriente, polarizzando un noi occidentale e unasimmetrica alterità orientale: in questa lettura uno dei simbolipiù ricorrenti è appunto di genere e riguarda la sottomissionefemminile. Gli studi postcoloniali, fra cui il lavoro di EdwardSaid76, riconducono questo segno comune alla retorica di undiscorso di potere che alla razionalità dell’Occidente
74 Demaria, 2003, p. 217.75 La questione del gender sarà al centro anche della parte finale del sesto capitolo; perle osservazioni che si faranno più avanti ci si avvarrà anche di ulteriori contributiteorici rispetto a quelli che adesso ricordiamo.
67
contrappone il primitivo e il retrogrado dell’Oriente, e poi loincarna nell’immagine di una femminilità esotica e pericolosa.
Stanno insieme, cioè, l’attrazione verso una diversità chenon può essere integrata e il percepire quello che è proprio comesuperiore: così la donna velata che simboleggia l’Oriente èl’oggetto di un desiderio irrazionale – in questo senso anchedistruttivo – e nello stesso tempo la sottomissione a un sistemaarcaico dimostra il primato evolutivo della società occidentale.
Questa estetica ha trovato un terreno particolarmente fertilenelle esperienze coloniali degli stati europei nell’Ottocento, maè rimasta una presenza tenace anche nella teoria di moltediscipline nella prima metà del Novecento; in un prolungamentomoderno se ne trovano tracce nel pensiero femminista degli anniSettanta, che matura un progetto di reazione mondiale al poteremaschile anche mutuando la visione della donna orientale emusulmana come schiava da liberare. D’altra parte, nell’evolversidi questo pensiero attraverso gli anni Ottanta del secolo scorso,un punto di snodo significativo è stato il superamento di questaprospettiva e l’aprirsi del confronto fra teoriche occidentali eorientali del movimento: i nuovi contributi hanno messo in lucequanto semplicistico potesse essere stato attribuire all’agencydel potere femminile europeo e americano una missione liberatricesu scala globale; quanto cioè le realtà della vita delle donne incontesti non occidentali fossero molteplici e differenti,irriducibili a schemi di tipo universalistico.
Se queste rappresentazioni si sono protratte a lungo, nondeve sorprendere che si premuri di guardarsene anche uno studiorecente come quello pubblicato due anni fa dall’antropologa RubaSalih. In Musulmane rivelate, Salih nota che in genere l’identitàsessuale viene messa in connessione con l’islam, assumendo percerto che in queste culture la dottrina religiosa influenzi ilruolo assegnato alle donne. L’autrice obietta che questo porta ainterpretazioni inadeguate perché incapaci di rilevare il peso diuna molteplicità di fattori. Secondo Salih il contestomediorientale è una gamma di realtà differenti: da alcune in cuic’è agli effetti un condizionamento forte dell’islam tradizionale
76 Edward Said, nato a Gerusalemme nel 1935 e scomparso nel 2003, è stato docente diinglese e letteratura comparata alla Columbia University. In un saggio del 1978 lostudioso palestinese americano ha proposto una lettura critica di una vasta porzione diopere letterarie e saggistiche occidentali nell’arco di vari secoli, sostenendo appuntoquanto una conoscenza superficiale e inesatta avesse funzionato come cornicerappresentativa europocentrica di un Oriente – vicino, medio ed estremo – arretrato einferiore. Said è anche autore di uno studio significativo della situazione mediorientalenella prospettiva storica e culturale del rapporto dei palestinesi con la popolazioneebraica, edito da Gamberetti.
68
sulla vita delle donne, ad altre in cui la religione ha unarilevanza scarsa – o non ne ha nessuna - rispetto ad altrematrici di tipo economico e culturale77.
Per diversi elementi, nei testi che esaminiamo la questionedell’identità femminile e la dottrina dell’Islam non sembranoessere in connessione diretta: lo sguardo di Suad Amiry e diSahar Khalifa è uno sguardo laico; in queste narrazioni non c’èné una storia di educazione religiosa, né una prospettiva valoriale condizionata dallamorale islamica. Pensiamo in particolare all’influenza che unavisione teologica - dotata di un suo finalismo che confligge conil senso del passato e del futuro di tipo storico - può avere perla memoria culturale: la visione teologica è presente nei testi,ma è descritta a distanza, da una prospettiva laica.
In una sequenza originale di Sharon e mia suocera Suad siaffaccia sulla vita dei vicini, la famiglia Zahi, assistendolanelle molte tragedie che nel corso degli anni gli Zahi si trovanoad affrontare. Si tratta di una famiglia musulmana popolare, consette figli: le vicissitudini sono quelle della tossicodipendenzadel maggiore, che lo porterà alla morte, e del tradimento delminore, che per le facilitazioni e gli agi che gli vengonoofferti diventa un collaboratore dell’intelligence israeliana; ilsuo compito da infiltrato palestinese è individuare fra amici edvicini eventuali attivisti della resistenza. Mentre cerca diaiutare Umm Zahi, la signora Zahi, Suad vede tutta la serie diqueste vicende, che sono uno spaccato di violenza e miseria,dell’equilibrio precario della vita all’ombra dell’occupazione.Su questo sfondo Suad Amiry ricama come un cammeo la descrizionedella fede islamica degli Zahi, che fra l’omicidio di un figlio,un appalto abusivo e l’adulterio di un altro, programmano il loropellegrinaggio annuale alla Mecca.
Il simbolo riappare anni dopo: Suad riceve in regalo dalfiglio più piccolo, il collaborazionista, un “enorme plasticodella Mecca”. Dopo lo stupore divertito, Suad si trova a non
77 “La maggior parte dei dibattiti sulla condizione femminile nell’Islam tende a ignorareil contesto politico, sociale ed economico nel quale le donne musulmane vivono le lorovite, un contesto nel quale l’islam non è che una delle variabili. In questo contesto,non solo si sono potute ignorare le pratiche di resistenza delle donne verso le forme dipotere e di esclusione cui sono state e sono tuttora soggette, ma si è potutomarginalizzare un’analisi storico-politica della formazione di diverse ideologie digenere nel vastissimo mondo islamico in favore in un approccio meramente esegetico, incui si è cercato nei testi e nelle fonti religiose, attraverso letture e riletture, la“vera” condizione delle donne nell’Islam. Questo libro intende affrontare una serie diproblematiche nelle quali lo status formale delle donne nell’Islam non è che una dellequestioni; e non sempre quella centrale. Una premessa fondamentale da cui si intendepartire è che né l’Islam, né le relazioni e i ruoli di genere possono essere analizzaticome immutabili o fissi”. Salih, 2008, p.12.
69
riuscire a smettere di pensare a questo oggetto. E’ presa da unsospetto: “perché Rami avrebbe dovuto regalarmi un plastico dellaMecca, conoscendo bene le mie posizioni di sinistra e sapendoperfettamente che la religione non è il mio forte? Che cosastanno cercando di dirmi Rami e i suoi grandi capi?”. Suadconclude che deve contenere una microspia con cui il Mossadisraeliano intende mettere la sua vita sotto controllo. L’ironiatraspare quando il marito Salim tenta di tranquillizzarla, primaassicurando che l’idea della cimice è “una sciocchezza” e poiproponendo in ogni caso di liberarsi del plastico; a questaipotesi Suad è sgomenta: “Ma come faccio a gettare la Mecca nellaspazzatura? - riflettei mentre imploravo Salim alla ricerca diuna soluzione78”. Dopo una serie di passaggi di mano il senso dicolpa di averlo regalato a un’amica, mettendola a sua volta arischio di spionaggio, alla fine convincerà Suad a gettarlo.
Con il simbolo del sacro cristallizzato nel plastico Amiryrealizza una sintesi di diversi elementi: ha la possibilità diaffermare la sua laicità mentre convoglia in una figuradell’assurdo i due temi della religiosità tradizionale, narratadal progetto di pellegrinaggio di Umm Zahi, e della religioneconnessa al fatto politico; l’Islam infatti è chiamato in causaper evidenziare il ridicolo del modus operandi dell’intelligenceisraeliana, che legge nella dedizione dei palestinesi all’islamil primo segno della minaccia di una vocazione al terrorismo.
Anche Khalifa affronta il problema del finalismo religioso inalcune parti di Una primavera di fuoco.
Però la prospettiva religiosa riguarda soggetti diversi daiprotagonisti: è nelle parole di personaggi marginali, come ifedayn ai quali Magid si è unito, o la vecchia nonna che invocaAllah perché salvi la vita al nipote – ancora Magid, colpito eferito gravemente dalla scheggia di una bomba israeliana; oppuresono dei ministri religiosi – uno musulmano e uno cristiano – adiscutere dal punto di vista di una competenza particolare laquestione del volere divino.
E’ difficile attribuire con chiarezza il punto di voce diqueste riflessioni: a volte sembra che sia quello delpersonaggio, altre quello dell’autrice. Così le domande sigeneralizzano. Come se Khalifa riuscisse a collocare Dio nelloscenario delle rappresentazioni collettive, perché questo aspettole interessa molto più del rapporto dei soggetti con una fedepersonale.
78 Sharon e mia suocera, p. 230.
70
Quando Magid, perse le speranze della carriera musicale, siunisce ai fedayn della resistenza, c’è una riflessione sullepossibilità e le speranze dei guerriglieri fuggiaschi. Ilregistro qui non è ironico, il concetto di Dio è piuttostoutilizzato come termine di un confronto di prospettive: quello,caustico, fra istanze ideologiche del discorso rivoluzionariopalestinese. Del tutto scoraggiato Magid è introdotto allalettura del Corano, che risponde alla mancanza di speranze controla potenza soverchiante degli israeliani: “’Leggi e capiraitutto’ - gli dissero - ‘l’universo, la gente e come va il mondo.Oggi si sale e domani si scende, non resta che scommettere sultrascendente’. - ‘Scommettere sul trascendente?’- chiese. - ‘Mache senso ha?’. - ‘Hai forse un'altra scelta?’ - gli obiettaronoloro. - ‘Abbiamo scommesso sul mondo e non è servito a niente,abbiamo scommesso sul sapere ed è stato inutile, abbiamoscommesso sul diritto e la coscienza e abbiamo trovato soltantouna moltitudine di adoratori di idoli, di servi del denaro. Manoi, noi possediamo qualcosa di più forte, più forte dell’atomo edi Hiroshima, più forte di Bush.’. - ‘E chi sarebbe più forte diBush?’. - ‘La fede’ - avevano risposto. - ‘Leggi, recita, pregaDio di farci vincere, chiedigli di distruggerli. Quelli, solo laforza li piegherà. E non c’è potenza né forza se non in Dio’.Annuì. Non discusse, non fece obiezioni, ma mormorò mesto: ‘CheDio vi conceda la vittoria, che nessuno vi pieghi79’”.
In questo passaggio la scelta prospettica è significativa:Khalifa tiene insieme l’elemento enfatico della fede deicombattenti con quello realista della disillusione delprotagonista, ben lungi dal trovare nell’Islam una chiave dilettura eroica o una motivazione a reagire al dramma che vive.Attraverso gli esempi che abbiamo citato - e in generale nellospazio di tutte le narrazioni - si rintraccia l’espressione diun’elevata consapevolezza culturale rispetto alla possibilità diaderire ai testi religiosi come testi comportamentali; possiamoassumere allora che questo sia un tratto che connota la societàaraba palestinese nella concezione di un’identità, anchefemminile, indipendente dalla prescrizione coranica.
Discutendo questo aspetto però abbiamo deviato dallaquestione posta dagli studi su identità femminile e islam, chenon è tanto quella della fede, della credenza religiosa, ma delrapporto fra precetto religioso e diritti e prescrizioni sociali in base al genere sessuale.
79 Una primavera di fuoco, p. 134.
71
In effetti nei testi un’ attribuzione precisa al maschile eal femminile c’è e richiama le matrici socio ambientali a cuiSalih dice di guardare prima o insieme a quella religiosa.
La società palestinese sembra segnata da una tradizione disegregazione per genere; pensiamo a un’idea di struttura culturale incui il centro non è occupato dalla sharia, la legge islamica, mane mantiene “ossificate80” le istruzioni di condotta normativa cheriguardano gli uomini e le donne.
Ovvero un’organizzazione relazionale che prevede laseparazione spaziale quanto simbolica fra maschile e femminile.
Però, considerata come appena detto nella cornice laica, lasegregazione per sesso non comporta alcuna esplicitazione di un codice, maprende piuttosto la forma di un habitus, di un agire consuetudinarioin senso lotmaniano81. Anche Salih pensa a forme di segregazionesessuale su diversi gradi, che non sono necessariamente legate aun’organizzazione sociale basata sulla morale teologica.
Per descrivere la società palestinese l’antropologa una duemodelli: il primo rielabora in chiave contemporanea la teoria diTalcott Parsons82 sui ruoli di genere, il secondo è lo scambiopatriarcale83’ di Deniz Kandyoti.
Con Parson Salih distingue aree sociali in base al fatto chei ruoli sessuali siano marcati o meno: nella vita pubblica, dauna parte, evidenzia che sotto l’occupazione israeliana si ècreata una forte società civile e le donne sono una presenzamassiccia nella politica e nelle strutture amministrative, conuna sorprendente dissoluzione della differenza sessuale; però,dall’altra, nella sfera professionale hanno ancora un ruolosecondario e c’è un netto distacco fra l’importanza attribuitaalle loro carriera contro quella maschile; terza area, la sferadomestica decisionale, dove la divisione rimane netta,probabilmente per la tradizione coranica, ma nel senso di un maggiorpotere femminile.
Anche il modello di Kandiyoti serve per parlare di unacontraddizione. Infatti in una società in cui il tasso diistruzione delle donne e la partecipazione delle stesse allasfera pubblica e politica sono fra i più alti del mondo arabo sivede un cambiamento all’indietro: la precarietà perenne infattispinge al recupero dei marcatori locali di modestia orispettabilità. Il fenomeno è detto dello scambio patriarcale,
80 Lotman, 2001, p. 56.81 Lotman, 2002, p. 224.82 Segre, 2009.83 Kandiyoti, 2007.
72
patriarchal bargain: è un concetto antropologico, che considera lasocietà palestinese dal punto di vista dell’esistenza di unaprotezione patriarcale, attivata con il contratto di matrimonio.Ora il fatto è che non si tratta di un segno negativo, perchémette in luce che le donne hanno uno spazio in cui muoversi, la strutturasociale segregata le dota di un potere specifico per negoziare protezione oautonomia.
3.2 Il modello della scena femminile
Riassumendo identifichiamo nei testi di Khalifa e Amiry ilriferimento a una società palestinese laica, in cui c’è unorientamento segregante sul gender sessuale che non comportaaffatto il semplice asservimento delle donne agli uomini.Guardiamo a un passaggio testuale di Una primavera di fuoco, che puòavere un interesse maggiore essendo l’unico testo non narrato dauna voce femminile esplicita.
Abbiamo detto che la sua struttura ricorda quella di unromanzo di avventura, con l’incastonarsi una nell’altra di piùsequenze narrative e nettamente improntata all’azione. Qui peròci sono punti in cui il ritmo rallenta e il tempo si dilata inscene perlopiù in interno, che ricordano quelle di un testoteatrale. Una in particolare si innesta nello svolgimento dellevicende e lo sospende; un passaggio che ricorda la cena femminiledi Niente sesso in città e ricorre anche in altri due testi diKhalifa84: è un dialogo fra donne che si svolge in una casa diRamallah alla vigilia dell’assedio israeliano.
Rimasto ferito nell’attacco israeliano al gruppo di fedayn acui si era unito, Magid si trova nella condizione doppiamentecritica di fuorilegge ed invalido: interviene allora ilpersonaggio della nonna, la Hajja, che si preoccupa di nasconderlodagli israeliani durante la convalescenza; ad aiutarla Suad,l’amica di Magid che un tempo suonava insieme a lui nella banduniversitaria.
Le due donne riescono a procurare al ferito una sistemazionenella ricca casa nella quale per un periodo Magid aveva lavoratocome giardiniere. La famiglia dei proprietari è stata smembratada una tragedia e a presidiare i loro beni sono rimaste soloLaura, unica figlia del ricco commerciante al-Washmi e la nonna,Madame al-Washmi.
L’urgenza di nascondere il ferito e di assisterlo porta cosìle quattro donne a convivere per alcuni giorni:, chiusa la
84 Terra di fichi d’India, Jouvence, 1996; La porta della piazza, Jouvence, 1994.
73
sequenza narrativa delle avventure del Magid ne scaturisceun’altra, dalla forma di una lunga enclave: per le diciotto pagineseguenti c’è solo il dialogo femminile.
L’intermezzo è spaziale e tematico, perché il contestodell’occupazione sfuma e al centro del narrato vengono a trovarsii pensieri e i giudizi di ciascun personaggio, mentre tutte equattro le donne sono impegnate in una conversazione, conKhalifa: “sull’ amore”.
Per una gerarchia di anzianità le due donne giovani, Laura eSu’ad, stanno in ascolto mentre Madame al-Washmi e la Hajja, lanonna di Magid, narrano e discutono sulle loro esperienze e sulleloro convinzioni rispetto a questo sentimento. I due personaggisono costruiti per antitesi: la Hajja è tematizzata perl’estrazione popolare e la femminilità araba tradizionale, mentreMadame per la formazione cosmopolita e lo status economicoelevato: agli occhi di questa la Hajja è “una nullità, un’ospiteingombrante, povera e ignorante”. Intrecciato al temasentimentale c’è un elemento ironico che passa proprio attraversoi racconti della Hajja: abbandonata all’evocazione dell’epocadella sua giovinezza la nonna inizia a vantare una di avventureromantiche improbabili, che muovono l’ilarità delle due ragazze.Prestando attenzione però emerge che il dialogo presenta unadimensione tutt’altro che frivola, perché è un confrontovaloriale sulla moralità dei sentimenti femminili: ciascunpersonaggio appare nella doppia luce di una prospettivasoggettiva e di una visione generale della condotta delle donne.Consideriamo il passaggio in cui la Hajja narra la presuntarelazione con un principe arabo: “lui era il figlio del Bey e ioero giovane, bella, elegante e splendente. Quando mi disse «seitutta la mia vita» ne fui felice e gli credetti. Era figlio delbey. Era bello come la luna, biondo con gli occhi azzurri. Erabello da impazzire. Andai con lui, persi la testa e rimasiincinta. - Laura esclamò: - sei rimasta incinta di lui?. - LaHajja si affrettò ad aggiungere imbarazzata: - Ma prima avevamofirmato il contratto matrimoniale85’”. Qui il gusto della fantasiae il potere della passione sopravanzano il fondo pur presente diuna morale sessuale basata sull’onore.
Questa invece la riflessione in cui Madame al-Washmi giudicale parole della prima: “quella donna era una bestia, avevavissuto nella lussuria e nel peccato. Si era presa degli uomini,li aveva eccitati e loro avevano lasciato le loro mogli perandare con lei, esattamente come aveva fatto lui. Ricordò quella
85 Una primavera di fuoco, p. 186.
74
notte di solitudine. Ricordò il dolore, la pena. Poi se ne eraandata, via, un po’ qui e un po’ là, ma in segreto, senza darescandalo, senza clamore. Salvaguardando la famiglia e il suoprestigio, il proprio buon nome e quello dei suoi figli86”. Laposizione di Madame è decisamente più tradizionale e corrispondea quello che un generale concetto di sottomissione femminileprescrive per il ruolo di moglie rispetto alla libertà sessualedel marito.
Ancora differente il modo in cui Su’ad, dopo aver ascoltatoMadame pronunciarsi a favore della morigerazione delle donne,pensa alla propria esperienza: “il grande amore è come la Causa,come la politica, come la Palestina, dura in eterno. Finiscequando finiamo noi. L’amore non è un gioco, è un precetto, ungiuramento, un obbligo. E le tornò in mente lui. Mormorò,sconsolata: no, non è possibile, e dentro di sé, si mise ariflettere sull’utilità di soppesare la sincerità87”. Laprospettiva di Suad è quella di un dilemma più moderno, cheintreccia il sentimento con la partecipazione politica, per lostesso problema di coerenza etica verso se stessa.
Ma la posizione di gran lunga più attuale è quella di Laura,nipote di madame ed erede della famiglia al-Washmi. Laura èsegretamente innamorata di Magid dal tempo in cui lui lavoravacome giardiniere alle dipendenze di suo padre, ed è sua lavolontà di offrire protezione al ferito e alle due donne che loaccompagnano. Quello che Laura pensa dell’amore emerge quando lanonna condanna il suo sentimento, accusandola di voler proteggereun terrorista: “la parola terrorista per lei, era soloun’espressione per indicare un’azione pericolosa che a loro nongarbava. Non garbava a chi? Non garbava a Sharon? E chi sarebbeSharon? Chi sarebbe Barak? Chi sarebbe Shamir? Chi sono tuttiquelli lì? Non sono tali e quali a lui? Anzi, peggiori di lui?Oltretutto lui è più bello, decisamente più bello di tutti loro,più alto e più bello, ha una bella voce suadente e suona bene lachitarra. Quanti ne ha uccisi lui? Cinque? Dieci? Quelli lì hannoucciso migliaia di persone88”.
Questi passaggi tracciano nello svolgersi della narrazionequattro profili morali: i personaggi sono poco credibili inquanto a spessore psicologico, l’interiorità serve soprattutto come spazio diipostatizzazione dei concetti del campo semantico della condotta morale femminile.
86 Una primavera di fuoco, p. 191.87 Una primavera di fuoco, p 191.88 Una primavera di fuoco, p 180.
75
In questo senso almeno due aspetti sono degni di nota. Perprima cosa il fatto che si tratta di un giudizio esclusivo, digenere: lontano dalla sfera pubblica, dove più ampio è il poteremaschile, la sanzione qui passa attraverso la competenzaspecifica del femminile, e le donne delle donne ne sono inpossesso nella doppia qualità di soggetti e di destinanti. Insecondo luogo questo spazio innesta nella narrazione elementi diun altro genere letterario, quello del romanzo rosa.
Nel saggio di cui si discuterà fra poco, Teorie di genere, siparla di un gruppo di studi americani che negli anni Novantahanno esaminato format televisivi specifici proprio in rapportoal genere letterario rosa: per esempio il lavoro di Brown del1994, che si concentra sul piacere della visione indotto da certiformat nelle spettatrici. Dall’osservazione di un gruppo di fandelle soap Days of our lives, Coronation Street, Sons and Daughters eNeighbours, Brown deduce che le spettatrici costruiscono unnetwork simbolico, una rete di discorsi tra donne basata sullasolidarietà, su un senso di “enpowerment” e di potenziale“resistenza” all’ordine patriarcale dominante. Brown osserva chetra amiche, o tra madre e figlia spesso si ironizza sulla culturamaschile criticando il comportamento dei protagonisti delle soap.
Il passaggio che abbiamo visto richiama alcuni trattiindividuati da Brown; ora, è poco realistico pensare che Khalifasi rivolga a un pubblico femminile come target specifico – come èil caso dei romanzi rosa e delle soap – ma potremmo però parlarein questa scena del piacere di una scrittura femminile da partedell’autrice. Infatti in Una primavera di fuoco si incontra più volteun’enunciazione impegnata a narrare quelli che potremmo definire‘temi’ femminili, istituendo inoltre spazi demarcatidall’identità sessuale dei soggetti di azione. Ripensiamo alleconsiderazioni di Ruba Salih sul potere di azione delle donne nelsistema di valore sociale palestinese: queste sonoantropologiche, per quello che abbiamo osservato in questaletteratura c’è una corrispondenza in termini cognitivi:un’autonomia cognitiva dal maschile che a livello testuale passa dal gusto dellanarrazione femminile.
3.3. L’abito di genere
Nell’orizzonte della memoria culturale ci si può chiedere sequesta separazione di spazi ha una rilevanza, se bisogna
76
considerare che produca un archivio di memoria basato sul genere.Per farlo occorre chiarire meglio il legame fra il concetto digenere e quello di scrittura femminile.
In Teorie di genere, Cristina Demaria offre una disanima deicontributi teorici femministi che guardano a questo problema. Ilsaggio propone una prospettiva testuale che tenga insieme ilconcetto di genere e quello di differenza sessuale; infatti neglianni Novanta la teoria entra in crisi proprio rispetto a questidue concetti, rispetto alla domanda cioè di quali siano leimplicazioni del gender per l’idea di uno spazio femminile specifico.
Scrive l’autrice: “nel postmoderno la definizione di gendersi estende, arrivando a caratterizzare: “tutto ciò che può esserepercepito come posizionante a livello soggettivo, in un’autorappresentazione”; e la concezione del femminile sfuma diconseguenza, perché: “la sessualità diventa una posizionefacilmente occupabile e trasformabile, da cui è espulsa sia laquestione dell’inconscio, sia quella dei contesti materiali incui avviene l’assunzione di un genere89”.
Per potersi confrontare con un problema di velocitàesponenziale di cambiamento, che la riguarda rispetto al versantepsicoanalitico e a quello culturale, la teoria deve ripensarequesti aspetti.
La psicoanalisi infatti: “soffre il limite di non contemplareil fatto che il soggetto non viene prodotto una volta per tutte:esso è sempre in formazione, è ripetutamente prodotto90”; d’altraparte dagli studi post coloniali in poi è difficile parlare diuna cultura, non solo perché ce ne sono altre ma perché “lospazio di quella che un tempo era la Cultura non è piùmonolingue: è invece ibrido, tradotto, creolizzato91”.
89 Demaria, 2003, p. 60.90 Demaria, 2003, p. 54.91 Demaria, 2003, p. 63.
77
Fra le teoriche che propongono soluzioni c’è Judith Butler92
che afferma che la frattura del discontinuo postmoderno va usata comesolco in cui far crescere nuove teorie, o: “una teoria di cui cisi riappropria per proporla in contesti politici: non si trattadi ‘applicarla’ ma di ricontestualizzarla e ‘reiterarla’ percontaminarla e aumentarne la rilevanza politica93”. La forza di unnuovo discorso femminista starebbe nel considerarel’identificazione, piuttosto che l’identità, in una sorta dinuova fenomenologia dell’esperienza.
E così ecco il punto di contatto con l’evoluzione dellasemiotica, che è simile, mente si sposta dallo strutturalismo alpost strutturalismo verso una semiotica dell’impronta: la propostafemminista che ci interessa di più, infatti, sfrutta proprio lavicinanza dei due percorsi ed elabora un modello incorporandopunti del pensiero di Peirce. Seguiamo l’idea di Teresa DeLauretis che pensa al ruolo del gender nella testualità culturalecome un “abito”: ricavando dal testo peirceano la modalitàd’interazione del soggetto con il mondo, suggerisce di pensare alflusso di connessioni fra mondo interno e mondo esterno comecerniera dell’esperienza, attraverso cui ognuno di noi “sedimentanel corpo e nella coscienza abiti individuali che sono sia ilrisultato, sia la produzione sociale del significato94”. Così,anche il gender, inteso nella differenza sessuale, ha inizionella percezione di segni assiologici, che si sedimentanoattraverso una valenza, e si riattivano e si rimettono inpratiche nella forma di un abito. Demaria sintetizza: “l’abito è
92 “Questo implica che non si tratta di mettere in relazione la razza, la sessualità e ilgenere, come se fossero assi di potere completamente separati. Ciò che appare entroquesta struttura enumerativa, come un insieme separabile, è in realtà la serie dellecondizioni di articolazione di ognuna. Come è vissuta la razza relativamente allasessualità? Come è vissuto il genere relativamente alla razza? In che modo le nazioni egli stati coloniali e neocoloniali mettono in atto le relazioni di genere nelconsolidamento del potere statale? In che modo le umiliazioni della legge coloniale sonostate rappresentate come evirazione (Fanon), o la violenza razzista come sodomizzazione(JanMohammed)? Dove e in che modo l’ “omosessualità” è allo stesso tempo la sessualitàimputata al colonizzato, e il segno incipiente dell’imperialismo occidentale (WalterWilliam)? In che modo l’ “Oriente” è stato rappresentato come il femminile velato(Lowe,Chow), e in che misura il femminismo ha depredato il “Terzo Mondo” in cerca diesempi di vittimizzazione femminile che confermassero la tesi di un’universalesubordinazione patriarcale delle donne (Mohanty)? E come accade che le possibilitàdiscorsive disponibili incontrino il loro limite in un “femminile subalterno”, intesocome una catacresi, la cui esclusione dalla rappresentazione è diventata la condizionedella rappresentazione stessa (Spivak)? Farsi queste domande significa continuare a porreil problema dell’identità, come parte di una mappa dinamica di potere nella quale leidentità sono costituite e/o cancellate, schierate e/o paralizzate.” Butler, 1993, p.109.93 Demaria, 2003, p.65.94 De Lauretis, 1986.
78
un prodotto del coinvolgimento di sé nella realtà sociale: ilsoggetto è colto in particolari configurazioni discorsive e ciòche lo differenzia è l’interpretazione, ma anche l’azione, lapratica politica, vale a dire la sua facoltà di agirestrategicamente95”.
Un intento politico non appartiene e non può appartenere allaricerca semiotica, ma il concetto di strategia è più cheprezioso: pensiamo a un abito di genere come strategia identitarianella scrittura di Amiry e di Khalifa. In Niente sesso in città, inSharon e mia suocera, attraverso questo abito passano filtri dimemoria fondamentali per la costruzione identitaria dellaprotagonista.
In Niente sesso in città è marcata già l’impostazione generale,dato che l’autrice contrappone il tema ‘pubblico’della situazionepolitica della Palestina contemporanea a un tema privato:l’identità femminile è asserita dal paradosso che tiene insieme idue piani.
Ma anche in Sharon e mia suocera c’è un confronto paradossale,descritto dal titolo; nel testo si racconta l’occupazione delgoverno israeliano insieme alle vicende private e familiari diSuad Amiry.
Il paragone fra un livello pubblico e uno privato li accomunama mentre in Niente sesso in città riguarda due aspetti ‘interni’ delsimbolo della Palestina, in Sharon e mia suocera entra in gioco unelemento dell’ altro israeliano. Anche quest’opposizione si reggesul genere: infatti tutto quello che è israeliano è connotato sul maschile,mentre la sfera della vita privata di Suad è punteggiata dai tratti del femminile. Dallaparte dell’occupazione ci sono i bombardamenti aerei, la violenzadei soldati ai checkpoint, la continua vessazione dellapopolazione da parte dei militari, il confronto estenuante diSuad con il funzionario dell’amministrazione civile israelianaper ottenere un documento di residenza in Cisgiordania; dallaparte della vita privata della protagonista invece i ricordidella madre, il racconto della convivenza con la suocera, lavisita dell’adorata nipote adolescente, la rievocazione delledifficoltà seguite al suo matrimonio come moglie non residente inCisgiordania di un cittadino cisgiordano, il rapporto con lavicina e l’affetto che lega Suad negli anni prima alla sua gattae poi alla sua cagna.
In un punto Suad, un’amica e il marito Salim sono sottopostia un controllo israeliano e Suad sfida l’ordine di uno dei due
95 Demaria, 2003, p. 46.
79
soldati che le ingiunge di “smettere di fissarlo96”; allora ilmilitare chiama in gioco il potere maschile di Salim perché“costringa sua moglie a comportarsi come si deve”, ma ottienecome risultato solo il crescere dell’ostinazione dellaprotagonista.
Suad è “dispiaciuta per Salim”, che è punito al suo posto:l’intento del soldato, il “macho in uniforme”, è di svilire Salimperché non è riuscito a placare la propria moglie. Ma Suad avevaun proprio programma narrativo, di collera, da cui non potevadeviare solo per il bene del marito: “era il minimo che potessifare per rendergli pan per focaccia. La mia era una vendetta cheaspettavo da tempo”
In sostanza il risentimento privato di Suad, maturato nelricordo della protagonista di tutte le frustrazioni subite sottol’occupazione, contro la gestione asettica e brutaledell’autorità israeliana, che controlla i cittadini palestinesiconsiderandoli numeri, nell’intento di ridurli a uno stato diassoggettamento. Il confronto passa per il femminile di Suad e il maschile delsoldato: lo sguardo è centrale come tramite di una contaminazioneche il soldato percepisce e dalla quale cerca di difendersi.
Il potere di Suad è un potere femminile e insieme la rendeautonoma dalla sottomissione di “MOGLIE97” di Salim: per questol’introduzione dell’elemento maschile del potere del marito èsuperflua nella sfida fra Suad e il soldato, ma viene sfruttatada quest’ultimo per deviare il confronto in una prova di forzafra uomini.
In questa scena, come in altre lungo il testo, possiamo direutilizzando l’idea di De Lauretis di abito, che Suad Amirysemantizza la sua esperienza etnica attraverso un abito digenere.
Rispetto a questa proposta il caso di Una svergognata è ancorapiù esplicito.
La protagonista scrive la sua storia – o il suo diario –risalendo ai ricordi dell’adolescenza e dell’infanzia; ora questopercorso, che abbiamo detto non lineare e non progressivo, è resopossibile dall’evocazione di una serie di simboli a cui Afaf siaggrappa e attorno ai quali dipana il narrare. Queste ancore sonotutte connotate per genere. Dall’amata gatta di Afaf, Ambar, con cuinelle prime pagine si apre la descrizione delle imposizioni chela protagonista ha dovuto subire fin dalla nascita, sviluppataattraverso la contrapposizione con la libertà e l’autonomia
96 Sharon e mia suocera, p. 189.97 In maiuscolo nel testo.
80
dell’animale; alla mela che da bambina Afaf ha ottenuto in regaloe a cui si è affezionata come ad un’amica, e che la madre la hapoi costretta ad “uccidere” per mangiarla divisa in parti fra ifratelli; alle donne che, ospiti in casa di sua madre,confidavano l’una alle altre le sofferenze della loro vita dimogli, per poi tornare servili nei confronti del marito una voltache la visita si era conclusa; all’amica Nawal, la vecchiacompagna di scuola, che sotto una forza e un’autonomia apparentisubisce come Afaf le conseguenze dell’essere una donna, pergiunta sola, nella realtà retrograda di Amman; fino alle sorelle,insieme alle quali alla morte del padre Afaf è privata dellaquota legittima dell’eredità, spartita interamente fra i fratellimaschi: questo racconto cela l’ennesimo simbolodell’inadeguatezza di Afaf, perché le sorelle si rassegnano confacilità al sopruso che hanno subito, invocando per sé stesse eper la protagonista il potere del “destino delle donne”. Questaserie d’immagini, che si susseguono come nodi della memoria diAfaf, se non producono una narrazione piana, costituiscono quelloche potremmo definire un tracciato: o meglio un tracciato dimemoria secondo l’abito di genere.
Infatti il riproporsi della stessa difficoltà produce lungola narrazione un campo semantico del femminile ridondante; una memoriafemminile obbligata da cui Afaf non riesce ad uscire, in quanto, comepiù volte scrive lei stessa ne è in qualche modo “malata”.
Una trasformazione sarà possibile solo all’interno di unarealtà in cui si è modificato l’assetto di potere basato sulgenere, in quella casa di Nablus in cui Afaf e la madre siritrovano in assenza del marito, da cui la prima ha divorziato ein assenza del padre di Afaf che è morto. E’ scomparsi gli uomini chele due donne sono libere, perché al di fuori della dinamica direlazione al maschile imposta loro dall’ organizzazione socialetradizionale.
Questo rende La svergognata un caso sui generis rispetto aglialtri tre testi: la questione palestinese è uno sfondo sfocatoper quella che può essere definita una narrazione metafemminile.
3.4 La firma di una donna?
L’incontro con una narrazione tanto densa di figure ascrivibilial campo semantico del femminile porta forse a questo punto adover chiarire a margine l’impostazione di quest’analisi, il modoin cui viene inteso il concetto di traccia femminile.
Richiamiamo la riflessione di Demaria sul problema dellariconoscibilità dell’enunciazione femminile, citando il dibattito
81
storico fra le due teoriche femministe Nancy Miller e PeggyKamuff, in cui ci si chiedeva – in una versione estrema delconcetto di segno - se sia possibile stabilire l’identitàsessuale dell’autore di un testo e che importanza abbia questaidentità per il modo in cui l’istanza enunciazionale appare alivello enunciativo.
Per tentare un paragone dovremmo immaginare di chiederci seavremmo pensato che ad esempio Una primavera di fuoco fosse scrittoda una donna, nel caso in cui fosse mancata la firma di SaharKhalifa sulla copertina.
La discussione di Miller e Kamuff riguarda una serie dilettere pubblicate anonime nel 166998, e presentate come scritteda una suora novizia al suo amante. Rispetto al problemadell’anonimato le critiche concordano: si tratta di un testoredatto da un uomo che narra con la voce di una donna e per laquale firma, come “Mariane”. La questione riguarda l’importanzada dare all’interpretazione maschile della soggettività di unadonna. La posizione di Kamuff è stringata: nella lezione deldecostruzionismo non ha nessuna importanza chi ha scritto quellelettere perché una lettura critica femminista partirà dal testo esarà il gesto interpretativo a fare la differenza, cercando dismascherare i segni del potere patriarcale laddove una letturamaschile vi aderisce. Per Miller il problema è più profondo:Miller entra in qualche modo dentro all’identità di chi narra –un uomo – per denunciare il fatto che la passione della monacaviene costruita da uno sguardo maschile, che riesce così acondizionare il desiderio femminile, piegandolo in un’esteticache le donne vengono indotte a percepire come propria: le lettereportoghesi, fingendosi scrittura femminile, mettono in gioco unadinamica di potere che riguarda, con le parole di Miller, “ciòche le stesse donne hanno creduto di sapere e di conoscererispetto al loro desiderio”.
La teoria femminista degli anni Ottanta supera queste dueposizioni: “oscillando, o meglio cercando una sintesi traattenzione per la testualità e celebrazione della firma99”; ma lasoluzione non è di tipo semplice, proprio perché questo pensierotrova la sua forza nell’ineliminabile progetto politico.
Se una disciplina come la semiotica può forse riconoscere lavalidità di una lettura ermeneutica come quella di Millernell’ottica di un progetto politico, non la può certamente
98 Le lettres portugaises, raccolta di cinque lettere, tradotta e pubblicata a Parigi nel 1669.99 Demaria, 2003, p. 94.
82
condividere: una lettura empatica100 , animata dalla volontà diagire verso la liberazione e la consapevolezza delle donne,dunque non potrà mai essere concorrenziale con un metodo chestudia il segno nella sua efficacia comunicativa. Questaimpostazione permette di rispondere alla domanda immaginaria cheabbiamo posto ipotizzando che in Una primavera di fuoco potessemancare la firma dell’autrice.
A quella domanda non risponderemmo secondo il punto di vistadi Kamuff, così da considerarla irrilevante: sottolineeremmoinvece il dato comunicativo, ovvero che proprio la firmadell’autrice enfatizza il valore testimoniale. Se, rispetto alproblema dell’autenticità visto nel primo capitolo, la soluzioneproposta è quella di guardare al potere referenziale etestimoniale, in sé e nelle sue strategie, allo stesso modo quiil punto di una ‘scrittura femminile’ ci interessa qualeasserzione comunicativa: i testi che analizziamo vogliono esserecostruiti a partire da un’esperienza femminile; le autricivogliono parlare proprio di questo.
3.5 ‘Contro-memoria’: un’idea da ripensare
Chiarito questo punto, concludiamo questa breve disanima: abbiamolasciato aperta la domanda sul rapporto fra la memoria delleautrici in un abito di genere e il livello dell’archiviocollettivo palestinese. Parlare di gender significa ancheriferirsi agli studi che vedono la memoria delle donne comeespressione di un diverso potere nell’orizzonte culturale in cuisi ascrive.
In Studi di genere e memoria culturale questa impostazione è espressadal concetto di contro memoria: in questa lettura le donne sonointerpreti non privilegiate della ricostruzione di un discorsonazionalista patriarcale e per questo possono offrire resocontidi memoria non ufficiali e spesso anche sovversivi. Le autricihanno un’impostazione che eredita molti elementidecostruzionisti: sottolineano l’importanza dell’immaginazioneper la scrittura della storia da parte delle donne, come tessutoche connette il passato, il presente e il futuro alla luce di ciòche avrebbe potuto, può o potrà essere; l’immaginazione comealternativa a una storia maggioritaria e dominante. Per esempioFortunati si volge alla risemantizzazione che la memoriafemminile può operare sul concetto di nostalgia: “all’interno di
100 Per il concetto di lettura empatica sempre Demaria, 2003, p. 73 e sgg.
83
una concezione dinamica dell’atto del ricordare, la nostalgiaassume una diversa connotazione, perché lo sguardo rivolto alpassato non è una fuga verso di esso, ma piuttosto unripercorrerlo per produrre cambiamenti nel presente101. Questeproposte teoriche risultano euristiche se consideriamo l’archiviodella memoria occidentale: in Europa e negli Stati Uniti lanarrazione e la celebrazione del passato sono segnati da unalunga tradizione di razionalismo, che diversi studi femministiperaltro connotano per genere, parlando di una narrazionepatriarcale102; inoltre lo scenario pubblico occidentale amplificale narrazioni dominanti, e in esso atti di contro memoria possonorisultare delle vere e proprie revisioni di un canone. Ma èaltrettanto giusto affermare questo per le narrazioni checonsideriamo? Per il valore culturale di questa scritturapossiamo parlare di memoria di soggetti femminili marginalizzati?
L’enunciazione di Khalifa e di Amiry offre l’occasione dicomplicare il concetto di contro memoria, osservando elementispecifici di un contesto non occidentale.
E c’è un concetto di Monticelli, quello di inclusione, chesembra interessante: “ogni gruppo, che contiene ed eccede iconfini dell’esperienza individuale, si definisce attraversoprincipi di esclusione e inclusione103.
Nei testi che consideriamo l’abito di genere sembra metterein gioco degli elementi - l’essere donne, l’essere soggette inquanto donne alle prescrizioni di una morale tradizionale el’essere palestinesi - che non sono riducibili l’uno all’altro. Prima ditutto non si può parlare solo di un atto di scrittura sovversivadal momento che in questa cultura recente l’essere palestinesiespresso dai testi rende Khalifa e Amiry rappresentanti di unanarrazione maggioritaria - quella del sogno di liberazione e dellaforza di un passato sempre rievocato - per la quale i lorocontributi non sono di revisione ma di fissazione di un canone.Ma sono differenti anche le forme testuali che riguardano lecomponenti del femminile e del femminile nella morale sociale.
Nei testi di Suad Amiry il femminile è un elemento cardinale,ma la prospettiva non può essere definita quella di una visionecritica. In Niente sesso in città tornano nella memoria delleprotagoniste ricordi che riguardano la demarcazione sociale delgenere: come ad esempio alla soglia dell’adolescenza gli spazifamiliari mutassero e sorelle e fratelli non potessero più
101 Fortunati, 2004, p. 16.102 Demaria, citando Lata Mani, p. 104.103 Monticelli, in Fortunati, 2004, p. 86.
84
dormire insieme; come, ancora, fossero le stesse bambine aprendere a utilizzare quest’assegnazione di valore, canzonando lecoetanee meno integrate perchè si “comportano come un maschio104”.In Sharon e mia suocera, nelle parti in cui prende corpo il raccontodelle vicende degli Zahi, Suad affronta il problema della moralesessuale musulmana descrivendo le dinamiche di potere internealla famiglia, l’obbligo della signora Zahi rispetto al voleredel marito e il segno di degrado costituito dal fatto che ilfiglio la insulti chiamandola “puttana105”. Alcuni paragrafi oltresi narra del modo in cui Suad e Salim riescono ad attraversareindisturbati il checkpoint di Qualandia, grazie alle artiseduttive dell’amica Rema, che scambiando alcune battute con ilsoldato israeliano al posto di controllo ottiene il via libera epoi grida a Suad: “hai visto che stile? Una vera troia dacheckpoint106”.
In questi due testi il femminile è ostentato, attraversoforme di ridicolizzazione, oppure appare quando fa da segnopuntuale di un ricordo. Non si può parlare però di denuncia delsistema di prescrizioni come invece nel caso di Khalifa, già inUna primavera di fuoco.
Qui il tema femminile è sempre più importante in parallelocon l’aggravarsi della situazione dell’assedio israeliano allaCisgiordania. Il problema delle condizioni delle donne però nonè, come nei testi di Amiry, legato al dramma dell’occupazione:semmai gli spazi di riflessione dei personaggi femminilicostituiscono un’alternativa allo sfilacciarsi della coscienzadei due protagonisti.
Il femminile emerge nell’irrazionale cioè, come elemento che resiste aldissolversi di certi percorsi isotopici e ne apre uno proprio. Nelleultime pagine c’è una lunga scena con Suad protagonista. In unariunione familiare quando Suad schernisce il fratello maggioreche dipende economicamente dai genitori, il fratello si scagliain un’invettiva contro la scandalosa libertà della ragazza, chedisobbedisce a un uomo della sua famiglia e conduce una vitaautonoma ignorando il suo debito verso il padre, che dovrebbeonorare sposandosi e indirizzando sul marito l’onere del suosostentamento economico. Segue una scena narrativa chiusa, cheriguarda l’amore romantico di Suad per un dirigente dell’Autoritàpalestinese e le dinamiche della loro relazione impossibile.
104 Niente sesso in città, p. 131.105 Sharon e mia suocera, p. 222.106 Sharon e mia suocera, p. 263.
85
Da una parte torna il gusto femminile della narrazione digenere – anche se con un’ impostazione generale meno segnatadall’abito del genere femminile di quella di Amiry, dall’altra inUna primavera di fuoco l’aspetto di denuncia, di confronto con leproblematiche delle donne rispetto alla società palestinese, è unelemento marcato.
Per La svergognata non è difficile parlare di una narrazionesolo femminile. Il testo è infatti il risultato dell’intreccioesclusivo fra il piano esperienziale della percezione di Afafcome donna e la percezione delle norme che ne definiscono iconfini.
Il personaggio del marito di Afaf è l’incarnazione dellaviolenza che i codici di genere tradizionali infliggono alledonne; la protagonista descrive la formazione da aguzzino nellafamiglia di origine del marito: “lui era cresciuto coccolato,viziato, perché unico maschio fra un esercito di femmine. Tuttociò che aveva voluto gli era stato dato gratuitamente. Anche icapelli delle sue sorelle, che tirava fino a strapparli, fino ache le ciocche si accumulavano per terra. Era bravissimo nelprendere a calci le sue sorelle più piccole. Si vantavaricordando queste prodezze infantili e ne parlava davanti a meper dimostrarmi che fin da bambino era stato un collerico107”.L’atto principale della protagonista di La svergognata è farsparire la presenza del marito e con essa la sua identità dimoglie sottomessa.
Rispetto alla considerazione di Monticelli sui confinidell’inclusione e dell’inclusione in ogni contesto culturale,potremmo dire che solo in La svergognata l’atto di scrittura è il tentativo direvisionare un canone; solo qui si può parlare di una forma di ‘contromemoria’ culturale. Negli altri tre testi l’abito del genere nonproduce questa forma, anche se naturalmente orienta laspecificità di uno sguardo che fa delle autrici qualcosa di piùche testimoni etniche del conflitto mediorientale.
Ne riparleremo nel sesto capitolo rispetto alla proposta diSiegrid Weigel di uno squirting gaze, sguardo strabico, come stilefemminile di scrittura.
107 La svergognata, p. 48.
86
PARTE SECONDA.Dai testi all’archivio culturale
Abbiamo concluso il capitolo sulla memoria collettiva palestineserichiamando la distinzione di Lotman fra culture orientatesull’inizio e culture orientate sulla fine e collocando quellapalestinese nel primo tipo, sia per l’età recente della suaformazione sia per il tratto comune della nostalgia per un’etàdell’oro, per un mondo originario scomparso in modo definitivo.Approfondiamo questa osservazione: diciamo che le narrazioniappaiono rivolte verso gli antenati, fanno del gesto dellascrittura quello di un agente identitario che si percepisce comefiglio, a livello culturale.Ne segue anche un modo particolare di concepire il dolore e ilrapporto con la vendetta, che discuteremo nel quinto capitolo.Per dare un’idea il più possibile chiara di questi due elementiaffianchiamo ai quattro testi altri due: Memoria di Salman Nature Dentro la notte di Ibrahim Nasrallah.Li introduciamo con i primi tre estratti in appendice tratti daquesti romanzi: il numero sette, il numero otto e il numero nove.Il primo è un’evocazione verso il passato. Dovrebbe già esserechiaro che c’è un registro infantile nel modo di narrare, nelsimbolo del coniglio che rimanda all’idea di una favola; anchenel riferimento diretto all’infanzia. Registro che torna nelsecondo estratto, la scena di violenza subita dagli abitanti diun villaggio per opera di un gruppo di soldati inglese. Quiquesto tratto prende anche in carico la totale assenza diaggressività, per cui il dolore e la sopravanzano qualsiasi ideadi reazione alla brutalità degli inglesi. Nel terzo estratto ilprotagonista torna bambino rispetto al segreto inviolabile dellavita sessuale dei genitori. Sull’elemento dei rapporti intiminella narrazione palestinese torneremo nell’ultimo capitolo.
4. Terra e figli: memoria dell’infanziaAnalizzando il sé autobiografico Eakin dedica uno dei quattrocapitoli al concetto del “sé relazionale” – Relational Selves, Relational
87
Lives108, – e lo apre con questa citazione del sociologo NorbertElias: “one must start from the structure of the relations betweenindividuals in order to understand the ‘psyche’ of the individualperson”.
Eakin propone un modello cognitivo d’interpretazione di alcunitesti letterari utile anche qui; sottolinea che in moltanarrativa contemporanea la storia del sé è passa per quella deglialtri - familiari e membri della comunità che costituiscel’ambiente esperienziale del soggetto che narra - perl’interscambio comunicativo che forma un sé in opposizione all’‘altro’, poi, riflette su alcuni casi in cui la memoriaautobiografica è in continuo dialogo con un altro sé prossimo al proprio:“more often than not the autobiographical act is the relationwith another key person, generally a parent: we might say that inthis case the relation to a proximate other makes the selfexistance109”.
Eakin distingue casi espliciti dove la narrazione è il legame- per esempio – fra un padre e un figlio, o fra una figlia e lamadre, e casi impliciti in cui la relazione con l’altro fonda ilsé narrato senza essere un vero e proprio tema; di questi osserva“i suspect that this need accounts for the considerable amount ofoverwriting that marks these otherwise powerful narratives”.
4.1. Sanzioni
Con questo punto di vista, prima di tutto si vede che sia in Lasvergognata che in Niente sesso in città le protagoniste parlano deipropri genitori e costruiscono ampie sessioni di memoria sulrapporto affettivo o conflittuale con loro.
Del padre di Suad abbiamo già parlato e abbiamo detto che inun punto arriva quasi a occupare la posizione della vocenarrante, quando rievoca il viaggio a Jaffa per il tentatoriconoscimento della casa della famiglia in Cisgiordania110. Anchela madre compare in alcune pagine centrali, quelle in cui Suad èin procinto di trasferirsi stabilmente a Ramallah. Laprotagonista si rivolge alla madre che spesso le ha narrato dellavita ‘in Palestina’ prima della sua nascita e le dimostra chericorda con esattezza particolari degli aneddoti che haascoltato, tanto da possedere lei stessa un’immagine topograficadella città di Jaffa e dei luoghi familiari della vita quotidiana
108 Eakin, 1999, p. 43.109 Eakin, 1999, p. 45.110 Primo estratto in Appendice.
88
dei suoi genitori. Le parole di Suad nell’occasione di un addio,o perlomeno di una lunga separazione, provocano il pianto dellamadre. L protagonista si sente colpevole per aver suscitato unasensazione dolorosa con il bisogno di testimoniare la memoriafamiliare: Suad infatti non sa se attribuire la madre piange laperdita attuale, la sua, o la perdita antica della terra che leicon ostinazione ha ri-descritto.
Anche in La svergognata il rapporto con la madre riguarda unaperdita, però il tema la terra palestinese. Afaf discute lastruttura dei rapporti familiari, e la sottomissione agli uomini.Quando dopo il divorzio fa ritorno alla casa in cui è cresciuta,insieme ai molti fratelli e sorelle, alla nonna e ai genitori, ilclan è dissolto: il padre è morto e i figli vivono ciascuno inuna propria casa con le mogli o i mariti. Ad accogliere Afaf c’èla madre rimasta sola. In questa seconda vita Afaf la perdona ericonosce che prova affetto nonostante per anni le abbiaattribuito la colpa della complicità alla morale tradizionale, ilsuo ruolo attivo nella combinazione del suo matrimonio e sappiache ha ignorato i bisogni e anche le sue richieste di aiuto. EAnche Afaf viene perdonata, perchè la madre accetta quellavisione del mondo che le è sempre sembrata il segnodell’inadeguatezza, se non della follia, della figlia.
Ma anche gli altri due testi sono caratterizzati da spazideputati alla sanzione di madri e padri rispetto ai personaggi:in Niente sesso in città molte delle voci narranti delle amiche di Suadevocano momenti di confronto con i propri genitori, che a secondadei casi giudicano la loro condotta femminile adeguata odeplorevole rispetto alle aspettative sociali; ma anche momentiin cui gli adulti sono gli attori di un mondo che le protagonisteosservano, serbandone nella memoria gli usi, le tradizioni, gliatteggiamenti verso la vita. Un caso è quello di Reem, l’amica diSuad cresciuta a Gerusalemme e diventata addetta stampa delgabinetto di Arafat. Nella sua vicenda personale il rapporto didipendenza anche affettiva dal padre emerge in una duplicedisapprovazione, sia per la condotta femminile che per quellapolitica.
Quando ha deciso di sposarsi con il compagno dell’adolescenzamai accettato come pretendente legittimo dal padre, Reem haricevuto una scomunica senza appello. Il padre l’ha raggiunta aParigi all’improvviso per tentare di dissuaderla; dopo una seriedi feroci discussioni i due si separano fra le lacrime e pochigiorni dopo Reem trova nella cassetta delle lettere una foto coni genitori e i fratelli vestiti a lutto, per la sua perdita.
89
La protagonista tredici anni dopo rivede il padre e vieneperdonata: ma sceglie nello stesso tempo di tacergli un fattonuovo. Reem è stata condannata a un periodo di carcere israelianoper la sua attività fra le file dell’OLP: la visita al padre siprolunga senza fare menzione di questo, fino a quando la Jeepmilitare dell’esercito si presenta al cancello di casa perprelevarla.
In Una primavera di fuoco le dinamiche di relazione dei figli coni genitori sono quelle, ognuna diversa dall’altra, di Magid, diAhmad e dei due personaggi centrali di ‘figlie’ di Suad e diLaura al-Washmi. La scomposizione fra più punti di vistacontribuisce alla tematizzazione di cui abbiamo già detto, delconfronto generazionale fra giovani palestinesi e palestinesidella generazione ‘pre-67’. Accanto alla sanzione dei dueprotagonisti da parte del padre giornalista, prendono spazioanche le voci della nonna di Laura e in modo più esteso quelladella madre di Suad, Umm Suad.
Questo personaggio è marcato anche con il valore simbolico dimadre della collettività: perchè trasforma la propria casa in unrifugio per gli abitanti dell’intero quartiere strettonell’assedio israeliano, offrendo cibo e cure a quanti hannoperso la casa a causa dei bombardamenti ed ai guerriglieri checombattono in un’estrema difesa contro la presa di Nablus.
Quando il fratello e il padre accusano Suad di essere troppoindipendente e la invitano a onorare la famiglia sposandosiperché si affidi a un marito disposto ad assumere l’onere del suosostentamento economico la ragazza si appella all’opinione dellamadre. Solo Umm Suad ha il potere di zittire il figlioincollerito e proteggere la figlia, esercitando l’ autorità delrispetto al suo onore.
La prospettiva generazionale si coglie anche nei due nuovitesti che veniamo a considerare. Il primo, Dentro la notte di IbrahimNasrallah, è costruito come un racconto surreale e sconnesso. Ilprotagonista fa un viaggio con un amico, che peraltro rimane pertutta la narrazione così indefinito da suscitare il dubbio che sitratti di un fantasma, di un alter ego immaginario. A questastoria se ne alterna un’altra che procede con più ordine: consorelle, fratelli, genitori e alcuni vicini il protagonista ècostretto a trascorrere un periodo ammassati in un sotterraneo,durante il lungo bombardamento israeliani del quartiere.
Ci sono scene di violenza cruda, scaturita dalle condizionidi vita estreme in cui versa il gruppo: oltre la fame e la
90
mancanza quasi totale dell’acqua, si raccontano storie di bambinicolpiti dal fuoco israeliano, dispersi, suicidi.
La prospettiva del protagonista è morire di fame insieme aglialtri, in pochi metri al buio, o essere ucciso dai soldati se percercare cibo si avventurasse in strada: in questo frangentel’uomo si rimette completamente all’autorità degli anzianigenitori; si tratta di un uomo adulto, con una moglie e duefiglie, che però qui, solo con i fratelli, è come regredito al suoruolo di figlio.
Ad un certo punto obbedisce anche all’ordine della madre chedecide, lei per tutti, di ricorrere come fonte di sostentamentoai cuccioli della gatta di casa, nati sotto le macerie e in lottaper la sopravvivenza proprio come gli umani. Dopo il comunicatoradio del muftì che autorizza gli assediati a nutrirsi di carne digatto, di cane e di topo se necessario, la madre ordina di andarea prendere i gattini. Il protagonista racconta: “ero andato. Perun momento avevo avuto l’impressione che mia madre volesseliberarsi di me. La mia razione poteva essere distribuita ai piùpiccoli. Non si può sapere che cosa può accadere nella menteumana in momenti come quelli. C’era chi si disseccava a vistad’occhio. Chi vomitava. Chi soffriva di forte diarrea comespremuto da mani pazze. A qualcuno gli occhi erano diventatisporgenti e si era gonfiato il ventre. E mia madre! Mia madre chediceva di aver vissuto abbastanza e che toccava ai piccoliprendersi la loro parte di vita. Non so se mi considerava tra ipiccoli o tra i grandi quando mi aveva detto: - Va a cercarequalcosa! Qualsiasi cosa che si possa mangiare!111”.
Se pensiamo a questo chiedersi se è fra i piccoli o fra igrandi, non possiamo non notare che è una domanda strana per unadulto e piuttosto sembra fatta da un bambino.
L’altro testo che introduciamo, Memoria, è in partel’autobiografia dell’autore, Salman Natur. Ai ricordi di unintellettuale quarantenne si alternano frammenti di memoria dialtri personaggi; lo stile è sconnesso, disordinato,caratterizzato da continui salti temporali. Un ordine comparesolo quando una di queste altre voci comincia diventa unapresenza stabile: si delinea un confronto con un “vecchio”, “natonel 1900” a cui il protagonista offre un passaggio in autoattraverso la Gisgiordania, “verso il sud112, fino a Giaffa. Iltesto si trasforma nell’autobiografia del vecchio, che porta consé un taccuino, “per non perdere la memoria” e inizia a
111 Dentro la notte, p. 104. 112 Memoria, p. 103.
91
raccontare ai compagni di viaggio aneddoti e storie di guerra,ricordando gli amici, gli affetti, i luoghi e i beni perduti:prima che si apra questa parte il protagonista aveva raccontatodella morte di suo padre, descrivendone le convinzioni, gliultimi anni di vita ed il funerale.
Anche il vecchio alla fine del viaggio morirà: dopo averrealizzato il desiderio di vedere la terra di un tempo, esprime achi lo ascolta la volontà di essere seppellito lì, a Giaffa. Lororispondono con un saluto che diventa un pensiero: “Addio nonno.Te ne vai, ma in noi è vivo l’amore per la nostra terra. Ticerchiamo e non ti troviamo. Parla un filo di voce. Parla unavoce che tace, prima di veder realizzato il suo sogno. Maritorneremo. Per quanto il viaggio sia lungo ritorneremo113”.Questa sembra la risposta a una richiesta, a un monito che ilvecchio ha suscitato senza formularlo.
4.2. Un’ipotesi culturale
Oltre il sé cognitivo di Eakin interrelato con quello di unpadre o di una madre nella narrazione autobiografica privata –qui tutte queste figure genitoriali fanno pensare che ci sia unafunzione che riguarda tutto il gruppo nella relazione fragenerazioni.
Essere ‘figli’ informa più che l’identità privata delleautrici e degli autori: parliamo di una collocazionesemiodiscorsiva, un riferimento topologico del punto di vocedell’ enunciazione culturale.
Se esiste una connotazione dei soggetti come figli, pensiamoall’intrecciarsi di tre livelli: un livello di costruzioneattanziale, sul quale la narrazione si volge agli antenati,costruisce soggetti ‘figli’ e padri destinanti della sanzionenella prospettiva storica del sé; poi un secondo livello di cuifra poco parleremo, influenzato dal codice ideologico delnazionalismo palestinese, che assegna precisi ruoli di genererispetto agli agenti che mette in discorso; infine un livellotematico dell’ infantile, ma anche stilistico, su cui in tuttitesti è distribuita una porzione ampia del ricordo.
Bisogna dire per il primo che è un tratto specifico dellesocietà arabe musulmane; Salih e molti altri antropologi trovanoche il sistema attribuisca un’importanza primaria ai rapportigerarchici all’interno dell’unità familiare, la Umma ed a quelliinterni al clan contadino, la Hamcula. Però per la memoria
113 Memoria, p. 135.
92
palestinese il tratto comune si fa particolare: crea unadirezione nel tempo espandendo sempre la ricerca del senso delpresente ad un dialogo continuo con i padri, rappresentanti delpassato.
Questi sono tutti soggetti che attendono o non vogliono o nonpossono concludere il proprio senso storico; nella metaforalotmaniana che abbiamo proposto agganciarsi ai padri sembracondizionare la rinuncia all’orizzonte per il futuro.
Nei sei testi tutti condividono la stessa prospettivagenerazionale: a parte il materno nel rapporto di Suad con suasuocera, in Sharon e mia suocera, che è basato sul paradosso di unadonna di oltre ottant’anni accudita come una figlia; tutti glialtri protagonisti sono figli. Lo è quello di Dentro la notte, loquello di Memoria, che ha un rapporto con un uomo più anziano dicui ascolta i ricordi, sono figli in Una primavera di fuoco Ahmad,Magid, Laura e Suad; lo è anche Afaf, la protagonista de Lasvergognata - seppure nella sua biografia reale Sahar Khalifa abbiadue bambine, avute nel corso del matrimonio di cui racconta, eche ha portato con sé in Cisgiordania dopo il divorzio. Sonofiglie anche le nove protagoniste di Niente sesso in città - come se iltema della menopausa avesse ricollocato il sé femminile fuori dallamaternità: si accenna soltanto al fatto che alcune siano madri.
4.3 I figli della terra
Oltre al campo dei ricordi e delle storie personali, laconnotazione riguarda la prospettiva etnica: nei passaggi in cuisi esprime la coscienza rispetto al conflitto, i palestinesi sonofigli di una terra madre. Esempio esplicito la metaforaclimaterica che regge tutta l’isotopia ironica di Niente sesso incittà: quando Suad parla dell’analogia fra la realtà politica delpaese e quella biologica delle sue cittadine, personifica laPalestina. Esprime il senso di un amore filiale deluso, econtrappone alle amiche “la mia non più amichevole Palestina”, sipreoccupa del “futuro della tormentata Palestina”, ed osserva chealla dedizione delle amiche “la Palestina non ha dato in cambiogran che114”; nelle ultime pagine rivolge al suo paese un appellodiretto – come aveva fatto per Sharon e scrive: “Ho cominciato apensare a quante donne attorno a quel tavolo si erano lasciatealle spalle degli esseri amati per te, Palestina. Mi è tornata inmente la frase che più mi è cara in un romanzo di Sahar Khalifeh,
114 Niente sesso in città, p. 11, p. 13.
93
Bab Assaha, (La porta della piazza): ‘La Palestina è una bestia chedivora i propri figli’115”.
Anche il testo di Natur, come Una primavera di Fuoco e Niente Sessoin città racconta più storie di palestinesi vittime delle vicendedel paese e spesso il riferimento a un personaggio è a: “unfiglio della nostra terra116”. Quando denuncia l’appropriazionedella terra dei coloni israeliani, il protagonista esclama:“tutte le terre di Eilut sono state prese da quellidell’insediamento di Kfar Horesh, dell’insediamento di Nahal edei kibbutz vicini. Ci hanno ammazzato e ci hanno ereditato!117”.Qui cioè sovrappone l’oggetto del furto ed il soggetto che losubisce, in un tropo ‘di apparentamento’ familiare-successorio.
In Una primavera di fuoco la semantizzazione etnostorica deifigli di una terra madre torna con frequenza. Nel crescendodrammatico, i palestinesi cominciano ad essere chiamati semprecon un sema doppio che individua il gruppo ed i giovani comesoggetti distinti: espressioni come “la gente e i loro figli”“figli della nostra gente” e “figli della loro gente118” inizianoa punteggiare il racconto.
Ancora, nel quartier generale di Arafat assediato, Magidassiste all’intervento di una delegazione internazionale dipacifisti, che fa cessare le ostilità per alcuni giorni; ilragazzo esprime l’idea che ha del ruolo internazionale rispettoalla situazione palestinese, utilizzando l’espressione orfani:“abbiamo creduto che il mondo si fosse dimenticato di noi,eravamo convinti di essere senza famiglia e senza amici, lasciatisoli, degli orfani a un banchetto di spilorci119.
A livello simbolico il caso più marcato sono le parole delsacerdote della moschea di Nablus, lo shaykh, che per esortareAhmad a credere nella difesa del paese indica la Palestina comeil cuore delle madri: “La Palestina è la madre, il suo cuore, il suoseno, il suo utero. Ci sarebbe una madre se non ci fosse laPalestina? Ovviamente no. Quindi la Palestina è la madre dellemadri120.
Qui la natura del contenuto connotato dal simbolo risale adessere attribuita alla denotazione del simbolo stesso.
115 Niente sesso in città, p. 168.116 Memoria, p. 26. 117 Memoria, p. 93.118 Una primavera di fuoco, p. 139, p.141, p.142.119 Una primavera di fuoco, p. 206.120 Una primavera di fuoco, p. 286.
94
Si può dire allora che la figura della terra madre facciaparte dello spettro del codice culturale palestinese? Forse sì,dato che torna anche in La svergognata, nel testo cioè menocentrato sulla tematizzazione delle vicende socio storiche delgruppo. Quando Afaf ottiene dal marito l’autorizzazione perpartire si abbandona a un lamento nostalgico per il paese: “erodisposta ad accettare qualsiasi condizione, pur di ritornare, digettarmi sul suolo del mio paese, di proclamare che ne ero unaparte, che da lì provenivo. Pur di annusare l’odore del fango edi affondare il volto nel grembo delle colline. Sognai che il miopaese era mia madre e che mia madre era il mio paese. Che le mieferite erano quelle del mio paese. Lo vedevo a modo mio. Come delresto lui mi aveva visto a modo suo. Ricoprivo di un velo tutti icolpi che avevo ricevuto. Non rinnegavo più i diritti di miamadre su di me. Ero una bambina e lei era mia madre121”.
Il paese si trasforma nella figura femminile di madre in unpassaggio graduale attraverso la metafora delle colline comegrembo. Afaf cerca una redenzione, un ricongiungimento ecoinvolge un destinante che è allo stesso tempo la madre reale,la sua e il paese madre: tutte e due, dice, l’hanno trattata nellostesso modo.
4.4 L’ideologia nazionalista e i comunicati dell’OLP
La convergenza fra la prospettiva di figli in senso individuale equella di figli nel discorso etnico collettivo ci spinge aun’altra ipotesi.
Così dalla dimensione letteraria guardiamo a un altro pianodella cultura palestinese in cui sono perpetuate e forse in partegenerate le figure a cui ci riferiamo, quello dell’ideologianazionalista. Nella realtà del conflitto vissuto dalla partepalestinese l’aspetto ideologico è importante: storicamentebisogna concepire e dare forma ad un’idea di nazione per poterrispondere all’affermazione progressiva del diritto dello Statodi Israele per la ragione ancora più urgente di difendersi dallapolitica israeliana di appropriazione progressiva del territorio.
La storia delle vicende palestinesi è anche quella dellarappresentazione sociale e politica della nazione palestinese neltempo, attraverso le forme istituzionali che la hanno elaborata.
Per il modo in cui pensiamo ad una semiosfera culturale, lamemoria che si scrive nei testi recepisce elementi salienti deldiscorso nazionalista istituzionale, che poi reinterpreta e
121 La svergognata, p. 73.
95
ricombina nella nuova dimensione del letterario. Demaria notal’importanza di intrecciare gli studi postcoloniali allaproblematica del genere, perché ci troviamo in un momento storico– gli ultimi vent’anni – in cui “il sorgere di nuovinazionalismi, nuove o rinnovate proposte di identità nazionali,la recrudescenza dei fondamentalismi etnici e religiosi, hannoindicato la necessità di analizzare la categoria di nazione el’ideologia nazionalista al di là delle ragioni storiche quali ilcrollo del comunismo, o la crisi delle democrazie sociali. Comeconsiderare la costruzione di queste nuove formazioni sociali eculturali e dunque di queste nuove identità? E’ possibileinventarle o favorirle, e a quali limiti o paradossi può andareincontro questa costruzione?122.
Il concetto di nazione offre alle società modelli simbolicicomplessi, in cui è fondamentale il ruolo che si assegna alpopolo. Demaria cita alcuni studi che fanno riflettere sul casopalestinese: ad esempio quello di Chatterjee, che osserva che laretorica nazionalista assomiglia a quella patriarcale ma siappella più che alla ragione, al sentimento e all’emozione eproduce un modello che si sorregge su stereotipi erappresentazioni tipiche di un ‘discorso femminile’; Balibar eWallerstein individuano una differenza fra movimenti nazionalicaratterizzati da ideologie positive, di liberazione, e movimentibasati su ideologie negative, come i nazionalismi di oppressione;Bhabha suggerisce di guardare alla nazione come: “ambigua eambivalente rappresentazione della storia e delle identità” nelcaso di quelle culture “che si vogliono riscrivere ereinterpretare123”.
Connettiamo l’aspetto della figura dei palestinesi allaretorica dei comunicati diffusi dall’OLP124 nei decenni chiave
122 Demaria, 2003, p.103. 123 Demaria, 2003, p .105. 124 Massad ricostruisce la storia del discorso ideologico nazionalista palestinese. Dopola dichiarazione istitutiva dello Stato di Israele, nel 1948, i palestinesi hanno vissutocirca un decennio privi di un leader e dunque anche di una rappresentazione etnicaunitaria. Per questo hanno guardato in questa fase all’ideologia ‘panaraba’ proposta daigoverni dei paesi vicini. La crescente consapevolezza della particolarità della lorosituazione, tuttavia, comincia a insinuarsi nelle fasce popolari più basse e dà luogoverso la fine degli anni Cinquanta all’emergere dei primi gruppi guerriglierinazionalisti nei campi profughi e nelle università. Così, nel 1964, sono proprio igoverni arabi a fondare il PLO (Palestine Liberation Organization, in italiano OLP), conlo scopo di tenere sotto controllo la forza del movimento indipendentista espresso dallaguerriglia. A seguito della guerra del 67’ però, e della successiva occupazioneisraeliana della Cisgiordania e di Gaza, nonchè della parte araba di Gerusalemme, laspinta ideologica ‘nazionalista’ fu comunque amplificata, tanto che ai vertici dell’Olpnel 1969 subentrò Jasser Arafat, che proveniva proprio dall’ambiente dei gruppi armati
96
della formazione dell’idea di una nazione palestinese. Seguiamolo storico americano-palestinese Joseph Massad125, che studia ildiscorso istituzionale in chiave di genere, nell’evolvere dellastoria palestinese. Nei comunicati diffusi dall’OLP, che è laformazione politica nazionalista più importante, trova undispositivo simbolico doppio, che definisce una maternità femminileper la terra nazionale insieme a una mascolinità infantile degliindividui deputati a legittimarne l’esistenza.
Per prima cosa, riflette Massad, quest’ideologia è opposta aquella israeliana, centrata sulla figura maschile del “pioniere”e sulla volontà di impregnare di nuova vita la terra vergineattraverso il possesso. Nel discorso retorico palestinese ipalestinesi sono i figli di una terra stuprata dall’invasore: una terra chequindi è squalificata nel suo potere riproduttivo ed è sostituitain una traslazione simbolica dal potere riproduttivo dei suoifigli.
Nella Carta Nazionale Palestinese, la dichiarazione checostituisce dal 1974 il documento costituzionale più importantedi questo nazionalismo, c’è un articolo che definisce chi siapalestinese: più che di cittadinanza si tratta di una condizioneeterna, che si trasmette da padre a figlio e che riguarda gliarabi che vivevano nel territorio palestinese almeno dal 1947 echiunque sia nato da padre arabo palestinese dopo questa data,dentro o fuori dalla Palestina.
Si trova la traslazione simbolica per la quale il poteregenerativo della madre terra invalidato dallo stupro israelianopassa a quello perpetuativo dei figli, sono loro i depositari
popolari ed era in grado di guidarne ed esprimerne le idee. Questo accadeva incontemporanea con un altro evento emblematico di un nuovo atteggiamento dei paesi arabiverso i palestinesi, che sarebbe poi rimasto costante nei decenni successivi: loscioglimento da parte del governo libanese della IntraBank, nel 1965, il gruppo bancarioarabo più forte del Medio Oriente, di proprietà dei palestinesi. Il crescente potere deigruppi immigrati aveva suscitato la preoccupazione di una possibile concorrenza con laborghesia locale libanese; negli stessi anni il Libano e gli altri paesi che avevanoaccolto con favore l’immigrazione palestinese dopo il 48’, cominciarono a restringerel’accesso alle loro frontiere. Il culmine di questa politica fu, nel 1970, la guerracivile fra esercito giordano e gruppi guerriglieri dell’OLP; nel 1971 l’OLP fu espulsodal paese e dovette trasferire i propri vertici a Tunisi, dove installò una nuova base.Sono questi eventi che producono, secondo Massad, la sensibilizzazione della borghesiapalestinese della diaspora per la causa ‘nazionalista’ e la decisione di finanziarel’azione politica di Arafat. Nel 1974, infatti, grazie a queste pressioni, l’OLP vienericonosciuto a livello internazionale come rappresentante esclusivo del gruppopalestinese: in quell’anno presso l’Assemblea delle Nazioni Unite Jasser Arafat riesce aspostare il sostegno a Israele e ottiene il riconoscimento della ‘nazione palestinese’ inuna dichiarazione firmata da tutti gli stati membri, ad eccezione degli Stati Uniti edello stesso Stato d’Israele.125 Massad, 1995, p. 467 e sgg.
97
dell’identità etnica dopo il 1948 in una linea di discendenzamaschile.
Sempre nel 1974, in una dichiarazione rivolta all’ONU, Arafatripropone la figura dei figli rileggendo la storia biblica delgiudizio di Salomone: così come la vera madre del racconto èquella che non ha accettato di dividere suo figlio in due metà,per placare la contesa, i palestinesi sono i veri figli dellaPalestina: il loro attaccamento all’integrità della terra gli haimpedito di accettare il piano di spartizione proposto nel 1947.Massad motiva anche il senso politico di questa retorica: mentrecerca di differenziarsi dai concetti tipici dell’ ideologiacoloniale europea, la virilità e il razionalismo, è costretta arileggerli e rinegoziarli per produrre una sua autenticità.
E’ importante anche un elemento borghese lungo l’isotopiadell’aiuto dei fratelli della diaspora, che hanno il compito di sostenere lalotta dei fratelli rimasti in patria, vessati dalla presenzaisraeliana. Infatti l’azione politica dell’OLP si afferma condecisione negli anni Settanta anche grazie al sostegno economicodella borghesia palestinese della diaspora, decisa a partire daquesto decennio a difendere in modo risoluto la causa dellanazione.
C’è traccia di questa influenza borghese per la costruzioneideologica anche nei testi. Quello meno permeato dalla simbologiarappresentativa dei figli è Dentro la notte: non a caso l’autore ècresciuto, e nato, in un campo profughi in Giordania, immerso inuna dimensione sociale ed economica di profilo basso dove èpresumibile che la penetrazione di una certa retorica borghesenazionalista fosse limitata.
Massad indica un momento di crisi della palestinità comecontinuazione dei figli quando nel 1987 erompe la prima Intifada. Inoccasione della nascita del movimento, che riscuote vastaattenzione internazionale, l’OLP proclama dal suo quartiergenerale di Tunisi la Dichiarazione di Indipendenza Palestinese eforma una nuova organizzazione, l’ONLU (Unified NationalLeadership of Uprising) deputata al sostegno ed alla promozionedell’Intifada.
Il discorso nazionalista si trova davanti alla possibilitàreale di fondare uno stato autonomo e all’apertura di un nuovociclo riproduttivo in cui la terra madre può tornare a dare lucead una nuova generazione. Nei comunicati del 1987, incorrispondenza della fase avanzata dell’Intifada, l’ attribuzioneè ambivalente: Arafat, che si era sempre definito un fratello,appare per la prima volta come padre simbolico della nuova nazione e
98
le metafore che riguardano lo Stato nascente sono insieme quelladi un matrimonio e quella di una gravidanza.
Massad studia l’alternarsi in questo momento storico didiverse attribuzioni simboliche all’elemento del maschile ed aquello del femminile; il fatto interessante è che rimane costante ilfondo della caratterizzazione dei figli: un’ immagine che corre lungo i duedecenni centrali della diffusione del discorso nazionalista, dalpanarabismo alla prima Intifada, di generazione di giovani unitiin un unico corpo, che Massad chiama il “corpo pieno di forza diun bambino”, del tutto libero della vulnerabilità che colpisceinvece il “vecchio o più maturo corpo maschile israeliano”.
Lo storico si riferisce spesso ad Anderson126, che trovava ilpotere del nazionalismo nella creazione di un legame stabile, diun cameratismo orizzontale: nasce qui l’idea moderna di potermorire per un concetto immaginato, piuttosto che uccidere perdifendere il possesso di qualcosa.
La tenuta e la pervasività della posizione generazionale difigli nella simbologia di questo gruppo etnico palestinese èriflessa nelle rappresentazioni occidentali: le retoriche dellapolitica progressista europea che promuovono l’azione in difesadegli oppressi in genere allestiscono la questione palestinesecome un dramma dei figli, di quegli orfani di cui Khalifa fa parlareanche a Magid in Una primavera di fuoco.
Quando si pensa alle manipolazioni a cui deve prestareattenzione una semiotica sociale vediamo che anche un prodottoletterario filtra la compenetrazione fra livello mediatico eidentità personale. In queste narrazioni di sé l’orizzontecognitivo introietta una componente della retorica ideologica.
4.5 Memoria infantile
Resta da esaminare il terzo livello dell’essere figli in questitesti, che riguarda la narrazione legata dell’infanzia. Infattici sono strutture discorsive che tornano e tematizzano gli annidell’infanzia, con loro codici mnestici particolari. Il sé adultodei testimoni del conflitto è spezzato dall’evocazione del séinfantile: un soggetto immerso in uno spazio di gioco e libertà,un orizzonte ludico perduto.
Questi ricordi sono una linea di memoria principale, nontanto in senso progressivo - nessuna narrazione parte dal tempodell’infanzia - ma come un filo conduttore tematico: l’infanziacontinua ad affiorare.
126 Anderson, 1996.
99
Iniziamo dai due testi dove questo accade meno: vogliamosostenere che anche qui la funzione dell’infanzia è specificaperché esprime un atteggiamento culturale che condiziona tutte esei le narrazioni.
Per primo Sharon e mia suocera: qui i ricordi sono riferiti adiversi blocchi temporali, tutti relativi all’età adulta; solo inun caso è rievocata una scena della vita di Suad bambina e sitratta di una sorta di immagine proustiana. Quando prima del 67’Gerusalemme era ancora per una parte ‘territorio palestinese’, lafamiglia della protagonista aveva l’abitudine di trascorrervi ilfine settimana. La visita iniziava con il rituale della colazionein una pasticceria artigianale del centro: Suad racconta quale“incanto” le procurava assistere alla preparazione delpasticciere della pasta che poi avrebbe mangiato; la bimba sichiedeva “quanti pezzi di pasta fossero volati in aria da quandoil nonno di Aref aveva aperto quel circo meraviglioso127”.L’immagine del circo e il sentimento di incanto sono marchelinguistiche di un universo mitico; il paragrafo successivodissolve bruscamente questa atmosfera e riporta Suad nelpresente, al checkpoint sta cercando di oltrepassare per entrarein Cisgiordania.
Anche la narrazione di Memoria di Natur è priva di ricordiinfantili: è piuttosto il racconto di una lunga serie di eventitragici occorsi al protagonista, ad amici, familiari econoscenti, sotto l’occupazione prima inglese e poi israeliana.Tuttavia, nelle prime pagine, il protagonista fa una riflessioneevocando proprio il dorato tempo della sua infanzia: in unparagrafo intitolato “Nostalgia” la voce narrante si chiede:“Perché non abbiamo conservato i ricordi innocenti dell’infanzia?C’era la sorgente, il pozzo, la terra sabbiosa che bruciava ipiedi scalzi, ed eravamo felici. Il vento trasportava sognifantastici, insieme al profumo del timo e al polline dei fiori.Seguivamo le tracce delle formiche e distruggevamo i loro nidi,fieri della guerra vittoriosa contro gli insetti. Era un’infanziacomune in tempi non comuni, potevamo ricamare speranze senzatemere che qualcuno ce le portasse via. Abbiamo perdutol’infanzia e ciò che si perde non ritorna. Non tornerà, dovremonoi tornare indietro, per ritrovarla. Tutti i giorni lasoffochiamo col nostro dolore, il rimpianto del paradiso perduto,la tristezza e la miseria della vita!128”. Qui è proprio ilprotagonista che offre una sintesi dell’esperienza palestinese e
127 Sharon e mia suocera, p. 104.128 Memoria, p. 20.
100
utilizza un sema che inverte il procedimento traumatico: mentre neltrauma l’impossibilità di elaborare una perdita ne impedisce ilsuperamento e dunque la possibilità di ordinarla in un passatoconcluso, qui l’uomo parla di come sia lui stesso, insieme aglialtri nella sua situazione, a soffocare il piacere del ricordonella percezione del dolore della perdita.
In Una primavera di fuoco la rievocazione dell’infanzia ha unospazio maggiore ed è la serie di ricordi doppia del punto divista dei due protagonisti. I ricordi di Magid non sonoesattamente confortanti: da bimbo è rimasto orfano ed è cresciutosolo con il padre giornalista, che non si era ancora risposato equindi non aveva ancora concepito Ahmad con la seconda moglie.Nell’infanzia di Magid campeggia la figura della nonna, quelpersonaggio della Hajja di cui abbiamo fatto parlato rispetto allascena femminile in casa al-Washmi.
La nonna alleviava la solitudine del protagonista, ma nontanto con le cure e con l’affetto; c’era un gioco che rispecchiail tipo di realtà popolare e violenta del campo profughi in cuilei e il nipote vivevano: in occasione dei matrimoni e dellefeste la Hajja si precipitava a suonare il tamburo ed a cantare,perché questa attività le rendeva un ricco compenso di cibo edenaro e Magid la seguiva come servitore, con il permesso ditenere per sé una parte delle offerte nuziali che ricavavanoinsieme. Ricordandosi dei cortei nuziali Magid prova deisentimenti contrastanti: è grato per la tempra che ha ricevuto daun’infanzia tanto dura, ha una forte simpatia per l’entusiasmorapace della nonna e nello stesso tempo invidia le condizioni incui è cresciuto il fratello Ahmad, accudito dalla madre eviziato, anche se questo lo ha reso un ragazzo più debole di lui.
La voce narrante appena oltre passa a Ahmad che in effettirievoca un’immagine molto diversa, ovattata, della sua infanzia:la madre lo pettina cantando e si preoccupa per la suasensibilità, perché il bambino “scoppiava a piangere ogni voltache sentiva le note di quella canzone, anzi, di qualsiasicanzone129”. La canzone della madre gli fa tornare in mente lavicenda che è il centro narrativo della parte del romanzo, partededicata proprio ai suoi anni di bambino: l’infatuazione per unabimba ebrea, Mira, che vive nell’insediamento che confina con ilcampo profughi palestinese.
Le due memorie d’infanzia di Magid e di Ahmad segnanocomunque il confine di un tempo perduto: la passione di Ahmad perMira sfocerà in un equivoco che lo condurrà in un carcere
129 Una primavera di fuoco, p. 32.
101
israeliano, trasformando per sempre l’indole delicata che laaveva potuta concepire; nel caso di Magid la spensieratezza e laspontaneità di quando era piccolo verranno sostituiti dai calcolidella sua carriera politica di funzionario corrotto.
E’ centrato sulla vita in un campo profughi anche Dentro lanotte. Qui la narrazione procede alternando quei due blocchi di presentedel viaggio con un amico e della cronaca dell’assedio del campodove vive la famiglia del protagonista. Accanto ai due percorsiprincipali la voce narrante colloca piccole sequenze minori, cheriguardano soprattutto la vita sentimentale del protagonista. Iltesto è sconnesso e frammentato: bisogna fare un certo lavorointerpretativo per ricomporre il senso complessivo lungo lanarrazione e per ogni paragrafo non è affatto facile capire aquale delle varie cornici isotopiche si riferisca.
In questo fluire il piacere narrativo e quello dellarievocazione sono assenti, sostituiti piuttosto da un’urgenzacome quella di una specie di trauma inconscio che ha bisogno diessere scritto. Uno solo dei molti racconti collaterali alle duescene del viaggio e dell’assedio, riguarda l’infanzia delsoggetto che narra. E’ un ricordo spiacevole, del bagno esternoalla casa che costringeva adulti e bambini a uscire in pienanotte per soddisfare i propri bisogni fisiologici: “per una pipìnotturna soffrivamo più di quanto oggi soffrano i ragazzi perl’esame di maturità. Era davvero un problema tornare, bagnato, aficcarti sotto le coperte, tra i tuoi fratelli. Era terribile cheti odiassero perché avevi bevuto un tè prima di dormire. Più diuna volta gli avevo spiegato che era meglio urinare fuoripiuttosto che su di loro. Ma incredibilmente, preferivano ilcontrario. Qualcuno di loro aveva proposto che facessimo, aturno, la pipì nel nostro giaciglio. – Così moriamo di freddo! –No. Prima che la pipì si raffreddi, arriva la successiva ariscaldare il giaciglio! Ma chi di noi poteva restare sveglio perorganizzare un’operazione così complicata?130”. Questo ricordoporta a immagini diverse, delle cose che i bambini non capisconodel mondo, del senso di mistero suscitato dalla vita dei grandi.Ad un certo punto torna il ricordo di un ordine molto strano,ricevuto da un’ adulta: un ordine che sovverte il sistema delleregole. Il bimbo è in visita a casa della zia ed esprime ilbisogno di fare pipì: gli viene indicato l’orto, dove fra lealtre piante ci sono anche i pomodori.
Il protagonista è così scandalizzato che grida; con unrivolgimento enunciazionale la voce narrante si rivolge al
130 Dentro la notte, p. 93.
102
lettore: “gridai sorpreso. Tu sai che l’urlo di sorpresa fa parteessenziale della nostra vita. Tutto ciò che ci capita adesso,cioè da sempre, ha per obiettivo farci dimenticare il nostrotipico grido di sorpresa. Se non lanci un grido di sorpresa difronte alla distruzione, alle rovine, vuol dire che ti ci seiassuefatto. E se ti ci sei assuefatto vuol dire che hanno vintoloro131”.
Qui il punto non è segnare un confine fra ciò che si èperduto e ciò che si ha, come in tutti gli altri esempiprecedenti: qui il ricordo fa una cosa opposta perché crea unlegame, sicuramente ancora un legame nostalgico, con quello che sideve conservare. C’è un senso di sé che a tutti costi non deveessere perduto; il ricordo di infanzia lo radica nel tempo.
Anche nel primo passaggio quando i bambini discutono su comerisolvere il problema del bagno fuori casa, a reggere il livellotematico c’è un elemento fantastico – la trovata infantile diurinare a turno per scaldare il materasso - ma non è tutto quiperchè nella coscienza di chi narra c’è il problema della sceltae la percezione dello shock dell’urinare “su di loro”.
Nel testo di Nasrallah piuttosto che il simbolo di un confinetimico fra il positivo che è il passato e il negativo che è ilpresente, l’infanzia serve per un promemoria identitario; se peròpoi consideriamo come procede il racconto forse questa è comunquel’evocazione di un’età dell’oro di un tempo perduto della dignità.Perché pagina dopo pagina la violenza cancella i confini, anchela capacità di stupirsi davanti all’orrore, che per ilprotagonista ha descritto come segno di un codice di valore delladignità.
Fra gli altri testi in esame è Niente sesso in città ad essere ilpiù segnato dalla presenza di narrazioni ‘infantili’. Le storiedei nove personaggi sono tutte imperniate proprio sui loro primianni di vita, sulle esperienze familiari e sui ricordi intimilegati ad essi. Due storie in particolare sono interessantiesempi di dispositivi semantici in cui la contrapposizione frapassato perduto ed presente tragico è costruita in modooriginale. Sono quelle di Maya e Rana.
Maya cresce nella Cisgiordania sotto occupazione negli anniSettanta: il racconto si basa sulla cattura dello zio, chemilitando nella resistenza viene arrestato dalla poliziaisraeliana e passa sette anni in carcere. Per vendicare lo zioMaya matura la decisione di unirsi ai gruppi di fedayn palestinesiin Libano e organizza una fuga notturna con alcuni amici. La
131 Dentro la notte, p. 99.
103
madre la scopre e la ammonisce con durezza dal ripetere gestitanto pericolosi. L’orgoglio e la determinazione della bambinacostituiscono l’isotopia ironica del racconto, ma connotano ancheun paradosso: molti anni dopo la madre sarà uccisa da unproiettile israeliano e Maya si confronterà insieme al fratellocon la possibilità reale di farsi martiri per vendicarne lamorte.
La scelta narrativa è quella di non enfatizzare l’aspettodrammatico e giocare sull’assurdo: la salma è contesa fra ifamiliari e gli attivisti. I fedayn della resistenza infattivogliono onorare la donna come una martire e coprirle i capellinel manifesto funebre: “con una hijab, o almeno con una sciarpabianca132”. Nel campo semantico c’è una doppia opposizione: ilcandore infantile della protagonista le fa considerare sul seriouna prospettiva improbabile, quella di combattere nelle filadella resistenza, con un rovesciamento ironico, lo stessodell’ipocrisia dei giovani attivisti, ma opposto, che rende ildolore reale della perdita della madre un sentimento frivolo.
Il tema del sacrificio religioso per la lotta patriottica c’èanche nell’infanzia di Rana, che si è svolta nella capitalelibanese, sempre negli anni Settanta. Il padre della bambina è iltipico rappresentante di una fascia alto borghese della borghesiapalestinese della diaspora. Con un gesto improvviso eall’insaputa delle moglie e delle figlie sceglie il martirio edirotta un aereo israeliano. Dopo la sua morte la famiglia sitrova oggetto di una grazia speciale : Rana, le sue sorelle e suamadre cominciano ad essere indicate come la compagna e le figliedi un eroe, con l’onere di vivere all’altezza della gloria delmartire e mantenere viva la memoria del suo coraggio. Laprotagonista comincia ad avvertire in tutto questo la fatalitàdella sua origine palestinese, l’inquietudine legata all’idea cheda adulta dovrà prendere parte a quel dramma in cui la morte delpadre è un’azione tanto meritevole. Alla Palestina Ranacontrappone Beirut, una capitale animata ed elegante, dove primabambina e poi adolescente conduce una vita ricca e varia, incompagnia dei bambini libanesi della sua classe scolastica.
L’infanzia è il simbolo di una fuga, o meglio del privilegiocognitivo di non sapere e di non voler sapere ciò che la storia ela realtà del conflitto palestinese impongono alla protagonistain qualità di agente responsabile.
Ma la struttura più complessa rispetto alle dinamicheinfantili di fuga si trova nel diario intimo di Sahar Khalifa. In
132 Niente sesso in città, p. 148.
104
La svergognata la linea dei ricordi di un’età innocente è presa incarico da un oggetto, una mela, con un’isotopia che percorrel’intero testo. Afaf evoca la mela in tre occasioni: la prima e laterza sono scene dell’infanzia, nella seconda la mela è l’oggettodi una riflessione che in qualche modo media fra le due sceneiniziale e finale.
Dapprima Afaf ricorda una passeggiata con il padre e ilregalo di lui che la vede fissare una mela e la compra. Tenendofra le mani il frutto però Afaf abbandona l’idea di mangiarlo: lamela prende vita, diventa un’amica della bambina, che incantatala lucida e le sorride e pensa di darle un nome. Tornati a casala madre e i fratelli di Afaf notano il regalo: contro ledisperate resistenza della bambina la madre le toglie la mela ela taglia a spicchi per dividerla fra tutti i bambini. Afaf viveil gesto come un crimine brutale, un assassinio in cui la mela“viene squartata” e “muore” e reagisce secondo il codice dellatragedia che sta immaginando: “ mi gettai per terra, fingendomimorta. Non mi credettero. Capitò un parente e chiese di me. Disolito mi viziava, perché ero ancora piccola. S’informò delleragioni della mia morte. Gli dissero: - La mela - . Mi davoancora per morta, quando lui mi domandò: - E’ vero che seiun’ingorda e che vuoi mangiartela tutta da sola? - . Risorsiimprovvisamente, per gridare: - Io, mangiare la mela? Come potreimangiare la mela133?”.
Molto più avanti, lungo la narrazione, quando Afaf è riuscitaad allontanarsi dal marito ed a rientrare in Cisgiordania, unpassaggio si apre con questo ‘pensiero’: “non avevo mai vistoniente di simile a una mela. Neanche in sogno. Neanche durante lamia infanzia. Era un sogno che mi introduceva nei meandri da dovenascono le fiabe di mia nonna e le storie delle spose del mare.No, niente di simile alle fiabe illustrate per bambini, con lineedefinite, particolari ben precisi e colori netti. Piuttosto comelo sfondo di un quadro, con colori sfocati e trasparenti, dovenulla è preciso e ben delineato, ma dove le sensazioni sono fortie cariche di magia e di segreti, avvolte da una musicaimpercettibile, che sgorga dagli aghi di un pino e dal profumo diun cipresso e dalle capsule delle piante di cotone134”.
Infine, la terza volta la mela torna un ricordo positivo cheriguarda la madre. Molto piccola nella cucina di casa, Afafpronuncia le sue prime parole per raggiungere una mela nelladispensa: la madre le porge il frutto e la invita a pronunciarne
133 La svergognata, p. 10.134 La svergognata, p. 106.
105
il nome, la bambina allora parla ripetendo più volte la frase cheha sentito: “Dì: mela”. La performance emoziona la donna che sisiede per terra con lei e la abbraccia. Afaf racconta che alloraebbe la:“sensazione di essere una mela, brillante rossa e bella.Tutta la vita cercai di ritrovare quella stessa sensazione. Pertutta la mia vita, la sensazione di essere una mela135”.
Qui il frutto incarna un orizzonte perduto sotto più aspetti:coinvolge la libertà, il calore e l’accettazione insieme.
Vogliamo sottolineare che nella riflessione della vocenarrante sull’immagine della mela c’è una modalità associativa,il senso della narrazione ed il legame del tempo sono costruitiaccostando immagini e percependo dati sensoriali, rinunciandoall’ordine di una progressione biografica e della formazione delsé. È vero che questo è un dato generalizzabile a qualsiasinarrazione, perché il ricordo infantile è un’ àncora, tieneinsieme la discrepanza fra il se stesso di un tempo e l’adulto diadesso; insomma offre una prova dell’interezza dellasoggettività, fa sentire di essere un uno.
Però nei testi che abbiamo visto il dispositivo è arricchito,porta con sé un modulo specifico che appartiene proprio allanarrazione culturale palestinese. Richiamiamo l’idea diHuinziga136 del gioco come prestazione rammemorativa e gli sviluppi diquesta teoria nel pensiero di Fink137 sul gioco liturgico del rituale.
Il gioco è molto più di una modalità di relazione deibambini, è un’attività che secondo Huinziga va collocata nellasfera sacra del senso culturale: ha la forza di esercitare unpotere espressivo superiore ai bisogni fisiologici e così fa dacollante della collettività. In questo senso è asservito allacultura, serve alla salute del gruppo.
Fink sostiene che nel gioco – come in altre condottefondamentali, quali il lavoro, la lotta, l’amore, il culto deimorti – l’uomo realizza la sua fondamentale apertura al mondo. Ilgioco totalmente gratuito, è irreale, è un gioco quello in cui cisia la “gioia pagana per il sensibile”, in cui si sperimenti il“piacere dell’apparenza”. Giocando l’uomo mina l’onnipotenza delmondo. Per questo si può pensare che il gioco ne sia il simbolo,per il fatto che entrambi sono senza fondamento, scopo, senso,valore e progetto, ma per il fatto nello stesso tempo cheentrambi “tengono aperti gli spazi e i tempi per l’essere dellecose”.
135 La svergognata, p. 143.136 Huizinga, 1972.137 Fink, 1992.
106
Quella memoria evocativa sembra basata sul gioco,sull’associazione analogica che attraversa il senso di unacollettività che a sua volta si auto percepisce dalla partegenerazionale dei figli e ne vive un registro ludico mnestico particolare, in cuisembra trovare rifugio.
Nei testi l’isotopia infantile si salda alle due dimensioniche abbiamo discusso, quella della sanzione e quella ideologica:sembra che le sostenga, nel blocco di un’età dell’oro perduta,rispetto al quale il presente della realtà ‘adulta’ è drammatico.
Se ci siamo riferiti ad una memoria dell’infanzia nel titolodi questo paragrafo è per l’effetto che ci sembra il prodotto deitre livelli intrecciati: quello del giudizio genitoriale, quellodella retorica ideologica, quello tematico dei ricordi infantili.
C’è un’immagine che forse vale più di qualsiasiteorizzazione. E’ un episodio di Dentro la notte di Nasrallah in cuiil protagonista è su un volo aereo. Con lui c’è anche unufficiale israeliano, che comincia a inseguirlo per uninterrogatorio, data la sua aria sospetta da terrorista. Ilprotagonista allora, si chiude nella toilette dell’aereo e sitaglia i baffi.
Questo gesto suscita un ritorno all’infanzia che poi dopoattraversa tutto il testo: il protagonista senza baffi è comecolpito da ricordi molto lontani che cominciano a comparire qua elà; nello stesso tempo spicca la rappresentazione sarcasticadella stolidità israeliana. L’ufficiale infatti non può capire,non riesce a comprendere cosa sia accaduto e dove sia finitol’uomo che stava interrogando, perchè non sa giocare al gioco palestinesedel protagonista. Appare anche con insistenza la vergogna delprotagonista verso sua madre, che lo rimprovera per essersitagliato i baffi: una condotta deplorevole per un uomo ormaiadulto, da irresponsabile e insieme poco virile. Vergogna che èquasi la percezione colpevole di essere fuggito, nella realtà oin un sogno, verso la dimensione ludica dell’infanzia.
107
5. Narrazione politica e mancanza di aggressività
Vorremmo suggerire che al ricorrere della dimensione ludicadell’infanzia si lega un altro elemento, ovvero il modo in cui inquesto archivio culturale la visione politica dà senso al doloree al rapporto con l’altro - o meglio con gli altri agenti delconflitto.
Nei testi la narrazione della violenza, del dolore e di unapossibile giustizia non sfocia in un programma di azioneoffensiva verso il futuro: come l’infanzia è un luogoprivilegiato anche rispetto alla realtà attuale della vita palestinese,rispetto a una responsabilità adulta che non trova una dimensionein cui radicarsi, così la percezione del dolore provocato da unagente non arriva a fornire le risorse simboliche di un agireaggressivo che risponda a quanto subìto.
Questo sembra dipendere dalla perdita di controllo spaziale di cuiabbiamo parlato nel secondo capitolo e dal modello mnesticoidentitario che abbiamo suggerito come conseguente, basato su unblocco di passato e ‘mozzo di orizzonte’.
Nei testi si può parlare di aggressività rispetto a dueaspetti: quello della rappresentazione del livello politico e poiquello della percezione dell’altro: percezione quest’ultima che sicoglie nei racconti che riguardano gli agenti socialideterminanti per la definizione dei confini del gruppo e delsignificato che circola al suo interno, primi fra tutti ‘gliantagonisti’ israeliani.
Il fatto è che ci sono spazi per il cinismo, perl’immaginazione, per l’ironia; sembra ragionevole pensare che ungruppo aggredito, che si pensa orientato verso un’aggressivitàreciproca, non abbia motivo di impiegare le proprie energie nelladimensione simbolica: quando ci si trova in una situazioneconflittuale si tende alla semplificazione e semmai allacostruzione di rappresentazioni ideologiche che servono allacausa. Ma la questione si complica se pensiamo al fatto chepossono esservi ragioni che impediscono la rappresentazione delnoi come gruppo coeso, o che possono complicare l’idea diavversario.
Vediamo in che modo nei testi si parla di chi è vittima, dichi è responsabile e come certi traumi siano in rapporto con
108
l’evolvere del conflitto e con la fissazione di una memoria cheha a che fare con la narrazione della storia arabo israelianapalestinese.
5.1. Il controllo dello spazio e la dinamica dell’agire
aggressivo
L’agire aggressivo ‘come risposta’ ad un’azione compiuta da unaltro soggetto è trattato in un saggio storico di Greimas da cuimutuiamo alcune considerazioni. Greimas pensa a una sequenzanarrativa passionale che coinvolge due soggetti: l’agire dell’unoimpedisce la congiunzione dell’altro con un oggetto di valore ecosì si apre la possibilità di un nuovo programma narrativo, unprogramma di vendetta. La sequenza è centrata sul sentimento dellafrustrazione, che fa da perno fra ciò che è a valle e la segue:l’aggressività, e ciò che è a monte e la precede: la mancatacongiunzione.
Il programma aggressivo che parte per “liquidare lamancanza138” passa attraverso il rapporto non tanto con l’oggettoma con l’antisoggetto: bisogna insomma che si percepisca che sivuole fare del male all’altro, piuttosto che ci si vuoleriappropriare dell’oggetto. Infatti, spiega Greimas, quando unsoggetto realizza che l’altro ha deluso le aspettative di unprogramma di azione atteso rispetto a un oggetto, si passa allapolemica, con il rivolgimento di una disposizione collaborativa inuna di malevolenza.
L’importanza di questa componente aggressiva scompare adesempio in una tipica deviazione dal programma della vendetta,quella socializzante della giustizia: in questo caso il desideriodi fare male viene sopravanzato da una delega di sapere,attraverso cui il soggetto rinuncia alla responsabilitàdell’azione rispetto al soggetto che ne riceve gli effetti.L’aspetto più interessante di questo modello, un po’ datatoormai, è la riflessione sul tempo come elemento regolatore dellosvolgimento del programma della vendetta. Greimas parla della noncongiunzione come stato terminativo di un programma passionale difrustrazione ma poi nota che in molto casi si può pensare anchead una situazione incoativa, di disgiunzione dall’oggetto di valorein una sequenza di “perdita”, di “mancanza”. In questo caso ilsentimento di frustrazione non dà luogo ad alcun programmanarrativo di liquidazione della mancanza: anzi, lo sostituisce
138 Greimas, 1985, p. 342.
109
prolungandosi, come mostrano alcuni lessemi che – in francese –esprimono la durata rispetto a ciò che l’ha provocato: amarezza,rancore139. Con le parole di Greimas: “non si tratta in alcun mododi un sintagma passionale di natura causale: ogni stato puòattardarsi, fino a ipostatizzare ruoli patemici”.
Cosa provoca la possibilità di questa deviazione preliminaredal programma vendicativo? Qui viene colto un punto che sembrafondamentale per la cultura palestinese: a precedere e nonsfociare nella vendetta è l’orientamento del soggetto sulla sua condizione didisgiunzione, anziché sull’agente che l’ha provocata; mentre la vendetta èun “programma narrativo umano”, i sentimenti durativi della noncongiunzione sono relativi al rapporto con il valore.
Se applichiamo questo modello ai testi troviamo unadifferenza ricorrente fra il resistere e il vendicare. Abbiamo dettonel secondo capitolo dell’importanza della perdita di controllodello spazio: quello spazio sembra l’oggetto di valore in gioco ela percezione costante di esserne disgiunti appare più importantedel desiderio di agire sul soggetto che ha provocato ladisgiunzione. L’azione alla quale contribuiscono la memoria e lanarrazione in generale non è aggressiva, ma di mantenimento divalore dell’oggetto.
Se ne può trovare un riscontro anche nello studio deldiscorso politico di Massad, che sottolinea come ricorra neidiscorsi politici dell’OLP un termine icastico che riguarda laterra, e lo descrive in senso etimologico: “la parola che indicalo stupro della terra, ightisah, è più comunemente tradotta con‘usurpazione’. La radice etimologica del termine è ghasaba, chesignifica ‘forzare qualcuno a fare qualcosa contro la suavolontà’. Anche quando è utilizzato per indicare il senso diun’usurpazione, come nella forma in ightisab al-huquq, che significa‘usurpazione di diritti’ questo termine conserva il secondo sensolegato al simbolismo sessuale140”.
Al di là della connotazione sessuale questo termine -ightisab - focalizza con efficacia il valore territoriale dellaperdita sofferta dai palestinesi; in questo senso la perdita dicontrollo del proprio luogo fisico sembra essere il vero puntofermo della rappresentazione di sé del gruppo politicopalestinese.
Nel lavoro del semiologo francese Eric Landoski l’usurpazione èoggetto di una sistematizzazione, in rapporto alle ideologiepolitiche. Secondo Landoski,“differenti ideologie sviluppano dei
139 Greimas, 1985, p. 217.140 Massad, nella nota 26 dell’articolo.
110
programmi narrativi specifici, che permettono o vietano aisoggetti di raggiungere le loro finalità. Questi programmi, purmanifestando implicitamente il volere costitutivo dei soggetti,mettono all’opera soprattutto le loro capacità di fare141”.L’usurpazione è una dinamica unilaterale fra soggetticontrapposti sul piano sociale: è il “fare di una parte che non èriuscita a imporre il proprio punto di vista per la debolezza deisuoi argomenti e che di conseguenza usurpa, con il ritorno allaforza bruta, ciò che non ha più il diritto di pretendere”.
E’ così anche nei testi che consideriamo: le ragioniisraeliane sono percepite come assurde e collegate ad un atto diforza che serve a scavalcarle, in quanto appunto, vuote. Unaparte importante del discorso palestinese ha usato questa vacuitàdelle ragioni dell’avversario per astrarre un modello che èsfociato nella politica dimostrativa dell’Intifada.
5.2 Complicare il concetto di Intifada
Nei testi in esame le vicende della sollevazione tornano piùvolte a essere narrate.
Si tratta di un’idea espressa a tutti gli effetti in un fare,ma di tipo non aggressivo: scioperi e manifestazioni di civiliinermi che lanciavano pietre contro i carri armati israeliani,nel rimando biblico alla lotta impari di Davide contro Golia,utilizzando la risorsa simbolica del più debole contro laviolenza del più forte. La prima Intifada del 1987 riuscì aottenere la visibilità di una campagna di livello internazionale:l’opinione pubblica occidentale addomesticò la lontananza e laparticolarità del conflitto mediorientale in uno schema noto; atal punto che ancora oggi la connotazione della causa palestinesecome diritto dei giusti è rimasta la risorsa tematica più usatadall’ideologia progressista nel discorso mediatico europeo.
La semplificazione del dolore in schemi simbolici rimandaall’idea della topica della denuncia in senso boltanskiano142, di
141 Landoski, 2003, p. 242.142 In un saggio pubblicato in Italia nel 2000 il sociologo francese Luc Boltanskistudia il modo in cui la politica globale contemporanea “si fa forza dell’elementopassionale della pietà”. Parla del consolidamento di alcune topiche - una topica delladenuncia, una topica del sentimento ed una topica estetica - attraverso cui lo spettatoredell’epoca moderna è portato a sentirsi vicino a persone molto lontane da lui e dellacui sofferenza non può occuparsi direttamente. Boltanski traccia le linee di un rapportotriadico, per cui il dolore rappresentato prevede sempre la posizione di ‘un infelice’,quella di ‘uno spettatore’, quella di ‘un agente’. La prima via per provocare adesione in qualcuno che assiste al dolore altri è la topicadella denuncia. In questa disposizione emotiva il dolore provoca “indignazione, el’indignazione trasforma la pietà. Questa non rimane disarmata, ma si dota delle armi
111
cui l’Intifada è certamente un esempio. Al pubblico europeo ildiritto dei palestinesi a esistere è presentato in un programmanarrativo passionale: chiaramente in questo senso è molto piùcomprensibile di quello bellico israeliano. Quindi la mancanza diaggressività è un attributo funzionale per una parte dellanarrazione ideologica di questo gruppo. Ma la situazionepalestinese non si può ridurre a uno schema semplice, a unacontrapposizione locale: l’Intifada non basta per rendere conto
della collera. E’ in questo senso che si può dire che punta verso l’azione, perché lacollera, che è un’emozione da attori, prepara l’impegno in una situazione nella qualepotrebbe realizzarsi in atti. Quale sarebbe la loro natura? Con ogni evidenzadell’ordine della violenza. … L’atto di parola che la manifesta è l’accusa”. La basedella denuncia è il bisogno di dotarsi di una teoria filosofica che costituisca unacatena causale fra l’azione di un persecutore e il destino di un infelice, teoria cheriguarda il potere di un agente e che è tanto più efficace quanto più riesce ad elevareil livello di astrazione di tale dinamica, proponendo uno schema di “dominazione”. …Per fornire prove della fondatezza dell’accusa la denuncia è alla continua ricerca dellamaggiore oggettività possibile, il suo discorso quindi è allo stesso tempo indignato eminuzioso, emotivo e fattuale. Rigurgita di dettagli, di oggetti, di luoghi, di date”. La seconda via è quella del coinvolgimento sentimentale, quella che sfrutta il fatto cheil dolore ha un potere avvicinante, rende simili tutti gli individui. In questa topica,spiega Boltanski: “una figura importante è quella dell’urgenza. Mentre nell’indignazionele risorse corporali vengono radunate per l’espressione della collera che vince il mutismodell’emozione bruta puntando verso la manifestazione della minaccia e della forza, nellatopica del sentimento esse vengono mobilitate per una gestualità espressionistadell’urgenza. La topica del sentimento cioè non si dispiega in una metafisica dellagiustizia, ma in quella dell’interiorità. E’ lasciando libero il cammino che porta alcuore che lo spettatore può accedere alle sofferenze che l’infelice prova intimamente,appunto, nel proprio cuore. Ciò che è interiore, cioè ‘reale’, manifesta la propriapresenza all’esterno: attraverso i mezzi del corpo (la sua agitazione, le sue lacrime,il suo sudore ecc.) appare in superficie una realtà che è irriducibilmente di un altroordine”. Infine Boltanski individua una terza modalità di espressione, che in qualche modoscavalca quell’alternativa fra oggettività e soggettività che le prime due topicherispettivamente incarnano: la topica estetica. Esiste cioè anche un modo di osservare lasofferenza direttamente, senza focalizzarsi subito sull’infelice (e quindi su di sé inqualità di benefattore virtuale) come nella topica del sentimento, nésull’identificazione di un persecutore da punire, come in quella della denuncia. Inquesto caso la posizione di un agente è occupata dalla figura di un ‘mostratore’:qualcuno “dotato della capacità di far vedere la sofferenza per ciò che essa ha disublime. Una volta escluse le persone fittizie del persecutore e del benefattore lasofferenza rimane in quanto puro male: guardandosi guardare questo male lo spettatoresvela la verità del male dentro di sé e compie così l’operazione estetica fondamentale,che in questa topica mira all’indifferenziazione del soggettivo e dell’oggettivo. Lospettatore simpatizza con l’infelice per quel tanto che questi si dà a vedere. La topicaestetica è in qualche modo più moderna delle precedenti, e si ascrive a una visionefilosofica in cui l’estetica e la politica cominciano a essere scisse. Proprio in questaautonomia della seconda, dice Boltanski, sta il valore liberatorio della topicaestetica che è in grado “di integrare in una problematica politica coloro che ne vengonoesclusi sia dal punto di vista della denuncia sia a partire dal sentimento – canaglie,banditi, marginali o forsennati”. Il meccanismo secondo cui agisce è quello di muoverepietà per gli infelici senza speranza di riscatto, utilizzando implicitamente l’una ol’altra delle prime due topiche.
112
del campo semantico in cui si muove l’ideologia politica diquesto gruppo.
I testi che stiamo considerando riflettono la presenza divarie tendenze e offrono rispetto a quella retorica uno spaccatomolto meno facile del modo in cui i palestinesi vedono lasituazione.
Così, in Dentro la notte si narra della marcia surreale, nel belmezzo dell’assedio, di un vicino di casa del protagonista: è pocopiù che un bambino, con degli stracci ha fabbricato una cinturaornata delle bandiere degli stati arabi e si muove verso lapostazione di difesa occupata dai guerriglieri per unirsi a loro,incurante degli spari che provengono dalle postazioni israeliane.Il ragazzo piange e intona l’inno diffuso per radio dall’ONLU143:“Sono le masse, sono le masse/io sono le masse, io sono lemasse/le teste dei servi saranno basse/Sono le masse ai duelati/dal Marocco agli Emirati!/ Sharon assassino ascolta!/la vocedi Beirut in rivolta/ Sharon boia ascolta!/ Servo degliamericani, americano/la voce di Amman va lontano/Prendi nota nel
Boltanski conclude osservando: “piuttosto difficile da mobilitare per la sofferenza diinfelici deboli, anonimi, comuni e considerati autentici (massacrati o affamati, poveridi bidonville ecc.), ambiti in cui sia la denuncia che il sentimento avevano una lorosolida tradizione, la topica estetica ha trovato un primo terreno fertile nellesceneggiature delle fiction televisive e solo in un’epoca relativamente recente è diventatauno strumento del reportage di guerra. 143 Organization for the National Liberation Uprising, costituita dall’OLP appositamente per sostenere l’Intifada.
113
quaderno/Viva Tell Zaatar144, in eterno!/Cieco, apri gli occhi,guarda/il sangue dei caduti a Sabra!145”.
Ora il fatto è che questo racconto non è connotato da unatimia positiva. Diversamente dal contenuto ideologicodell’Intifada che prevede che dalla disperazione scaturisca unanuova forza, una speranza irriducibile alla gravità dellasituazione di vita, qui il contenuto positivo è sparito. Il gestodel ragazzo è privo di senso, non serve a niente. La scena non siconclude, non si sa se il personaggio riesce a sopravvivere alfuoco israeliano e a raggiungere la postazione dei guerriglieri;
144 “Chiunque parli oggi di Sabra e Chatila sa che i suoi interlocutori intendono cosavoglia dire. Chi invece parlasse oggi di Tell al Zatar, anch’esso in Libano, nontroverebbe comprensione altrettanto pronta. La ragione per cui tutti ricordano Sabra eChatila è che pochi giorni dopo la strage, il 25 settembre 1982, quattrocento milaisraeliani scesero in piazza a Tel Aviv per urlare il loro sdegno contro Sharon che, nonimpedendo il massacro, aveva compromesso l’onore del Tzahal, l’esercito israeliano.Nessuno invece scese nelle piazze delle città arabe per denunciare la vergogna delmassacro di Tell al Zatar, compiuto dalle milizie cristiane arabe – le stesse di Sabra eChatila – e dai feddayn palestinesi del partito filo siriano di Al Saiqa. Se si guarda alcomplesso degli avvenimenti della guerra civile libanese tra il 1975 e il 1982, sicontano ben cento - centocinquantamila morti e si nota come nelle fasi salienti delconflitto l'Olp abbia assunto la funzione di detonatore della crisi. In Libano, come inGiordania, i palestinesi scelsero di allearsi con i partiti e gli ufficiali dell’esercitonasseriani, con il Baath, con le organizzazioni sindacali legate ai partiti comunistilocali. A differenza della Giordania, però, l'instabile equilibrio interno del Libano siera retto, sino al 1975, sul rapporto ben calibrato tra partiti e milizie cristiane,sunniti, sciiti, drusi, in un Paese che conta diciassette nazionalità e circa ottoreligioni. A partire dal 1974, Arafat buttò sulla bilancia il peso di alcune migliaia di feddaynfuggiti dalla Giordania e ben riparati nei campi profughi. I dirigenti dell'Olpschierarono con la sinistra libanese i propri feddayn in tutti gli incidenti a fuoco checominciarono a susseguirsi. Lavorarono anche per fare implodere l'esercito nazionalelibanese che rapidamente si disgregò, seguendo le linee di frattura confessionali edetniche. Istruito direttamente dai feddayn si formò anche un esercito del Libano arabo. La Siria del generale baathista Hafez al Assad non aveva però alcuna intenzione diassistere senza intervenire alla formazione di un governo arabo-palestinese fortementeaggressivo in un Paese come il Libano, che considerava parte integrante della propriasfera d'influenza. Il primo giugno 1976 un corpo di spedizione, forte di ben diecimilasoldati e duecentocinquanta blindati, passò quindi la frontiera siro-libanese,ufficialmente in difesa di due villaggi cristiani attaccati dall'esercito del Libanoarabo. Una parte di questo contingente, affiancato da milizie cristiane e da feddayn palestinesidel partito filo siriano di Al Saiqa, assediò il campo di Tell al Zatar, in cui vivevanocinquantamila profughi palestinesi.Per cinquantadue giorni si scatenarono ben settantaattacchi: gli assedianti impedirono l'ingresso nel campo di cibo e acqua e gli abitantiiniziarono a morire di fame e di sete. Il vertice palestinese non fece nulla peralleggerire le sofferenze dei profughi, non permise infiltrazioni, continuando aconsiderare il campo come un proprio fortino assediato. Il 12 agosto fu infine alzatabandiera bianca. Gli assedianti penetrarono nel campo e in dodici ore uccisero più di millecinquecentopersone, fra cui donne, vecchi e bambini. Si trattò dell’ennesima sconfitta dellastrategia jihadista di Arafat”. Panella, 2007, p. 225 e sgg. 145 Dentro la notte, p. 134.
114
il fuoco è sulla marcia e sulla canzone. La trascrizione perintero dell’inno crea una tensione fra l’eroismo come figura delsignificante e l’assurdo sul piano del significato.
5.2.1 L’Islam
Un elemento felicemente eluso dallo schema passionaledell’Intifada è la componente della lotta religiosa; omissionenon da poco se consideriamo che la narrazione del precettocoranico è per certi aspetti una narrazione aggressiva. Il Coranopropone rispetto all’idea di giustizia una configurazione che nonè assimilabile nella visione occidentale, in particolare perl’idea di punire con la morte e per quella ancora più eversivadel martirio, del sacrificio personale per la giustizia divina.
Il fatto che quella palestinese sia una cultura laicacoesiste con il dato della penetrazione di alcuni aspetti dellareligiosità islamica nell’ideologia politica.
Così troviamo una accanto all’altra la condanna dellaviolenza israeliana da cui viene lo schema dell’Intifada e lapossibilità di morire per sconfiggere il nemico, come indicato daAllah. Questo si vede bene ad esempio in Una primavera di fuoco, nellariflessione di Ahmad sull’imminente attacco israeliano a Nablus esul dispiegamento delle forze di difesa: “Ahmad si sentiva uno diloro, parte di questo popolo, di questa pulsazione accelerata. Lecanzoni della Resistenza, con tutto il loro significato, glifluivano dentro e il suo animo s’innalzava sopra il monte Ebal,diventava una creatura alata che osserva il mondo come se fosseuno schermo su cui scorrono immagini di nobili battaglie emartirio. Si dimenticò di suo padre e di sua madre. Anche se nonera armato, i ragazzi di ogni appartenenza e schieramento, leforze di sicurezza, gli accessi fortificati, le mine posizionatein luoghi strategici, i cuochi, il minareto, le vedette, leguardie in allerta, tutto questo lo faceva sentire protetto. Nonera indifeso. Era questa, la vittoria. E lui partecipava a tuttoquesto sforzo, lui era nel giusto. Fede, morte nobile emartirio146”.
Si tratta di una sorta di compendio dell’ideale palestinesedi resistenza. C’è la componente - che possiamo ascrivere aldiscorso dei comunicati dell’OLP – del vitalismo di un gruppo digiovani come nucleo dell’immagine dei combattenti. C’è al contempoun elemento lirico, che proviene dai toni di una formazioneoccidentalizzante degli intellettuali e dell’elite politica
146 Una primavera di fuoco, p. 175.
115
palestinese nella prima metà del Novecento147. E c’è la cornicedel programma del martirio di matrice coranica: una tensioneverso una ricompensa immateriale, effimera, che spetta a chicombatte nel giusto.
L’aspetto più interessante però riguarda il valore che èassegnato all’idea di vittoria: Ahmad non parla di prevaricazione,ma di gruppo, centro, protezione, di soggetti che hanno forzagrazie all’ unità. Il valore del resistere uniti sostituisce laprospettiva del vendicare aggredendo, ma è diverso anche da quellodell’Intifada di rispondere senza aggredire. Questa resistenzapalestinese è un gesto orientato al passato, o più specificamenteorientata al passato di quanto sia la lotta dell’Intifada, che haun contenuto positivo volto al futuro.5.2.2 Il progetto antimperialista e l’attenzione internazionale
Nei romanzi spesso c’è anche un atteggiamento di distanza per cuile motivazioni del conflitto sono viste da una prospettivaesterna, la voce narrante riporta elementi del discorsoideologico senza esaltarne i valori.
In Una primavera di fuoco Magid comincia a tenere un diariomentre presta servizio a difesa del quartier generale di Arafatsotto assedio. Ad un certo punto c’è l’arrivo di una delegazioneinternazionale di pacifisti, che per alcuni giorni sostiene gliassediati condividendone le dure condizioni di vita: Magid scriveche è composta da quaranta membri: “di ogni credo e nazionalità:inglesi, tedeschi, americani, italiani e persino ebrei” e poiracconta: “Claude Lèostec, responsabile della delegazionefrancese, ci ha detto: - Quando ho sentito quello che stavaaccadendo a Ramallah ho temuto che avrebbero commesso una nuovastrage e ho deciso che sarei venuta a qualsiasi costo. Ha
147 “Per definire l’ambiente di formazione di questa nuova cultura politica, occorrepensare a paesi in cui le caratterizzazioni religiose hanno ancora maggiore portata eimplicanze che da noi. Questa generazione, educata negli istituti scolastici religiosi diNazareth, di Gerusalemme e di Beirut, in particolare quello dei Gesuiti, e all’UniversitàAmericana di Beirut, vi aveva attinto una formazione occidentalizzante, trovando unaprima identificazione nello storicismo laico e panarabo del palestinese George Antonius.Già sotto i mandati britannico e francese, la sua acculturazione politica si era avutasoprattutto sulla tradizione repubblicano – radicale del liberalismo europeo del secoloscorso, con una predilezione per l’esempio di Garibaldi e le idee di Mazzini, per leesperienze della Carboneria, della Giovine Italia, e dei Burschenschaften degli studentitedeschi: quindi per l’azione rivoluzionaria, idealistica, a volte clandestina edestremistica. In tale ambiente nacque negli anni Cinquanta il Movimento dei Nazionalistiarabi; approdato attraverso il ‘socialismo arabo’ a posizioni marxiste-leniniste; esso sisciolse nel 1968 dando luogo al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e alFronte Democratico Popolare per la Liberazione della Palestina, guidati rispettivamenteda George Habbash e Nayef Hawatme: ovvero l’ala sinistra dell’Organizzazione per laLiberazione della Palestina.” Postfazione di Pino Blasone, in AA. VV., 2002, p. 211.
116
aggiunto che i componenti della delegazione sono certi che latenacia dei palestinesi rafforza la tenacia di chi è contro laglobalizzazione e il predominio di America e Israele. Che ipalestinesi, e chi sta dalla loro parte, alla fine uscirannovincenti dalla guerra. Che sarà Sharon il perdente. Un’ebrea diorigine canadese, Neta Golan, l’ha interrotta per aggiungere: -Vorrei che i miei figli vivessero nella pace e nell’amore, peròfin quando c’è l’occupazione nessuno vivrà in pace..148”
Magid non commenta le parole della delegata francese, silimita a riportarle e anche il riferimento al personaggiodell’ebrea è neutrale; nel complesso il passaggio assomiglia a unresoconto giornalistico. Ed è un buon resoconto, che riassumel’ideale antimperialistico di molta narrativa politicaprogressista occidentale: il punto è il legame fra una similevisione e il coinvolgimento degli agenti interni ed esterni. Cosatrovano i palestinesi nella rappresentazione della lotta globalecontro gli Stati Uniti? O meglio qual è il punto di contatto frala perpetrazione della violenza israeliana e la motivazione diuna riscossa globale antiamericana? E’ piuttosto ovvio che non cisia una risposta semplice. In questo senso Khalifa rende lapercezione del modo in cui è letto il caso palestinese da agentiesterni: lo specifico è riuscire a descriversi attraverso occhi einteressi altrui.
In altre parti si trova una versione molto diversa delrapporto fra le condizioni palestinesi e gli interessi altrui:oltre il distacco, il senso ideologico positivo scompare deltutto. Ad esempio Nasrallah costruisce la scena di un incontrodiplomatico surreale, senza riferimenti politici e storici, cheriguarda una non meglio precisata “Grande Realizzazione”. Come inun sogno il protagonista e l’amico sono presi in un vortice distrette di mano, saluti e congratulazioni mentre una serie difigure appena abbozzate sfila davanti a loro: “Ci ritroviamo perla seconda volta con un uomo bianco, davanti alla GrandeRealizzazione. L’uomo bianco ci parla in inglese dell’importanzadel progetto. E’ molto orgoglioso perché la Realizzazione èdavvero di alto livello e perché ci hanno contribuito in molti,di diverse nazioni. Uno degli accompagnatori presenta un uomoimportante che sostituisce l’anglofono bianco. Questo ci parla inarabo. – Vi potreste chiedere come mai nessun cittadino hapartecipato a questa Grande Realizzazione. In realtà questo eravoluto. Perché lui voleva che la Grande Realizzazione fosse unasorpresa per il nostro popolo e un dono nell’angusto anniversario
148 Una primavera di fuoco, p. 207.
117
dell’avvento del governo della libertà!149”. In un paragrafo pocooltre l’amico e il protagonista hanno questo scambio di battute,straniante: “Mi dice: – Il presidente Bush ha avuto un infarto. –Grazie a Dio, Gorbaciov non ci era piaciuto sin dal primomomento! – . L’anglofono ha interrotto la visita qui per correredal presidente!150”.
In questo passaggio l’amarezza e il cinismo azzerano laprospettiva dell’agire rispetto al futuro.
5.2.3. Gli Stati arabi.
Nei romanzi non c’è un soggetto palestinese pronto a reagire aggredendol’aggressore israeliano, come si prospetta invece con enfasi, peresempio, nei comunicati dell’OLP.
Anche perché nella storia recente del popolo palestinesequello israeliano non è il solo aggressore: gli stati arabilimitrofi hanno avuto una quota di responsabilità importantedurante tutto l’evolvere della situazione. Nella definizione piùcorretta si parla appunto di conflitto arabo - israeliano –palestinese: “quando le risoluzioni dell’Onu li identificavanounicamente come profughi e i dirigenti di Israele negavano conostinazione che fossero un popolo i palestinesi sapevano di nonessere siriani, di non essere libanesi, di non essere giordani,sapevano di essere un popolo specifico, distinto dai popoli deipaesi confinanti. Di non essere siriani lo sapevano dagli anniVenti, quando i nazionalisti palestinesi separarono il lorodestino dal disegno della “Grande Siria”, che avrebbe dovutoriunire Libano, Palestina e Giordania sotto l’egemonia diDamasco. Di non essere libanesi lo sanno da quando gli interessidella borghesia beirutiana hanno giocato i profughi palestinesicontro i diseredati locali. I “fratelli arabi” hanno spesso fattopesare ai palestinesi la loro condizione di stranieri nei Paesiospitanti, e questo ha consolidato la consapevolezza della loroidentità nazionale151”.
I testi sono tutti attraversati da questo segno dicostitutiva differenza dei palestinesi, differenza che rispettoal dolore identifica gli altri stati arabi come agenti. Questo èuno scostamento netto rispetto all’ideologia panaraba, che pureaveva inciso nella visione politica palestinese perlomeno finoalla sconfitta di Nasser nel 1957.
149 Dentro la notte, p. 163.150 Dentro la notte, p. 151. 151 Postfazione di Isabella Camera d’Afflitto a Kanafani, 1991, p. 105.
118
La denuncia più forte della responsabilità dei paesi arabi èin Dentro la notte, dove Nasrallah parla dei palestinesi come ‘corpicontesi e spartiti per essere mangiati’: la ‘carne palestinese’compare nella linea narrativa che riguarda l’assedio vissutoinsieme alla famiglia e torna in quella del viaggio onirico conl’amico. Rispetto alla prima scena il protagonista narra dellasospensione dei bombardamenti: “Ormai c’erano gli osservatori.C’erano gli osservatori dell’Alto Comitato Arabo. C’era quellodella Lega degli Stati Arabi. E quello della Croce RossaInternazionale. E altri e altri ancora. Erano arrivati tutti dopoche gli aggressori avevano finito le munizioni. Correvamo, aprepararci al prossimo assedio! Ormai tutti avevano diritto a unaquota della nostra carne!152”. Il racconto passa allevicissitudini del protagonista e dell’amico: mentre i due sonostrattonati dai funzionari di una qualche organizzazionediplomatica, c’è la conversazione fra due generali dei paesialleati: “Una chiamata dall’estero. All’altro latol’interlocutore cercava di tenere basso il tenore del discorsofino a farlo sembrare scherzoso: – Caro mio, non volete lasciarciniente della loro carne? Volete papparvi la nostra parte?Lasciateci un ruolo nella regione! – . Il generale avevarisposto: - Adesso è compito nostro! – . E quello dall’altraparte aveva superato i confini con i carri armati. Noi dicevamo:- Arrivano i soccorsi! – . Gli dicevo: - Si dice che gliamericani abbiano fatto i loro conti. Hanno trovato che farcifuori per mani locali costa meno che mandare i marines. Così labattaglia è fraterna. Ci possiamo sempre riconciliare, perdonare,cioè solidarizzare. Poi la differenza del cambio si divide inparti uguali. Così su nessuno ricade per intero il nostrosangue!153”.
Qui non solo i palestinesi non hanno nessun potere di offesa,ancora prima manca la possibilità di una difesa: si descrivonodelle vittime sacrificali. C’è una storia altrui, la narrazione delpotere dei paesi arabi e i palestinesi ne sono oggetto,strumento.
5.2.4. Sovrapporre gli israeliani agli inglesi
Un altro aspetto che la retorica dell’ Intifada taglia fuori, mache torna con costanza nei testi, è la percezione di una violenzareiterata, che non è attribuibile agli israeliani come agenti originari.
152 Dentro la notte, p. 144. 153 Dentro la notte, p. 146.
119
In effetti nella storia palestinese è stata la dominazioneinglese del Protettorato, dagli anni Venti al 48’, a costituireil punto d’origine delle vicende di contesa di uno spazio esembra esserci un filone di memoria tramandato dalla generazione‘pre-48’ a quella successiva, che colloca l’occupazioneisraeliana come fase più recente di un’unica storia: una storiadi violenza inglese, poi araba, poi israeliana, poi araba, poi dinuovo israeliana.
Sia le protagoniste di Niente sesso in città che il vecchionarratore di Memoria danno idea di questo spazio del ricordo chesi snoda senza cesure, senza differenze fra un dolore e l’altro.
Potremmo dire che il testo di Natur è centrato proprio sullaconfusione dei nemici: i molti aneddoti narrati sono tutti storie disoldati, di fucilazioni, di fughe, di imboscate, in cui al centroc’è sempre il gruppo di abitanti di un villaggio palestinese –sempre collocato con precisione con il riferimento al suo nome –e un gruppo di aggressori. A volte si riesce a capire che sitratta di soldati arabi e che si fa riferimento a episodi discontri sanguinosi fra palestinesi e popoli di paesi limitrofiche più volte hanno avuto luogo nella storia del conflitto. Altrevolte non c’è nessun riferimento all’identità degli aggressori,che rimangono senza nome. Altre ancora, come nel passaggio cheriportiamo in appendice154, il riferimento arriva da un dettagliosecondario: solo da un breve scambio di battute fra un soldato euna donna si capisce che si tratta di inglesi.
Si potrebbe persino azzardare, in una considerazionecomplessiva dei racconti che hanno per oggetto aggressioni dicivili, che il senso del dolore inflitto dagli israeliani, perun’economia culturale, replica quello originario, inflitto aipalestinesi dagli inglesi. Come dire che una quota diaggressività significativa è stata ormai spesa dai palestinesinelle insurrezioni del triennio fra il 1936 e il 1939, che lastoria ha fissato con il nome di Grande rivolta araba155.
154 Estratto 8. In Appendice.155 “La rivoltà iniziò in ambiente urbano con un grande sciopero generale nel 1936,coordinato dall’Alto Comitato Arabo. Ispirato alla dottrina della resistenza passiva edella disobbedienza civile contro la Gran Bretagna e la sua politica ‘imperialista’ (dicui il sionismo era considerato un’emanazione) sfociò in scontri armati con l’esercitobritannico. Agli scontri parteciparono anche bande irregolari provenienti dai paesivicini, che rappresentavano il respiro panarabo dell’insurrezione: una in particolare,guidata da Fawzi al – Din al-Qauqji, raccoglieva giovani dalla Siria, dall’Iraq e dallaTransgiordania. All’interno dei comitati organizzatori, tuttavia, si manifestarono entrobreve tempo anche gli antagonismi locali: tra le generazioni più giovani e i vecchinotabili, fra le varie famiglie di notabili, tra gli interessi delle classi urbane equelli delle campagne. L’ultima fase della rivolta si configurò come una vera e proprialotta di classe fra i notabili urbani e i contadini palestinesi. Inizialmente limitata,
120
Si sente, sia nel caso di Natur che di Amiry, una sorta diprostrazione che riguarda la descrizione e la denuncia in particolare proprio dellaviolenza israeliana. Forse, perlomeno in Natur, il risentimentoaggressivo è quasi trasferito dal rapporto con gli israelianialla rappresentazione cruda dei primi episodi di sopraffazione daparte degli inglesi.
Rispetto a quello che abbiamo detto sul trauma potremmoimmaginare che l’evento traumatico originario sia quello dellaviolenza inglese e che con lo scontro con gli israeliani si riattivisovrapponendo il dolore del presente a quello del passato.
Un altro elemento da notare è che se c’è un agganciosimbolico - pur debole - fra la sofferenza reale dei palestinesidi oggi e la narrazione politica antimperialista antiamericana,di origine europea, questo passa senza dubbio per lasedimentazione nella memoria collettiva dell’aggressività degliinglesi.
5.2.5 La resistenza polemica e la strategia contrattuale
Citiamo un ultimo brano che ci fa aggiungere un tasselloimportante.
E’ un passaggio di Una primavera di fuoco in cui due visioniopposte fanno pensare alla distinzione greimasiana fra agirecontrattuale collaborativo e agire polemico malevolo. Durante ilpranzo in occasione della visita del fratello avvocato, a cuioltre che Suad e i genitori partecipano anche Ahmad e il padregiornalista, si apre una discussione sulla strategia di difesadel popolo palestinese, perché il giornalista riflette se siameglio “per la gente e per la Causa perdere il cinquanta o ilcento per cento”. Poi passa a una cupa consapevolezza, che ormaiin realtà “non c’è già più niente”; però i palestinesi potrebberomagari: “riavere indietro qualcosa, con la tattica giusta”.Queste parole provocano l’ira del fratello avvocato di Suad, cheinveisce: “Non è vero che se la sono presa! Noi li aspettiamo alvarco. Non cederemo, non ci inginocchieremo, fino all’ultimolattante156”.
Il senso della discussione è sintetizzato nel passaggiosuccessivo, in cui il giornalista reagisce: “Sorrise e si guardòintorno per vedere come reagivano gli altri a parole come quelle,
la repressione inglese divenne durissima, con la creazione di campi di concentramento el’esilio forzato dei capi della rivolta. E’ in questa occasione che gli inglesicostruirono la maggior parte delle strade della Palestina, proprio per facilitare glispostamenti dell’esercito”. In Emiliani, 2007, p. 28.156 Una primavera di fuoco, p. 302.
121
già ascoltate centinaia, migliaia di volte dalla bocca di poeti egovernanti e durante le prediche in moschea. Vide che Suadsorrideva malevola, che Umm Su’ad fissava il figlio dissimulandol’irritazione e che suo figlio, Ahmad, guardava fisso il cibo manon lo toccava. In tono scherzoso, tanto per cambiare discorso ealleggerire l’aria, gli chiese: - Com’è Ahmad questomsakhkhan?157”.
Sintetizzando quello che abbiamo detto finora: c’è unasituazione politica complessa, da cui deriva l’impossibilità didotarsi delle risorse identitarie di un agire aggressivo; c’è unnucleo attivo basato sull’idea politica di resistere e inoltre,accanto al discorso polemico, c’è questo spazio che ripensal’azione in un quadro contrattuale, come strategia per tornareindietro, per riavere qualcosa. Al centro di tutto c’è la perditadella terra. La perdita progressiva del controllo ha disarmato lavisione politica ma ha anche radicato l’importanza della terra:pensiamo che il fatto di arginarne la sottrazione resistendo apraanche all’idea contrattuale di negoziare per riaverla.
5.3. Rappresentazioni dell’’altro’
Nei testi l’ideologia politica torna anche nella descrizione deipersonaggi: l’aspetto più sorprendente di questa narrativa è ilfatto di descrivere attraverso l’ironia e il fantastico figureche nella storia del conflitto sono caricate dalla portata dellaretorica politica.
Esamineremo ora i racconti che chiamano in causa l’idea delmartirio, l’immagine degli israeliani e quella di due figure dirappresentanti dell’autorità politica: quindi racconti dell’altro,di soggetti che delimitano dall’interno o dall’esterno il sensodel gruppo.
L’assenza di un programma aggressivo sembra responsabiledirettamente di questo modo ri raccontare l’altro: saltato loschema aggressivo, salta anche quello di un noi contro un loro,sparisce lo spazio per la descrizione di un soggetto eroico einsieme quello dell’antisoggetto si frammenta e si confonde. Cosìin una testimonianza letteraria troviamo una molteplicità dipunti di vista inimmaginabile in discorsi istituzionali, cheforse in questo caso rende la fiction narrativa più esaurienteriguardo alla realtà sociale di quanto possa essere un reportaged’inchiesta.
157 Una primavera di fuoco, p. 303.
122
5.3.1 Martiri
In Niente sesso in città il suicidio eroico è al centro di due sequenzedi ricordo delle amiche di Suad. La prima è quella di cui abbiamogià parlato, del padre di Rana, ricco borghese che ha sceltoimprovvisamente di sacrificarsi. L’aspetto interessante è che intutta la narrazione non compare mai un giudizio sul gesto ed ilproblema della sanzione devia su un tema diverso, un temainfantile. Rana racconta di un gruppo di gioco di bambinipalestinesi tutti figli di shashid, di martiri: il nuovo arrivato,Iyad, per una regola estemporanea inventata dalla protagonistapuò essere ammesso solo dopo aver ricevuto l’augurio che suopadre diventi presto uno shashid.
Anche l’altra occorrenza è originale: dopo la morte dellamadre colpita da un proiettile israeliano, Maya e il fratellohanno una discussione su chi dei due debba sacrificarsi per vendicarla. Mayasi offre volontaria e il fratello replica: “No non puoi, hai trefiglie piccole..Devo essere io..adesso che la mamma è morta, lamia vita è finita”. I due sono interrotti dall’arrivo del padreche li costringe a rinunciare all’idea: “Se loro sono deiselvaggi, non c’è bisogno di essere come loro. Se voletemantenere viva la sua memoria e onorarla, continuate a farequello che faceva lei per i poveri e i bisognosi. E’ così che sifa vivere il suo ricordo158”.
Qui vale un codice doppio, per due opposizioni fra semidiversi. Per i figli è l’onore a contare rendendo doveroso quelloche invece il padre colloca su un piano di inciviltà,caratterizzando come proibito l’assassinio, un gesto disumano dicui la moglie è stata vittima.
In Memoria di Natur c’è una versione ironica esplicita delproblema. Un contadino racconta indignato alla moglie le paroleche ha sentito da alcuni giovani combattenti: dopo aver sparato auna gallina per mangiarla hanno detto all’uomo che la bestia è“morta da martire”. Il protagonista lega a questo unaconsapevolezza desolata, conclude che: “la Palestina da quelgiorno è perduta159”. La sanzione rovescia il giudizio di valore:quello che nel martirio è il mandato dell’onore, la promessa dellaricompensa divina per il sacrificio terreno, diventa il segno certo diuna perdita irrimediabile, della scomparsa di un valore, quandoserve a giustificare un atto futile.
158 Niente sesso in città, p. 148. 159 Memoria, p. 62.
123
Stessa attribuzione timica in Dentro la notte, quando ilprotagonista e il compagno decidono di imbracciare le armi perraggiungere un gruppo di guerriglieri. Con un discorso solenne ilcapo della guerriglia spiega ai due nuovi arrivati che la loroprima missione sarà un attacco suicida. Con un procedimento daWitz freudiano la voce narrante passa subito dopo a descrivere laloro fuga: “il pendio smottava sotto i nostri piedi. La cimasmottava. Gli alberi stessi scivolavano. Nella nostra folle corsacalpestavamo tutto. L’uomo ci correva dietro gridando: -Compagni! Compagni! Fermatevi! Compagni! Tornate indietro! Miservono due vostre fotografie! - Non c’era stato bisogno difermare una macchina. Un camion si parò davanti a noiall’improvviso. L’autista era riuscito a fermarsi all’ultimomomento: Ma vi volete ammazzare? – No! Veramente no! – Avevacapito al volo che cosa ci stesse succedendo: - Su, salite!160”.
5.3.2 Gli israeliani
La dissacrazione ritorna nei testi di Suad Amiry e questa voltariguarda l’altro israeliano. In Sharon e mia suocera si racconta lagita turistica di Suad e sua nipote a Gerusalemme: mentre guidafra i monumenti della città Suad si imbatte in un uomo anzianoche ha avuto un attacco cardiaco, lo fa sdraiare sul sedileposteriore dell’auto e si dirige verso l’ospedale. L’uomo è “unisraeliano”. Suad racconta che quando entrambi capiscono ditrovarsi davanti al nemico, sua nipote e il malato sonoterrorizzati.
L’ironia è su due livelli narrativi simultanei: mentrefantastica sulla fatalità della morte dell’uomo prima di arrivarein ospedale e sul confronto con la polizia israeliana, Suad parlacon lui e risponde a una serie di domande. Il malato spera che non sitratti davvero di una donna palestinese: “Siete di Betlaikhem? (Betlemme) -indaga con tono stanco e un pesante accento anglo-israeliano.Avrei voluto dirgli che sì, venivamo dalla città della pace, manon l’ho fatto. Avrei voluto aiutare quel pover’uomo morente adaggrapparsi a uno dei rassicuranti miti israeliani, ma non cel’ho fatta. – Ramallah - rispondo parlandogli attraverso lospecchietto. - RAMALLAH? - . Il suo orrore è totale. – Perché nonsi rilassa un po’? – gli rispondo. Volevo davvero che smettesse
160 Dentro la notte, p. 124.
124
di investigare, perché gli shock potevano rivelarsi fatali per ilsuo povero cuore. Ma lui prosegue. - Ramallah è una cittàcristiana. – Una volta – dico in tono pragmatico. – Lei ècristiana. – Musulmana – faccio io161”.
Amiry costruisce così un dispositivo in cui osserva se stessaattraverso la paura dell’altro; in Niente sesso in città invece troviamo ilprocedimento ironico opposto. La narratrice spiega che alla cenaprende parte anche Judy Blanc, un’amica ebrea: “ma visto che perIsraele i tre milioni e mezzo di arabi palestinesi in realtà noncontano, pur trattandosi di una socia fondatrice e di una delleG8, ho volutamente deciso, per amor di reciprocità, di nonconteggiarla. Per quanto mi riguarda, la vita di Judy non ha maiavuto luogo162”.
Poi c’è una specie di gesto performativo dell’enunciazione:dopo la storia di Reem nel capitolo 6, troviamo una pagina vuotache si intitola: “senza numero. Judy”, con una frase: “(La suavita per quanto mi riguarda, non ha mai avuto luogo)”.
Non mancano altri esempi sorprendenti. In La svergognata unadelle poche note umoristiche, se non la sola, riguarda gliisraeliani: mentre supplica il marito per tornare in Cisgiordania- in un passaggio dunque drammatico - Afaf racconta: “A tavolacrollai. Gli dissi: ‘sento la mancanza di mia madre, la mancanzadella mia famiglia, della gente. Sento la mancanza persino degliebrei. Lasciami tornare a fare una visita. A vederli163”.
Anche in Dentro la notte e in Memoria la descrizione del nemico èoriginale. Nel primo il protagonista racconta che nelloscantinato dove è rinchiuso con i vicini c’è anche “una contadinadagli occhi belli”, della quale sua madre gli ha detto che “èebrea”: la donna ha sposato un palestinese. I bambini non sifidano della donna ma vengono convinti da una serie di fatti chenon c’è “da stare attenti”. Prima l’abito tradizionale, che:“indossava esattamente come mia madre”, poi l’invocazione adAllah perchè sostenga i palestinesi contro i loro nemici – isionisti, gli inglesi, gli americani e i loro agenti – “lanciataesattamente come mia madre, con lo stesso accento delle campagneche noi che andavamo a scuola non sapevamo imitare”; poil’informazione offerta dalla madre stessa del protagonista: “nel48 è uscita con noi. E’ una di noi”. Infine la domanda dei
161 Sharon e mia suocera, p. 148. 162 Niente sesso in città, p. 24.163 La svergognata, p. 72.
125
piccoli sulla vera prova di eroismo: “E’ vero che i suoi figlisono con i partigiani?164.”
Ancora nel testo di Natur gli israeliani sono i personaggi diun episodio che tematizza il riconoscimento della casa, di cui abbiamogià parlato rispetto all’esperienza delle famiglie palestinesifuggite nel 1948. Qui la prova ha un esito positivo: ilprotagonista viene accolto dal nuovo occupante, un “artista”israeliano. Come il confronto fra la nipote di Suad e il malatoisraeliano in Sharon e mia suocera, il contatto fra vecchio e nuoviproprietari è scioccante: “la moglie è andata ad aprire la portae si è spaventata alla vista di quell’arabaccio. L’uomo,vedendosi aprire la porta da una donna seminuda, ha perso laparola e, sul punto di tornare indietro, ha stretto la scatola difiammiferi che aveva in tasca, quasi volesse dare fuoco alvillaggio e a tutto ciò che c’era dentro. La donna lo ha invitatoad accomodarsi e ha chiamato suo marito. L’artista tremava dipaura e fissava il copricapo, la cordicella che lo teneva su e ibaffi lunghi e folti dell’uomo165”. Dopo aver rifiutato il whiskeyofferto dal padrone di casa il protagonista comincia a raccontarela sua storia, ascoltato con grande attenzione dall’artista edalla moglie. L’israeliano è così turbato da decidere di cambiarecasa, ma anche in quella nuova si scopre ad attendere che:“arrivi un altro arabo a chiedere della casa dov’era nato”. Cosìdecide di lasciare il paese.
Dopo la storia, che si intitola “Artista - 1 ” c’e n’èun’altra, “Artista – 2”, dove l’immagine è giocata su unasfumatura diversa. All’artista Itshi Mambush viene chiesto se sache la casa dove abita appartiene a una famiglia di profughi diGenin; lui risponde: “Mi dovrebbero ringraziare. Ho avuto curadella casa: l’ho ingrandita, messa a posto e ripulita! – E seinvece qualcuno di loro venisse a reclamarla? – Pretenderei ilrimborso di tutte le spese e un risarcimento del lavoro fatto persistemarla166”.
Vediamo per ultimo Una primavera di fuoco. Qui la costruzionemantiene una sorta di doppia lettura dell’identità israeliana: dauna parte il nemico, nella forma di un soggetto collettivoimpersonale, agente della sofferenza come ‘carnefice spietato’;dall’altra una ragazza israeliana fa parte del racconto intimo diAhmad, che da bambino si innamora di lei.
164 Dentro la notte, p. 78.165 Memoria, p. 66. 166 Memoria, p. 67.
126
Il loro rapporto è basato sul clichè culturale del confronto conl’altro: Ahmad e Mira parlano due lingue diverse; giocano attraversola recinzione che chiude l’insediamento israeliano adiacente alcampo profughi comunicando a gesti. Si presentano e Mira vieneincuriosita prima dalla macchina fotografica e poi dalla gatta diAhmad. Poi la situazione precipita, proprio per il cucciolo: lagatta fugge e giorni dopo Ahmad viene a sapere che Mira l’hapresa con sé.
Khalifa marca un’usurpazione, non solo a livello materiale:Ahmad infatti provava lo stesso amore per Mira e per l’animale eperde entrambe per colpa degli israeliani; quando una notte entranell’insediamento deciso a riprendere la gatta viene sorpreso daisorveglianti e arrestato.
Lo accusano di essersi introdotto nell’insediamento perseminare delle mine e ha inizio la spirale discendente dellafortuna dei protagonisti: tutta la famiglia viene limitata neipropri spostamenti dall’esercito israeliano, preoccupato dicontrollare i parenti di un terrorista, per la stessa ragioneMagid perde i favori del notabile locale, Al washmi, che gliaveva promesso di appoggiarlo e farlo emigrare in Europa; Ahmadvive tutta la violenza del carcere, che lo cambierà in modoirreversibile. Lui e Mira si rincontreranno nelle pagine finali,cresciuti di diversi anni, durante una manifestazione lungo ilmuro che gli israeliani stanno costruendo. Si tratta della scenache precede il suicidio di Ahmad. Lui assiste alla disperazionedi Mira per la morte della ragazza con cui era allamanifestazione, quella Rachel uccisa dal bulldozer israeliano.
Le ragioni del raptus con cui scaglia l’ambulanza contro isoldati sono già nella sua riflessione: “si ricordò di come avevapianto lui, quando lo avevano arrestato dopo la faccenda dellagatta. Quanto si era augurato che piangesse non una ma migliaiadi lacrime, che si torturasse come era stato torturato lui.Quanto avrebbe voluto tradirla come lei aveva tradito lui dandoloin pasto ai soldati e ai guardiani notturni. Aveva pianto, dapiccola. Ma per paura, non per la sofferenza che pativa lui. Eadesso a farla piangere erano i soldati, i suoi, quelli del suogoverno. Accidenti a te, quanto ti ho voluto bene. Piangi adesso?Son lacrime di coccodrillo. Sei bella tu. Quanto ti ho volutobene. Ti ho tenuta sul cuore, sotto il maglione, ho contemplatola tua fotografia come fosse un uccellino, una gemma dialbicocco, ho contemplato quei capelli che ti si sollevavanosull’altalena, come un aeroplanino, un aeroplanino di carta. Misi dilatava l’anima, sospinta dalle brezze estive e da una
127
passione adolescenziale che sognava l’amore, sognava laspensieratezza, una foto, una gatta e quei bei capelli. Sei bellatu. Ma dove viviamo? Con questo clima non ci sono né ambiente nébellezza né umanità. Qui ci sono i soldati, c’è un carro armato ec’è mio padre che piange come un bambino167”.
Abbiamo visto una vasta gamma di rappresentazioni graduali,da quella quasi identificativa di Suad nel malato israeliano aquesta ultima in cui l’elemento del nemico ipostatizza quasi lavisione di fine della Storia, perché cancella il rapporto umano fraAhmad e Mira e anche il senso della vita del protagonista. Tantoche potremmo dire che qui non c’è più neanche il nemicoisraeliano ma solo un orizzonte vuoto, senza prospettive, chesbarra la costituzione di qualunque soggettività.
5.3.3. Arafat e Bush
Guardiamo a come sono rese due figure di autorità. La prima èquella di Arafat in Una primavera di fuoco. Qui Khalifa sfrutta lospazio del testo letterario per restituire un’immagine intima, unArafat umano. Mette anche in discussione una serie di punti deldiscorso politico palestinese, sottolineandone aspetti cheriguardano l’idea di aggressività.
Nel diario che tiene mentre è barricato con altri soldatidentro la residenza di Arafat per difenderla dall’assedio diSharon, Magid descrive una situazione assurda: “perché morire perun uomo che aveva visto soltanto in fotografia? Il fatto che cisia un governo da fotografare non ha stornato i pericoli, anzi liha concretizzati168”. Quando però i carri armati fanno breccia suun lato del complesso e la situazione precipita, Magid hal’impulso di andare a osservarlo. Viene emozionato dalla tenacia chericonosce nello sguardo di Arafat; piange e il presidente gli siavvicina: “lo osservò attenzione, da breve distanza. Magid simise sull’attenti, abbassò gli occhi e si preparò a sentirsirivolgere una qualche domanda. La domanda gli piombò sulla testacome un’ascia: - Sei un combattente? – Assieme alla salivadeglutì la mortificazione per le proprie lacrime e l’umiliazioneper una vita consumata da un destino avverso, dall’occupazione edal coma. Cercò di assumere un tono di voce fermo. – Sì sono uncombattente – rispose. Arafat gli si avvicinò ancora di più e glibisbigliò in un orecchio: - E queste lacrime? – Gli parve chequesta domanda gli lacerasse la carne. Avrebbe voluto difendere
167 Una primavera di fuoco, p. 328.168 Una primavera di fuoco, p. 200.
128
la propria debolezza, la propria sensibilità dicendo: « Perchésono un artista » ma fu assalito da un senso di vergogna davantial suo comandante e ai compagni e non osò. – Perché sono unessere umano - , rispose. Arafat annuì e passò oltre169”.
Arafat è passato a incarnare un valore. Ci sono elementi cherichiamano il paterno, le aspettative di un padre verso unfiglio, piuttosto che la semplice richiesta di adeguatezza ad unsoldato da parte di un comandante. Il ruolo di Arafat non èviolento, non si tratta di un esempio da seguire per rispondereaggressivamente agli israeliani; torna semmai l’idea dellaresistenza.
Poi la voce narrante fa una riflessione politica in pienaregola: Arafat predica il martirio come strategia; si rivolgealla politica internazionale e a Sharon, attira l’attenzionesulla violenza israeliana e nello stesso tempo sulla resistenzastrenua dei palestinesi: “Avete mai visto un martire che trama?Io sì, l’ho visto al secondo piano di una palazzina semidistrutta[…]. E ho dedotto che Karzai qui non ci verrà170, che iocontinuerò a vivere e Sharon recepirà il discorso e ilsottinteso171”.
L’enfasi sul discorso dell’uomo di potere è il motivo di unadisillusione. La stessa di tutti gli altri esempi in cuiinteressi altrui e agenti esterni saturano lo spazio per unapossibile narrazione ottimista dei palestinesi come soggetti. Mail valore della figura del presidente non è scomparso. Poco dopoArafat è un uomo con un’ossessione: “non importa quanto piccola, nonimporta quanto grande, non importa quanto alterata, non importaquanto malandata, la Palestina deve assolutamente esistere.Ordirà trame, cercherà di persuadere, pencolerà verso sinistra epoi verso destra, salirà e scenderà fino alla morte, ma lei deveassolutamente esistere. Lui gioca con lo spago della sua kufiyya ocon un dito, a dadi o a scacchi, a mosca cieca o a qualsiasialtro gioco, ma lei deve assolutamente esistere. A costo dellasua vita, lei deve assolutamente esistere. Bene. Ma allora checosa ne sarà di noi?172”.
La configurazione è la stessa della scena fra il giornalistae l’avvocato sul futuro della Palestina: c’è il nucleo semantico
169 Una primavera di fuoco, p. 204. 170 Il riferimento è ad Hamid Karzai, primo presidente eletto democraticamente inAfghanistan nel 2004, figura politica ambigua e contestata, da una parte per i rapporticon il partito Taliban e dall’altra per le influenze esercitate dal governo statunitensesulle sue decisioni.171 Una primavera di fuoco, p. 251. 172 Una primavera di fuoco, p. 252.
129
della resistenza e uno schema contrattuale che sostituisce quellopolemico, per cui Arafat tende alla terra palestinese comeoggetto di valore ed è soggetto di un programma strategicorispetto ad essa. Solo, qui è più marcata la chiusuradell’orizzonte per la vita intera del gruppo: mentre Arafat giocala posta della terra, che cosa ne sarà dei palestinesi?
Il punto di domanda amaro c’è anche nella scena in cui SuadAmiry telefona al presidente degli Stati Uniti in Sharon e miasuocera. In un capitolo che s’intitola: “11 settembre 2002 ‘CAROPRESIDENTE PUSH’”, Suad chiama “il numero del presidente” inoccasione dell’anniversario dell’attentato alle Twin Towersdell’anno precedente, per denunciare la situazione deipalestinesi, sottoposti a cinque mesi di assedio israeliano. Iltono sale da alcune trovate ironiche fino al vero e propriosarcasmo: dall’imitazione che Suad fa del proprio accento, “lamaggior parte dei balestinesi ha un problema a pronunciare le P ele B”, al misunderstanding continuo fra Suad e Bush: “No..No..signorpresidente, non.. – ho ripetuto a voce molto alta e scandendobene le parole: - signor presidente , ISRAELE… CI… HA… MESSI…NOI… I TRE MILIONI E MEZZO DI PALESTINESI... AGLI ARRESTI…DOMICILIARI! - Rest, riposo, sì, sì, riposo…perché non riposate??In fondo avete bisogno di un po’ di riposo”, fino al gioco diequivoci sulla trasparenza: “Dica alla sua gente che, se voleteentrare a far parte del mondo libero, dovete essere assolutamentetrasparenti e quando dico trasparenti voglio dire trasparenti, micapisce signora? - Non vorrà dire trasparenti per la fame, signorpresidente? E’ all’Autorità nazionale palestinese che avetechiesto di essere trasparente, non alla gente comune! – Vogliodire quel che voglio dire –, c’è stata una lunga pausa, quindi unpiccolo fischio, prima che il presidente aggiungesse: - Miascolti bene, signora, nelle società LIBERE e DEMOCRATICHE comela nostra non facciamo distinzioni tra gente comune e governo - .– Sì certo, lo vedo signor presidente173”.
5.4 Ironia, straniamento e orientamento al passato
Concludendo questo capitolo possiamo affermare che l’ironia e ilfantastico debbano essere messi in connessione con la mancanza diuna predisposizione aggressiva, ma non solo: pensiamo anche checi sia la percezione costante dello spazio sottratto, usurpato, aorientare verso una dimensione onorica la narrazione politicapalestinese.
173 Sharon e mia suocera, p. 123.
130
Sembra che la frustrazione della perdita mantenga lanarrazione completamente legata a un oggetto che non c’è più e adun ruolo che è sparito di conseguenza: i palestinesi non sono ingrado di agire perché non hanno la possibilità di pensarsi nelfuturo. Da qui deriva quello straniamento rispetto allasituazione da cui a livello semantico si origina il dispositivoironico e che lascia campo aperto a quello fantastico. Da quivengono il simbolo dell’Intifada e quello più importante dellaresistenza, come unico gesto attivo in un discorso polemico -gesto attivo ma appunto non aggressivo, perché riguarda ilmantenimento e non l’appropriazione. Da qui nasce anche l’ideaparallela di un agire contrattuale che permetta di avere indietroqualcosa, di tornare in possesso in qualche modo. Esattamente comel’infanzia è un luogo dove andare perché nel presente e nel futuro laresponsabilità sembra essere troppa, anche l’ideologia politica èorientata al passato. Al posto dell’aggressività verso gliisraeliani troviamo semmai un promemoria del dolore: un sentimentoincoativo, come suggeriva Greimas, legato all’ipostatizzarsidella frustrazione, che antepone la relazione di disgiunzione conl’oggetto a quella aggressiva con l’avversario. L’infanzia e lapolitica, con una loro struttura particolare in questa cultura,ci rimandano all’idea di un blocco spazio-temporale ‘mozzo difuturo’ e centrato sull’orientamento al passato.
131
PARTE TERZA
6. Tirare le somme, riparlare di genere.6.1 Conclusioni
Ci sono alcune osservazioni che dobbiamo fare rispetto altentativo complessivo di quest’analisi. Quello che abbiamo dettorispetto alla memoria, alla teoria dell’identità di genere, ingenerale tutto quello che abbiamo avuto la pretesa di definirecome tratto caratterizzante della cultura palestinese lo abbiamoconcluso partendo dalla superficie discorsiva di sei testinarrativi. - Guardare alla letteratura in questo senso vuol direconfrontarsi con un rischio specifico: la tentazione disemplificare.
La prima insidia è quella dello schema orientalista a cuiabbiamo accennato per il gender, schema che riduce la questioneculturale ad aspetti lampanti come la religione islamica e lasottomissione delle donne, che poi nella realtà lampanti non sonoaffatto, o meglio non solo. Altra soluzione semplice sarebbefarsi tentare dal sensazionalismo, per cui magari il fatto diindividuare strutture narrative associative e una funzione ludicadella rievocazione dell’infanzia, come abbiamo fatto nel quartocapitolo, rischia di sfociare nella celebrazione ingenua diun’incredibile fantasia palestinese; è molto più probabileinfatti che lo stile discorsivo risulti originale, non sapendoabbastanza dei codici narrativi della tradizione letterariaaraba174.
174 Un argomento che qui non trattiamo, ma che riguarda da vicino i testi è l’influenzache per la narrativa ha la tradizione poetica. A dire la verità c’è un fatto duplice: nonsolo la poesia ha una diffusione elevata in tutti i paesi arabi e anche in Palestina,come genere di consumo culturale unificante dei vari profili di classi sociali diverse,ma sembra proprio che la narrativa derivi dall’evoluzione di un genere poetico in unaforma di prosa, attorno al Mille. Per il primo aspetto ricordiamo che molti degli autori di narrativa palestinese sonoanche poeti e che in tutti e sei i testi che analizziamo vengono citati più volte i poetiAbu Salma e Mahmoud Darwish, vere icone del senso collettivo dell’arte. Nel caso diDarwish l’arte va insieme con l’impegno politico della militanza mai interrotta nell’OLP:è stato lui a redigere il testo della Dichiarazione d'Indipendenza dello Statopalestinese e dopo Arafat è la prima e ad oggi unica personalità palestinese a cui sianostati concessi i funerali di Stato. Per il secondo aspetto c’è uno studio dell arabista Mohamed Salah Omri (Omri: 2008) sul
132
Ancora rispetto alla mancanza di aggressività di cui si èparlato nel quinto, speriamo di aver reso chiaro che si tratta diun problema di disorientamento culturale per cui manca la visionedi un futuro politico possibile e non certo di una qualità di‘bontà etnica’ alla Rousseau. Un’osservazione di Lucy Ladikoffperaltro lega anche l’infantilismo e l’attaccamento agli antenatia qualcosa di irrisolto, perché indica in questa cultura unaforte chiusura psico-sociale, o meglio una rimozione dellasessualità nell’immaginario collettivo. Ma anche qui, si potrebbeosservare, siamo da capo a un problema di riduzionismo..
Quindi ci accontentiamo di ribadire che nessuna delleaffermazioni di quest’analisi punta a rivelare come funzioni lacultura palestinese, ma solo a mettere in evidenza aspettimacrotestuali rispetto alla semiosfera in cui è prodotta questanarrativa. - E in questo senso guardare alla letteratura offre anchevantaggi. Il campo semantico che si organizza in questa formatestuale sfrutta delle risorse esclusive e lo spazio letterariopuò offrire una prospettiva d’osservazione più ampia di quella diun saggio storico, ma anche di quella del giornalismo didenuncia.
Abbiamo ottenuto una cognizione particolare della rilevanzatanto narrata della perdita palestinese della terra; di che pesoabbia l’elemento sociale collettivo e di quanti modi diintenderlo ci siano; della frattura forte fra due generazioni.Sono emersi anche elementi importanti sugli agenti implicati nelconflitto. Nei testi non c’è semplicemente una guerra fraisraeliani e palestinesi, rispetto alla narrazione occidentale siraccontano relazioni differenti: il contatto con gli europeidurante il protettorato inglese e il rapporto con gli stati arabidell’area sono componenti di un tessuto di senso culturale in cui
legame fra la fiction araba contemporanea e il maqamah, un tipo di composizione in prosaritmata con una tradizione antichissima, che è passato attraverso le vicissitudini deigeneri letterari arabi nei secoli. I maqamah sono sequenze di brevi racconti cheromanzano fatti della vita quotidiana, mettendo a confronto idee diverse. Secondo Omri letracce del maqamah nello stile della narrativa si ritrovano in “a) un elemento picarescolegato al tema del viaggio e dello spostamento; b) una relazione particolare fra unnarratore e un protagonista, originato dalla narrativa di genere delle gesta e dellefrasi del profeta Mohammed; c) un registro linguistico che cerca il ritmo anche nellaprosa, saja’ e pone particolare attenzione all’ornamento linguistico, badi’; d) un mix dihoumor e serietà, o di intrattenimento e parti pedagogiche”. Sono molti gli elementi di questo studio che renderebbero doveroso discuteredell’influenza del maqamah per i testi che consideriamo. Ma la nostra analisi non punta auno studio specifico dello stile letterario e quindi ci fermiamo qui, sottolineando solocome la consapevolezza di una storia complessa di influenze, proprie della letteraturaaraba, serva ad arginare facili entusiasmi di un interprete occidentale rispetto allapossibilità di considerare ‘originali’ alcune forme di questi testi narrativi.
133
gli israeliani intervengono a un altro livello, più superficiale,incidendo soprattutto per l’aspetto politico dell’occupazione. - Abbiamo anche discusso di problemi di ordine filosoficorispetto alle due questioni molto diverse del genere e dellatestimonianza nei testi. L’interpretazione di alcuni lettorisenza competenze teoriche di semiotica è stato l’aggancioinformale per valutare alcuni strumenti concettuali e confermarlivalidi: il genere è ripensato in una nuance di effettireferenziali e testimoniali molto simili a quelli ricavabilinella pratica interpretativa reale. - Infine abbiamo discusso dell’idea della scrittura di genere eadesso ci torniamo per un aspetto, per approfondire una questioneaperta dalle posizioni di Khalifa e Amiry: i due modi dielaborare il ruolo sociale femminile, così diversi, meritano unapprofondimento sul campo semantico che ne motival’organizzazione.
6.2 LimitiPerò prima ci sono altre osservazioni da fare sul corpus di testiche abbiamo scelto, perché deve essere chiaro quali sono i limitiper i quali quest’analisi non può essere considerata completa.
Le direzioni problematiche in realtà sono molte, ma ci sonodue aspetti in particolare a cui bisogna porre attenzione. Ilprimo, epistemologico, è la traduzione, perché abbiamo analizzatotesti scritti in arabo come lingua madre - quelli di Nasrallah,di Natur e Khalifa, mentre Amiry scrive in inglese - e poifiltrati con la pubblicazione italiana. Nel secondo riuniamoquello degli spazi commerciali e quello dello spaziodell’analisi, per cui inevitabilmente il rapporto type-token fraquesti testi e l’insieme della letteratura palestinese non èesauriente.
- Con la traduzione italiana si perde del tutto il senso della scelta discrivere usando l’arabo parlato: Sahar Khalifa per Una primavera di Fuoco eper altri suoi romanzi utilizza il dialetto di Nablus, ponendofra l’altro problemi notevoli di traduzione.
Si tratta di una scelta politica, della decisione di usareuna lingua reale, in un contesto di sfasamento sociolinguisticosu due, o meglio su tre livelli. Infatti prima di quello parlatoci sono due versioni di lingua scritta. Innanzitutto l’arabocoranico, classico, quello della storia letteraria scritta.L’arabo coranico non è in uso fra i parlanti, serve soprattuttoagli studi dei testi religiosi, però la differenza fra questo e
134
la sua versione moderna, l’arabo standard, o moderno, non è lastessa che possiamo pensare fra il latino e l’italiano: a livellodi lessico l’arabo standard evolve continuamente, dato che un po’ovunque dal Marocco all’Iraq è la lingua dell’informazione, dellacultura e della stampa, ma a livello morfosintattico le dueversioni sono molto vicine.
Il problema è che nessuna delle due è una lingua conosciutada tutti: questo perché “secondo una statistica recentedell’Organizzazione araba per l’Istruzione, la cultura e lescienze un terzo della popolazione del mondo arabo – circa centomilioni di individui, quasi tutti fra i 15 e i 45 anni – è difatto analfabeta175”. Segue che il dialetto, nelle migliaia divarianti locali, è la vera lingua utilizzata in tutte lesituazioni comunicative della vita quotidiana, da tutti: non faeccezione la classe colta che ha dimestichezza con la linguascritta. Quindi la scelta di Khalifa, Nasrallah e Natur è unascelta di segno progressista, perché allarga in qualche modo labase di quanti possono leggere i testi con una pienacomprensione; ovviamente rimane il problema dell’analfabetismopalestinese.
Si apre una questione ulteriore rispetto a quali palestinesici si voglia riferire: i campi profughi in Libano sono unversante drammatico, perché manca completamente l’impegnoassistenziale dello Stato libanese rispetto all’istruzione dibase dei rifugiati; poi c’è il dato che riguarda la disparità fraistruzione maschile e femminile, che soprattutto nella Strisciadi Gaza subisce gli effetti dell’adesione popolare al partito diHamas con una visione tradizionale della società che non prevedeil costo sociale di un’istruzione anche femminile. Il datocomplessivo dell’analfabetismo però è sorprendentemente basso efa della Palestina (dei Territori occupati) un’enclave culturalenell’alfabetizzazione media del mondo arabo176.
175 Ladikoff, nell’Introduzione a Zaqtàn, 2008, citando: “Alalksù”: Un terzo degli arabi èanalfabeta, nel quotidiano arabo “Alhayat” , no. 16349, 8/01/2008, p.1.176 “Nella giornata mondiale sull'alfabetizzazione, lo scorso 8 settembre, il presidentedel centro di statistica palestinese, ‘Ala Awwad, annuncia orgoglioso i dati sullapopolazione dei Territori palestinesi occupati. Stando agli standard utilizzatidall'Unesco, il numero di analfabeti tra la popolazione palestinesi è di 123 milasoggetti. Il dato si riconferma tra i più bassi al mondo. Anche se probabilmente sitratta di cifre inesatte, nel 2009, su un’età media di 15 anni, si è registrato un tassodi analfabetismo pari al 5.4%, mentre, tra il 2005 e il 2008, nel resto del mondo arabosi riportava il 27.6%. Questa la definizione Unesco di analfabetismo: una persona che non sané leggere né scrivere, capendolo, un brano semplice in rapporto con la sua vita giornaliera”. Articolo tratto daInfopal, agenzia stampa sul web che si occupa, per l’Italia, dell’informazione quotidianasulla situazione palestinese: http://www.infopal.it/leggi.php?id=15780.
135
Questo della lingua araba, che non cogliamo nella traduzioneitaliano, è l’oggetto di una accesissima diatriba culturale e inquesto senso la Palestina è davvero un contesto sui generis e leautrici e gli autori che consideriamo sono rappresentati di unamentalità evoluta. Basti pensare che nel 2004 un giornalistaegiziano, Cherif al-Choubachy, pubblicò un saggio in cuidenunciava il legame fra l’immobilismo socio culturale e ilpurismo linguistico: molti intellettuali arabi tradizionalistiinfatti negano la possibilità di usare i dialetti nella linguascritta, sostenendo che si tratterebbe di una distorsioneriduttiva della ricchezza dell’arabo classico. Il saggio infiammòl’opinione pubblica fino allo scandalo.
Una considerazione molto forte, in italiano, è quella di LucyLadikoff, ricercatrice di Lingua araba all’Università di Genova,di origine palestinese. Commentando un romanzo di un autorepalestinese, Ghassàn Zaqtàn, (scritto in arabo letterario),Ladikoff riflette: “chiunque legga autori arabi si rende contoche molti di essi, quando parlano della venerata lingua madre,rivelano un attaccamento patologico, incestuoso, quasi infantilecon essa. L’incesto è un tabù perché nuoce, tiene prigionieri,impedisce l’indipendenza, ostacola la possibilità di guardarel’altro, chiude la mente alle novità, impedisce la trasgressione– da trans-gredior, attraversare, fuoriuscire – che è unacomponente essenziale della creatività. Considerare la madre comeun dio unico, un legame non rescindibile, è una vitale necessitàdella prima infanzia; ma altrettanto necessarie saranno leprogressive separazioni: solo esse consentiranno di accedere allacuriosità, alla conoscenza, alla sessualità, alla conquista delmondo e all’appropriazione di se stessi177”.
Una seconda questione che riguarda la traduzione, oltre alfatto di perdere un aspetto importante è quella di ricevereinformazioni aggiuntive che modificano l’approccio alla lettura. Loaccenniamo soltanto, ma non è un problema da poco.
Bisognerebbe riflettere su che cosa si intenda per narrativapalestinese tradotta: i testi di Khalifa e Amiry hannotraduttrici donne mentre quelli di Nasrallah e Natur hannotraduttori; i titoli vengono modificati; gli editori fanno sceltemolto diverse sugli apparati che gli editori forti escludonocompletamente mentre quelli minori conservano in lunghe pre opost fazioni. Anche le scelte sui glossari dei termini arabi sonomolto diverse, da assolutamente assenti a puntuali, acircostanziali: con cinque o sei voci integrate con altre note.
177 Zaqtan, 2008.
136
In sostanza quello della traduzione come possibilità dimanipolazione del testo fa riferimento a un enorme bacino diquestioni filosofiche che naturalmente noi non affrontiamo; peròcogliamo un aspetto che ci porta dalla traduzione al limitecostituito dagli spazi di commercializzazione di questi testi.
- Guardando al consumo di cultura globale, nove anni fa Aptersegnalava la “commercializzazione di un’estetica internazionaleemergente”e descriveva come un gusto “esotico” fosse efficace nelriadattare qualsiasi testo, autore e contenuto alle tendenzecontemporanee: le letterature non occidentali erano “addomesticatein un continuum globale e plurale178”. D’accordo chel’orientamento commerciale è una strategia che esiste da quandoesistono mercati, dobbiamo però riconoscere l’esistenza nel 2010di un piano globale a tutti gli effetti, per cui avvicinarsi allatraduzione di una letteratura lontana e non massificata comequella palestinese vuol dire trovarsi faccia a faccia proprio conalcuni fatti ‘alla Apter’.
Non trascurabile per esempio il mix estetico fra letteraturadei diritte delle donne e echi del marxismo rivoluzionario checolpisce in modo inevitabile la grafica, gli apparati e leinformazioni sulle autrici nelle pubblicazioni italiane diKhalifa e Amiry. Un mix che si avverte molto bene anchenell’orientamento dei commenti tratti dal blog di Anobii di cuiabbiamo parlato nel primo capitolo, per cui molti lettori si aspettanouna determinata impostazione dai testi e sono delusi se questo nonrisponde alla ragione per cui ne hanno scelto il consumo.
Un gioco forza particolare per esempio è nella copertinaGiunti di La svergognata dove campeggia la fotografia di una modellacon occhi truccati di scuro, all’orientale, che ammicca con ilvolto parzialmente coperto da un velo. E’ palese che dopol’attentato negli Stati Uniti del 2001 la rivitalizzazione delsimbolo della sottomissione femminile fa vendere anche in Italia;una rivitalizzazione, però, che non corrisponde a quanto vienenarrato nel testo: nel romanzo si denunciano problemi dellacondizione femminile, certo, ma non c’è alcun riferimento alleregole coraniche sull’abbigliamento femminile.
Nei mesi in cui venivano scritte queste pagine è uscita nellesale la versione cinematografica di un romanzo della scrittrice egiornalista palestinese Rula Jebreal, La strada dei fiori di Miral179.Testo che sarebbe stato interessante inserire nell’analisi perché
178 Apter, 2001. 179 Jebreal, 2005.
137
rispetto a molti altri esclusi per ragioni di spazio, a cui frapoco accenneremo, questo si distingue per un registro geuinamemte‘rosa’, è un esempio di letteratura palestinese popolare chepotrebbe essere paragonato ai testi pubblicati nella collanaHarmony dell’editore Mondadori. La scelta di Rizzoli, che lopubblica in Italia, infatti è quella di una confezione di bassolivello, con una copertina che anche qui che richiama il velo, macon un più romantico senso orientalista: la modella della foto ècoperta da un velo attorcigliato nell’immagine classica delbeduino sahariano, senza rimandi al hijab o al chador, cioè ai velidi uso realmente comune nei paesi che aderiscono al precettoislamico del corpo femminile coperto.
In realtà, in questo romanzo, come ne La svergognata, laprospettiva della morale coranica è assolutamente assente: laconfezione quindi è incongruente al contenuto.
Quanto al film, questo è più fedele, semantizza il profilodella protagonista Miral come è nel romanzo: un’ eroina moltooccidentale, con una vocazione all’indipendenza dal poteremaschile e la ricerca della completa autonomia personale.
In questo senso offre forse una nuova possibilità didiffusione commerciale del prodotto, in una confezione più fedelealle intenzioni dell’autrice. Sarebbe interessante seguirel’evoluzione della veste grafica delle prossime edizioni.
Un ultimo aspetto importante, sempre su un continuumeditoriale globalizzato, è la differenza fra mercato italiano emercato inglese. La Gran Bretagna infatti ha avuto un ruolofondamentale nella formazione culturale palestinese, anchelinguistica - Suad Amiry, fra molti, ha studiato in Scozia escrive in inglese. Ed ha una sua responsabilità storica direttanell’oppressione della popolazione palestinese durante ilProtettorato inglese dagli anni Venti al 1948, e poinell’abbandono del destino politico del territorio e dei suoicittadini dopo la proclamazione dello Stato di Israele.
Dal materiale disponibile nella ricerca sociologica,antropologica, letteraria e in genere culturale appare chiaro chementre in Itala la questione palestinese è filtrata dalla visionespecifica del marxismo e interessa soprattutto gli studimarxisti, nel mondo scientifico anglosassone è un campod’indagine privilegiato, su vasto raggio. Anche la quantità ditesti pubblicati sul mercato editoriale cambia: quella britannicaè dieci volte superiore a quella italiana. Infatti bisognaricordare che la traduzione ha dei costi e per poterli sostenerele scelte devono seguire attentamente le richieste del mercato
138
culturale; tradurre un testo inedito che non ha prospettivecommerciali significa ‘sforare’ i bilanci editoriali. Si può direche il mercato britannico è sensibile alla letteraturapalestinese quanto quello italiano – in una proporzione moltominore – lo è piuttosto alla letteratura israeliana.
- I pochi testi disponibili in italiano, comunque, li abbiamodovuti escludere quasi tutti dall’analisi per economia ditrattazione. I testi più importanti per integrare molte tematicheche abbiamo trattato sono: Le stelle di Gerico, della scrittrice,fotografa e regista Liana Badr; Uomini sotto il sole, che è il classicodella letteratura palestinese tradotta a livello internazionale,di Ghassan Kanafani; il cult ironico Il pessottimista, di Emil Habibi;i racconti brevi della prima autrice donna celebre all’estero,Samira Azzam - che con Kanafani appartiene alla generazioneprecedente a quella delle autrici e degli autori che abbiamoconsiderato; il romanzo più esplicito rispetto alla tematicasessuale, Ritratto dal passato, del redattore, documentarista, poeta escrittore Ghassan Zaqtan; infine gli estratti di un romanzo di unautore molto amato fra i palestinesi, Ibrahim Giabra, e iracconti di alcuni altri autori contemporanei molto originali perquanto riguarda lo stile, perlomeno tre: Akram Haniyya, MuhammadAli Taha, Yahya Yakhuf.180
Anche di Khalifa e Amiry abbiamo escluso romanzi importanti:di Amiry il più recente, Murad Murad pubblicato nel 2009, diKhalifa Terra di fichi d’India e La porta della piazza, che come Una primavera difuoco sono storie collettive con molti personaggi, che toccanotemi disparati: la difficoltà di sopravvivere sotto occupazione enei campi profughi, la vita delle donne, il problema dellaresistenza armata, il confronto fra generazioni.
Dunque si deve assumere che le osservazioni proposte sonoirrimediabilmente opache. Questo lavoro non può risolvere nessunageneralità che riguardi la letteratura palestinese. Ma si sperache, in una genuina vocazione semiotica, sia servito a coglierealcuni aspetti e magari a suggerire, segnalare direzioni peranalisi presenti e future.
Vediamone alcune rispetto al progetto del Centro di Studiinterdisciplinare su Memorie e Traumi Culturali dell’Universitàdi Bologna (TRAME) sul case-study del conflitto.
6.3 Il progetto di ricerca sul conflitto mediorientale
180 Tutti i racconti citati sono anche in AA. VV., La terra più amata, del 2002.
139
Il Centro di Studi dell’ateneo bolognese ha avviato nel 2009 unprogetto di ricerca sul conflitto mediorientale.
Sulla pagina web che presenta il progetto sono elencatiaspetti su cui concentrare l’attenzione, strategie d’analisi eobiettivi dell’analisi del contesto memoriale del conflitto araboisraeliano palestinese, con i suoi agenti. Sono interessanti, inparticolare, i tre livelli che il metodo della ricerca dovrebbetoccare: “Il primo è il livello della costruzione discorsiva,perchè ogni testo è sempre esito di una pertinentizzazione e diuno sguardo individuale. Il secondo è quello dei condizionamenti.Ogni testo di una cultura, in particolare quando ne trasmette lamemoria, ne porta segnate forme di manipolazione: ogni testo èmanipolato, attraverso ‘doveri’ di memoria, topiche dellasofferenza, dinamiche di risarcimento memoriale e identitario, inogni testo ci sono delle ideologie. Il terzo è quello del tessutosemantico, per cui sempre in un testo si trovano campi semanticiricorrenti o regolarmente elusi o narcotizzati181”.
Con quello che abbiamo detto abbiamo già toccato moltiaspetti tangenti al progetto del Centro: il problema dellavisione di genere e del rapporto fra esperienza femminile ememoria, quello della riscrittura letteraria di un passato nonancora fissato dalla collettività perché molto recente, l’idea diuna memoria traumatica ma orientata al passato in senso positivo,il modo non aggressivo di rappresentare l’altro. Nello stessotempo però rimangono alcuni punti che sarebbero interessanti persviluppare oltre quest’analisi. Proponiamo cinque direzioni:- Nel progetto si sottolinea l’importanza di un archivio completoche comprenda una rassegna di tutte le forme testuali dellacontemporaneità nel contesto della società israeliana e di quellapalestinese. Allora potrebbe essere interessante confrontare imodi in cui l’ironia e il fantastico utilizzati nella letteraturacome dimensioni entro cui far passare la rappresentazionedell’altro israeliano, si riflettano – o meno – in testiistituzionali, come quelli di telegiornali, quotidiani, riviste,radio, comunicati di associazioni politiche oppure in altri testi‘artistici’, video istallazioni, fotografie, film, testi musicalie teatrali; ma forse, ancora più interessante, il modo in cuipossano ritrovarsi o meno in testi commerciali, come manifestipubblicitari e slogan e campagne di prodotti di consumo: se SuadAmiry può parlare al telefono con “il Presidente Push” si puòvendere un’assicurazione sulla vita in Cisgiordania prendendo ingiro la figura dei bulldozer israeliani?
181 Citiamo da http://www.trame.unibo.it/TRAME/Ricerca/Progetti/trauma_mem.htm.
140
- Per una documentazione esauriente è stato ovvio leggere alcunitesti di letteratura israeliana contemporanea – la controparte diquella che abbiamo esaminato: è stato interessante notare che inun testo recente di David Grossman, A un cerbiatto somiglia il mio amore ein uno di Abraham Yehoshua, Fuoco amico, ci sono sessioni narrativeche gettano luce su un particolare modo israeliano di intenderel’altro, corrispondente a quello che abbiamo detto esistere neitesti delle autrici e degli autori palestinesi in quest’analisi;al contrario, un testo ‘femminile’ come Dolly city, della giovanescrittrice israeliana Orly Castell Bloom, mostra un atteggiamentomolto diverso.Una seconda direzione interessante sarebbe allora il confrontofra immagini dell’altro nella letteratura contemporaneaisraeliana e in quella contemporanea palestinese. - Per quanto riguarda il rapporto fra memoria e oblio possiamopensare alla recente questione della nuova storiografiaisraeliana, cioè di una tendenza culturale emersa da circa undecennio, per cui gli storici israeliani stanno cominciando aripensare parte di una visione originaria che ha motivato i primicinquant’anni della storiografia del nuovo Stato e stannocominciando ad ammettere la presenza di un’impostazionedistorcente nella prima storiografia, una visionemitologica182delle ragioni della fondazione dello Stato. Unproblema particolare ad esempio è quello dell’esodo palestinesedel 48’, rispetto al quale si sta aprendo lo spazio per ilriconoscimento di una strategia di terrore che le forzeisraeliane hanno messo (o avrebbero messo) in atto per indurre lapopolazione araba alla fuga.
Sia Amiry che Natur guardano direttamente a questo problema,proponendo ampie sessioni di memoria che riguardano le azionibelliche israeliane sul territorio in quell’occasione ma anche invari episodi nei vari decenni del conflitto. Come si confronta lacritica letteraria con il progressivo saldarsi di informazioni ditipo storico fra testi finzionali e ufficiali? Questi romanzipotranno mai costituire delle prove indiziarie? In una terzadirezione sarebbe interessante studiare come certi discorsi aconfronto fra arte e informazione possono in caso saldarsi in unapiù generale idea della verità.- Una quarta linea di ricerca in qualche modo collegata a questaviene in mente rispetto a una circostanza specifica. Dal 2008 hapreso il via un’iniziativa patrocinata dall’Unesco e dalla Legaaraba per la Letteratura, per cui hanno visto la luce a
182 Codovini, 2009.
141
Gerusalemme già tre edizioni annuali del Festival Palestinesedella Letteratura. Ad li là delle importanti partecipazioni discrittori europei e palestinesi, fra cui molti di quelli cheabbiamo citato, il punto di interesse è l’azione politica delgoverno israeliano, che ognuna delle tre vigilie del festival hacercato di impedirne la realizzazione, arrivando a sparare sullasede scelta per l’evento e riuscendo ogni volta a costringerel’organizzazione a spostarsi all’ultimo momento in un altroluogo, creando una sorta di clima cospiratorio per un’occasionedi cultura, mondana, del tutto pacifica. Le ragioni del Governoisraeliano sono state “quelle di un inaccettabile coinvolgimentodell’autorità palestinese nell’evento”.
Per una ricerca che guardi alla reale possibilità dellacultura di comunicare aspetti del contesto in cui è prodotta, edi farsi per questo anche strumento politico, un evento delgenere è un punto d’inizio più che prezioso per dimostrare leproprie motivazioni. In questo senso riportiamo due degliarticoli pubblicati in occasione del festival del 2009 da duequotidiani inglesi di orientamento politico simile, ma non
142
identico, il Progressive183 e il Guardian184, suggerendo che c’èmolto da dire anche solo del modo in cui si è disposti aconsiderare la gravità di una situazione del genere. - Con la quinta proposta ci avviamo anche verso il paragrafoconclusivo. Abbiamo citato la scena femminile ‘chiusa’ di Unaprimavera di fuoco come un modello per pensare all’abito di generedell’enunciazione, che in questo caso orienta il tipo dicostruzione discorsiva. C’è una sezione, cioè, in cui l’isotopianarrativa complessiva è sospesa e si apre uno spazio esclusivo,
183 “The Israeli government sent in troops on May 23 to try to break up the opening ofthe second annual Palestine Festival of Literature in East Jerusalem. Stephanie Saldana, an American writer living in Jerusalem, went to the PalestinianNational Theater for what she thought was going to be the opening of the festival.“Wearrived and the place was swarming with the Israeli army, with trucks and huge guns,” shewrote in an e-mail to a friend. “I am still in shock. To ban literature? To ban reading?How is this possible?”The Israeli minister of internal security ordered the busting of the literature festival,according to The Guardian newspaper.“Shortly before the opening event was due to begin, asquad of around a dozen Israeli border police walked into the Palestinian NationalTheater, in East Jerusalem, and ordered it to be closed,” the Guardian reported. “Policebrought a letter from the Israeli minister of internal security which said the eventcould not be held because it was a political activity connected to the PalestinianAuthority.”The Palestine Festival of Literature is supported by UNESCO and the British Council,among others. After they were kicked out of the theater, the speakers and some of theaudience members regrouped at the French cultural center.Egyptian novelist Ahdaf Soueif gave this account at palfest.org: “I saw 10 old friends inthe first minute, all the Jerusalem cultural and academic set were there, a lot ofInternationals, a lot of press,” she wrote. “We stood in the early evening light, by thetables laden with books and food and flowers, nibbled at kofta and borek and laughed andchatted and introduced new friends to old. . . . Then we started moving towards theauditorium and I heard someone say quietly, ‘They’ve come.’“Who? “Looking around – andthere they were, the men in the dark blue fatigues, with pack-type things strapped totheir backs and machine-guns cradled in their arms. I had a moment of unbelief. Surely,even if they were coming to note everything we said and to make a show of strength theystill wouldn’t come with their weapons at the ready like this? But then there were moreof them, and more”.Soeuif described the walk to the French cultural center, and the successful resumption ofthe festival there. “We could have gone on for hours – but we stopped at half past eight.We dispersed; energized, happy, shaking hands, signing books, promising to all meet upagain. Today, my friends, we saw the clearest example of our mission,” she said, invokingthe words of Edward Said. “To confront the culture of power with the power of culture.”The Palestine Festival of Literature, a weeklong celebration, is continuing in variousPalestinian cities. (Palfest brings writers and artists from around the world toPalestinian audiences,” says its website, palfest.org. Along with Soueif, the writers taking part in the festival this year include: Suad Amiry,Victoria Brittain, Carmen Callil, Abdulrazak Gurnah, Suheir Hammad, Nathalie Handal,Jeremy Harding, Rachel Holmes, Robin Yassin-Kassab, Brigid Keenan, Jamal Mahjoub, HenningMankell (accompanied by his wife, Eva Bergman), Deborah Moggach, Claire Messud, MichaelPalin, Alexandra Pringle, Pru Rowlandson, Raja Shehadeh, and M G Vassanji. Though Israel did not succeed in shutting down the entire festival, the use of the armyto try to quash a literary event sent achilling message. “It's another horrific wayIsrael, the so-called democracy, tries to commandeer and bully the spirits of the peoplethey continue to oppress,” says the Palestinian American poet Naomi Shihab Nye. She calls
143
sanzionatorio in base all’identità di genere dei personaggi. Oraperò abbiamo visto che il tema femminile nei testi può assumeremolti registri diversi, e intrecciarsi a quello politico, anzichésospenderlo.
Uno studio esclusivamente di genere rispetto alla memoriadovrebbe, crediamo, approfondire questo punto cercando distabilire come e quali tratti femminili sono messi in scena inuna narrazione sociopolitica. O meglio cosa significhi perl’identità culturale di queste donne intrecciare - o meno –
the bust at the Palestinian National Theater part of a “harrowing campaign of harassmentand humiliation. The next part of that campaign may be a crackdown on anyone who marksIsrael’s Independence Days as a “nakba,” or catastrophe, reports Haaretz. On May 24, Israel’s ministerial committee for legislation “approved a preliminaryproposal which would make it illegal” to hold such protests, the paper said. Those whowould violate it would “face up to three years in prison”. Matthew Rothschild, 25 maggio2009, The Progressive.184 “Armed Israeli police last night tried to halt the opening night of a prominentPalestinian literary festival in Jerusalem when they ordered a Palestinian theatre toclose. The week-long festival, supported by the British council and Unesco, has brought severalhigh-profile international authors – among them Henning Mankell, Michael Palin and AhdafSoueif – on a speaking tour of Jerusalem and the West Bank. Shortly before the openingevent was due to begin, a squad of around a dozen Israeli border police walked into thePalestinian National Theatre, in East Jerusalem, and ordered it to be closed. Policebrought a letter from the Israeli minister of internal security which said the eventcould not be held because it was a political activity connected to the PalestinianAuthority. Members of the audience and the eight speakers were ordered to leave, but the event washeld several minutes later, on a smaller scale, in the garden of the nearby FrenchCultural Centre. Israeli police were deployed on the street outside. "We're so taken aback. It's is completely, completely independent," Egyptian novelistSoueif, who is chairing the Palestine Festival of Literature, said. "I think it's verytelling," she told the crowd at the French centre. "Our motto, which is taken from thelate Edward Said, is to pit the power of culture against the culture of power." Israel regularly prevents political Palestinian events in East Jerusalem, but hasrecently also started to clamp down on cultural events in an apparent attempt to extendcontrol over the city. The development comes at a time of growing international concernover the Israeli government's demolition of Palestinian homes and the continued growth ofJewish settlements in East Jerusalem. In March, the Israeli authorities banned a series of Palestinian cultural events inJerusalem, including a children's march, intended to mark the Arab League's designationof Jerusalem as the capital of Arab culture for this year. Israel said the eventsbreached its ban on Palestinian political activity. Earlier this month, Israeli policeclosed down a Palestinian press centre that had been established in East Jerusalem forthe visit of Pope Benedict XVI. Israel captured East Jerusalem in the 1967 war and later annexed it – a move notrecognised by the international community. Mankell, a Swedish crime novelist, told the crowd at Saturday's event: "Don't lose hope."He compared the raid to life in South Africa under apartheid and added: "What reallymakes us human beings is our capacity for dialogue. "The only way we can save ourselvesfinally in the end is the capacity for making dialogue with each other." The festival will stage events in the West Bank cities of Ramallah, Bethlehem, Hebron andJenin this week before returning to the same Palestinian theatre in East Jerusalem onThursday night for a final event, although that also appears at risk of being closed.
144
tematiche di genere con la questione complessiva della vitaquotidiana sotto l’occupazione. Ci sono dei limiti? Ci sonoaspetti che amplificano il potere femminile sovrapponendo questedue problematiche? In questo senso abbiamo già visto che lescelte di Amiry e Khalifa sono molto diverse, all’ultima domandala scelta di Amiry sembra rispondere di sì, mentre quella diKhalifa, di no.
Chiudiamo quest’analisi approfondendo due elementi chepossono essere considerati con un valore di segno oppostorispetto alla femminilità palestinese: l’enunciazione segnata dalgenere e la memoria sociale dal punto di vista di agentifemminili.
6.4 Questioni aperte: l’onore e i ruoli di genere
Sottolineiamo che queste ultime osservazioni sono motivatedalla lettura anche di quei testi di altri autori e autrici che èstato impossibile includere per ragioni di sintesi. Comeancoraggio testuale fra quelli che invece costituiscono il nostrocorpus possiamo guardare anche a un confronto fra gli ultimi treestratti in Appendice, il numero nove, dieci e undici, e uno acui abbiamo già accennato, il quarto. I primi due sono parti deltesto di Nasrallah, che hanno un tema sessuale esplicito.L’ultimo è un passaggio di Una primavera di fuoco in cui ladescrizione degli agenti del conflitto e del loro destino passaattraverso una lunga e complessa metafora gastronomica. Il quartoestratto è la scena di Niente sesso in città in cui la situazione difasto e allegria di una riunione familiare in occasione di unmatrimonio si trasforma nell’annuncio di un dramma.
Ritorniamo sul tessuto semantico dei testi di Amiry e Khalifaconsiderando le tracce delle pratiche sociali che sottendono, conun approccio simile a quello di Lotman nel caso dei decabristi185.
Micky Rosenfeld, an Israeli police spokesman, said the event was closed down becauseIsrael believed it was organised or funded by the Palestinian Authority. Rosenfeld said asigned order had been handed over by police. "This is the policy being implemented withregard to any events which are either organised or funded by the Palestinian Authority inJerusalem," he said. He added that previous Palestinian events in the city, including thepress centre for the pope, had been closed under the same policy. However, Rafiq Husseini, the chief of staff to the Palestinian president, Mahmoud Abbas,who was in last night's audience, was dismissive of the Israeli actions. "It shows howthe Israelis are not thinking, he said. "This is a cultural event. There is no terrorism,there is nobody shooting. It's just a cultural event."They are creating enemies forthemselves"”. Rory McCarthy, 24 maggio 2009, Jerusalem Guardian.185 Nello storico Tipologia della cultura Lotman esaminava un corpus di testi scritti daintellettuali decabristi. Rilevava un comportamento distintivo, per il quale i decabristitraducevano nella realtà il codice del romanticismo nell’arte. “Ogni catena di azionidiventava ‘testo’ se la si poteva collegare in modo illuminante con un determinato
145
Alla base c’è l’osservazione fondamentale di Ruba Salih, sulfatto che “mentre nella maggior parte delle Costituzioni degliStati occidentali l’unità base della società è l’individuo, nellesocietà mediorientali le Costituzioni identificano come unità lafamiglia. Ne segue che parlare di individualità in questicontesti sociali è una forzatura, bisogna semmai pensare aun’idea di cittadino come attore sociale che si muove a partireda un sé interconnesso186”.
Nei romanzi analizzati questo elemento si rileva confacilità, già a livello superficiale, nei processi diattorializzazione. C’è un’attenzione particolare alle figure chepopolano la quotidianità pubblica: non solo familiari, parenti evicini, ma venditori, Immam, contadini, fedayin, vedove,adulteri, cantanti, politici. E oltre, anche per figure spazialicome strade, piazze, kasbah, palazzi, scale e porte.
Isotopie attoriali che rimandano a un suggerimentointeressante di Bertrand a proposito di un “orizzontedossologico187”: commentando un racconto di Michaux188 in cui unaserie di elementi - /la città/, /i turisti/ - compaiono in serie,Bertrand parla di cornici che delineano “l’agire stereotipatodell’attore sociale”. Il soggetto sociale inserito nei programmidell’uso conosce la sua lezione, o con le parole di Coquet: “è unafigura di non-soggetto”.
Significativamente, come una sorta di promemoria identitario,in tutti e sei i romanzi torna la figura dei vicini: attraverso ivicini il sé, esteso alla propria famiglia, è soggetto allasanzione sociale.
Dato che anche nella costruzione discorsiva si ritrova unacollocazione della soggettività protesa verso l’esterno,un’individualità che di frequente sconfina nell’altro, viene dapensare che le implicazioni di una struttura sociale come questavanno molto in profondità.
Suggeriamo l’idea che nella cultura palestinese questomeccanismo di sanzione attivo a livello sociale si basisull’onore: pensiamo che le costruzioni enunciazionali di Khalifae Amiry siano modi diversi di elaborare un’identità femminilecircoscritta da confini sistematici, quelli di una vastastruttura soggiacente basata sul codice dell’onore.
soggetto letterario.” È in questo senso, secondo Lotman, che la semiotica può studiare lacorrelazione tra diversi sistemi segnici 186 Salih, 2008, p. 80 - 81.187 Bertrand, 2002, p. 155.188 Michaux, 1967, p. 143.
146
Nel 2007 un’antropologa dell’università dell’Oregon, DianeBaxter, ha pubblicato uno studio proprio su questo argomento.Nella società palestinese, dice Baxter: “più che un codice, cheimplica un sistema di regole e norme, l’onore è un’ideologia avasto raggio, dinamica e variamente articolata, che riguarda il‘modo giusto di vivere189’”. Ci sono implicazioni importanti perla costruzione del genere sessuale, nei ruoli del maschile e delfemminile come agenti primari di un intero sistema di senso.
E’ generalmente condiviso che questa dinamica converge sullasessualità femminile: l’onore è il riconoscimento maturato daimembri maschili di una famiglia nella quale le donne hanno unacondotta sessuale appropriata; ma la ricerca sociologica,sostiene Baxter, mentre teorizzava correttamente un concetto comequello di contratto patriarcale, per il quale donne e uominicollaborano nel mantenimento del sistema di genere adeguandosirispettivamente a precise attese performative, tendeva asottolineare i condizionamenti del femminile e a tralasciare quelli delmaschile.
Così osserva Baxter, si è privilegiata la coerenza rispettoalla dimensione dell’indefinito e all’ambivalente, strutturandola categoria della sottomissione femminile; il quadro culturalecioè di società costruite sullo squilibrio della dominazionemaschile, in cui si assume che gli elementi legati all’onore – lasegregazione sessuale, il velo, i matrimoni combinati – sianovissuti dalle donne come costrittivi e sminuenti.
Baxter invece vuole spostare il punto e affermare che almenola realtà palestinese è più complessa: le cose non stanno così,non c’è un dramma maschile dell’onore, in cui le donne,nonostante la centralità del loro comportamento sessuale, “sonocome attori che abbiano ottenuto una piccola parte”.
Per prima cosa, nell’ordine di una saldatura fra leosservazioni di Baxter e un’analisi semiotica, è fondamentalel’accento posto sul carattere fluido, anziché fisso, dell’ideologiadell’onore. Ci sono tutti i mutamenti storici, politici edeconomici che accelerano e rallentano le trasformazionisocioculturali , quando non le causano direttamente:l’immigrazione ebraica, la guerra del 1948, l’allontanamento deipalestinesi dalle case e dal territorio, l’amministrazione dellaWest Bank da parte della Giordania - fino al 1967 ; tutti questieventi hanno toccato tutti gli aspetti della vita palestinese.Gli abitanti della West Bank e di Gaza con la guerra del 1967 ela successiva occupazione israeliana hanno visto un altro trauma
189 Baxter, 2007.
147
sommarsi ai già enormi cambiamenti in atto. I palestinesi hannodovuto riallineare la loro identità e nello stesso tempo lottarecontro certi aspetti di questa e resistere per preservarne altridi quella precedente: alcuni aspetti della pratica dell’onore hannoperso valore, altri hanno acquistato salienza e i requisiti delmaschile e del femminile sono divenuti fluttuanti. Fra iricercatori che lavorano in questo senso Massad, a cui abbiamofatto riferimento e Holt190, che segnala una crisi della mascolinità,perche i palestinesi sentono di essere del tutto vulnerabili difronte agli israeliani.
Baxter riflette sulla possibilità di una definizione: èimpossibile rendere un’idea di onore valida per tutti ipalestinesi; tuttavia ci sono elementi che sembrano condivisidalla maggioranza: “l’onore non è qualcosa come un cappello, chesi toglie e si mette, anche se i requisiti e le nuances sonoinfluenzate dalla classe sociale, dal livello di educazione, dalcontesto di vita - città, villaggio, o campo profughi –l’ideologia dell’onore è un modo di vivere, una guida, e ingenerale, quasi per tutti, un confort”.
La misura nell’abbigliamento e nel comportamento, laverginità fino al matrimonio e la monogamia, intesa in senso di‘fedeltà’, sono elementi che la maggior parte delle donne e degliuomini palestinesi giudicano importanti. Per esempio per lacondotta sessuale nella vita quotidiana di una donna flirtare èdisapprovato a livello generale; le visite di donne a uomini concui non hanno parentela sono normali solo se ci sono altri adultipresenti; gli appuntamenti in una fase iniziale del rapporto fraun uomo e una donna sono immaginati un po’ da tutti con lapresenza di qualche membro della famiglia di lei. Le donne chevivono praticando questi valori e seguendo queste abitudini dicondotta ricevono rispetto, credibilità e onore per loro stesse eper i loro familiari maschi.
Ora, sostiene Baxter, il punto è che cosa accade agli uomini,quando le donne non hanno una condotta onorevole. Una donna può atutti gli effetti provocare la rovina della sua famiglia con uncomportamento vergognoso, una rovina che riguarda la stimasociale, ma anche un’eventuale posizione politica o lo statuseconomico. E’ molto comune per esempio che rispetto ad unaattività commerciale, a qualsiasi livello della scala sociale ein qualsiasi tipo contesto abitativo, il gestore di un’attivitàche trovi danneggiata la reputazione delle donne della sua
190 Holt, in Tessler, 1997.
148
famiglia debba contemplare il fallimento economico comeprospettiva certa.
Se questa può essere considerata un’implicazione cheinteressa a livello generale qualsiasi società basatasull’importanza della condotta sessuale femminile, Baxterindividua la specificità della cultura palestinese rispetto alcodice dell’onore per il fatto che non è uno strumento di potere,ma si costituisce come rete di responsabilità dei familiari maschirispetto alle donne, come un codice che crea un rapportospecifico fra fratelli e sorelle. L’antropologa analizza alcunicasi molto diversi fra loro, nei quali un fratello è intervenutoa proteggere l’onore di una sorella in difficoltà a livellosocioeconomico, o in cui la ha seguita in una fase ditrasformazione importante della sua vita o in cui si è occupato alivello economico dei sui figli, orfani del padre, per garantirleil diritto al privilegio di non lavorare fuori casa. I casi citatiriguardano una madre che lavora come agente assicurativo e vivein un campo profughi, la direttrice di un liceo di Nablus, duecasalinghe di estrazione sociale elevata, una parrucchiera di unvillaggio.
Il punto dell’onore palestinese secondo Baxter non è neicondizionamenti che procura alla psicologia femminile: le donneseguono il loro senso di Il Ana 191- individualità, responsabilitàmorale personale - nell’organizzare le proprie scelte rispettoalle conseguenze per i propri familiari della loro condottasessuale.
Le donne sono soggetti secondari della scomunica che segueuna condotta disonorevole; questa è considerata una conseguenzadiretta dell’incapacità degli uomini, (fratelli prima che padri)a far valere la loro autorevolezza, ma soprattutto il fallimentodel loro ruolo di accudimento e sostegno delle donne. L’analisipassa per una lunga sessione di interviste femminili che per
191 Baxter ripensa l’idea del sé interconnesso, a livello sociale, introducendo ilconcetto di Il Ana. Con questo l’Islam appronterebbe già una dimensione di radicale moralità dell’individuo,che deve, da solo, come persona, essere giudicabile di fronte a Dio. Ma oltre il precettocoranico, sostiene Baxter, l’ Il Ana sfuma in un’idea di individualismo sociale, che oggiè una componente importante della vita palestinese anche per i palestinesi non religiosi.Una forma di dignità delle proprie azioni che diventa rilevante, in particolare, da quandol’occupazione ha posto pesanti limiti alla possibilità di provare orgoglio rispetto allagestione dei propri beni e della propria condizione di benessere e libertà. Con le paroledi Baxter: “while the social, connected, traditional, has to come to representPalestinian selfhood and the outside “modern” (rational, egocentered, freedom-loving) isimagined as uplifting, imposing on, or destroyng it, Il Ana , as separate from the familyor others social bodies, has a long history in Middle East, rather than being a recentmodernist/capitalist imposition”.
149
ragioni di spazio non possiamo riportare – con la conseguenteconsapevolezza che non si coglie la completezza e la complessitàdella tesi dell’antropologa – in cui cerca di spiegare come ledonne concepiscono questa struttura relazionale.
Baxter conclude arrivando a sovvertire, per il casopalestinese, il modo in cui molti studiosi concepiscono irapporti di genere in società segregate per sesso e incardinatesul valore della condotta femminile. Secondo lei il sistemadell’onore in questo caso produce uno spazio particolare,provvede una libertà delle donne come agenti sociali con unpotere superiore a quello degli uomini. Spazio che valuta doppiorispetto a quello maschile, nella consapevolezza di essere ingrado di condizionare una vasta serie di aspetti e la vita di piùpersone, con la loro condotta.
Naturalmente, sottolinea, questo non riguarda tutte le donne,ma solo quelle che identificano come esistenza desiderabilequella condotta all’interno della cornice normativa dell’onore192.
Ritorniamo alla società palestinese e all’onore femminile neitesti che abbiamo considerato: in diversi momenti narrativi itesti restituiscono elementi che non possiamo non connettere conl’analisi della Baxter. In particolare questo vale per la loroposizione enunciativa. Lo spazio narrativo di Amiry, ma anchequello di Khalifa, sembra condizionato da questa regolazionesociale: gli autori uomini sono voci narranti assimilabili aquelle di narratori occidentali, per il tratto postmoderno dellafine delle certezze, del relativismo etico, per il modo diosservare in solitudine una realtà essenziale, scarnificata, inuna prospettiva per molti aspetti autoreferenziale.
Invece le autrici hanno un tratto insieme composto ecomposito; niente nei testi, pur molto diversi fra loro, di Amirye Khalifa, è mai fuori contesto. Anche La svergognata, il testo più
192 Una delle interviste riguarda una ventinovenne che vive in un villaggio vicino aBetlemme con cui – come con le altre intervistate – Baxter trascorre alcuni mesi. Lastoria di Nadia è il caso di una deviazione dal codice, per il desiderio di un’autonomiafuori dagli schemi dell’onore. Dopo due divorzi, Nadia è stata aiutata dalla famiglia delfratello, che ha costruito per lei una casa vicina alla loro, per aiutarla con i trefigli piccoli e permetterle così di continuare a lavorare. La sua reputazione, però, èfortemente compromessa dal fatto che non trascorre con loro il suo tempo libero, e cosìnon onora con la sua dedizione le cure ricevute dal fratello; Nadia spesso passa lagiornata a Gerusalemme, a fare shopping o in visita da amici e torna la sera tardi. Nadiaspiega a Baxter che “si sente soffocare, che vorrebbe essere libera dal controllo dellafamiglia del fratello e che a Gerusalemme cerca un buon marito”. Un nuovo matrimonio lesembra la sola alternativa plausibile: l’idea di vivere sola con i bambini non èrealistica perché sono troppo piccoli. Baxter sottolinea che anche in questo casol’attenzione degli abitanti del villaggio si focalizza sull’inadeguatezza dei fratelli diNadia. L’affermazione comune è: “perché non sono stati in grado di guidarla?”.
150
eccentrico rispetto alla dimensione socio familiare, rientra indei confini precisi rispetto alla censura della sessualità, comediremo nell’ultimo paragrafo.
Quella delle autrici è un’osservazione affacciata su ununiverso sociale: le donne stanno dentro una trama culturale tanto quanto lascrittura letteraria maschile è quella di singoli individui.
6.4.1 Tracce di stile: lo sguardo strabico e l’ornamentoAbbiamo trattato questo aspetto solo qui, in chiusura, perché sispera sia evidente che comporta una complessità che non siamo ingrado di affrontare, rispetto ai testi, nello spazio e con lerisorse concettuali e informative di quest’ analisi. Questo perònon impedisce di fare alcune osservazioni essenziali. Per esempioa livello tematico nei romanzi si descrivono aspetti diun’organizzazione sociale basata sulla condotta femminile: omeglio, questo succede nei testi di Khalifa e Amiry, perché Nature Nasrallah non discutono mai di problemi che riguardano ledonne.
Questo aspetto è già un riflesso della segregazione socialeper generi: la scena femminile di Una primavera di fuoco, che abbiamovisto nel terzo capitolo, ne illustra una forma realizzata nellapratica; abbiamo anche sostenuto che in quel passaggio narrativoci fosse un posizionamento di genere dell’istanzadell’enunciazione, ovvero che Khalifa mostrasse un gustoparticolare nella narrazione di un tema ‘rosa’.
Se questi testi scritti da donne trattano anche tematiche femminili, andandooltre ci poniamo la domanda di come dicano cose che non sono solo didonne.
Citiamo una riflessione di Agnes Cardinal che analizza uncorpus di testi memoriali della Prima Guerra mondiale, scritti daautrici. Le considerazioni della studiosa legano una certastranezza che risulta nelle costruzioni discorsive femminilirispetto a temi tradizionalmente oggetto di testi maschili. Oranel caso palestinese non c’è certo una tradizione di razionalismofilosofico a cui le donne possano o vogliano opporsi; peròCardinal si lega a un’idea interessante, quella di uno stile digenere nella scrittura femminile, mutuando dalla tedesca SiegridWeigel il concetto di squirting gaze, sguardo strabico. ConCardinal: “a women who writes, Weigeil argues, tends toaccomodate two points of view at once: that of the patriarchalsimbolic order and that of the authentic female vision. Moreoften than not this brings about literary products which are
151
strangely destabilized and destabilizing193”. Un elemento cheunisce Niente sesso in città, Sharon e mia suocera e Una primavera di fuoco èproprio la doppiezza di sguardo: il tenere insieme costantementela realtà del conflitto e l’esperienza di un soggetto definito –e anche segregato per genere. L’enunciazione testuale sfrutta dicontinuo questa ‘prospettiva strabica’ e la testimonianza ne èarricchita.
Consideriamo l’ultimo estratto: il numero undici, da Unaprimavera di fuoco. Qui la situazione storica e politica è descrittacon una “insalata mista”. La riflessione è di Umm Su’ad, la madredi Suad e la benefattrice del quartiere di Nablus assediato. Laframmentazione geografica dei Territori occupati e la complessacomposizione sociale della popolazione originano una serie dimetafore ridondanti, nella costruzione discorsiva di uno sguardoche sale sempre più in alto: dal colore delle maniche di una camicia,alla camicia senza bottoni, alle chiazze su una cartina; dalleverdure dell’insalata alla cassetta, alla cassetta venduta; dal“miscuglio” fra contadini e intellettuali, al miscuglio frapalestinesi ed ebrei; al miscuglio fra ebrei americani, europei eafricani; fino al tropo unificante di natura gastronomica dellaciotola mastodontica in cui cuoce la minestra di un orco. E’quello strabismo della scrittura femminile che origina una formacosì originale: uno strabismo gastronomico-politico?
Consideriamo anche il quarto estratto, il passaggio di Nientesesso in città in cui Fadia è riunita con la famiglia in Giordania ei preparativi per la cerimonia delle nozze sono interrotti dallanotizia dell’attentato terroristico. Anche qui c’è una spiccataridondanza semantica, questa volta attorno al tema del lusso:Amiry descrive il fratello, il suo stile di vita e gli oggettiche compongono la scena con uno stesso gusto, un po’ infantile,dell’opulenza e del bello. Spicca la scelta narrativadell’attenzione per gli orpelli, per ciò che è in più, per ildettaglio. Tutto il testo di Niente sesso in città presenta questaricchezza sul livello linguistico. E se con un’ipotesi certamenteun po’ forte pensassimo che il ruolo delle donne di cui parlavaBaxter passa anche un certo modo enunciazionale, per un punto divista più ampio, quello di un agente con più potere?
Nel 2006 Mondadori ha pubblicato una raccolta di raccontiscritti da più di trenta autrici diverse, tutte arabe e tuttecontemporanee, e quasi tutte di area mediorientale. Nellapostfazione la libanese Joumana Haddad, giornalista enarratrice esordiente, riflette: “il nostro è un linguaggio
193 Cardinal, in Fortunati, 2003, p. 234.
152
ancora vergine, in fieri, e non interamente esplorato dallescrittrici arabe (al contrario degli scrittori che ne hannoesplorato a fondo tutte le varianti), ma promette dellenovità, perché offre ai lettori l’altro punto di vista: quellodella donna. Noi abbiamo la possibilità di violare, ditrasgredire, gli uomini no194”.
A cosa si riferisce Haddad? A uno spazio femminilespecifico in società basate sull’onore femminile e segregateper sesso? O lo stile di Khalifa e Amiry dipende da unaspecifica libertà palestinese che in altri contesti non c’è? Oancora si tratta di una vitalistica bravura delle autrici insé che non ha nessun legame con la cultura palestinese? Lospazio di un’analisi generale come la nostra non ci permettedi approfondire; ma l’ultima delle tre sembra un’ipotesiimprobabile.
6.4.2 Oblio, memoria e sesso
Se osiamo seguire il filo di queste domande c’è un ultimo aspettoa cui accennare e che dovrebbe interessare da vicino una ricercadelle forme di memoria collettiva.
Rispetto all’idea di Baxter ricordiamo che nel terzo capitoloabbiamo definito diverse le posizioni delle due autrici in fattodi denuncia o meno della condizione femminile: mentre Khalifa èmolto critica rispetto all’idea di una condotta sessualefemminile sanzionata dalla società, Amiry non considera ilproblema direttamente e lo lega semmai alla difficile situazionedell’occupazione o – in certi passaggi – a un problema didiseducazione di certe fasce sociali.
La differenza fra le due posizioni sparisce su un tema che èlegato a una condotta rispettosa dell’onore femminile di cuiparla Baxter: nei testi di entrambe c’è una completa censurarispetto al sesso. Questo ci sembra un vero tratto unificante nonsolo fra Khalifa e Amiry ma in comune anche con altre scrittricipalestinesi rispetto agli autori uomini.
Consideriamo gli estratti numero nove e numero dieci, entrambi tratti da Dentro la notte: con il riferimento prima e la descrizione poi di un rapporto sessuale, Nasrallah fa qualcosa che Amiry e Khalifa non possono affatto fare. Peraltro il riferimento alla vita sessuale dei genitori anziani infrange in modo sorprendente un tabù della nostra società e sarebbe
194 Colombo, a cura di, 2005, p. 266.
153
interessante riconnettere questo elemento con quello infantile dicui abbiamo parlato nel quarto capitolo.
Nei pochi casi in cui nei testi si tocca il tema sessuale leautrici si comportano in modi differenti: mentre Khalifa vira suuna vaga descrizione romantica, Amiry ironizza sul dato socialestesso della censura. Il tono audace di Niente sesso in città, basatosu una metafora ormonale femminile probabilmente apre laconcessione a una pagina limite come quella in cui un’amica diSuad scopre che cosa sia l’omosessualità: anche qui con ironiaAmiry porta la questione sul candore della bambina, che chiede alpadre se Dio sia gay.
La soluzione facile con cui l’autrice affronta il tema sembrasolo confermare che i versanti censurati sono naturalmente tuttiquelli legati alla sessualità: quella omosessuale, quellaeterosessuale, il fatto sociale della prostituzione e il drammadello stupro. Rispetto a questo anche l’altro autore, Natur, hauno spazio di libertà che manca completamente nel caso delleautrici: Natur parla più volte di episodi di aggressioni inglesie di soldati siriani in rapporto al terrore delle donne di unaritorsione sessuale da parte degli aggressori.
Su questo punto, sulla narrabilità della violenza sulledonne, l’assenza tematica ci richiama a una questione centraleper lo studio della memoria collettiva. Parliamo di un grupposociale che vive in condizione estreme, anche a livello dellaviolenza sociale e la possibilità di testimoniare la sofferenzaattraverso la letteratura è stata proprio una delle ragioni concui abbiamo iniziato quest’analisi.
Come si confronta la ricerca di forme di memoria collettivecon l’omissione sociale di un problema come quello della violenzasessuale?
Non si tratta solo di confini blindati fra privato ecollettivo; la censura riguarda alche il sesso sul piano delfenomeno sociale; su quel piano quindi su cui si svolge lamaggior parte della riflessione che riguarda il dolore e iltrauma della collettività.
Che cosa ne facciamo, in uno studio sulla memoria di ungruppo, di un problema di oblio che riguarda il collettivo?
154
AppendiceEstratti
Estratto 1. Sharon e mia suocera. Pagina 110 - 111.-----------------------------------------------------------------
Ho preso due cubetti di ghiaccio e sono tornata a letto. Nell’istante incui ho chiuso gli occhi tamponandoli con il ghiaccio le immaginidell’ultimo viaggio di mio padre alla sua casa di Jaffa hanno cominciatoa scorrermi davanti.Ricordavo la sua sofferenza e la sua depressione quando, nel 1968, eraandato a Jaffa a visitare la casa. L’aveva presa malissimo. Doveva esserestata molto dura, e ora so che cosa avesse voluto dire veramente:
“Mi sono sentito ferito, arrabbiato, frustrato, furibondo, che altroposso dire, quando la famiglia ebrea che vive nella casa non mi ha fattoentrare. Si sono così spaventati quando mi hanno visto davanti allanostra/loro casa. Mi hanno semplicemente chiuso la porta in faccia e sene sono andati. Non hanno risposto ai miei disperati tentativi dirichiamare la loro attenzione bussando di nuovo alla porta. Speravo chela riaprissero, per poter spiegare loro che volevo semplicemente visitarela casa, provare a rinfrescare i miei ricordi, ero curioso di vedere se inostri mobili o una parte dei nostri mobili erano ancora lì. La cosa chemi mancava di più erano i libri nella biblioteca. Non avevo intenzione diprendere niente. Anche se avessi voluto, sapevo molto bene che loro nonme l’avrebbero consentito. Non avevo in programma di fare una scenata,perché sul piano emotivo non me la potevo permettere. Era da un mese che,in previsione di quella visita, mi esercitavo a tenere a freno leemozioni e, ancor di più, le mie reazioni. Le emozioni o le reazioninormali non erano consentite. Tutto doveva essere assolutamente sottocontrollo”.
A questo punto, più che parlare con noi, sembrava che mio padre stesseborbottando fra sé e sé.
“Pensavo che la sola cosa che mi sarei concesso di fare, una volta che miavessero lasciato entrare in casa, sarebbe stato di chiedere lafotografia di mia madre, sempre che fosse ancora appesa al suo posto”
Mio padre aveva fatto una lunga pausa e poi, cambiando tono, avevaaggiunto:
“A vostra madre quella foto non è mai piaciuta. Le dava noia che sulnostro letto matrimoniale ci fosse la fotografia di mia madre, non lasua. Io ce l’avevo messa prima che ci sposassimo e per me era piuttostodifficile toglierla o sostituirla”
Mentre mio padre sprofondava nella poltrona, i suoi occhietti penetrantierano andati lentamente scomparendo. Con il palmo scuro e rugoso dellemani si era coperto la parte inferiore del viso segnato da una sorta distordimento.
155
Dopo un minuto o due, con una risata forte e nervosa e occhi lucidi egonfi di lacrime, aveva aggiunto: “Comunque, non essere ammesso nellanostra casa di Jaffa mi ha salvato dalla reazione di vostra madre”.
La storia non poteva che chiudersi con una nota di follia, mi dicevo!
Stava così male che si era dovuto mettere a letto. Per giorni e giorninessuno era riuscito a rivolgergli la parola.
Estratto 2. Sharon e mia suocera. Se questa è vita. Pagina 278 – 279.-------------------------------------------------------------------------------------
“Si, ci piacerebbe molto visitare lo zoo” rispondiamo Leila ed io conentusiasmo.Sappiamo entrambe che Kalkilya è sotto molti punti di vista una cittàaperta e all’avanguardia (il sindaco arabo di Kalkilya e il sindaco dellavicina città israeliana di Kfar Saba, membro del partito Meretz, hannofirmato un gemellaggio tra i loro comuni; gli israeliani progressisti diKfar Saba hanno inviato al governo Sharon una petizione, chiedendo che ilmuro sia eretto in territorio ebraico), ma addirittura uno zoo? Questo sìche è un progetto pilota!Il nostro giro dello zoo inizia da una deliziosa giraffa bambinatrasportata via mare dal Sud Africa. Mi chiedo se sia un donodell’African National Congress al popolo palestinese. A differenza ditutti gli altri animali dello zoo di Kalkilya, la baby-giraffa ha l’ariadi essere del tutto ambivalente riguardo alla situazione politica, forseperché riesce a vedere al di là del muro di separazione.
Vicino alla giraffa, su una piattaforma di cemento al centro di unaminuscola gabbia di filo spinato, c’è un’anziana e superba leonessa. Ciinformano con discrezione che ha perso da poco il suo beneamato marito.Non faccio in tempo ad accostarmi e a rivolgerle qualche parola dicondoglianza, che mi guarda dritta negli occhi e dice: “Adesso sai che cosa significa vivere in gabbia, isolata e tagliata fuoridal tuo ambiente naturale”.“Lo so, sono davvero dispiaciuta, ti dobbiamo delle scuse”.“Non ti preoccupare, sono gli israeliani che devono molte scuse a tutte edue” aggiunge la leonessa.Ci abbracciamo tra le lacrime.
Estratto 3. Niente sesso in città. Pagina 138.---------------------------------------------------
Tutte le spose potenziali erano sedute una accanto all’altra. Fu la mammaa prendere per mano l’adolescente Warda e a trascinarla nel centro dellastanza (la pista da ballo), dove tutte la pregarono di danzare. Una voltain più, in un battibaleno la ragazzina si trasformò in una seducentedanzatrice del ventre. Mentre le donne battevano le mani e seguivano lamusica cantando, la madre di Warda si sfilò la sciarpa elegante e laannodò attorno alle anche della figlia, facendone risaltare in tal modo imovimenti dell’addome. Dopo cinque minuti, Warda si interruppe e attirò
156
in mezzo alla pista la sua amica Ghada. Poi fu il turno di Zhara, Flora,Huda e di tutte le altre, finchè il mio non fu completamente dimenticato.Se la danza per la selezione delle spose durò una mezz’ora, il ballodelle donne più anziane durò almeno tre volte tanto. Al momento del caffèfinale, ogni ragazzina servì la propria “suocera” potenziale, mentre lamamma ed io servimmo le altre.
Una settimana o due dopo, Warda, Zhara,Ghada e Huda erano ufficialmentefidanzate.Volarono nel loro nido dorato, mentre io atterravo in America perprendere una laurea in ingegneria.
Estratto 4. Niente sesso in città. Pagina 155 – 156.----------------------------------------------------------
Mi accorsi che mio fratello ci stava osservando tutti e cinque conimpazienza. Sua moglie Jasmin, io, le sue due incantevoli figlieadolescenti, e seppur in grado minore, suo figlio Muneer, ce ne stavamolì fermi a scambiarci commenti carichi di reciproca ammirazione. Rais,che in Giordania era un personaggio politico di primo piano, dovevaspesso mediare tra i due mondi in conflitto nei quali viveva; il lussodella sua vita privata e l’austerità della sua vita pubblica in un paesecome la Giordania.
Attraversando di corsa l’atrio per rispondere al telefono sistemato sulripiano di una splendente vetrina breakfront nera, Yasmin quasi inciampònell’abito da sera. “Ciao, Hyam..” fu la sola cosa che riuscì a dire, poiammutolì e diventò bianca come un cencio. Sebbene fossimo a qualche metroda lei, udimmo distintamente le grida della sua carissima amica Hyam. Losguardo remoto di Yasmin, il viso privo di espressione, nonché latensione immediata del corpo ci fecero capire che doveva essere successoqualcosa di terribile.
“D’accordo, d’accordo, Hyam..habibti, lo dico a Rais e veniamo subito…Dimmisolo dove ti trovi in questo momento, in quale ospedale”.“Oh, no…ho la sensazione che Mustafa al-‘Aqqad abbia avuto uninfarto,”disse Rais con un sospiro. Mustafa al-‘Aqqad, famoso cineastasiriano, e sua moglie Hyam erano arrivati da Los Angeles il giorno prima,apposta per le nozze. Mentre Rais chiedeva a Yasmin di passargli ilricevitore, squillò il suo cellulare.“Pronto…sì…si…Dio…Oh, no…Radisson Sass…Sheraton…Oh, mio Dio…hai dettoanche all’Hyatt Regency? Ma i nostri ospiti sono tutti lì…nell’atrio, inattesa che passino a prenderli…Oh, Dio.”
Estratto 5. La svergognata. Pagina 48 - 49.--------------------------------------------------
Per quella ragione, quando nacqui, non levarono lodi di ringraziamento enon implorarono le benedizioni di Dio. Ero stata privata della polvere dirame e delle perline azzurre*. Per questo non venni colpita dalmalocchio, neanche una volta. Non mi toccarono incantesimi, sale eturibolo. Ero invidiosa? Certo che lo ero. E lo sono ancora. A chi di noi
157
non piacerebbe pisciare profumo? E visto che questa voglia non sirealizzò, divenni invidiosa. Le perline azzurre allora si sparpagliarono,e le loro spalle si curvarono sotto il peso; si piegarono sempre di più ela mia invidia aumentò. Ma non riuscii a colpirli col malocchio perché datempo ero stata avvilita e umiliata. Più si curvavano, più aumentava laloro voglia di vomitare. Mi vomitarono addosso e non rimase nulla in meche non venisse utilizzato come pretesto per vomitare. Mi vomitavano sututto il corpo, la testa, la schiena, lo stomaco, il sorriso, la mialeggerezza, la mia svergognatezza e i miei crimini. Diventai unacriminale senza crimini.
* E’ costume appuntare sull’abito del neonato maschio una perlina azzurra, per proteggerlodal malocchio. Le femmine in genere non vengono colpite dal malocchio. Chi si trova inposizione di inferiorità, o tale viene considerato, non può colpire con il malocchio.(N.d.r.)
Estratto 6. Una primavera di fuoco. Pagina 325 – 326.---------------------------------------------------------------
Una contadina si percosse il viso con il palmo della mano urlando: “Gliulivi! Povera me, povera Subhiyya, che schifo di vita!”. Un soldato laspinse lontano dall’albero. Arrivò una ruspa che lo sradicò, estirpò finoall’ultima radice. Le ruspe sono come dinosauri, hanno fauci di balenache inghiottono gli alberi, le pietre, le rocce e il ventre della terra,poi ruminano tutto, divorano quello che hanno rimosso e quello che hannofatto a pezzi, depositano di lato quel che resta e poi affondano,sprofondano nelle viscere del terreno. Le zanne affondano, la testaruota. Come una mitologica bestia. Le ruspe scavavano barbare voragini,triturano i rami che restano, le pietre, le splendide rocce. Roccesplendide. Belle come il grembo di una donna incinta, di una donnaprolifica, immensi seni lattei che hanno cullato innumerevoli macchie dianemoni, muschio e centinodie. Rocce splendide. Quanto hanno cullato ipiù bei giorni della nostra infanzia, quanto abbiamo pensato a lorodurante i nostri esili, quanto le abbiamo ammirate al tramonto quando sitingono del colore del sole e quando luccicano come specchi nellapioggia. Rocce splendide. La mandibola da balena si avventò, sgranocchiòle rocce come fossero pezzi di zucchero, zanne e bracci articolatistridettero. Scatta, fotografa, questa è Storia. Scatta, fotografa letristezze della terra. Scatta, fotografa le pene della gente. Scatta,fotografa. E chi ha un animo puro si fa bello della magnificenza dellaterra, dell’incanto del cielo e della brezza di mare. E quell’occidentaleben pasciuta, la discendente della Tatcher, parla di ambiente, di ozono,di umanità. Con questo clima non ci sono né ambiente né ozono né umanità.Ci sono solo ruspe che scavano la poca salute che resta, i rimasugli delcervello. Cosa rimane se si perde il cervello? Resta forse la Storia?
Estratto 7. Memoria. Pagina 28.--------------------------------------
La memoria mi tradisce e declina giorno dopo giorno.
158
Un giorno la perderò e sarò soltanto un corpo che vaga senza meta nellestrade affollate o nella solitudine dei sentieri pietrosi, alla ricercadi un coniglio bianco, che mi dica dove abito. Il coniglio impauritoscapperà e io gli correrò dietro, finchè incontrerò un cacciatore, unamico che ha preso la vita come viene, ha avuto un’infanzia felice e nonla ha dimenticata. Mi prenderà per mano, prenderà per mano me checombatto contro i mulini a vento, che sarò nulla, nulla assoluto. Miporterà nella casa dove sono nato, mi restituirà alla famiglia. Poi,tornerà dai suoi, contento dell’aiuto dato a un vecchio che aveva persola memoria: - Se non fosse per me lo avrebbero sbranato le iene. Ci sbraneranno le iene se perderemo la memoria. Le iene ci sbraneranno.
Estratto 8. Memoria. Pagina 99.--------------------------------------
Mamma mia! Cosa non gli hanno fatto, senza alcuna pietà, questi giovaninel fiore degli anni! La strada era piena di rovi, li hanno denudati,gettati a terra, obbligati a strisciare a pancia in giù, poi li hannouccisi. Quando mi hanno sentito urlare «Li hanno ammazzati! Li hannoammazzati!» ci sono venuti addosso dall’altra parte, ci hanno legati,messi al muro e riempiti di botte. Con le mani in alto, piangevamo epregavamo: - La prego, mister, la prego!Abbiamo visto la morte con i nostri occhi. Vedevamo in ciascuno di loroquaranta uomini. E noi, cosa eravamo, noi?!Bambini di sei anni!Gli anziani si erano messi a terra e le ragazze si imbrattavano il viso,perché avevano paura che le violentassero. Hanno incaprettato mio padre,sono uscito e ho cercato rifugio tra un gruppo di donne, una zia mi hacoperto con il suo corpo, un soldato si è avvicinato di corsa e hachiesto:- Dove, baby?- No baby, mister.Continuavano a seguirci quando, quando al tramonto siamo arrivati a Majdal-Karum.
Estratto 9. Dentro la notte. Pagina 128.----------------------------------------------
Mio padre, finalmente ritornato, appena vista mia madre, aveva detto cheaveva bussato a tutte le porte, invano. Gli avevo detto: - Babbo, èancora di ferro! E’ questo che conta!- E’ di ferro ragazzo!- Ci farai una bella figura con la vecchia!Mia madre mi aveva sgridato: - Vergognati, ragazzo!Ma io insistevo e chiedevo a mio padre: - Non hai sentito la suamancanza?Mio padre a quel punto, giurava che i ragazzi di questi tempi non avevanopiù rispetto per nessuno!Io non ero più un ragazzo!
159
Quando erano entrati nella loro stanza avevamo cacciato via i bambini. Ifigli di sorelle e fratelli. Noi grandi invece eravamo rimasti neiparaggi. La nostra curiosità ci inchiodava alle fessure della porta.Eravamo rimasti a lungo nel corridoio chiedendoci se mio padre stesseprovando il ferro del mestiere per la seconda volta, o, piuttosto lostesse ripulendo dalla ruggine che gli si era attaccata, da ormaisvariati anni.Dall’interno, nemmeno un sussurro che ci dicesse che cosa stavasuccedendo!
Estratto 10. Dentro la notte. Pagina 79.----------------------------------------------
Era affascinante sua figlia. Una nera perfetta. Camminava come un’asta.Appena la vedevo, avanzava dentro di me come una selva. Una selva contutte le sue leonesse, le sue tigri, le sue lupe.“La voglio!”Lei aveva detto: “A condizione che passi prima per il mio letto, se seiun uomo!”.Ero impazzito. Lo sai come siamo pazzi a volte. Mi sono detto: «questa èla mia occasione!» Ho represso il disgusto per tutta quella carne. Horingraziato Dio di non vederla. Era buio. Forse a causa della sfida chemi era stata posta, avevo accettato di essere stuprato. Perché sì, èstato uno stupro. Adesso lo posso dire.Erano i miei primi giorni lì. Era una specie di gioco, di resa, disuicidio. Si gettava l’anima in mezzo alla corrente. Ero caduto. Nondovevo esitare. Avevo cercato una fessura. L’avevo finalmente trovata.Era viscosa. Reagiva male. Pareva che fossi il primo a penetrarla dadecine di anni. Era impazzita. Sussultava. I legni del pavimento copertodi sabbia, soffitto di un caffè, scricchiolavano.Quando mi ero scostato, mi aveva dato qualche pacca dicendo: “Alzati. Vàda lei. Adesso è tua!”.Volevo alzarmi ma non ce la facevo. Aveva riso. La notte, con la sua densa oscurità, aveva tremato.
Estratto 11. Una primavera di fuoco. Pagina 219 – 220.----------------------------------------------------------------
Ahmad corse a dirle: “gli ebrei hanno attaccato”, ma lei non glicredette. Gli ebrei avevano già minacciato più volte di attaccare eoccupare – o per meglio dire rioccupare – i territori dell’Autorità e nonl’ avevano poi fatto. I frammenti di territorio controllati dall’Autoritàsembravano un’insalata mista. Anche la gente per strada, giocandosull’assonanza fra Sulta, Autorità e salata, insalata. Faceva battutesarcastiche a questo proposito: la Sicurezza dell’insalata, un governod’insalata, il caos dell’insalata, uno schifo di insalata. Da un punto divista geografico le porzioni di territorio dell’Autorità parevano unacamicia fatta a brandelli: il colletto qui e la manica laggiù, un pezzodel davanti e un pezzo del dietro. Niente bottoni. Sulla cartina parevanochiazze d’olio su dell’acqua torbida, e Umm Su’ad si intristiva. “Chesoluzione è mai questa?”. Senza forma, senza confini, senza soluzione di
160
continuità. Al vertice, gruppi, tribù e organizzazioni che paionocetrioli, pomodori, ravanelli, lattuga e prezzemolo dentro una cassettasenza fondo, senza coperchio e senza sponde laterali. Verdure arrivate dachissà dove, sminuzzate in pezzettini grandi come francobolli, gonfiatecome materassi per essere vendute ai contadini, ai poveri e alle vedove.E anche il popolo è variegato quanto l’Autorità: un contadino Tubas, unbeduino di Khan Yunis, in intellettuale a Ramallah, uno che dice unaparola in arabo e una in inglese, e poi ragazze che giocano inpantaloncini corti e spose avvolte in tuniche e veli. Uno stranomiscuglio, disomogeneo e senza un minimo comune denominatore. Sull’altroversante, un miscuglio ancor più ricco, più pittoresco: un colonocanadese, altri coloni che arrivano da Parigi, Roma, Londra e poi dallaBulgaria e dalla Romania, neri che vengono dall’Abissinia e dall’Etiopia.Una cosa davvero sbalorditiva, una cartina geografica stupefacente, unparco giochi per bambini, una piazza piena di matti, una ciotolamastodontica con sopra un cuoco che pare un orco e ci rimesta comefossimo la minestra che si papperà.
Appendice 2.Autrici e autori
SAHAR KHALIFA nasce a Nablus nel 1941. Dopo un matrimonio duratotredici anni, combinato dalla sua famiglia, riesce ad ottenere ildivorzio e l’affidamento delle due figlie. Durante questi anniscrive un primo romanzo che viene pubblicato nel 1972, Lan na’udgiawari lakum, “Non saremo più le vostre serve”. Tornata inCisgiordania dalla Libia dove aveva vissuto con il marito, atrentadue anni si iscrive al Corso di Laurea in LetteraturaInglese della Birzeit University e poco dopo, nel 1976, pubblicaun secondo romanzo, Terra di fichi d’India. Lo spaccato è quello dellasocietà palestinese nei primi anni Settanta. I due fratelliprotagonisti, Adel e Usama, vivono un conflitto drammatico: mentreil primo è stato costretto a cercare lavoro in una fabbricaisraeliana, Usama è incaricato da un’organizzazione di resistenzadi preparare un attentato contro di questa. Il romanzo fa scalporeanche per la scelta di utilizzare nei dialoghi la lingua parlata,allontanandosi dall’arabo classico. Khalifa si sposta negli StatiUniti, dove consegue un dottorato in Studi sulle Donne. Nel 1890esce il quarto romanzo, I girasoli, centrato sulla dicotomia trateoria e pratica dell’intellighenzia palestinese circa ilprogressismo e l’emancipazione femminile. Nel 1986 vienepubblicato Memorie di una donna non realista, che in italiano diventa Lasvergognata. Nel 1989 Khalifa torna a Nablus e fonda il Centro delleDonne, il primo centro palestinese a occuparsi della condizionefemminile e della formazione di ricercatrici in campo sociale.
161
Durante il coprifuoco seguito allo scoppio della prima IntifadaKhalifa, si dedica alla stesura del sesto romanzo, La porta dellapiazza, edito nel 1990. In una Nablus assediata gli uomini sonoperlopiù ricercati, e dunque clandestini in una gestione femminiledelle risorse e delle cure. A condividere il coprifuoco, bloccatenella stessa casa, sono tre donne molto diverse: una ragazzalaureata e militante, una prostituta accusata di collaborazionismoe la levatrice del quartiere. Anche qui Khalifa fa la scelta diutilizzare il dialetto di Nablus, anziché l’arabo classico. Nel1993 il Centro di Nablus si sdoppia con una seconda sede a Gaza,che sarà affiancata da una terza ad Amman, in Giordania. Gliultimi due romanzi sono L’eredità, del 1997 e Una primavera di fuoco del2004. Sahar Khalifa è tradotta anche in ebraico.
SUAD AMIRY nasce a Damasco nel 1951 da una famiglia palestineseemigrata in Siria dopo l’occupazione israeliana del 1948. Studiaarchitettura a Beirut, poi negli Stati Uniti, infine a Edimburgoper la specializzazione. Nel 1981 decide di vivere nei TerritoriOccupati e si trasferisce con il marito a Ramallah inCisgiordania. Insegna Architettura alla Birzeit University ed èdirettore del Riwaq Centre for Architectural Conservation diRamallah. Oltre ad aver scritto e curato una serie di saggisull’architettura palestinese, nel 2003 pubblica Sharon e Mia suocera,la cronaca in forma di diario dell’occupazione israeliana diRamallah e della Muqataa, il quartier generale di Arafat, fra ilnovembre 2001 e il settembre 2002. A seguito del vasto successoeditoriale il testo è stato ripubblicato con l’aggiunta di unanuova parte, Se questa è vita, in cui Amiry amplia le proprie memoriescrivendo anche di periodi precedenti, in particolare quelli deglianni dell’emergere della prima Intifada. Tra il 1991 e il 1993 èmembro della delegazione palestinese per la pace in Medio Orienteche partecipa agli incontri negli Stati Uniti. La carriera comeautrice prosegue con Niente sesso in città, edito nel 2007 e infine conla pubblicazione nel 2009 di Murad Murad. Qui Amiry, travestita dauomo, si unisce per una giornata a un gruppo di braccianti. Larealtà è quella delle centinaia di lavoratori palestinesi che peril ben più alto stipendio israeliano ogni mattina cercano diintrodursi in Israele violando il “muro”: il confine erettodall’esercito per blindare la Cisgiordania da Gerusalemme. SuadAmiry è tradotta anche in ebraico.
IBRAHIM NASRALLAH nasce nel 1954 in un campo profughi in Giordaniadove si erano rifugiati i suoi genitori, originari di un villaggio
162
vicino a Gerusalemme. Studia nella scuola e nel college dell’UNRWA(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees inthe Near East), si laurea in Arabia Saudita. Trova lavoro comeinsegnante dal 1976 al 1978, poi come giornalista fino a 1996. Dal1996 al 2002 dirige gli Affari Culturali della Fondazione Circolodelle Arti Khalid Shuman. Si afferma inizialmente come poeta eoltre ai romanzi pubblica saggi e libri per bambini. Inoltre èpittore e fotografo. In italiano, nel 2001, è tradotto Febbre, chel’autore ha scritto nel 1985. Nel romanzo si ripresenta ilNasrallah insegnante: un maestro di scuola elementare vienetrasferito in un villaggio in Arabia Saudita e divide una stanzacon un suo omonimo, che si rivela una sorta di fantasma della suacoscienza e dei suoi incubi. Dentro la notte. Diario palestinese è del 1992,pubblicato in Italia nel 2004. Ibrahim Nasrallah è tradotto anchein ebraico.
SALMAN NATUR nasce a sud di Haifa nel 1949. La sua è famiglia èdrusa, appartiene cioè a una setta musulmana che oggi conta circadue milioni di fedeli, e che professa una dottrina con elementisincretici cristiani, musulmani, ebraici e induisti.L’appartenenza a una minoranza religiosa non confligge nel caso diNatur con l’identità araba palestinese: dopo gli studi difilosofia si dedica infatti al problema dei profughi. Lavora comegiornalista, occupandosi della testimonianza in racconti e memoriedel popolo palestinese. Più di una volta risulta scomodo algoverno israeliano al punto di subire limitazioni alla proprialibertà professionale e personale. Natur vive con la moglie e iquattro figli nel villaggio in cui è nato, è un autore prolificodi saggi, pieces teatrali e romanzi. Memoria, del 2008, è ad oggila prima traduzione italiana. Natur è stato il primo presidentedell’associazione degli scrittori arabi in Israele. Membro delladirezione del Centro “Adalah”, direttore della rivista “QadayaIsra’iliyya”, è impegnato nel far conoscere la filosofia araba ela cultura palestinese, soprattutto in ambito universitario. Èinfine noto come traduttore dall’ebraico: ha tradotto in arabo ilromanzo di David Grossman Il vento giallo.
163
Bibliografia
A
- AA. VV., “La terra più amata, voci della letteratura
palestinese”, Manifestolibri, Roma, 2002.
- AA. VV. “Parola di donna, corpo di donna: antologia di
scrittrici arabe contemporanee”, a cura di Valentina Colombo,
Mondadori, Milano, 2005.
- Elena Agazzi, Vita Fortunati, a cura di, “Memoria e saperi”,
Meltemi, Roma, 2007.
- Benedict Anderson, “Comunità immaginate. Origine e diffusione
dei nazionalismi”, Manifesto Libri, Roma, 1996.
- Jeffrey C. Alexander, Ron Eyerman, Berhard Giesen, Neil J
Smelser, Piotr Sztompka, “Cultural Trauma and Collective
Identity”, University of California Press, London, 2004.
- Suad Amiry, “Niente sesso in città”, Feltrinelli, Milano, 2007.
- Suad Amiry, “Sharon e mia suocera. Se questa è vita”,
Feltrinelli, Milano, 2003.
- Suad Amiry, “Murad Murad”, Feltrinelli, Milano, 2009.
- Emily S. Apter, Traslation in a global market, numero monografico,
Public Culture, 13, 1, 2001.
- Aleida Assmann, Ute Frevert, “Geschichtsvergessenheit
Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten
nach 1945”, Stoccarda, Deutsche Verlags-Anstalt, 1999.
- Aleida Assman, “Ricordare. Forme e mutamenti della memoria
culturale”, Il Mulino, Bologna, 2002.
- Samira Azzam, “Palestinese! E altri racconti”, Edizioni Q, Roma
2003.
B
164
- Liana Badr, “Le stelle di Gerico”, Edizioni Lavoro, Roma, 2010.
- Silvia Barbieri, Roberto Marino, in Trauma e Memoria: forme del
ricordo e dell’oblio nel modello traumatico, Symbolon,
http://www.psicotraumatologia.it/symbolon/rivista/rivista.htm
- Roland Barthes, “Elementi di semiologia”, Einaudi, Torino,
1966.
- Diane Baxter, Honor Thy Sister: Selfhood, Gender, and Agency in Palestinian
Culture, Anthropological Quarterly, vol 80, 3, 2007.
- Jill Bennett, Rosanne KennedyBasingstoke, “World Memory:
Personal Trajectories in Global Time”, Palgrave Macmillan, New
York, 2003.
- Zdena Berger, “Raccontami un altro mattino”, Baldini Castoldi
Dalai, Milano, 2008.
- Denis Bertrand, “Basi di semiotica letteraria”, Meltemi, Roma,
2002.
- Luc Boltanski, “Lo spettacolo del dolore”, Raffaello Cortina,
Milano, 2000.
- Jerome Bruner, La costruzione narrativa della realtà, in Ammaniti e
Stern, a cura di, “Rappresentazioni e narrazioni”, Editori
Laterza, Bari, 1991.
- Judith Butler, “Corpi che contano”, Feltrinelli, Milano, 1993.
C
- Guido Calderon, L’escalation teocratica non è solo una risposta all’occupazione.
Viaggio nella cultura politica dell“islamismo dal basso, “Liberazione”, 24
giugno 2007.
- Orly Castell Bloom, “Dolly city”, Stampalternativa, Viterbo,
2008.
165
- Cathy Caruth., a cura di, “Trauma. Explorations in memory”, The
John Hopkins University Press, Baltimore-London, 1995.
- Giovanni Codovini, “Geopolitica del conflitto arabo israeliano
palestinese”, Mondadori, Milano, 2009.
- Vincent Colonna, L’autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littèrature,
tesi inedita curata da Gerard Genette, EHESS, 1989.
- Oliver ConollyBashshar Haydar,The Case Against Faction,Philosophy and
Literature - vol 32, 2, 2008.
D
- Teresa De Lauretis, “Feminist studies/Critical studies”,
Indiana University Press, Bloomington, 1986.
- Cristina Demaria, “Teorie di genere: femminismo, critica
postcoloniale e semiotica”, Bompiani, Milano, 2003.
- Serge Doubrovsky, “Fils”, Seuil, Parigi, 1977.
E
- Paul John Eakin, “How Our Lives Become Stories”, Cornell
University Press, Ithaca - London, 1999.
- Umberto Eco, “Kant e l’ornitorinco”, Bompiani, Milano, 1997.
- Marcella Emiliani, “La terra di chi? Geografia del conflitto
arabo israeliano palestinese”, Il Ponte, Bologna, 2008.
- Astrid Erll, Reading Literature as Collective Texts: German And English War
Novels of the 1920s as Media of Cultural and Communicative Memory, in
Christian Bode, a cura di, “Anglistentag”, Wissenschaftlicher
Verlag, Monaco, 2003; “Kollektives Gedachtnis und
Erinnerungskulturen”, Stuttgard, Metzler, 2005; Re-writing as Re-
visioning: Modes of Representing the Indian Mutiny in British Literarure, European
Journal of English Studies, vol 10, 2, 2006.
F
166
- Paolo Fabbri, Gianfranco Marrone, a cura di, “Semiotica in
nuce”, Meltemi, Roma, 2000.
- Shoshana Feldman, Dori Laub, “Testimony. Crisis of Witnessing
in Literature, Psychoanalysis, and History”, Routledge, New York-
London, 1992.
- Eugen Fink, “Il gioco come simbolo del mondo”, Hopefulmonster,
Firenze, 1992.
- Jaques Fontanille, “Pratiche semiotiche”, in Semiotiche, 4,
2006.
- Vita Fortunati, Gilberta Golinelli, Rita Monticelli, a cura di,
“Studi di genere e memoria culturale”, CLUEB, Bologna, 2004.
G
- Gerard Genette, “Figure 3. Discorso del racconto”, Einaudi,
Torino, 1986.
- Gerard Genette, “Fiction et diction”, Seuil, Parigi, 1991.
- Elena Giliberti, a cura di, “Finzioni Autobiografiche”,
QuattroVenti, Urbino, 2008.
- Paul Gilroy,“The Black Atlantic: Modernity Double
Consciousness”,Verso, Londra,1993.
- Algirdas Greimas, “Del senso 2: narrativa, modalità, passioni”,
Bompiani, Milano, 1985.
- David Grossman, “A un cerbiatto somiglia il mio amore”,
Mondadori, Milano, 2008.
H
- Johan Huizinga, “Homo ludens”, Einaudi, Torino, 1972
J
- Rula Jebreal, “La strada dei fiori di Miral”, BUR, Milano,
2005.
K
167
- Ghassan Kanafani, “Uomini sotto il sole”, Sellerio, Palermo,
1991.
- Diane Kandiyoti, Old Dilemmas or New Challenges? The Politics of Gender and
Recostruction in Afghanistan, in “Development and Change”, vol. 38, 2,
2007.
- Sahar Khalifa, “La svergognata”, Giunti, Firenze, 2008.
- Sahar Khalifa, “Una primavera di fuoco”, Mondadori, Milano,
2008.
- Sahar Khalifa, “Terra di fichi d’India”, Jouvence, Roma, 1996.
- Antje Krog, “Country of My Skull”, Random House, Johannesburg,
1998.
L
- Eric Landoski, “La società riflessa”, Meltemi, Roma, 2003.
- Mounir Laouyen, L’autofiction: une recéption problématique,
http://www.fabula.org/forum/catalogue99/208. php
- Dori Laub, Nanette C. Auerhanh, Knowing and not knowing about massive
psychic trauma: forms of traumatic memory, International Journal of
Psychoanalysis, vol 78, 1223, 1998.- Jaques Lecarme, L’autofiction: un mauvais genre?, in “Autofictions &
Cie”, Colloque de Nanterre, a cura di Serge Doubrovsky, Jaques
Lecarme e Philippe Lejeune, RITM, 6, 1992.
- Philippe Lejeune, “Il patto autobiografico”, Il Mulino,
Bologna, 1986.
- Jurij M. Lotman, Boris A. Uspenskij, “Tipologia della cultura”,
Bompiani, Milano, 2001.
- Jurij M. Lotman, “La semisfera”, Marsilio, Napoli, 1992.
- Jurij M. Lotman, “Tesi per una semiotica delle culture”,
Meltemi, Roma, 2006.
168
M
- Giovanni Manetti, “L’enunciazione: dalla svolta comunicativa ai
nuovi media”, Mondadori, Milano, 2008.
- Joseph Massad, Conceiving the Masculine: Gender and Palestinian Nationalism,
The Middle East Journal, vol 49, 3, 1995.
- Miguel Mellino, “La critica postcoloniale”, Meltemi, Roma,
2005.
- Angela Mengoni, a cura di, “Racconti della memoria e
dell’oblio”, Protagon, Siena, 2009.
- Philippe Mesnard, Charles H. Kahn, “Giorgio Agamben à l’Epreuve
d’Auschwitz – Temoignages/Interprètations”, Editions Kimè,
Parigi, 2001.
- Henri Michaux, “La nuit remue, Mes proprietès”, Gallimard,
Parigi, 1967.
N
- Ibrahim Nasrallah, “Dentro la notte”, Ilisso, Nuoro, 2004.
- Salman Natur, “Memoria”, Edizioni Q, www.edizioniq.it, stampa:
StudioVD, Perugia, 2008.
O
- Christina Olin-Scheller, Michael Tengber, “If It Ain't True,
Then It's Just a Book!” The reading and teaching of faction literature,
Journal of Research in Reading, UKLA, 2010.
P
- Carlo Panella, “Il libro nero dei regimi islamici”, Rizzoli,
Milano, 2007.
- Ilan Pappe, “Storia della Palestina moderna”, Einaudi, Torino,
2005.
- John Peters, Witnessing, Media, Culture & Society 24, 2002.
169
- Nicolas Pethes, Jans Ruchatz, “Dizionario della memoria e del
ricordo”, Mondadori, Milano, 2002.
R
- Francois Rastier, “Sémantique interprétative”, PUF, Parigi,
1987.
- Paul Ricoeur, Algirdas Greimas, “Fra semiotica ed ermeneutica”,
Meltemi, Roma, 2000.
- Paolo Rossi, “Il passato, la memoria, l’oblio”, Il Mulino,
Bologna, 1991.
S
- Edward Said, “La questione palestinese”, Gamberetti editrice,
Roma, 1995.
- Edward Said, “Orientalism”, Pantheon books, New York, 1978.
- Mohamed Salah Omri, Local Narrative Form and costruction of the Arabic Novel,
Novel, vol 41, 2/3, 2008.
- Ruba Salih, “Musulmane rivelate: donne, islam, modernità”,
Carocci, Roma, 2008.
- Sandro Segre, “Talcott Parson: un’introduzione”, Carocci, Roma,
2009.
T
- Mark Tessler, Ina Warriner, Gender, Feminism, and Attitudes Toward
International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from the Middle East,
World Politics, vol 49, 2 , 1997.
- Anna Lisa Tota, We regret: memoria pubblica e politiche della riconciliazione,
in Jacobs, Hanharan, a cura di, “Blackwell Companion to the
Sociology of Culture”, Blackwell, Oxford, 2005.
- Enzo Traverso, “Auschwitz e gli intellettuali. La Shoà nella
cultura del dopoguerra”, Il Mulino, Bologna, 2000.
W
170
- Sigrid Weigel, Der schielende Blick: Thesen zur Geschichte weiblicher
Schreibpraxis, in “Die Verborgene Frau: Sechs Beitrage zu einer
feministischen Literaturwissenshaft”, Argument, Berlin, 1983.
- Binjamin Wilkomirski: “Fragments. Memories of a Wartime
Childhood”, Schocken Books, New York, 1996.
Y
- Abraham Yehoshua, “Fuoco amico”, Einaudi, Torino, 2008.
Z
- Ghassàn Zaqtàn, “Ritratto del passato”, Poiesis, Alberobello,
Bari, 2008.
171