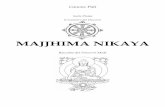FIGURE DEL CORPO E SCIENZA DELL’ATTRIBUZIONE, in Fisiognomica del senso. Immagini Segni Discorsi,...
Transcript of FIGURE DEL CORPO E SCIENZA DELL’ATTRIBUZIONE, in Fisiognomica del senso. Immagini Segni Discorsi,...
Fisiognomica del senso
Immagini, segni, discorsi
a cura diMarina De Palo, Filippo Fimiani, Antonella Trotta
Liguori Editore
Questa opera è protetta dalla Legge sul diritto d�autore (http://www.liguori.it/areadownload/LeggeDirittoAutore.pdf).Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla citazione, alla riproduzione in qualsiasi forma, all�uso delle illustrazioni, delle tabelle e del materiale software a corredo, alla trasmissione ra-diofonica o televisiva, alla registrazione analogica o digitale, alla pubblicazione e diffusione attraverso la rete Internet sono riservati. La riproduzione di questa opera, anche se parziale o in copia digitale, fatte salve le eccezioni di legge, è vietata senza l�autorizzazione scritta dell�Editore.
Liguori EditoreVia Posillipo 394 - I 80123 Napoli NAhttp://www.liguori.it/
© 2011 by Liguori Editore, S.r.l.Tutti i diritti sono riservatiPrima edizione italiana Gennaio 2011Stampato in Italia da Liguori Editore, Napoli
De Palo, Marina (a cura di):Fisiognomica del senso. Immagini, segni, discorsi/Marina De Palo, Filippo Fimiani, Antonella Trotta (a cura di)Teorie & Oggetti delle Scienze SocialiNapoli : Liguori, 2011 ISBN-13 978 - 88 - 207 - 5349 - 8
1. Semiotica 2. Linguaggi letterari I. Titolo II. Collana III. Serie
Ristampe:������������������������������������������20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
La carta utilizzata per la stampa di questo volume è inalterabile, priva di acidi, a PH neutro, conforme alle norme UNI EN ISO 9706 ∞, realizzata con materie prime fibrose vergini provenienti da piantagioni rinnovabili e prodotti ausiliari assolutamente naturali, non inquinanti e totalmente biodegradabili. (FSC, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS).
Indice
1 Premessa di Marina De Palo, Filippo Fimiani, Antonella Trotta
3 Fisiognomica e linguaggio di Federico Albano Leoni 1. La conoscenza fisiognomica 3; 2. Fisiognomica e linguaggio 4; 3. Fisiognomica e
fonologia 6; 4. Un esperimento 10; 5. Fisiognomica e economia 11; 6. Conclusioni 15.
17 Per una fenomenologia del vago di Marina De Palo 1. Wittgenstein e i linguisti 17; 2. Vedere ciò che è comune: Galton e il ritratto di
famiglia 20; 3. Wittgenstein: il �vedere come� e la fenomenologia dell�espressione 23; 4. La Gestalt tra Kant e Husserl 26; 5. Morfologia idealistica e strutturalismo 28; 6. Gestalt e strutturalismo: strutture senza soggetto 30; 7. �Vedere come�, soggettività e intersoggettività 32; 8. Campo simbolico e campo indicale: dov�è l�ellissi? 33.
35 Wittgenstein & il giallo. Filosofia, fisiognomica e letteratura poliziesca di Sara Fortuna 1. Brevissima storia di una passione letteraria (come introduzione) 35; 2. Il giallo
prediletto: Rendez-vous with Fear alias The Mouse in the Mountain 39; 3. Note su filosofia e detective story 41; 4. Paradigmi fisiognomici nell�indagine poliziesca 47; 5. Primaria & Periferica: sul carattere paradossale della dimensione fisiognomica per Wittgenstein 49; 6. Un inizio per concludere: l�apertura di Rendez-vous with Fear 51.
55 Breve nota su Odisseo di Luca Cerchiai 1. Prima di Scheria 55; 2. A Scheria 56; 3. Circe, le Sirene e Ade 59.
63 Impronte d�anima. Espressione e figuralità in pittura di Filippo Fimiani 1. Indici e indizi (quasi una premessa) 63; 2. Impressionabilità 65; 3. Scoperte, violenze
e sotterfugi 67; 4. Un gesto rammemorante 69; 5. Pigmalione fotografo 72;
77 Figure del corpo e scienza dell�attribuzione di Antonella Trotta 1. Fisionomie 77; 2. Il volto della pittura 81; 3. Identità 85.
INDICEviii
91 Il ritratto parlato. Norma e identità nel XIX secolo di Silvana Turzio 1. La protofotografia 91; 2. La fotografia medica 93; 3. La norma 94; 4. La fotografia
del controllo 95; 5. Il dispositivo segnaletico 96; 6. Il teatro dell�immagine 101.
103 Specchio di sguardi, tra semiotica e cinema di Vincenzo Spisso 1. Una citazione e un�evidenza 103; 2. Quattro livelli di ambiguità 105; 3. Luci ed
ombre del volto sullo schermo 106; 4. Virtualità 115.
119 In primo piano. Immagini-affezione e dispositivi di visione di Alfonso Amendola 1. Una premessa 119; 2. La vera vita, la piccola vita 120; 3. Griffith, o del volto rifles-
sivo 123; 4. Ejzen�tejn, o del volto intensivo 128; 5. Una storia piena di storie 130; 6. Generi e dispositivi 133.
139 Qualcosa deve rimanere di Maggie Cardelùs
145 Bibliografia
163 Gli autori
Premessa
di Marina De Palo, Filippo Fimiani, Antonella Trotta
�Qualcuno entra da una porta, a volte compie un�azione o fa un gesto con una mano, o un cenno del capo, a volte dice qualcosa.� Questa, più o meno, la descrizione più che essenziale dataci dagli studenti in Scienze della comu-nicazione, della Laurea magistrale in Teoria della comunicazione, audiovisivi e società della conoscenza e del Laboratorio di Semiotica e Comunicazione negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. L�abbiamo chiesta noi così, ridotta all�osso e in diretta, mentre i loro amici e compagni di corso entravano nell�aula multimediale, alcuni che salutavano con un sonoro o un timido �buongiorno�, altri con un leggero movimento del capo, altri ancora levandosi il cappello imposto dal freddo invernale del campus dell�Università di Salerno.
Questo piccolo esercizio non ha mancato di suscitare un po� di divertita sorpresa. Era, in effetti, malizioso, e strumentale. Ricalcava, infatti, un altro evento comune e ancor più quotidiano, e riecheggiava un altro esperimento mentale, di ben altro tenore e, spiegavamo poi agli studenti incuriositi e interdetti, celeberrimo. Si trattava, abbiamo finalmente confessato, del vero e proprio personaggio concettuale evocato da Erwin Panofsky (1961, pp. 214-215; 1996, pp. 3-5) su una scena fondativa e �primaria� del suo metodo (Mitchell 1991). Com�è noto, innestato su una parafrasi dell��intelligente americano� Charles Sanders Peirce1, l�esempio dell�uomo col cappello che saluta incarna quello che Panofsky, sulle orme di Ernst Cassirer, intende sin dagli anni Trenta per �senso� o �sintomo culturale�, e personifica la distin-zione metodologica tra iconografia e iconologia. Si tratta di luoghi capitali non solo per la storia dell�arte, che superano di molto quanto vogliamo richiamare qui. Ci preme, però, evidenziare che, sulla falsariga dell�esempio panofskiano d�una familiarità quotidiana con �il mondo pratico degli oggetti e degli eventi� e �con il mondo un poco più che pratico dei costumi delle
1 In Issues of Pragmatism (1905), la frase originale, riferita da Peirce anche a se stesso, suona così: �it is the belief men betray and not that which they parade which has to be studied� (Peirce 1931-1958, 5.444 nota). La riporta anche Edgar Wind (1963, p. 258); cfr. Panofsky 1975, p. 18.
PREMESSA2
tradizioni culturali, prodotte da una determinata civiltà� (Panofsky 1975, p. 4), intendevamo proporre ai nostri studenti una situazione insieme per-spicua e densa che implicava, nella sua manifestazione, ed esigeva, nella sua comprensione, l�orizzonte della fisiognomica.
Ma le cose erano più complicate del caso scelto da Panofsky, già fertilis-simo luogo germinativo del dibattito sui rapporti tra iconografia, iconologia e semiotica � e psicoanalisi (Didi-Huberman 1990, pp. 195-205, 215-217) �, e precocissimo punto d�incrocio tra storia dell�arte e cultura visuale. Per noi, infatti, non si trattava di un �atto isolato di saluto�, solo muto e gestuale, ma di un�azione complessa e articolata, fatta anche di un atto verbale. Il nostro esempio, tratto da una forma di vita quotidiana e dal suo determinato orizzonte di credenze implicite o, per dirla con Wittgenstein (1983, § 66), di �giochi linguistici� condivisi, quasi complementare alla non meno rituale civil inattention di Goffman (1997), presentava infatti il caso di un�impressione generale, che non era affare solo di un riconoscimento e d�una significazione vincolati al visivo, ma anche d�una comprensione linguistica, non necessariamente per segmenti discreti e isolabili come i particolari e gli indizi iconografici. Non solo il viso e il corpo, ma anche il corpo vivente della lingua parlata si mostrava tutt�insieme e immediatamente come una fisionomia e un�identità innervata da inclinazioni e pulsioni, emozioni e sentimenti, intenzioni e volontà, significati e valori. La parola e il gesto di saluto realizzavano un fatto performativo e, dunque, si presentavano in quanto �volto�, giacché, a ripetere a modo nostro un�etimologia di Varrone (De lingua Latina 6.78), proprio nomine dicitur facere, a facie, qui rei quam facit imponit faciem.
Prendendo ad esemplificazione quanto accadeva nel vivo delle nostre lezioni, grazie a un uso didatticamente utile della complessità della deissi (Gumbrecht 2004, pp. 120 ss), mettevamo gli studenti di fronte un�evidenza pragmatica che, a nostro avviso, introduceva e legittimava le attività del La-boratorio: per dare conto delle dinamiche e dei dispositivi di tale �fenomeno fisiognomico�, fatto di segni e aspetti molto differenti tra loro se non etero-genei per natura e funzione, bisognava convocare attrezzi, atteggiamenti e competenze diverse per vocazione e formazione, spesso inedite rispetto al loro percorso di studi.
Agli appuntamenti del Laboratorio, anche grazie al sostegno del Dot-torato in Scienze della Comunicazione, si sono confrontati studiosi di varia estrazione e di più ambiti disciplinari � filosofia del linguaggio e fonologia, semiotica ed estetica, storia dell�arte e archeologia, sociologia del cinema e storia della fotografia �, e autori di prassi e poetiche dell�arte, sensibili al-l�incontro, vago ma necessario, tra fisionomia e senso. Di questo, il presente volume spera di dare una testimonianza non troppo manchevole.
Figure del corpo e scienza dell�attribuzione
di Antonella Trotta
�Dis-moi comment tu classes, et je te dirai qui tu es.�Roland Barthes, Littérature et discontinu
1. Fisionomie
Nel 1874, un saggio apparso a Lipsia, in «Zeitschrift für bildende Kunst» di Carl von Lützow, e dedicato alla revisione del catalogo dei dipinti italiani del Rinascimento nella Galleria Borghese, presentava al pubblico degli spe-cialisti e degli amatori d�arte l�applicazione di un nuovo metodo di analisi che, per risultati e procedure, prometteva di sconvolgere clamorosamente l�ordine e i metodi della storia dell�arte.
In una breve premessa al testo, l�autore � l�italiano Giovanni Morelli alias il russo Ivan Lermolieff1 � chiariva infatti che per attribuire correttamente i dipinti degli Antichi Maestri è essenziale distinguere tre livelli di unità di analisi: il primo, scriveva, riguarda �la posizione e il movimento del corpo umano, la forma del viso, il colorito, il panneggiamento� e tutti gli elementi espressivi che determinano l�impressione generale della composizione ma non definiscono interamente la forma. Il secondo comprende alcuni particolari anatomici, come �la mano�, �l�orecchio�, �il fondo a paesaggio�, l��accordo o la cosiddetta armonia dei colori�; il terzo, alcune �piccolezze materiali�, che sfuggono all�artista �senza che se ne accorga� (Morelli 1886, pp. 86-87). Espressivamente marginali nella composizione, queste due classi di elementi, che all�artista sfuggono per abitudine, come accade con alcuni giri di frase
1 Con tale pseudonimo, una �trasposizione� del suo vero nome (Frizzoni 1991, p. 360) � come quello di Johannes Schwarze, aggiunto alla prima edizione del volume sulle gallerie tedesche �, Morelli avrebbe firmato i suoi lavori fino al 1883. Fino ad allora, la sua vera identità era ignota anche ad alcuni dei suoi più accesi sostenitori (Gibson-Wood 1988, pp. 202-203). Questa scelta, che interessò Freud, com�è noto precoce lettore di Morelli e influen-zato dal suo metodo di analisi (Spector 1969; Wollheim 1973; Ginzburg 1986), ancora oggi è al centro di speculazioni, come in Agamben 2008, pp. 77-80.
FISIOGNOMICA DEL SENSO78
ricorrenti nella lingua parlata o scritta, sono tratti individuali e caratteristi-ci del linguaggio pittorico, indizi espressivi della personalità dell�autore, e, poiché l�intima comprensione della personalità di un artista non è altro che profonda conoscenza della forma, evidenze fondamentali per la produzione del giudizio critico (Zerner 1997, pp. 15-30). In definitiva, continuava Mo-relli, era necessario �imparare a vedere correttamente� (Morelli 1886, p. 5), al riparo dai tiri mancini giocati dall�impressione generale � cui lo spettatore comune, invece, aderisce con maggior trasporto �, o dall�esercizio superficia-le dello studio psicologico: queste pericolose digressioni dell�immaginazione, per esempio, avevano indotto Charles Blanc, l�autorevole fondatore della «Gazette des Beaux Arts», a riconoscere erroneamente la tournure de l�esprit di Leonardo in un San Sebastiano appena passato sul mercato e che ora, grazie all�esame rigoroso della sola maniera pittorica, poteva essere restituito senza dubbio al leonardesco Cesare da Sesto (Morelli 1874, pp. 4-5).
Questo metodo di analisi si realizza in un procedimento che, mutuato dagli strumenti dell�analisi testuale e, in particolare, dall�esame grafologi-co dei caratteri della scrittura, affondava le sue radici in una tradizione consolidata nella storia della storia dell�arte, da Giulio Mancini, Jonathan Richardson, Antoine Dézallier d�Argenville, Luigi Crespi, fino a Luigi Lanzi e ai fratelli Goncourt (Ginzburg 1986; Morelli 1991, p. 20; Vouilloux 1997, pp. 25-60; Zerner 1997, p. 17). Eppure, era una novità rivoluzionaria.
Per Morelli, che aveva studiato medicina a Monaco con il celebre bio-logo Ignatius Döllinger, a Berlino aveva frequentato il salotto di Bettina von Arnim e i protagonisti della più recente erudizione storico-artistica, e, a Milano, aveva guardato da vicino i dipinti antichi nella bottega del re-stauratore Giuseppe Molteni (Anderson 1987, 1989/1990, 1991), si trattava di classificare i dati visivi ricavati dall�osservazione diretta in griglie compa-rative, allo scopo di distinguere le modalità espressive peculiari a ciascuna scuola pittorica, a ciascuna bottega e, se possibile, ad ogni singolo artista. Declinazione del metodo sperimentale, il suo metodo di analisi pretendeva così di essere quasi infallibile in quanto, da questo punto di vista, le attribu-zioni non avrebbero più valore di opinioni, ma sarebbero dimostrazioni di una teoria delle opere d�arte intese, a dirla con Taine, come �fatti positivi che possono essere osservati� (Taine 1996, p. 51).
Con questo strumento di precisione, Morelli ricostruiva la fisionomia delle scuole pittoriche del Rinascimento (Morelli 1886, p. 5). In Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin (1880), per esempio, presentava la pittura dell�Italia settentrionale in una complessità di articolazioni fino ad allora sconosciute alla storia dell�arte: nella pinaco-teca di Monaco, cambiava molte attribuzioni accreditate, ma a suo parere
FIGURE DEL CORPO E SCIENZA DELL�ATTRIBUZIONE 79
estremamente ottimistiche, a Giovanni Bellini, a Mantegna e a Giorgione e proponeva in una nuova luce i rapporti stilistici tra Palma il Vecchio e Lorenzo Lotto, riscrivendo completamente la cronologia degli indirizzi formali del Rinascimento veneziano. A Dresda, attribuiva prodigiosamente a Giorgione la Venere dormiente che passava allora sotto il nome di Sassofer-rato, e a Berlino equilibrava il ruolo dominante che gli studi riconoscevano alla bottega dei Bellini nella pittura veneziana del Rinascimento con una ridefinizione della fisionomia stilistica di Antonio e Alvise Vivarini. Inol-tre, in una visione del tutto originale della formazione di Raffaello e dei lineamenti delle scuole pittoriche dell�Italia centrale, eccentrica tanto alla tradizione vasariana quanto ai risultati della connoisseurship contemporanea, non solo deduceva dalla ricorrenza di alcune contiguità morfologiche un inedito rapporto di maestro-allievo tra il semisconosciuto pittore urbinate Timoteo Viti e il giovane Raffaello, ma definiva la portata di personalità artistiche come Perugino e Pinturicchio trasferendo loro un gran numero di dipinti e disegni già dati a Raffaello (Gibson-Wood 1988, pp. 205-206; Ferino Pagden 1993).
Proprio il caso Raffaello, d�altra parte, chiariva una volta per tutte la natura degli indici decisivi per la felice applicazione di questo metodo at-tributivo, �semiologico e analitico avant la lettre� (Damisch 1970, p. 71). Se i dettagli metodologicamente più significativi sono ricavati in primo luo-go dalla �rigorosa osservazione delle forme e della calligrafia del corpo umano� (Morelli 1886, p. 5), solo un indagatore esperto, padrone della �grammatica dell�arte�, infatti, è in grado di classificare correttamente le forme caratteristiche di Raffaello e dei Cinquecentisti, la cui maniera, per la costante dissimulazione delle asperità nella rappresentazione della figu-ra umana, genera indeterminatezza, disomogeneità, polisemia, e rischia di produrre una pericolosa politomia epistemologica. Solo un occhio educato �con grande fatica e con molti anni di studio� arriva ad isolare sotto �il fino senso della grazia� di Raffaello il �largo metacarpo colle dita ancora un po� impacciate� e a focalizzare �le unghie che non giungono fino alle estremità delle dita� come caratteristiche del suo stile giovanile. Al contrario, la rilevanza del �substrato osseo� sotto �l�involucro della carne�, tipica delle figure di Pollaiolo, Signorelli, Filippo Lippi o Botticelli, e, più in generale, dei maestri del Quattrocento, consente anche al �conoscitore novizio� una soluzione univoca dei casi attributivi. La mano con le dita ossute, le unghie quadrate dai contorni ben segnati, il naso grosso con le narici larghe e il cranio pronunciato che ricorrono nelle figure di Botticelli, infatti, rendono la sua maniera pittorica trasparente al procedimento critico (Morelli 1991, pp. 51-52 e 61-62).
FISIOGNOMICA DEL SENSO80
Non troppo diversamente, nel 1894, Charles Sanders Peirce avrebbe paragonato, con una sorprendente metafora allo stesso tempo morfologica e biologica, la funzione strutturante dei segni-indici �to the hard parts of the body�, �nails, teeth, hair, and bones�, che, pur necessari alla vita, sono, a differenza dei �living tissues� come il sangue, o delle somiglianze, definitiva-mente sottratti alle continue trasformazioni dei processi metabolici (Fimiani 2009, p. 177).
Per Morelli, dunque, la storia dell�arte è scienza dell�arte istruita nella disciplina catalogatrice e la precisione percettiva dell�occhio, e si costituisce come successione di singoli casi attributivi, analizzati nella dimensione ri-gidamente sincronica e stilisticamente omogenea della Kennerschaft (Previtali 1978, p. 29).
Da questo punto di vista, Morelli è �uno storico dell�arte malgré lui� (Panofsky 1997, p. 27): nei suoi lavori, infatti, la ricostruzione delle fisio-nomie delle scuole regionali suggerisce l�aspirazione ad un modello storio-grafico autonomo dal coinvolgimento di �regioni più alte del pensiero�, dal principio di gusto o di bellezza, per esempio (Morelli 1991, p. 31), e essenzialmente organico, in analogia con lo sviluppo della lingua. La �fisio-nomia generale� delle scuole pittoriche italiane per Morelli si definisce nella medesima �coesione organica� con il territorio di origine che determina la �diversità della razza� e le parlate regionali. Come il �linguaggio della parola�, il �linguaggio della forma� è un organismo vivente generato dal �suolo nativo� che �parla da per tutto la lingua del popolo, cioè il dialetto�: ma se, in Italia, il �linguaggio della parola� si è cristallizzato nella forma della lingua letteraria, quello dell�arte non ha perduto le sue caratteristiche locali né la sua determinazione a svilupparsi organicamente, come dimo-stra la coerenza morfologica delle opere di una determinata scuola (Morelli 1886, pp. 6-7). Se i singoli individui partecipano all�evoluzione della stirpe, i singoli artisti contribuiscono allo sviluppo naturale dell�organismo-scuola con le proprie caratteristiche individuali e le variabili della propria personalità, che, d�altra parte, si trasforma sempre secondo natura, �dall�interno�, e mai nel �casuale caotico scambio di influssi esterni� (Levi 1987, p. 35; Trotta 2006, pp. 88-100).
Così si spiegano, per esempio, le divergenze nell�intonazione cromatica tra due allievi di Palma il Vecchio come il bergamasco Giovanni Cariani e Bonifazio Veronese (Morelli 1886, pp. 182-183, 193); si chiarisce lo sviluppo della scuola veneziana �dalla nascita alla morte�, e, addirittura, si può azzar-dare l�ipotesi della fine per necessaria consunzione dell��arte barocca�, che �morì di morte naturale� ben prima che Canova, David, Carstens o Cornelius fondassero �la così detta arte nuova� (ivi, p. 6).
FIGURE DEL CORPO E SCIENZA DELL�ATTRIBUZIONE 81
Ma, se il compito del conoscitore è indagare la grammatica dell�arte, le �forme di cui il genio popolare fa uso nella lingua dell�arte� non sono tutte egualmente eloquenti, e più che dai dipinti, spesso sfigurati dal tempo o da restauri maldestri, per Morelli �i tratti particolari tanto spirituali quanto materiali dei diversi maestri e delle diverse scuole� sono provati dai disegni, già identificati come ortografia della pittura da una lunga tradizione critica (Barbillon 2008): essi espongono, infatti, �tutto l�uomo senza maschera e senza artifizi� e consentono di ricostruire più correttamente le genealogie sti-listiche che articolano �la storia dell�arte di un popolo� (Morelli 1886, pp. 10-11). È questa la via che ha sollecitato lo studio scientifico del disegno tra Ottocento e Novecento, da Gustavo Frizzoni, Adolfo Venturi e Corrado Ricci, a Moritz Thausing e Franz Wichoff, a Bernard Berenson, Heinri-ch Wöfflin, Hans Tietze, e Bernhard Degenhart che, nel 1937, avrebbe preteso di isolare nei disegni dei maestri italiani una costante grafica (Zelle der Strichgruppe) etnicamente e geograficamente determinata che, impressa nell�inconscio dell�artista, definiva il carattere dello stile individuale e della scuola regionale (Sciolla 1983/1984, 2009). Ma, se �blood is thicker than water�, scriveva Tietze nel 1944, �then spirit is surely stronger than blood�: le scuole italiane del Rinascimento sono innanzitutto un concetto storico, una complessa unità artistica che si istruisce tanto negli effetti della risposta attiva agli impulsi esterni quanto nei risultati del suo stesso potere attrattivo, e assorbe solo alcuni degli artisti �born and trained� nel suo territorio. Esse sono �not a natural product, but a spiritual power� (Tieze, Tieze-Conrat 1970, pp. 2-3).
2. Il volto della pittura
Per Morelli, invece, la dimostrazione della coesione organica dello stile con l�ambiente fisico che lo genera si spinge fino all�estrema conclusione che non solo il carattere di ciascuna scuola pittorica corrisponde al carattere della popolazione della medesima area geografica, ma anche che le attitudini fisiche e mentali dei compatrioti costituiscono il lessico comune e fondativo del linguaggio pittorico di artisti di una stessa scuola. Per questo, non solo l��arte figurativa� deve essere studiata in situ, con la medesima applicazione che richiede l�apprendimento di una lingua straniera (Morelli 1886, pp. 6-7), ma il riconoscimento dei suoi più intimi caratteri può essere condizionato dalla nazionalità di chi vi si applica. I tedeschi, ad esempio, per una sorta di mancanza dovuta alle proprie caratteristiche nazionali, oltre che per difetto di metodo, �on pris souvent des courges pour des figues� (Morelli a Layard,
FISIOGNOMICA DEL SENSO82
20 giugno 1884, in Gibson-Wood 1988, p. 191). Proprio come chi �non ben pratico dei dialetti parlati nel nostro paese, non riesce a distinguere a pieno le analogie e differenze� (Frizzoni 1888, p. 293).
Il tema, che investiva tanto le ragioni della storia dell�arte quanto i moventi del contemporaneo processo di costruzione dell�identità naziona-le, per Morelli, che scriveva in tedesco, era innanzitutto un efficace stru-mento di propaganda nell�ambiziosa battaglia di affermazione culturale e metodologica che il �partito Lermolieff� intendeva condurre nel corpo vivo del sistema dell�arte (Frizzoni 1991, pp. 358-359)2. ln Germania, infatti, la recente disputa sulla Madonna del Borgomastro Meyer, accesa dalla grande mostra di Dresda su Hans Holbein � il �Raffaello tedesco� � nell�anno fondativo dell�Impero, e che aveva coinvolto personalità del calibro di Thau-sing, Lützow, Waagen e Wilehm von Bode, aveva dimostrato, a partire dal riconoscimento dei caratteri artistici nazionali, la definitiva affermazione della recente ricerca storico-artistica negli studi accademici e nelle istituzioni museali (Kultermann 1997, pp. 137-142; Brown, Van Nimmen 2005, pp. 223-228). Ai risultati, insieme descrittivi e normativi, della Kunstwissenschaft tedesca, Morelli e i �morelliani� � Gustavo Frizzoni e Jean Paul Richter per primi � opponevano invece un progetto metodologico, analitico e valutativo, che, attraverso la riconsiderazione di un gran numero di personalità artisti-che, ridefiniva i contorni delle scuole regionali del Rinascimento italiano, riscriveva i cataloghi dei musei e riorientava gli interessi dei collezionisti e le strategie del mercato dell�arte.
Inoltre, il procedimento critico di Morelli si radicava profondamente nella cultura tedesca: il principio della coesione organica che presiedeva all�organizzazione dei dati visivi in griglie comparative, infatti, si iscriveva di diritto in quella tradizione settecentesca della Veirgleichung che, a partire dal principio unificante della forma della Naturphilosophie, nel XIX secolo in Germania si formalizzava nelle istituzioni di un sistema comparato della storia naturale, passando per il comparativismo geografico e linguistico di Alexander e Wilhelm von Humboldt e la fortuna del modello dell�anatomia comparata di Georges Cuvier nella definizione dello statuto di alcune di-
2 Per Frizzoni, d�altra parte, Morelli �è pratico della loro lingua quasi al pari della propria�, al punto di trovare favorevole alla sua esposizione �la ricchezza della lingua germanica�. Al contrario, i tedeschi masticano malamente l�italiano: Karl Friedrich von Ruhmor, per esempio, era andato incontro ad un disastro interpretativo a proposito del Ritratto di Bindo Altoviti di Raffaello per una lettura fuorviante del testo vasariano: �now I myself have the greatest respect for learning�, scriveva a questo proposito Morelli, ma �the German critic would have acted more discreetly� se non si fosse assunto l�onere della traduzione (Morelli 1907, p. 113).
FIGURE DEL CORPO E SCIENZA DELL�ATTRIBUZIONE 83
scipline scientifiche contemporanee. In particolare, confortato dagli anni di studio monacesi e dall�esperienza diretta del felice adattamento del modello anatomico ad un diverso campo di ricerca3, Morelli poteva identificare �un Botticelli o un Giorgione partendo da un particolare caratteristico o da una serie di particolari caratteristici e correlati�, così come Cuvier aveva ricostruito gli organismi di creature scomparse grazie all�istruzione di una tassonomia funzionale fondata sulla classificazione di un numero rilevante di frammenti ossei diversi. Per Jaynie Anderson questa �ovvia� analogia con il procedimento, essenzialmente quantitativo e tipizzante, dell�anatomia comparata consente di sgomberare il campo dalle interpretazioni in chiave �investigativa� del metodo morelliano e dall�assimilazione, a partire dalla comune radice indiziaria, di tale procedimento al modello, qualitativo e individualizzante, della semeiotica medica proposto da Carlo Ginzburg (Anderson 1991, pp. 494-505). Se per Ginzburg, infatti, Morelli si inserisce in un lungo percorso epistemologico che stringe insieme i saperi fondati sulla induzione delle cause dagli effetti grazie all�analisi di indizi e sintomi individuali � dalla cultura venatoria alla grafologia, dalla criminologia alla psicanalisi (Ginzburg 1986) � per la Anderson, invece, Morelli lavora, come un botanico o uno zoologo, alla comparazione dei soli caratteri esteriori della forma, in quanto �nei dipinti, come nella morfologia delle piante, niente è nascosto� (Pau 1993). Come Cuvier era un �antiquarie d�une espèce nouvelle�, Morelli, che trasferiva i principi della descrizione e della classificazione degli organismi naturali all�analisi dei prodotti dell�attività umana, era il fondatore di una nuova scienza dell�arte (Anderson 1991, p. 502).
Eppure, i contemporanei vedevano chiaramente nel metodo morellia-no un�estensione della semeiotica medica e, più in generale, un�applicazio-ne del paradigma indiziario. Nel 1894, su «Nineteenth Century» il critico Charles Whibley ricordava al pubblico anglosassone, presso cui il metodo morelliano godeva di un certo successo, che questa scienza dell�arte non era che �anthropometry (so to say) of art criticism�: il catalogo delle forme ca-ratteristiche di Morelli, infatti, non era che una variazione delle complesse schede antropometriche con cui Alphonse Bertillon, il fondatore del Service d�identité judiciaire di Parigi, dal 1883 individuava le qualità del singolo soggetto dall�analisi quantitativa delle caratteristiche fisiche dell�intera po-
3 Morelli, per esempio, riconosceva apertamente una contiguità metodologica tra la scienza dell�attribuzione e il �vedere bene� su cui si fondavano gli studi di Louis Agassiz, che, allievo di Dollinger, aveva trasferito agli studi geologici l�attenzione alla comparazione morfologica di Cuvier (Morelli 1991, p. 86).
FISIOGNOMICA DEL SENSO84
polazione (Briefel 2006, p. 58)4. Nel 1881, Anton Springer, professore di storia dell�arte a Lipsia e generoso patrocinatore del metodo e dei risultati degli studi morelliani, in una recensione dal titolo Kunstkenner und Kunsthisto-riker, riconduceva l�attenzione di Morelli a dettagli come il contorno delle orecchie e la forma dei lobi o il dorso della mano � per Springer ormai imprescindibili per qualunque analisi attributiva � alla professione medica che lo studioso avrebbe esercitato in gioventù (Brown, Van Nimmen 2005, p. 127). Ancora, nel 1891, Bode, direttore del Kaiser Friedrich Museum di Berlino e acerrimo oppositore di Morelli tanto nel dibattito sullo statuto della storia dell�arte quanto nel mercato, non esitava a denunciare il conoscitore italiano come un �quack doctor�: �as a surgeon�, scriveva, Morelli ha stu-diato l�anatomia umana concludendo che gli Antichi Maestri trasferiscono le proprie caratteristiche fisiche �even in painting portraits�, e ha compilato un catalogo di �ears, noses, and fingers, the former property of Sandro, Mantegna, Raphael, Titian and Co.�, con cui ha preteso di individuare �unerrengly� ciascun artista (Anderson 1996)5.
In realtà, il metodo morelliano doveva apparire in primo luogo istruito nei principi tipologici ed individualizzanti della fisiognomica e delle sue più recenti declinazioni, dalla frenologia alla craniologia, che, se pure ormai largamente in discredito presso i più avanzati circoli culturali, erano assai influenti presso il pubblico ampio. Anche Charles Darwin, alla cui lezione rivoluzionaria lo stesso Morelli richiamava il suo metodo d�analisi (Morelli 1886, p. 4), al di là delle affermazioni di principio, non ne aveva dismesso completamente i criteri generali in The Expression of the Emotions (1872), sia pure riconcettualizzandoli in termini di sviluppo e evoluzione (Smith 2006, pp. 180-214). Inoltre, il successo dei Physiognomische Fragmente di Lavater, così spesso ripubblicati, riletti, parodiati e riassunti tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo da essere noti a chiunque avesse una certa cultura
4 È utile ricordare che il lavoro di Bertillon, come le illustrazioni che accompagnavano i suoi volumi pubblicati, tra la fine del XIX e il principio del XX secolo erano materiali di studio tanto per gli anatomisti che per gli artisti. L�Anatomie artistique (1890) di Paul Richer, medico e professore di anatomia all�École des Beaux-arts di Parigi dal 1903 al 1922, per esempio, ispirato al motto di Cuvier �ordonner en voyant� e dedicata a medici e artisti, ne era fortemente influenzato (Comar 2009, pp. 56-57). Ancora, sulla contemporanea fortuna dell�applicazione dei metodi e degli strumenti di analisi giudiziari all�esame delle opere d�arte, cfr. Cardinali, De Ruggieri, Falcucci 2007. Negli anni Quaranta del Novecento, per lo sto-rico dell�arte Max Friedländer, la connoisseurship è essenzialmente una disciplina investigativa: �Di fronte al mascheramento, all�affettazione e all�ipocrisia che intorbidano l�arte, l�esperto diventa un criminalista� (Friedländer 1995, p. 154).
5 Morelli, che non aveva mai esercitato la professione medica, reagiva piuttosto vivace-mente a chi sottolineava tali analogie: cfr. Anderson 1991, pp. 494-495.
FIGURE DEL CORPO E SCIENZA DELL�ATTRIBUZIONE 85
letteraria, si doveva alla loro presunta applicabilità all�organizzazione della vita quotidiana, alla difesa dell�ordine sociale, alla medicina, alla letteratura, ma anche all�insegnamento nelle Accademie di Belle Arti e alla connoisseurship (Graham 1979). Lavater, egli stesso distinto connoisseur, infatti, considerava le figure dipinte utili all�esercizio fisiognomico come i corpi in carne e ossa, e, nei Saggi illustrava le caratteristiche della fisionomia umana fondamentali per il suo lavoro con dettagli copiati, più o meno fedelmente, da dipinti o sculture. Questi particolari, fissati nello stile e trasparenti all�analisi più dei dati dell�osservazione diretta della natura, in Lavater sollecitavano allo stesso tempo il discorso fisiognomico sulle qualità dell�effigiato e il giudizio estetico sulla qualità dello stile, entrambi strumenti per la promozione di �the knowledge and love of mankind� (Percival 2003, pp. 77-78). E se per Jonathan Richardson la scienza del conoscitore consisteva in �nicely to di-stinguish things nearly resembling one another�, non doveva essere difficile, per i contemporanei, ricondurre la competenza dell�occhio esercitato di Morelli alla distinzione dell�occhio del fisiognomista che, grazie allo studio prolungato e ad una larga conoscenza del mondo, discriminava �fundamen-tal features� che sfuggivano al quotidiano istinto fisiognomico della gente comune (Stafford 1993, p. 84). Né doveva esser strano assimilare le famose tavole di dettagli anatomici tratti dai dipinti dei maestri del Rinascimento pubblicate dal conoscitore italiano nel volume sulle gallerie tedesche alle esemplificazioni fisiognomiche delle illustrazioni di Lavater. Tanto più che, le dispute accese in Germania intorno al Ritratto di Bindo Altoviti di Raffaello della pinacoteca di Monaco nella seconda metà del secolo e culminate nel 1883, in occasione delle celebrazioni per il quarto centenario della nascita dell�Urbinate, dimostravano ancora la vitalità negli studi storico-artistici del-l�applicazione di un modello interpretativo �diagnostico� e, sostanzialmente, fisiognomico (Brown, Van Nimmen 2006, pp. 108-118).
3. Identità
Sia pure �per malignità o ignoranza�, da questo punto di vista il metodo morelliano a buon diritto poteva apparire una classificazione artificiale, ricavata cioè dalla valutazione di un numero ristretto di somiglianze e differenze6. Per
6 D�altra parte, i notissimi diagrammi anatomici che illustravano il suo metodo attributivo riguardavano solo pochi dettagli caratteristici, in particolare la forma della mano e dell�orec-chio. Gustavo Frizzoni, allievo e traduttore in italiano di Morelli, infatti, preferì ometterle nelle edizioni delle opere del maestro da lui curate (Anderson 1991, p. 502).
FISIOGNOMICA DEL SENSO86
uno scienziato della sua generazione si trattava di un grave fraintendimento, che Morelli intendeva chiarire affermando la discendenza diretta del suo procedimento dal metodo sperimentale di Leonardo, di Galileo, e soprattut-to di Darwin, che aveva basato The Origin of Species (1859) manifestamente sulla classificazione naturale (Anderson 1991, p. 502). Al di là delle dichiara-zioni di principio e delle accuse dei detrattori, però, la maggior parte delle analisi di Morelli si organizzano soltanto intorno a pochi dettagli anatomici fondamentali, come radicatamente fisiognomici sono, lo ha già sottolineato Carolyn Gibson-Wood, la sua teoria dello stile e il concetto di personalità artistica (Gibson-Wood 1988, pp. 213-216). Per Morelli, infatti, come le at-titudini mentali e le caratteristiche fisiche locali definiscono gli stili regionali, quelle dei singoli artisti determinano lo stile individuale: a proposito della scuola ferrarese, che ha acquistato il suo �peculiare carattere locale� solo nel Quattrocento, negli studi sulle gallerie tedesche Morelli definisce senza mezzi termini Cosmè Tura pittore �il duro, ruvido e angoloso, ma anche grandioso� e Francesco Cossa �severo, talvolta un po� burbero, il quale ha delle affinità col Tura, ma mai grottesco come lui�. Poiché �la forma esteriore della figura umana non è accidentale ma dipende da cause spirituali� (Morelli 1886, pp. 105-106), le opere d�arte sono un�estensione dell�artista e contengono i segni esteriori dei tratti interiori del maestro: �il carattere o lo stile di un�opera d�arte, scriveva Morelli, nasce insieme con l�idea, o per parlare più chiaramente, l�idea dell�artista genera la forma e determina il carattere e lo stile� (Morelli 1991, p. 86) e, poiché ciascun artista non solo �vede le forme alla sua propria maniera� (ivi, p. 40) ma spesso traspone in pittura �taluni difetti e bruttezze fisiche sue proprie� (ivi, p. 87), l�analisi dei dettagli caratteristici ne restituisce tanto la personalità artistica quanto l�identità psicofisica. Il metodo morelliano, infatti, procede dalla forma allo spirito e dallo spirito alla forma (ivi, p. 86).
Non sorprende, allora, che per Morelli lo studio dei ritratti sia �certo uno dei più interessanti che possa presentarsi ad uno storico dell�arte� e banco di prova del suo modello interpretativo (ivi, p. 70). Ancora nella lunga premessa metodologica agli studi sulle gallerie romane � nell�edizione tedesca signifi-cativamente intitolata Kunstkenner und Kunsthistoriker � è dedicato infatti ampio spazio all�analisi della Velata di Palazzo Pitti, il celebrato ritratto dell�amante di Raffaello allora attribuito ad un oscuro copista bolognese del XVII secolo: �tipo autentico di donna romana� del Rinascimento, per Morelli questa �maestosa e veramente nobile testa� poteva essere stata �concepita e dipinta� solo da Raffaello che, per amore e per stile, ne aveva dissimulato le origini popolari in un �mirabile sguardo�, una �altera bocca�, una �nobile fronte�. Tanto più che, qualche anno più tardi e dopo la morte del maestro, �uno
FIGURE DEL CORPO E SCIENZA DELL�ATTRIBUZIONE 87
dei suoi scolari�, con maggiore freddezza d�animo e di stile, avrebbe ritratto il medesimo soggetto �in un modo così comune e ripugnante che si direb-be veramente d�aver dinanzi una donna della più abietta condizione�7. In conclusione, la presenza della �forma fondamentale� e �affatto raffaellesca� dell�orecchio �carnoso e rotondo�, vera e propria caratteristica invariante nel catalogo dell�Urbinate, dalla giovinezza alla maturità, allontanavano qualun-que dubbio sull�autografia del dipinto (ivi, pp. 69-70). Nel medesimo volume, inoltre, il doppio registro della deduzione dell�identità del soggetto e della personalità del pittore sostiene lo studio del Ritratto d�uomo di Lorenzo Lotto della Galleria Doria Pamphili: il soggetto, sebbene �ancora in fresca età�, è pallido, �tiene la mano sul cuore, come se ivi avesse sede il dolore�, �non è elegante, secondo il significato usuale della parola�, ma la sua figura corri-sponde �in tutto all�espressione di profonda mestizia dei tratti del suo viso�. Il dipinto, firmato, è inequivocabilmente di Lotto e solo per un�incongruenza cronologica non è possibile considerarlo un autoritratto dell�artista, noto per la sua natura �eccitabile, nervosa e chiusa in se stessa�, per il �temperamento malinconico� e la �tristezza d�animo� (ivi, p. 318).
In definitiva, come la fisiognomica scompone la fisionomia umana, rin-traccia le intime connessioni e i rapporti tra ogni parte, e la ricompone in una sorta di grafologia del carattere allo scopo di figurare �the whole man to an experienced eye� (Stafford 1993, p. 96), lo sguardo metodologico di Morelli isola alcuni dettagli come fondamentali della grammatica della forma di cia-scun maestro, ne istruisce la coerenza in quanto indici della personalità artistica e, infine, istituisce una teoria dello stile inteso come carattere del carattere.
Inoltre, il metodo attributivo definisce non solo lo statuto del suo oggetto di studio, ma anche la distinzione intellettuale, culturale e fisica di chi lo ap-plica: se di una fisionomia lo sguardo comune non nota che �un porro sulla fronte�, �un labbro leporino�, �il naso camuso�, gli �occhi azzurri invece di neri�, l�occhio del connoisseur scopre infatti �un significato spirituale nel volto umano, nella forma e nel movimento della mano, nella postura del corpo, insomma in tutto quanto spetta alla figura dell�uomo� grazie ad una disposi-zione naturale e al lungo studio (Morelli 1991, p. 21). E, mentre lo spettatore comune si perde davanti alla maniera degli Antichi Maestri, il conoscitore, di �robusta ed aitante� costituzione fisica e �portamento dignitoso pari alla
7 Si tratta della Fornarina di Palazzo Barberini che Morelli, come Quatremère de Quincy ma diversamente dai contemporanei Müntz e Crowe e Cavalcaselle, considerava opera di Giulio Romano. Per la ricostruzione della fortuna critica del dipinto, com�è noto oggi riconosciuto come opera completamente autografa di Raffaello, anche grazie ai risultati dal recente restauro, cfr. almeno Mochi Onori 2000, pp. 5-18.
FISIOGNOMICA DEL SENSO88
naturale giovialità del suo spirito�, con �mente colta� (Frizzoni 1991, p. 370) ma cranio sgombro da �protuberanze filosofiche�, rimane padrone di sé (Morelli 1991, pp. 38 e 69). Oppure, ironizzavano i contemporanei, risponde con eccezionale intensità: per il caricaturista inglese George du Maurier, infatti, gli effetti caratteristici di un expertise ben condotto erano afasia improvvisa, disturbi gastro-intestinali e dell�udito, perdita di equili-brio e repentini sbalzi di umore (Briefel 2006, p. 64)8. Al contrario, il plain man, cui sfugge l�apprezzamento competente del linguaggio dell�arte, al più può essere afflitto da un fastidioso �aesthetic headache�, come accade al protagonista di The American di Henry James (1877) che, fisiognomicamente caratterizzato come �national type� e �undeveloped connoisseur�, al Louvre era stato costretto ad allungarsi su un divano al centro del Salon Carré tanto era spossato dall�indecifrabile �new kind of arithmetic� di Raffello, Tiziano e Rubens (James 1978, p. 17).
Human connoisseurship, allo stesso tempo democratico ed elitario, da que-sto punto di vista il metodo morelliano sembrava passare i limiti del dominio specialistico del mondo dell�arte per rispecchiare i principi e incorporare le competenze in cui la contemporanea classe borghese istruiva quotidiana-mente la propria distinzione fisica, culturale e sociale. Mentre in città il volto anonimo della folla, infatti, sconvolge le gerarchie e moltiplica le identità, la nuova classe media, educata dal romanzo naturalista e dalla detective story ad individuare dai dettagli il fisico borghese e quello popolare, le vittime e i colpevoli, intende distinguersi � e, se necessario, difendersi � scrutando �il corpo altrui� come �una collezione di dettagli da rilevare, di individui da interpretare� (Courtine, Haroche 1992, p. 179). D�altra parte, Morelli non riconosceva forse la personalità artistica di Botticelli dalla mano �plebea�, dalla unghie tozze e nere, e quella di Raffaello dal carattere �molto casalingo e borghese� delle sue mani? (Morelli 1991, pp. 91 e 89).
Per questo, nel 1910, Paul Bourget il sottile indagatore delle attitudini e le idiosincrasie del suo tempo in un décor mondain, adattando il romanzo naturalista ad un pubblico colto non aveva esitato ad utilizzare la scienza dell�attribuzione come chiave di volta per dipanare una vicenda di passio-ni private e di comportamenti pubblici della borghesia sullo sfondo della �manie particulière� del secolo, il collezionismo di Antichi Maestri (Bourget 1993).
8 I medesimi sintomi sembra cogliessero, per ammissione di entrambi, Bernard Berenson, storico dell�arte, straordinario conoscitore e discepolo, sia pure talvolta infedele, di Morelli e Thomas Hoving, curatore del Metropolitan Museum negli anni Settanta (Hoving 1997, pp. 19-20).
FIGURE DEL CORPO E SCIENZA DELL�ATTRIBUZIONE 89
�What is technically called connoisseurship�, avrebbe scritto Lady Ea-stlake in un emozionato necrologio di Morelli, richiede un�ampia gamma di attitudini intellettuali, dall�acutezza dell�avvocato alla capacità diagnostica del fisiologo fino all�abilità ad indagare il passato dell�antiquario e dello storico e si configura come un sapere pratico che �most of us are practicing every day, more or less consciously, the art of comparison�: la connoisseurship, concludeva, �is a modern profession, because a modern necessity� (Briefel 2006, p. 56).
Bibliografia
About Ilsen, Les fondations d�un système national d�identification policière en France (1893-1914). Anthropométrie, signalements et fichiers, «Genèses», 54 (2004), pp. 28-52.
Abruzzese Alberto (1991), Metafore della pubblicità, Costa & Nolan, Genova.� (2003), Lessico della comunicazione, Meltemi, Roma.Ackermann Marion, Friedel Helmut (hg.) (2001), ShattenRisse. Sihouetten und Cutouts,
Hatje Cantz, Ostfildern.Agamben Giorgio (2008), Signatura rerum. Sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino.Agosti Giacomo, Manca Maria Elisabetta, Panzeri Matteo (a cura di) (1993), Giovan-
ni Morelli e la cultura dei conoscitori (Atti del convegno internazionale, Bergamo 1987), 3 voll., Lubrina, Bergamo.
Albano Leoni Federico (2002), Sulla voce, in A. De Dominicis (a cura di), La voce come bene culturale, Carocci, Roma, pp. 41-65.
� (2003), I correlati spettroacustici di una �voce leggermente rauca, con un tono di sarcasmo quasi amaro�. Fonetica e linguistica della parole, in E. Magno Caldognetto, P. Cosi Piero (a cura di), Voce, canto, parlato. Studi in onore di Franco Ferrero, Unipress, Padova, pp. 31-36.
� (2007), Saussure, la sillaba e il fonema, in De Palo, Elia 2007, pp. 56-85.� (2009), Dei suoni e dei sensi. Il volto fonico delle parole, il Mulino, Bologna.� (in stampa), Karl Bühler et la physionomie acoustique des mots: les occasions manquées de
la phonologie, in D. Samain et al. (éds.), Karl Bühler penseur du langage. Linguistique, psychologie et philosophie (Actes du colloque international, Paris 2009).
Albano Leoni Federico, Maturi Pietro (1992), Per una verifica pragmatica dei modelli fonologici, in G. Gobber (a cura di), La linguistica pragmatica, Bulzoni, Roma, pp. 39-49.
Amendola Alfonso (2001), Melò. Del tumultuoso divenire delle passioni, in G. Frezza (a cura di), Fino all�ultimo film. L�evoluzione dei generi nel cinema, Editori Riuniti, Roma, pp. 129-161.
� (2002), Carmelo Bene. Un�avanguardia audiovisiva tra reinvenzione e riscrittura simbolica, in A. Cicalese, A. Landi (a cura di), Simboli, linguaggi e contesti, Carocci, Roma, pp. 17-27.
� (2006), Frammenti d�immagine. Scene, schermi, video per una sociologia della sperimentazione, Liguori, Napoli.
� (2009a), Il desiderio nel cinema di Jean Vigo e Rainer Werner Fassbinder. Due modelli, due tentazioni visionarie e politiche, in A. Amendola, E. D�agostino, S. Santanicola
BIBLIOGRAFIA146
(a cura di), Il desiderio preso per la coda. Modelli, teorie, rappresentazioni, Plectica, Salerno, pp. 141-156.
� (2009b), Lo specchio e l�implosione. Jean Baudrillard sociologo dei media, in E. de Con-ciliis (a cura di), Jean Baudrillard o la dissimulazione del reale, Mimesis, Milano, pp. 23-38.
Anderson Jaynie, Giovanni Morelli et sa définition de la �scienza dell�arte�, «Revue de l�art», 75 (1987), pp. 49-55.
� �The geniale Bettina�: Giovanni Morelli in Conversation with Bettina von Arnim, «Oxford German Studies», 18-19 (1989/1990), pp. 48-51.
� (1991), Dietro lo pseudonimo, in Morelli 1991, pp. 494-578.� The Political Power of Connoisseurship in Nineteenth-Century Europe: Wilhelm von Bode
versus Giovanni Morelli, «Jahrbuch der Berliner Museen», 38 (1996), pp. 107-119.
Andronico Marilena (1997), Giochi linguistici e forma di vita, in Marconi 1997, pp. 241-286.
Arnheim Rudolf (1989), Film come arte (1960), Feltrinelli, Milano.Austin John L. (1987), Come fare cose con le parole (1962), Marietti, Genova.
Baer Ulrich, Photography and Hysteria: Toward a Poetics of the Flash, «Yale Journal of Criticism», 7 (1994), pp. 41-77.
Baker Gordon P. (2004), Wittgenstein�s Method. Neglected Aspects, Blackwell, Oxford.Balázs Béla (1987), Il film. Evoluzione ed essenza di un�arte nuova (1952), Einaudi, To-
rino.Baqué Dominique (éd.) (1993), Les Documents de la modernité. Anthologie de textes sur la
photographie de 1919 à 1939, J. Chambon, Nîmes.Barbillon Claire (2008), La grammaire comme modèle de l�histoire de l�art, in R. Recht et
al. (éd.), Histoire de l�histoire de l�art en France au XIX siècle, La documentation Française, Paris, pp. 433-446.
Barjavel René (2001), Cinema totale. Saggio sulle forme future del cinema (1944), Editori Riuniti, Roma.
Barthes Roland (1970), L�Impero dei segni (1970), Einaudi, Torino.Bartholeyns Gil, Golsenne Thomas (2010), Une théorie des actes d�images, in G. Bar-
tholenys, A. Dierkens, Th. Golsenne (éds.), La performance des images, Éditions de l�Université de Bruxelles, Bruxelles, pp. 15-25.
Basso Fossali Pierluigi, Dondero Maria Luigia (2008), Semiotica della Fotografia, Gua-raldi, Rimini.
Baudrillard Jean (1996), Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? (1995), Cor-tina, Milano.
Baxandall Michael (2000), Forme dell�intenzione (1985), Einaudi, Torino.Belting Hans (2001), Bild-Anthropologie, W. Fink Verlag, München.
BIBLIOGRAFIA 147
Benjamin Walter (1982), Pittura e grafica (1917-1918), in Id., Metafisica della gioventù. Scritti 1910-1918, Einaudi, Torino, pp. 202-204.
� (1982a), Sulla pittura ovvero Zeichen e Mal (1917-1918), ivi, pp. 205-209.� (2004), Lettera da Parigi [II]: Pittura e Fotografia (1936), in Id., Opere Complete VI.
Scritti 1934-1937, Einaudi, Torino, pp. 441-459.Bergfelder Tim, Harris Sue, Street Sarah (eds.) (2007), Film Architecture and the Tran-
snational Imagination. Set Design in 1930s European Cinema, Amsterdam University Press, Amsterdam.
Bertillon Alphonse (1886), De l�identification par les signalements anthropométriques, Con-férence au Congrès pénitentiaire de Rome (22 décembre 1885), «Archives d�anthropologie criminelle», Masson, Paris, pp. 193-223.
� (1893), Identification anthropométrique. Instructions signalétiques, Imprimerie admini-strative, Melun.
Bettini Maurizio (2000), Guardarsi in faccia a Roma. Le parole dell�apparenza fisica nella cultura latina, in Id., Le orecchie di Hermes. Studi di antropologia e letterature classiche, Torino, Einaudi, pp. 313-356
Böhme Gernot (1995), Atmosphäre, Suhrkamp, Frankfurt a.M..� (1998), Anmutungen. Über das Atmospherische, Tertium, Stuttgart.� (2010), Atmosfere, estasi, messe in scena. L�estetica come teoria generale della percezione
(2001), Christian Marinotti, Milano.Bolinger Dwight (1986), Intonation and Its Parts: Melody in Spoken English, Stanford
University Press, Stanford.� (1989), Intonation and Its Uses. Melody in Grammar and Discourse, Arnold, London.Bonfantini Massimo (2004), La semiosi e l�abduzione, Bompiani, Milano.Bonfantini Massimo, Proni Giampaolo (1983), To guess or not to guess, in Eco, Sebeok
1983, pp. 137-156.Borutti Silvana (2009), Dai sensi ai sensi, in De Luca, Fimiani 2009, pp. 27-39.Bou Núria (2002), Sguardi nel tempo. Mito e passione nel cinema di Hollywood (1996),
Editori Riuniti, Roma.Bourget Paul (1993), La dama che ha perduto il suo pittore (1910), Giunti, Firenze.Brancato Sergio (2007), Senza fine. Immaginario e scrittura della fiction seriale in Italia,
Liguori, Napoli.Breton André (1988), Nadja (1928), in Id., �uvres, vol. I, Gallimard, Paris, 1988.Briefel Aviva (2006), The Deceivers: Art Forgery And Identity in the Nineteenth Century,
Cornell University Press, Ithaca-New York.Brown David Alan, van Nimmen Jane (2005), Raphael and the Beautiful Banker. The
Story of the Bindo Altoviti Portrait, Yale University Press, New Haven-London.Brown Gillian, Yule George (1983), Discourse Analysis, Cambridge University Press,
Cambridge.Bruce Colin (1997), Sherlock Holmes e i misteri della scienza (1997), Cortina, Milano.
BIBLIOGRAFIA148
Brunetta Gian Piero (1974), Nascita del racconto cinematografico, Patron, Bologna.
Bühler Karl (1978), La crisi della psicologia (1927), Armando, Roma.
� (1980), Il principio della Gestalt nella vita dell�uomo e degli animali (1960), Armando, Roma.
� (1983), Teoria del linguaggio. La funzione rappresentativa del linguaggio (1934), Armando, Roma.
� (2009), Théorie du langage (1934), Agone, Marseille.
Burch Noël (1990), Life to Those Shadows, California University Press, Berkley-Lon-don-Los Angeles.
Buzzi Gabriele, D�où ça regard. Appunti sulla significazione del volto, «Ocula», s.n. (2005): http://www.ocula.it/files/buzzi_dou_ca_regarde_%5B147,049Kb%5D.pdf
Cardinali Marco, De Ruggieri Maria Beatrice, Falcucci Claudio (2007), Diagnostica artistica. Tracce materiali per la storia dell�arte e per la conservazione, Palombi Editore, Roma.
Carluccio Giulia (1999), Verso il primo piano. Attrazioni e racconto nel cinema americano. 1908-1909: il caso Griffith-Biograph, Clueb, Bologna.
Caroli Flavio (2002), Storia della fisiognomica. Arte e psicologia da Leonardo a Freud (1995), Electa, Milano.
� (1998), L�Anima e il Volto. Ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon (cat. esp.), Electa, Milano.
Casetti Francesco, Di Chio Ferdinando (2001), Analisi della televisione, Bompiani, Milano.
Cassirer Ernst (2004), Lo strutturalismo nella linguistica moderna (1945), Guida, Napoli.
Cattaruzza Serena (2008), L�indicazione della realtà, Mimesis, Milano.
Cavell Stanley (2000), Il tramonto al tramonto. Wittgenstein filosofo della cultura, in D. Sparti (a cura di), Wittgenstein politico, Feltrinelli, Milano, pp. 64-68.
� (2001), La riscoperta dell�ordinario. La filosofia, lo scetticismo, il tragico (1979), Carocci, Roma.
� L�accessibilité de la seconde philosophie de Wittgenstein, «Europe», 906 (2004), pp. 63-77.
Cerchiai Luca, Le ricette di Circe, «L�incidenza dell�Antico», 5 (2007), pp. 103-144.
Cerri Giovanni (1995), Cosmologia nell�Ade in Omero, Esiodo e Parmenide, in R. Cantile-na (a cura di), Caronte. Un obolo per l�Aldilà (Atti del convegno, Fisciano 1995), «Parola del Passato», L (1995), pp. 437-467.
� (2007), L�Oceano in Omero: un�ipotesi nuova sul percorso di Ulisse, in E. Greco, M. Lom-bardo (a cura di), Atene e l�Occidente. I grandi temi (Atti del convegno internazio-nale, Atene 2006), Scuola Archeologica Italiana di Atene, Atene, pp. 13-51.
Chaplin Charles S. (1993), La mia autobiografia (1964), Rizzoli, Milano.
BIBLIOGRAFIA 149
Charcot Jean-Martin (1892), Clinique des maladies du système nerveux, vol. I, Aux bureaux du Progrès Medical, Paris.
Chauvaud Frédéric (1991), De Pierre Rivière à Landru, La violence apprivoisée au XIXe siècle, Brepols, Bruxelles.
Chauviré Christiane (1992), Présentation de L. Wittgenstein, Leçons et conversations sur l�esthétique, la psychologie et la croyance religieuse, Gallimard, Paris, pp. I-LIV.
� (2003a), Voir le visible. La seconde philosophie de Wittgenstein, PUF, Paris.
� (2003b), Wittgenstein: l��il phénoménologique, in Ead., Le grand miroir. Essais sur Peirce et sur Wittgenstein, Presses universitaires de Franche Compté, Besançon, pp. 343-358.
Chéroux Clément (2009), L�errore fotografico (2003), Einaudi, Torino.
Chomsky Noam (1980), Rules and representations, Basil Blackwell, Oxford.
Coleman John (1998), Phonological Representations. Their Names, Forms and Power, Cam-bridge University Press, Cambridge.
� (2002), Phonetic Representations in the Mental Lexicon, in J. Durand, B. Laks (eds.), Pho-netics, Phonology and Cognition, Oxford University Press, Oxford, pp. 96-130.
Comar Philippe (2009), Une leçon d�anatomie à l�École des Beaux-Arts, in Id. (éd), Figures du corps. Une leçon d�anatomie à l�École des Beaux-Arts (cat. exp.), Beaux-Arts de Paris, Paris, pp. 19-66.
Corbin Alain (1978), Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution aux XIXème et XXème siècles, Aubier, Paris.
Courtine Jean-Jacques, Haroche Claudine (1992), Storia del viso. Esprimere e tacere le emozioni (XIV-XIX secolo) (1988), Sellerio, Palermo.
Cremonini Giorgio (1997), Verso una tecnologia dell�immaginazione, in L. Pellizzari (a cura di), Carlo Rambaldi e gli effetti speciali, Aiep, San Marino.
� (1999), Shining, Lindau, Torino.
Cristin Renato (1997), Nota introduttiva a Kracauer 1997, pp. 7-11.
Cruttenden Alan (1986), Intonation, Cambridge University Press, Cambridge.
D�Agostino Bruno (2003), Scrittura e artigiani sulla rotta per l�Occidente, in S. Marchesini, P. Poccetti (a cura di), Linguistica è Storia � Spachwissenschaft ist Geschichte � Scritti in onore di Carlo De Simone, Giardini, Pisa, pp. 75-84.
� Il valzer delle Sirene, «Annali di Archeologia e Storia Antica», 15/16 (2008/2009), pp. 151-153.
D�Agostino Bruno, Cerchiai Luca (1999), Il mare, la morte e l�amore. I Greci, gli Etruschi e l�immagine, Donzelli, Roma.
Damisch Hubert, La partie et le tout, «Revue d�esthétique», 2 (1970), pp. 168-188.
Davis Norbert (2007), Rendez-vous col terrore (1943) Einaudi, Torino.
Deleuze Gilles (1984), L�immagine-movimento (1983), Ubulibri, Milano.
BIBLIOGRAFIA150
Del Gratta Cosimo, Ebisch Sjoerd J.H., Ferretti Antonio, Gallese Vittorio, Perrucci Mauro, Romani Gian Luca, The sense of touch: embodied simulation in a visuo-tactile mirroring mechanism for the sight of any touch, «Journal of Cognitive Neuroscience», 20 (2008), pp. 1611-1623.
De Luca Pina, Fimiani Filippo (a cura di) (2009), Le immagini i sensi, Mimesis, Mi-lano.
De Mauro Tullio (1965), Introduzione alla semantica, Laterza, Bari.� (1980), Guida all�uso delle parole. Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi
capire, Editori Riuniti, Roma.� (1982), Minisemantica, Laterza, Roma-Bari.De Palo Marina, Elia Annibale (a cura di) (2007), La lezione di Saussure. Saggi di
epistemologia linguistica, Carocci, Roma.De Palo Marina (2009), L�io, i sensi e il linguaggio. Dall�antipsicologismo alla semantica della
persona, in De Luca, Fimiani 2009, pp. 95-112.� Le �je�, la phénoménologie et le discours. Bühler, Benveniste et Husserl, «Beiträge zur
Geschichte des Sprachmissenschaft», 20 (2010), pp. 155-165.Deuber-Mankowsky Astrid (2007), Praktiken der Illusion, Vorwerk, Berlin.Diamond Cora (2006), L�immaginazione e la vita morale, Carocci, Roma.Didi-Huberman Georges (1982), L�invention de l�hystérie. Charcot et l�iconographie photo-
graphique de la Salpêtrière, Macula, Paris.� (1990), Devant l�image, Minuit, Paris.� (1997), L�Empreinte, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris.� (2002), L�image survivante. Histoire de l�art et temps des fantômes selon Aby Warburg,
Minuit, Paris.� (2004), La danse de toute chose, in L. Mannoni, G. Didi-Huberman, Etienne-Jules
Marey, photographe des fluides, Gallimard-RMN, Paris.Ducrot Oswald (1995), Langage et action, in O. Ducrot, J.-M. Schaeffer (éds.), Nouveau
dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, Paris, pp. 641-650.Duval Rémy (1934), Surimpression, in Baqué 1993, pp. 130-132.
Eco Umberto (1975), Trattato di semiotica generale, Bompiani, Bologna.� (1983), Corna, zoccoli, scarpe. Alcune ipotesi su tre tipi di abduzione, in Eco, Sebeok
1983, pp. 235-262.Eco Umberto, Sebeok Thomas A. (a cura di) (1983), Nel segno dei Tre � Dupin, Holmes,
Peirce, Bompiani, Bologna.Edmonds David, Eidinow John (2002), La lite di Cambridge. Quando (e perché) Ludwig
Wittgenstein minacciò Karl Popper con un attizzatoio (mentre Bertrand Russell faceva da arbitro) (2001), Garzanti, Milano.
Ejzen�tejn Sergej M. (1986), La forma cinematografica (1946), Torino, Einaudi.Elkins James (ed.) (2006), Photography Theory, Routledge, London.
BIBLIOGRAFIA 151
Epstein Jean (2002), Fotogenia dell�imponderabile (1935), in Id., L�essenza del cinema, Bi-blioteca di Bianco&Nero, Roma.
Esparza Estaum José Ramón (2009), Fijar una sombra, in V.I. Stoichita (ed.), La Sombra (cat. exp.), Museo Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid, Madrid.
Evans Noel M. (1991), Fits and Starts: a Genealogy of Hysteria in Modern France, Cornell University Press, Ithaca.
Ferino Pagden Sylvia (1993), Raffaello come test-case della validità del metodo morelliano, in Agosti, Manca, Panzeri 1993, vol. II, pp. 331-334.
Ferraris, Maurizio (2004), Goodbye Kant! Cosa resta oggi della Critica della ragion pura, Bompiani, Milano.
Fimiani Filippo (2009), Simulations incorporées et tropismes empathiques, «Images Re-vues. Revue d�Histoire, Anthropologie et Théorie de l�Art de l�Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)» http://www.imagesrevues.org/Arti-cle_Archive.php?id_article=45.
� (2009a), Traces de pas. Atmosphères, affects, images, in B. Rougé (éd.), Mouvoir/Emou-voir: ou la fonction esthétique? (Actes du Colloque international, Pau 2005), Presses Universitaires de Pau, Pau, pp. 177-188.
� (2010), La lutte immobile. Matières, métamorphoses et dialectiques de l�image, in J. Pigeaud (éd.) Métamorphose(s) (Actes du Colloque international, Nantes 2007), Presse Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 353-372.
Floch Jean-Marie (1997), Identità visive. Costruire l�identità a partire dai segni (1995), Franco Angeli, Milano.
Fontanille Jacques (2001), L�osservatore come soggetto enunciativo (1989), in P. Fabbri, G. Marrone (a cura di), Semiotica in nuce. Vol.II. Teoria del discorso, Meltemi, Roma, pp. 44-62.
� (2004), Soma et sema. Figures du corps, Maissoneuve et Larose, Paris.Fortuna Sara (2002), A un secondo sguardo, manifestolibri, Roma.� (2005), Il laboratorio del simbolico. Fisiognomica, percezione, linguaggio da Kant a Steinthal,
Guerra, Perugia.� (2007), Percezione obliqua, linguaggio, gioco dei segni: dal Saussure inedito all�ultimo Witt-
genstein, in De Palo, Elia 2007, pp. 98-114.� (2007a), Alcune osservazioni sulla nozione di aspetto al crocevia tra linguistica, filosofia e
psicologia cognitiva, in G. Andrighetto, D. Femia, R. Petrilli (a cura di), Il filo del discorso. Intrecci testuali, articolazioni linguistiche, composizioni logiche, Aracne, Roma, pp. 141-166.
� (2010), Il giallo di Wittgenstein. Etica e linguaggio tra filosofia e dective story, Mimesis, Milano.
Franzini Elio (2009), Immagini del corpo, in De Luca, Fimiani 2009, pp. 13-25.Franzoni Claudio (2006), Tirannia dello sguardo. Corpo, gesto, espressione dell�arte greca,
Einaudi, Torino.
BIBLIOGRAFIA152
Freedberg David, Gallese Vittorio, Motion, emotion and empathy in aesthetic experience, «Trends in Cognitive Sciences», 11 (2007), pp. 197-203.
Freedberg David (2007), Empathy, Motion and Emotion, in K. Herding, A. Krause Wahl (hg.), Wie sich Gefühle Ausdruck verschaffen: Emotionen in Nahsicht, Driesen, Berlin, pp. 17-51.
� (2009), Movement, Embodiment, Emotion, in Th. Dufrene, A-Ch. Taylor (éds.), Cannibalismes Disciplinaires, Quand l�histoire de l�art et l�anthropologie se rencontrent, INHA/Musée du quai Branly, Paris, pp. 37-61.
Frégier Honoré Antoine (1840), Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes, et des moyens de les rendre meilleures, J-B. Baillière, Londres-Paris.
Freud Sigmund (1967), L�interpretazione dei sogni (1899), in Id., Opere, vol. III, Bollati Boringhieri, Torino.
� (1972), Fantasie isteriche e loro relazione con la bisessualità (1908), ivi., vol. V.� (1976), Introduzione alla psicoanalisi (1916), ivi., vol. VIII.Frezza Gino (1978), L�immagine innocente. Cinema e fumetto americani delle origini, Napo-
leone, Roma.� (2006), Effetto notte. Le metafore del cinema, Meltemi, Roma.Fried Michael (2008), Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University
Press, New Haven-London.Friedrich Janette (2004), Les idées phonologiques de Karl Bühler, in Friedrich, Samain
2004.� (2009), Présentation de K. Bülher, Théorie du langage, Agone, Marseille, pp. 21-
58. Friedrich Janette, Samain Didier (éds.) (2004), Karl Bühler. Science du langage et mé-
moire européenne, Les dossiers d�HEL» [supplément électronique de «Histoire Epistémologie Langage»], Paris, SHESL, 2 (2004): http://htl.linguist.jussieu.fr/dosHEL.htm.
Friedländer Max J. (1995), Il conoscitore d�arte (1946), TEA, Milano.Frizot Michel (éd.) (1985), Identités: de Disderi au photomaton (cat. exp.), éditions Photo
Copies-Centre National de la Photographie, Paris.Frizzoni Gustavo, La quinta edizione del Cicerone di Burckhardt, «Archivio storico del-
l�arte», 1 (1888), pp. 290-296.� (1991), Cenni biografici (1897), in Morelli 1991, pp. 337-374.Furuhata Yuriko, Indexicality as �Symptom�: Photography and Affect, «Semiotica», 174
(2009), pp. 181-202.Fusaroli Riccardo, Sguardo, voce, corpo: un�analisi semiotica di uno spot Playstation 2, «Ocu-
la», 6 (2005) http://www.ocula.it/files/fusaroli06_%5B139,189Kb%5D.pdf
Gargani Aldo (2008), Wittgenstein. Musica, parola, gesto, Cortina, Milano.Garofano Raffaele (1885), Criminologia, Bocca, Torino.
BIBLIOGRAFIA 153
Garroni Giovanni (2005), Elogio dell�imprecisione. Percezione e rappresentazione, Bollati Boringhieri, Torino.
Gatian de Clérambault Gaetan (1942), Les Psychoses hallucinatoires chroniques. Analyse. Pathogenie (1924), in Id., �uvres Psychiatriques, PUF, Paris.
Getsy David (2003), Encountering the Male Nude at the Origins of Modern Sculpture. Rodin, Leighton, Hildebrand, and the Negotiation of Physicality and Temporality, in A. Roesler-Friedenthal, J. Nathan (eds.), The Enduring Instant: Time and the Spectator in the Visual Arts, Gebr. Mann Verlag, Berlin, pp. 296-313.
Gibson James J. (1999), Un approccio ecologico alla percezione visiva (1986), il Mulino, Bologna.
Gibson-Wood Carolyn (1988), Studies in Theory of Connoisseurship from Vasari to Morelli, Garland, New York.
Gilardi Ando (2003), Wanted. Storia, tecnica e estetica della fotografia criminale, segnaletica e giudiziaria (1978), Bruno Mondadori, Milano.
Ginzburg Carlo (1986), Spie. Radici di un paradigma indiziario (1979), in Id., Miti, emblemi e spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino, pp. 158-209.
� (2007), Réflexions sur une hypothèse vingt-ans après, in D. Thouard (éd.), L�interprétation des indices. Enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, Presses Universi-taires du Septentrion, Villeneuve d�Asqc, pp. 37-47.
Giovannoli Renato (2007), Elementare, Wittgenstein!, Medusa, Milano.
Giuffredi Maurizio (2001), Fisiognomica arte e psicologia tra Ottocento e Novecento, CLUEB, Bologna,
Goethe Johann Wolfgang von (1992), Sul Laocoonte (1798), in Id., Scritti sull�arte e la letteratura, Bollati Boringhieri, Torino.
Goffman Erving (1987), Forme del parlare (1981), il Mulino, Bologna.
� (1997), La vita quotidiana come rappresentazione (1956), il Mulino, Bologna.
Gombrich Ernst (1965), Arte e illusione (1960), Einaudi, Torino.
� (1971), Della percezione fisionomica (1960), in Id., A cavallo di un manico di scopa. Saggi di teoria dell�arte, Einaudi, Torino, pp. 69-85.
� (1983), Aby Warburg. Una biografia intellettuale (1970), Feltrinelli, Milano.
Graham John (1979), Lavater�s Essays. A Study in the History of Ideas, Lang, Berna.
Gregory Richard L. (1998), Occhio e cervello. La psicologia del vedere (1996), Cortina, Milano.
Griffero Tonino, Quasi-cose che spariscono e ritornano, senza che però si possa domandare dove siano state nel frattempo. Appunti per un�estetica-ontologia delle atmosfere, «Rivista di estetica», 33 (2006), pp. 45-68.
� Atmosfericità: �Prima impressione� e spazi emozionali, «Aisthesis», 1 (2009), pp. 49-66 http://www.seminariodestetica.it/Aisthesis/03griffero.pdf
� (2010), Atmosferologia. Estetica degli spazi emozionali, Laterza, Roma-Bari.
BIBLIOGRAFIA154
Gros Kenneth (1992), The Dream of the Moving Statue, Cornell University Press, Itha-ca-London.
Guillaume Paul (1968), L�imitation chez l�enfant (1925), PUF, Paris.� (1979), La psychologie de la forme (1937), Flammarion, Paris.Gumbrecht Hans Ulrich (2004), Epiphany/Presentification/Deixis. Futures for the Huma-
nities and Arts, in Id., Production of Presence. What Meaning cannot convey, Stanford University Press, Stanford, pp. 91-132.
Gurisatti Giovanni (2006), Dizionario fisiognomico. Il volto, le forme, l�espressione, Quod-libet, Macerata.
Halliday Michel A. K. (1967), Intonation and Grammar in British English, Mouton, The Hague-Paris.
� (1976), Intonation and Meaning (1970), in Halliday: System and Function in Language. Selected Papers, edited by G.R. Kress, Oxford University Press, London, pp. 214-234.
Hartley Lucy (2006), Physiognomy and the Meaning of Expression in the Nineteenth Century Culture, Cambridge University Press, Cambridge.
Heckscher William Sebastian M.H. (1967), The Genesis of Iconology (1964), in Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes (Akten des XXI Internationalen Kon-gresses für Kunstgeschichte), Bd. III, Verlag Gebr. Mann, pp. 239-262.
Hildebrand von Adolf (2001), Il problema della Forma nell�arte figurativa (1893), Æsthe-tica, Palermo.
Holly Michael Ann (1993), Iconografia e iconologia (1992), Jaca Book, Milano.Hoving Thomas (1997), False impressions: The Hunt for Big-Time art Fakes, Simon&Schu-
ster, New York.Huemer Wolfgang (2004), Introduction. Wittgenstein, language, philosophy of literature, in
J. Gibson, W. Huemer (eds.), The literary Wittgenstein, Routledge, London, pp. 1-14.
Hughes Ted (1979), Moortown Diaries, in Id., Poesie (2008), Mondatori, Milano.Husserl Edmund (1960), Meditazioni Cartesiane (1931/1950), Bompiani, Milano.� (1995), Lezioni sulle sintesi passive (1966), Guerini, Milano.
Jakobson Roman, Halle Morris (1956), Fundamentals of Language, Mouton, The Hague-Paris.
Jay Martin (1993), Downcast eyes: the denigration of vision in twentieth-century French thought, University of California Press, Berkeley-Los Angeles.
James Henry (1978), The American (1877), W.W. Norton&Co., New York-London.Journot Marie-Thérèse (2004), Piccolo dizionario del cinema (2002), Lindau, Torino.
Katz Jerrold (1972), Semantic Theory, Harper and Row, New York.
BIBLIOGRAFIA 155
Koch Gertrud (1997), Pygmalion � oder die göttliche Apparatur, in M. Mayer, G. Neu-mann (hg.), Pygmalion. Die Geschichte des Mythos in der abendländischen Kultur, Rom-bach Litterae Band 45, Freiburg, pp. 423-441.
� (2001), Pygmalions Werkstatt. Die Erschaffung des Menschen im Atelier von der Renaissance bis zum Surrealismus, Wienand Verlag, Lenbachhaus-München-Köln.
� Die kinematographische Animation des Schattens, «figurationen», 02/04 (2004), pp. 55-66.
Kozloff Max, Pygmalion Reversed, «Artforum», 3 (1975), pp. 30-37.Kracauer Sigmund (1997), Il romanzo poliziesco. Un trattato filosofico (1971), Editori
Riuniti, Roma.� (1997a), Theory of Film (1960), Princeton University Press, Princeton.Kultermann Udo (1997), Storia della storia dell�arte (1981), Neri Pozza, Vicenza.
Ladd Robert D. (1996), Intonation Phonology, Cambridge University Press, Cam-bridge.
La Matina Marcello (2004), Cronosensitività. Una teoria per lo studio filosofico dei linguaggi, Carocci, Roma.
Lant Antonia, Haptical cinema, «October», 75 (1995), pp. 45-73.Lavater Johann K. (1989), Frammenti di fisiognomica (1775-1778), Theoria, Roma-
Napoli.Lavater Johann K., Lichtenberg George C. (1991), Lo specchio dell�anima. Pro e con-
tro la fisiognomica: un dibattito settecentesco, a cura di G. Gurisatti, Il Poligrafo, Padova.
Lebenzsztejn Jean-Claude (2009), Pygmalion, Les Presses du Réel, Bruxelles.Le Brun Charles (1992), Le figure delle passioni. Conferenze sull�espressione e la fisionomia
(1668), Cortina, Milano,Le Maistre Barbara (2004), Entre film et photographie. Essais sur l�empreinte, PUV, Pa-
ris.Leonardo da Vinci (1995), Trattato della Pittura, TEA, Milano.Lessing Gotthold Ephraim (2007), Laocoonte (1766), Æsthetica, Palermo.Levi Donata (1987), Fortuna di Morelli: appunti sui rapporti fra storiografia artistica tedesca e
inglese, in G. Agosti, H. Ebert, D. Levi (a cura di), La figura e l�opera di Giovanni Morelli. Studi e ricerche, Biblioteca Civica �AngeloMai�, Bergamo, pp. 19-54.
Lévinas Emanuel (1990), Totalità e infinito (1961), Jaca Book, Milano.Lindblom Björn (1986), On the Origin of Discreteness and Invariance in Sound Patterns, in
J.S. Perkell, D.H. Klatt (eds.), Invariance and Variability in Speech Processes, Law-rence Erlbaum Associates, Hillsdale-London, pp. 493-523.
� (1990), Explaining Phonetic Variations. A Sketch of the H&H Theory, in W.J. Hardcastle, A. Marchal (eds.), Speech Production and Speech Modelling, Kluwer, Dordrecht, pp. 403-439.
BIBLIOGRAFIA156
� (1992), Phonological units as adaptive emergents of lexical development, in Ch. Ferguson, L. Menn, C. Stoel-Gammon (eds.), Phonological development: models, research, im-plications, York Press, Timonium, pp. 131-163.
Lipovetsky Gilles (1989), L�impero dell�effimero (1987), Garzanti, Milano.
Lyotard Jean-François (2008), La fenomenologia (1954), Mimesis, Milano.
Llewellyn Nigel (1997), Une science du regard: les connaisseurs, in E. Pommier (éd.), Histoire de l�histoire de l�art, Klincksieck, Paris, pp. 293-325.
Lo Piparo Franco (2005), Cosa fa di una lingua una lingua. Aristotele e il linguaggio, La-terza, Roma-Bari.
Macey David (1998), Lacan in Context, Verso, London.
Magli Patrizia (1995), Il volto e l�anima. Fisiognomica e passioni, Bompiani, Milano.
Magritte René (1992), Catalogue Raisonné. Oil Paintings 1916-1930, edited by S. Whit-field, M. Raeburn, D. Sylvester, The Menil Foundation-Fonds Mercator-Philip Wilson Publisher, London-New York.
� (2001), Ecrits Complets, Flammarion, Paris.
Malcolm Norman (1988), Ludwig Wittgenstein. La vita di un grande maestro del pensiero contemporaneo (1958), Bompiani, Milano.
Marconi Diego (a cura di) (1997), Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari.
Marin Louis (1992), Grammaire royale du visage, in G. Didi-Huberman (éd.) (1992), À visage découvert (cat. exp.), Flammarion, Paris, pp. 70-88.
Marineo Franco (2005), FACE/ON. Le narrazioni del volto cinematografico, BUR, Mi-lano.
Martin Jean-Clet, Noudelmann François, Rouan François (2004), Le corps de l�em-preinte. Études photographiques, Kimé, Paris.
Martinelli Renzo (2007), Presentazione a Davis 2007, pp. V-XI.
Martinet André (1971), Elementi di linguistica generale (1960), Laterza, Bari.
� (1965), La considerazione funzionale del linguaggio (1962), il Mulino, Bologna.
Mathon Catherine (éd.) (1999), Duchenne de Boulogne, 1806-1875 (cat. exp.), École nationale supérieure des beaux-arts, Paris.
Maturana Humberto R., Varela Francisco J. (2001), Autopoiesi e cognizione. La realiz-zazione del vivente (1980), Marsilio, Venezia.
McCarren Felicia, The �Symptomatic Act� Circa 1900: Hysteria, Hypnosis, Electricity, Dance, «Critical Inquiry», 21 (1995), pp. 748-774.
McNeill David, Aspects of aspect, «Gesture», 1 (2003), pp. 1-17.
Melchiorri Alessandro (2002), La dimensione patemica negli spot, in I. Pezzini (a cura di), Trailer, spot, clip, siti, banner. Le forme brevi della comunicazione audiovisiva, Meltemi, Roma, pp. 111-145.
Merleau-Ponty Maurice (1963), La struttura del comportamento (1942), Bompiani, Mi-lano.
BIBLIOGRAFIA 157
� (1967), Segni (1960), il Saggiatore, Milano.� (2003), Fenomenologia della percezione (1945), Bompiani, Milano.Metz Christian (1980), Cinema e psicoanalisi. Il significante immaginario (1977), Marsilio,
Venezia.Mitchell William J. Thomas (1991), Iconology and Ideology: Panofsky, Althusser, and the
Scene of Recognition (1988), in C. Farago (ed.), Reframing the Renaissance. Visual Culture in Europe and Latin America, 1450-1650, Yale University Press, New Haven, pp. 292-300.
Mochi Onori Lorenza (2000), Biografia di un dipinto, in Id. (a cura di), Raffaello. La Fornarina (cat. esp.), De Luca, Roma, pp. 5-18.
Monk Ray (1994), Wittgenstein. Il dovere del genio (1991), Bompiani, Milano.Morelli Giovanni, Die Galerien Roms. Ein kritischer Versuch für Iwan Lermolieff. Die Galerie
Borghese, «Zeitschrift für bildende Kunst», 9 (1874), pp. 1-11, 73-81, 171-178, 249-253.
� (1886), Le opere dei maestri italiani nelle Gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, Zanichelli, Bologna.
� (1907), The Italian Painters: Critical Studies of their Works. The Galleries of Munich and Dresden, Murray, London.
� (1991), Della Pittura italiana. Studii storico-critici. Le Gallerie Borghese e Doria-Pamphili in Roma (1897), a cura di J. Anderson, Adelphi, Milano.
Morin Edgar (1980), Le star (1957), Olivares, Milano.Mulligan Kevin (1990), Criteria and Indication, in R. Haller, J. Brandl (hg.), Wittgenstein
Eine Neubewertung (Akten des 14 Internationalen Wittgenstein-Symposiums), Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, pp. 94-105.
� L�essence du langage, les maçons de Wittgenstein et les briques de Bühler, «Les dossiers d�HEL» [supplément électronique de «Histoire Epistémologie Langage»], Pa-ris, SHESL, 2 (2004): http://htl.linguist.jussieu.fr/dosHEL.htm
Nguyen Noël (2005), Perception de la parole, in Id. et al. (éds.), Phonologie et phonétique. Forme et substance, Lavoisier-Hermes Science, Paris, pp. 425-447.
Oliva Carlo (2003), Storia sociale del giallo, Todaro, Lugano.
Païni Dominique (1993), Le complexe de Pygmalion (sculpture à l�écran), in D. Païni, M. Frizot (éds.), Sculpter-photographier/photographie-sculpture, Marval, Paris, pp. 109-119.
Pallasmaa Juhani (2001), The Architecture of Image. Existential Space in Cinema, Raken-nustieto, Helsinki.
Panofsky Erwin (1961), Sul problema della descrizione e dell�interpretazione del contenuto di opere d�arte figurativa (1932), in Id., La prospettiva come �forma simbolica� e altri scritti, Feltrinelli, Milano, pp. 203-218.
BIBLIOGRAFIA158
� (1975), Introduzione (1939), in Id., Studi di Iconologia, Einaudi, Torino, pp. 3-38.
� (1975a), Il movimento neoplatonico e Michelangelo (1939), ivi, pp. 236-319.
� (1997), La storia dell�arte come disciplina umanistica (1938), in Id., Il significato nelle arti visive (1955/1962), Einaudi, Torino, pp. 3-28.
Payne Alina (2002), Reclining Bodies. Figural Ornament in Renaissance Architecture, in G. Dodds, R. Tavernor (eds.), Body and Building. Essays on the Changing Relation of Body and Architecture, The MIT Press, Cambridge (Mass.), pp. 94-112.
Pau Richard (1993), Le origini scientifiche del metodo morelliano, in Agosti, Manca, Panzeri 1993, pp. 301-313.
Peirce Charles Sanders (1931-1958), Collected Papers, ed. by A.W. Burks, Ch. Hart-shorne, P. Weiss, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
Percival Melissa, Johann Caspar Lavater: Physiognomy and Connoisseurshp, «British Journal of Eighteenth Century Studies», 26 (2003), pp. 79-90.
Percival Melissa, Tytler Graeme (2005), Physiognomy In Profile: Lavater�s Impact On European Culture, University of Delaware Press, Newark.
Perissinotto Luigi (1997), Wittgenstein e la filosofia continentale, in Marconi 1997, pp. 319-343.
Persyn-Vialard Sandrina (2005), La linguistique de Karl Bühler, Press Universitaire de Rennes, Rennes.
Petrilli Raffaella (2004), Il detective e le parole. Le strutture semantiche del giallo, Bonanno, Acireale-Roma.
Piaget Jean (1968), Lo strutturalismo (1968), Il Saggiatore, Milano.
� (2000), La formazione del simbolo nel bambino: imitazione, gioco e sogno. Immagine e rap-presentazione (1945), La Nuova Italia, Firenze.
Pierrehumbert Janet (1987), The Phonology and Phonetics of English Intonation (1980), Indiana University, Bloomington.
� (2001), Exemplar Dynamics: Word Frequency, Lenition and Contrast, in J. Bybee, P. Hopper (eds.), Frequency and the Emergency of Linguistic Structures, Benjamins, Am-sterdam-Philadelphia, pp. 137-157.
Piras Antonio (2010), Le parole del volto, in Vinci 2010, pp. 47-63.
Pizzo Russo Lucia (2009), So quel che senti. Neuroni specchio, arte e empatia, ETS, Pisa.
Pozzi Enrico, Fotografare l�inconscio: Galton e Freud, «Il Corpo», 6/7 (1996/1997), pp. 67-106.
Previtali Giovanni, A propos de Morelli, «Revue de l�art», 62 (1978), pp. 27-31.
Prieto Luis (1971), La scoperta del fonema. Interpretazione epistemologica, in Id., Lineamenti di semiologia. Messaggi e segnali (1969), Laterza, Bari, pp. 169-194.
Quinche Nicolas (2006), Crime, science et identité. Anthologie des textes fondateurs de la criminalistique européenne (1860-1930), Slatkine, Genève.
BIBLIOGRAFIA 159
Renson Jean (1962), Les dénominations du visage en français et dans les autres langues romanes. Etude sémantique et onomasiologique, 2 voll., Les Belles Lettres, Paris.
Rinaldi Rinaldo (a cura di) (2002), Il volto. Ritratti di parole (Atti del convegno, Parma 2000), Unicopli, Milano.
Rodler Lucia (2000), Il corpo specchio dell�anima. Teoria e storia della fisiognomica, Bruno Mondadori, Milano.
Rosch Eleanor (1987), Wittgenstein and categorization research in cognitive psychology, in M. Chapman, R.A. Dixon (eds.), Meaning and the Growth of Understanding, Springer, Berlin, pp. 151-166.
Rösler Wolfang (1990), Mnemosyne in the Symposium, in O. Murray (ed.), Sympotika. A Symposium on the Symposion, Oxford University Press, Oxford, pp. 230-237.
Rossi Mario (1999), L�intonation. Le système du français: description et modélisation, Ophrys, Paris.
Russo Cardona Tommaso (2009), Le peripezie dell�ironia. Studio sul rovesciamento ironico, Meltemi, Roma.
Sacks Harvey, Schegloff Emmanuel A., Jefferson Gail, A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation, «Language», 50 (1974), 696-735.
Saussure (CLG/E), Cours de linguistique générale, édition critique établie par R. Engler, 4 voll., Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1967-1974.
� (2005), Scritti inediti di linguistica generale, ed. it. di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari.
Schlieben Lange Brigitte (1980), Linguistica pragmatica (1975), il Mulino, Bologna.
Schade Sigrid, Charcot and the Spectacle of the Hysterical Body. The �Pathos Formula� as an Aesthetic Staging of Psychiatric Discourse � a Blind Spot in the Reception of Warburg (1993), «Art History», 18 (1995), pp. 499-517.
Schapiro Mayer (2002), Frontalità e profilo come forme simboliche (1969), in Id., Per una semiotica del linguaggio visivo, Meltemi, Roma, pp. 158-191.
Schneller Katia, Sur les traces de Rosalind Krauss. La réception française de la notion d�index, 1977-1990, «Études photographiques», 21 (2007), pp. 123-143.
Sciolla Gianni Carlo, Appunti sulla fortuna del metodo morelliano e lo studio del disegno in Italia, �fin de siècle�. Studi in onore di Luigi Grassi, «Prospettiva», 33-36 (1983/1984), pp. 385-389.
� (2009), Il disegno. Storia, interpretazione e prospettive attuali, in M.R. De Rosa (a cura di), Gianni Carlo Sciolla. Storia e critica d�arte del Novecento, La città del sole, Na-poli, pp. 9-44.
Searle John (1976), Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio (1969), Bollati Borin-ghieri, Torino.
Semprini Andrea (1992), Lo sguardo semiotico, pubblicità, stampa, radio, Franco Angeli, Milano.
BIBLIOGRAFIA160
Sheriff Mary D. (2004), Moved by Love. Inspired Artists and Deviant Women in Eighteenth Century France, Chicago University Press, Chicago.
Sicard Monique (1998), La fabrique du regard, Odile Jacob, Paris.Sierek Karl (2007), Foto, Kino, und Computer. Aby Warburg als Medientheoretiker, Philo &
Philo Fine Arts EVA, Hamburg.Simmel Georg (1985), Il significato estetico del volto (1901), in Id., Il volto e il ritratto, il
Mulino, Bologna, pp. 43-50.Simone Raffaele (1995), The Language User in Saussure (and after), in L. Formigari,
D. Gambarara (eds), Historical Roots of Linguistics Theories, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, pp. 233-249.
Smith Jonathan (2006), Charles Darwin and Victorian Visual Culture, Cambridge Uni-versity Press, Cambridge.
Sontag Susan (2004), Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società (1977), Ei-naudi, Torino.
Soucy Pierre-Yves (éd.) (1990), Wittgenstein et la critique du monde moderne (Actes du colloque international, Bruxelles 1990), La Lettre Valée, Bruxelles.
Souveryns Patrick, Heins Patrick (2009), (Re)lire Magritte. 7 clés pour comprendre une �uvre d�art, De Boeck, Bruxelles.
Spector Jack, The Method of Morelli and its Relation to Freudian Psychoanalysis, «Diogenes», 66 (1969), pp. 63-83.
Spinicci Paolo (2000), Sensazione, percezione, concetto, il Mulino, Bologna.Stafford Barbara (1993), Physiognomics or Corporeal Connoisseurship, in Ead., Body Criti-
cism: Imaging the Unseen in Enlightenment Art and Medicine, The MIT Press, Cam-bridge (Mass.), pp. 84-103.
Stimilli Davide (2005), The Face of Immortality: Physiognomy and Criticism, Albany (NY), State University of New York Press.
Stoichita I. Victor (2000), Breve storia dell�ombra (1997), il Saggiatore, Milano.� (2006), L�effetto Pigmalione. Breve storia dei simulacri da Ovidio a Hitchcock, il Saggia-
tore, Milano.Straus Erwin (2005), Le forme della spazialità. Il loro significato per la motricità e la per-
cezione (1930), in E. Straus Erwin, H. Maldiney, L�estetico e l�estetica, Mimesis, Milano, pp. 35-68.
Stumpf Carl (2006), Phénomènes et fonctions psychiques (1906), in Id., Renaissance de la philosophie. Quatre articles, Vrin, Paris, pp. 133-167.
� (2006a), Renaissance de la philosophie (1907), ivi, pp. 115-132.Summers David, Maniera et Mouvement: The Figura Serpentinata, «Art Quarterly», 15
(1972), pp. 269-301.
Tagliapietra Andrea (2008), La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Bollati Boringhieri, Torino.
BIBLIOGRAFIA 161
Taine Hippolyte (1996), Filosofia dell�arte (1893), in Id., Scritti estetici. Metodo e dottrina, Alinea, Firenze.
Tieze Hans, Tieze-Conrat Erica (1970), The Drawings of Venetian Painters, in the 15th and 16th Centuries, J.J. Augustin Publisher, New York.
Toccafondi Fiorenza, De Karl Bühler à Karl Popper, «Philosophiques», 26 (1999), pp. 279-300.
� (2009), La scuola di Berlino e gli scritti teorici di Karl Duncker, intr. a Karl Duncker, Coscienza e vita. Saggi fenomenologici (1927-1940), Le Lettere, Firenze.
Trotta Antonella (2006), Berenson e Lotto. Problemi di metodo e di storia dell�arte, La città del sole, Napoli.
Trotter David, Stereoscopy: Modernism and the �Haptic�, «Critical Quarterly», 46 (2004), pp. 38-58.
Trubeckoj Nicolaj S. (1971), Fondamenti di fonologia (1939), Einaudi, Torino.Vecchio Sebastiano (2005), Giallo a tinte celesti su fondo incerto, in Id., La puffa di Babele,
Bonanno, Acireale, pp. 145-165.Vedovelli Massimo (2004), Lingua in giallo, Guerra, Perugia.Vernant Jean-Pierre (2007), L�individu, la mort, l�amour (1989), in Id., �uvres. Religions,
Rationalités, Politique, vol. II, Seuil, Paris, pp. 1307-1476.Vernant Jean-Pierre, Frontisi-Ducroux Françoise (1998), Ulisse e lo specchio. Il femmi-
nile e la rappresentazione di sé nella Grecia antica (1997), Donzelli, Roma.Vicentini Claudio (2007), L�arte di guardare gli attori. Manuale pratico per lo spettatore di
teatro, cinema, televisione, Marsilio, Venezia.Vinci Daniele (a cura di) (2010), Il volto nel pensiero contemporaneo, Il Pozzo di Gia-
cobbe, Trapani.Violi Patrizia (1997), Significato ed esperienza, Bompiani, Milano.Volli Ugo (2002), Figure del desiderio. Corpo, testo, mancanza, Cortina, Milano.Vouilloux Bernard (1997), L�art des Goncourt. Une esthétique du style, L�Harmattan,
Paris.
Warburg Aby (1928-1929), Grisaille-Mantegna, Warburg Institute Archive (WIA), III.102.5.5.
Weinrich Harald (2004), Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo (1964), Bologna, Il Mulino.
Williams Linda (1995), Corporealized Observers: Visual Pornographies and the �Carnal Density of Vision�, in P. Petro (ed.), Fugitive Images, Indiana University Press, Blooming-ton & Indianapolis, pp. 3-41.
Wind Edgar (1963), Some Points of Contact between History and Natural Science, in R. Klibansky, H.J. Paton (eds.), Philosophy and History: The Ernst Cassirer Festschrift, Harper & Row, New York, pp. 255-264.
Wittgenstein Ludwig (1979), Della certezza (1969), Einaudi, Torino.
BIBLIOGRAFIA162
� (1983), Ricerche filosofiche (1953), Einaudi, Torino.� (1983a), Libro blu e Libro marrone (1958), Einaudi, Torino.� (1990), Osservazioni sulla filosofia della psicologia (1980), Adelphi, Milano.� (1998), Ultimi scritti. La filosofia della psicologia (1949-1951) (1992), Laterza, Roma-
Bari.� (2000), Osservazioni sui colori (1977), Einaudi, Torino.Wollheim Richard (1973), Giovanni Morelli and Origins of Scientific Connoisseurship, in Id.,
On Art and the Mind: Essays and Lectures, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), pp. 177-201.
Zanzotto Andrea (2009), Conglomerati, Mondadori, Milano.Zerner Henri (1997), Ecrire l�histoire de l�art. Figures d�une discipline, Gallimard, Paris.