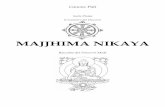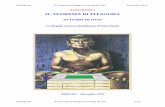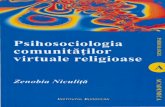Etnografia virtuale e convergenza: spazi, tempi, discorsi e pratiche della tv sul web
Transcript of Etnografia virtuale e convergenza: spazi, tempi, discorsi e pratiche della tv sul web
LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
Etnografi a virtuale e convergenza: spazi, tempi, discorsi e pratiche della TV sul web
1. Scenari della convergenza, nuovi media ed etnografi a di Rete
Che cosa è successo, negli ultimi vent’anni, al sistema dei media? Buona parte dei tentativi di rispondere a tale domanda prende le mosse dal lungo elenco dei sistemi tecnici e dei device, degli apparecchi e delle applicazioni che affollano il panorama mediale contemporaneo: il digi-tale e il satellite, il web e il telefono cellulare, gli MP3 e i DivX, e con loro i decoder, i social network, i sistemi peer-to-peer e così via. Limitarsi a tale elenco signifi ca però arrestarsi al livello più superfi ciale del fenomeno di trasformazione: quello delle mille rivoluzioni annunciate con caden-za ormai quotidiana da giornali ed ‘esperti’ dei media. Per rendere con-to della reale natura del cambiamento non è però suffi ciente limitarsi esclusivamente al piano tecnologico, ma è necessario, a un livello più profondo, affrontare la struttura delle nuove forme di relazione che ven-gono a instaurarsi, da una parte, tra i differenti media e, dall’altra, tra produzione, distribuzione e utenza. Tale struttura è oggi informata dal fenomeno defi nito da più parti convergenza.
Convergenza è infatti il termine spesso usato, e talvolta abusato, per descrivere il principale processo – o meglio, la serie di processi – che investe oggi il sistema dei media: l’esito ultimo di una tendenza ormai pluridecennale all’aggregazione, ibridazione, moltiplicazione e accumu-lo di piattaforme, contenuti, stili, linguaggi differenti. Per usare la defi -nizione ormai classica di De Sola Pool, «un solo mezzo fi sico – fi li, cavi o onde radio – può farsi canale di trasmissione di messaggi che in passato erano forniti per vie distinte [e allo stesso tempo] un servizio che in pas-sato veniva fornito da un singolo mezzo – fosse l’emittenza televisiva, la stampa o la telefonia – oggi può viaggiare su canali fi sici differenti»1. Si rompe così la corrispondenza biunivoca tra il canale di trasmissione e il tipo di messaggio trasmesso: quella per cui, per fare un solo esempio, è ‘televisione’ tutto quello che passa sull’apparecchio chiamato televisore.
1 De Sola Pool (1995), p. 35.
00_Tosoni.indd Sez3:6300_Tosoni.indd Sez3:63 11-11-2010 10:07:3211-11-2010 10:07:32
64 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
Con la convergenza, invece, lo stesso medium può consentire la trasmis-sione di contenuti di tipo eterogeneo (ma di semplice trasmissione non si tratta, se si parte dall’assunto per cui ‘il medium è il messaggio’); allo stesso modo, lo stesso contenuto può viaggiare su device e piattaforme differenti. Né, come detto, si tratta in questo senso di una semplice que-stione tecnica, legata in modo inevitabile alla digitalizzazione. Al contra-rio, occorre sottolineare come le implicazioni della convergenza siano di portata ben più vasta: ciò cui si assiste è infatti l’origine di «un sistema fortemente interdipendente, e caratterizzato dalla crescente presenza di imprese “trasversali” ai diversi settori dell’industria culturale»2.
Il ‘termine ombrello’ di convergenza tiene così insieme, e descrive, una serie di fenomeni diversi, anche se spesso profondamente intreccia-ti tra loro. Questa complessità trova del resto puntuale riscontro nella ricerca empirica svoltasi sul tema, molto ricca – soprattutto negli ultimi anni – ma spesso disorganica e ‘ricalcata’ sui metodi sviluppati per altri oggetti di studio (primi fra tutti, i cosiddetti ‘nuovi media’), senza tenere conto della necessità di far interagire (appunto, convergere) dimensioni e livelli differenti. Il tema della convergenza è stato fatto proprio prima dalle indagini macroeconomiche, attente prevalentemente agli sviluppi del sistema (in termini di fusioni, acquisizioni, spostamenti di capitale, ridefi nizione di assetti organizzativi e sinergie), e poi dalle humanities, principalmente nel solco dei Film and Media Studies e della storia dei media, con approcci o totalmente indipendenti dalla ricerca sul campo, o comunque poco sistematici e ‘leggeri’ nel piegare metodi e risultati a supporto di teorie e ricostruzioni. Paradossalmente (ma non troppo), è il settore della ricerca amministrativa, o comunque quello più vicino alle culture della produzione e distribuzione, ad aver meglio sviluppato e precisato un impianto metodologico: ma in questo caso il forte rischio è quello di un’adesione acritica alle logiche dei media, senza il dovuto distacco dall’oggetto di studio, fi no a forme di vera e propria ‘consulen-za’ alla produzione fortemente sbilanciate sul versante operativo.
Un utile modo di uscire da questa impasse è quello di defi nire meglio il concetto di convergenza, evidenziandone i differenti livelli, strati-fi cati ma costantemente interrelati. Si possono infatti distinguere una dimensione tecnologica, legata alla digitalizzazione e alle molteplici piattaforme attraverso cui è possibile accedere ai contenuti mediali; una istituzionale ed economica, legata alla nascita di conglomerati globali e alla moltiplicazione di offerte commerciali; una estetica e linguistica, con testi che diventano marchi e brand ‘estesi’, transmediali, sempre più complessi per il fruitore disposto a seguirne le ‘tracce’; e infi ne, una
2 Ortoleva (2002), p. 283.
00_Tosoni.indd Sez3:6400_Tosoni.indd Sez3:64 11-11-2010 10:07:3211-11-2010 10:07:32
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 65
culturale, che si apre a nuove relazioni che intercorrono tra produzione e consumo, tra professionisti e spettatori3.
Proprio quest’ultima dimensione risulta di particolare interesse. Sen-za cadere negli opposti estremismi degli ‘entusiasti’ di fronte alle possi-bilità di partecipazione fornite dai nuovi media e degli ‘apocalittici’ per cui il web non è altro che l’ennesima forma di ‘distrazione di massa’, i nuovi rapporti tra utenti e istituzioni mediali modifi cano, almeno in par-te, la struttura del sistema nel suo complesso. Seguendo la lettura data da Henry Jenkins4, la convergenza è popolata dallo scontro, o – al con-trario – dall’incontro, tra due logiche distinte e complementari: da un lato, le tattiche bottom-up, dal basso verso l’alto, con la rielaborazione e la riappropriazione grassroots dei contenuti messi in circolo, fi no allo User-Generated Content e al citizen journalism; dall’altro, le strategie top-down, dall’alto verso il basso, con le decisioni (di offerta come di restrizione di tali possibilità) prese dalle istituzioni mediali. La presenza di nuovi spazi di manovra per lo spettatore-utente, di margini di interazione a lungo confi nati nelle subculture di fandom ma ora sempre più diffuse e visibili, soprattutto – sebbene non esclusivamente – in Rete, in un sistema che diventa più mobile, costringe i professionisti e le istituzioni a tenere con-to di interpretazioni e letture diverse dei propri prodotti, fi no al punto di favorirle esplicitamente (cogliendone la valenza promozionale) o di tentare di instradarle commercialmente (con forme di vera e propria exploitation del lavoro altrui).
Il paradigma della convergenza, con i suoi vari livelli e con le forze talora opposte che lo percorrono, spiega bene come, con la diffusione del web e delle nuove tecnologie, il sistema dei media sia sì cambiato, ma lungo direzioni diverse da quelle preconizzate dai vari profeti della ‘rivoluzione digitale’. La televisione, per esempio, è ancora saldamente al centro dello scenario mediale: non solo rimane il business più impor-tante, ma è anche la tecnologia più diffusa e il collettore dei contenuti più visti e conosciuti. Il mezzo televisivo, semmai, si ridefi nisce: in una parola, converge. Tre parole chiave descrivono i caratteri della TV conver-gente: estensione, accesso e brand. I programmi si estendono oltre lo spazio loro dedicato nel palinsesto, circolano in forma di frammento, si com-pongono attraverso narrazioni complesse e distribuite su più media. I contenuti si raggiungono con percorsi di accesso sempre più intricati, che possono fare a meno del televisore, sostituito dal web o dal cellula-re, o che invece ne sfruttano ogni potenzialità, riverberando tra repli-
3 Le quattro dimensioni della convergenza sono individuate in Scaglioni - Sfardini (2008).4 Cfr. Jenkins (2007).
00_Tosoni.indd Sez3:6500_Tosoni.indd Sez3:65 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
66 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
che, canali, fi nestre di programmazione. I prodotti TV diventano brand, marchi riconoscibili e capaci di tenere insieme i vari pezzi di racconto e di guidare lo spettatore nella complessità delle nuove offerte. Anche in questo caso, si rompe in sostanza una relazione biunivoca: quella che tradizionalmente legava il singolo programma a uno slot di palinsesto, quale possibilità unica di consumo nel fl usso delle immagini TV.
In questo scenario mutato e mutevole, Internet assume, tra le sue varie funzioni, anche quella di spazio propriamente televisivo. Da un lato, la Rete è uno spazio di pratiche di visione di contenuti TV: basti pensare allo sterminato archivio audiovisivo fornito da YouTube, allo stre-aming di programmi (originali o replicati dopo la messa in onda su pic-colo schermo) sui portali ad hoc delle emittenti o sulle web-TV di nuovi editori, o ancora alle forme di download e streaming, legale e illegale, che consentono non solo di rivedere, ma spesso di anticipare, secon-do nuove temporalità, la trasmissione dei prodotti. Dall’altro, il web è anche uno spazio di discorsi sulla TV: una risorsa dove trovare informa-zioni sui programmi e sulle modalità di messa in onda, un’arena dove commentare le performance o i singoli episodi, un’enciclopedia in cui trovare dettagli, retroscena, anticipazioni e gossip. Insomma: se è vero che la televisione occupa una posizione centrale nel sistema dei media, è altrettanto vero che nello scenario convergente questa si può capire e completare solo attraverso i suoi altri ‘pezzi’, audiovisivi e discorsivi, diffusi in Rete e altrove.
È precisamente in tal senso che questo nuovo spazio simbolico, che potremmo defi nire ‘web televisivo’, rappresenta per la ricerca sui media nell’epoca della convergenza una sfi da non rinviabile. Da una parte, infatti, web e nuovi media in genere (si pensi per esempio ai dispositivi di comunicazione mobile) costituiscono, come si è detto, uno dei prin-cipali spazi in cui il prodotto mediale si espande e si decentra, come pure uno dei principali spazi in cui avviene l’incontro e la mediazione tra le pratiche, i discorsi e le strategie dei diversi attori sociali che inter-vengono nel processo comunicativo. Dall’altra, però, il web televisivo è innervato dalle pratiche comunicative ‘convergenti’ in un modo che è specifi co e inedito al tempo stesso. Così, le stesse metodologie di tipo etnografi co5, già sperimentate nel corso degli anni Novanta per affron-tare le prime forme di incontro tra web e televisione (e in particolare, le fan culture), necessitano di un profondo riadattamento per l’analisi dei nuovi scenari. Non si tratta più, infatti, di studiare pratiche e discorsi di specifi ci sottogruppi e di comunità circoscritte e ben riconoscibili in Rete, come sperimentato per esempio nel celebre lavoro di Nancy Baym
5 Un’utile ricostruzione teorica e metodologica si trova in Tosoni (2004).
00_Tosoni.indd Sez3:6600_Tosoni.indd Sez3:66 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 67
sulle fandom community delle soap opera6. Si tratta, invece, di ricostrui-re e inseguire le traiettorie di proliferazione del discorso televisivo, e le pratiche decentrate che vi prendono congiuntamente forma. Esigenza che rinvia, come vedremo, ad approcci metodologici più vicini all’im-postazione connettiva e multisituata della virtual ethnography proposta, all’inizio del presente decennio, da Christine Hine7, per la quale l’ogget-to dell’etnografi a «consiste in un “argomento”, più che in un “luogo”»8 o in una singola comunità. Se infatti, come già scriveva la Hine, «lungi dal rimpiazzare i vecchi mass media, Internet in certi spazi si affi da a essi, per strutturare il dibattito tra partecipanti sulla base di esperienze comuni»9, l’area di manovra della virtual ethnography può essere proprio il ‘web televisivo’, vale a dire l’insieme di quegli spazi in cui Internet ‘si affi da’ alla televisione ‘per strutturare il dibattito’. L’oggetto di ricerca può diventare così un ‘pezzo’ di televisione, letto attraverso la sua rap-presentazione e la sua discorsivizzazione su Internet: singoli programmi come il «Grande Fratello» o «Lost», interi generi come il reality o la fi c-tion italiana, brand di rete e di offerta come Italia 1, Fox o Sky risultano così temi possibili (e passibili) di un’etnografi a on line.
2. Per un approccio etnografi co al web televisivo
L’approccio etnografi co – come tutte le metodologie di ricerca non standard – trova uno dei propri principali punti di forza nella fl essibi-lità e nella capacità di rimodellarsi, a partire da alcuni assunti di base, sulle specifi cità dei propri oggetti d’analisi10. La virtual ethnography, la sua applicazione agli ambienti virtuali, non fa eccezione. Messa a punto all’interno del campo disciplinare degli Internet Studies a partire dai primi anni Novanta, questa costituisce, proprio per la capacità di rende-re conto di fenomeni complessi e di processi non ancora esaustivamente mappati, una delle più promettenti metodologie di ricerca per il web televisivo e gli scenari della convergenza. A tale scopo, è però necessaria tutta una serie di operazioni di riadattamento dell’approccio al nuovo oggetto di analisi, come pure una defi nizione – fl essibile e rigorosa assie-me – dei principali punti di attenzione per l’osservazione.
6 Cfr. Baym (2000).7 Hine (2000), p. 37. 8 Tosoni (2004), p. 166.9 Hine (2000), p. 145.10 Per una prima introduzione alle metodologie etnografi che basate sull’osservazio-ne, cfr. Dal Lago - De Biasi (2006), Gobo (2001) e Cellini (2008).
00_Tosoni.indd Sez3:6700_Tosoni.indd Sez3:67 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
68 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
Come vedremo, è così necessario innanzitutto rifl ettere sulla spazia-lità disegnata dalle traiettorie di proliferazione del web televisivo analiz-zato (par. 2.1), ossia rifl ettere su come questo attraversa, e congiunge, ambienti virtuali differenti (come quando un blog, per esempio, ripro-pone un frammento di un prodotto televisivo presente su YouTube). Metodologicamente, tale primo ordine di problematiche rinvia al pro-blema della defi nizione del campo etnografi co, ossia alla defi nizione dei limi-ti e dei confi ni entro i quali situare l’osservazione e l’analisi.
La spazialità del web televisivo non risulta inoltre statica, ma dinamica: i discorsi e le pratiche a esso collegate possono interessare nel tempo spa-zi (e soggetti) differenti, e disegnare in Rete geometrie diverse. Allo stes-so modo, discorsi e pratiche possono, da una parte, registrare nel tempo variazioni di intensità che scandiscono la riconoscibilità di ritmi differen-ti, e dall’altra instaurare rapporti plurali e complessi con le temporalità del medium televisivo (si pensi al caso del liveblogging tipico dei reality, o ai diversi passaggi della fi ction seriale). Tali ordini di problematiche sono nel complesso riconducibili a un secondo, fondamentale punto d’atten-zione: quello relativo alla temporalità del web televisivo (par. 2.2).
Infi ne, risulta centrale la defi nizione di quelli che Blumer chiama «concetti sensibilizzanti»11: all’inizio della ricerca, si tratta di poco più che ‘aree di interesse’ genericamente defi nite e scarsamente codifi cate, semplici punti di attenzione che orienteranno l’osservazione del ricer-catore. Col procedere della ricerca, i concetti sensibilizzanti andranno però specifi candosi e precisandosi, fi no a farsi dettagliatamente e pun-tualmente defi niti: e ciò, in un rapporto circolare con il processo di osservazione sul campo, per cui osservazione e concetti sensibilizzanti si orientano e si strutturano reciprocamente in modo progressivo. Per quanto riguarda il web televisivo, a risultare centrali sono i discorsi (par. 2.3) e le pratiche (par. 2.4) che ruotano attorno al medium televisivo (a un prodotto, un genere, una rete, una piattaforma) osservabili on line.
2.1. Spazio e defi nizione del campo etnografi co
La prima, fondamentale operazione per ogni approccio di ricerca basa-to sull’osservazione, inclusa la virtual ethnography, è quella della defi ni-zione del campo etnografi co12, ossia dello spazio – o degli spazi – entro
11 Per la prima formulazione di tale fortunato strumento metodologico, cfr. Blumer (1954).12 Per un approfondimento sulle metodologie etnografi che in generale, e sulle problematiche relative al taglio del campo etnografi co, si veda il già citato Gobo (2001).
00_Tosoni.indd Sez3:6800_Tosoni.indd Sez3:68 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 69
cui situare e contenere l’azione stessa dell’osservare. Si tratta di un’ope-razione estremamente delicata, dal momento che scelte diverse pos-sono avere un profondo impatto su come appare il fenomeno studia-to: costruendo un campo etnografi co troppo ristretto si rischia infatti di ignorare aspetti importanti del fenomeno stesso, mentre un campo troppo esteso implica, nella migliore delle ipotesi, una dispersione di attenzione e tempo che espone al rischio di una ricognizione solo super-fi ciale del fenomeno. Come sempre avviene con le metodologie non standard di ricerca, non esistono però regole fi sse e rigide a guidare il ricercatore in tale operazione: si tratta di una scelta che dipende dalla sua sensibilità, dalle domande che lo muovono, dalle risorse che è in grado di mobilitare, come pure – ovviamente – dalla natura del fenome-no oggetto di studio.
Per tutti gli anni Novanta, l’etnografi a di Rete ha in genere ‘tagliato’ i propri campi etnografi ci attorno a un unico sistema tecnico di intera-zione (una chat, un forum, un MUD), identifi candolo con un gruppo o una ‘comunità’ (quasi si trattasse del corrispettivo digitale del ‘villaggio’ dell’etnografi a tradizionale) e studiando in modo approfondito (ma esclusivo) i discorsi e le pratiche che questo ospitava al suo interno13. Già nei primi anni del presente decennio tale scelta metodologica è sta-ta però sottoposta a critica serrata14, in particolare perché spingeva il ricercatore a ignorare tutte quelle interazioni, pur fondamentali per il gruppo studiato, che avvenivano in ambienti digitali differenti rispetto a quello su cui si era tagliato il campo etnografi co (per esempio, gli scam-bi via e-mail dei membri di una chat), su altri media (come il telefo-no) o faccia a faccia. Nel caso dell’analisi del web televisivo, tale scelta si rivela vistosamente inadeguata anche per un secondo ordine di motivi: le forme di decentramento ed espansione del discorso televisivo sulla Rete risultano troppo articolate ed eterogenee per permettere l’identi-fi cazione di singoli ‘luoghi’ di interazione, o anche di singoli concatena-menti di luoghi, che possano essere considerati in qualche modo tipici o esemplari di quanto va avvenendo on line. A tale proposito, basti pen-sare anche solo alle differenze tecnico-funzionali tra ambienti di comu-nicazione, per cui un sito web, un blog, un social network, un forum, una chat in tempo reale, un sito-repositorio di risorse (come YouTube) rendono possibili forme di interazione profondamente diverse tra loro.
Tra le proposte alternative, assai più promettente appare quella avan-zata da Christine Hine15, in quella che resta a tutt’oggi una delle più raf-
13 Cfr. supra, par. 3.2 del saggio di Tosoni. 14 Cfr. Paccagnella (2002).15 Si veda Hine (2000).
00_Tosoni.indd Sez3:6900_Tosoni.indd Sez3:69 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
70 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
fi nate rifl essioni metodologiche sulla virtual ethnography: la ricercatrice opta infatti per un’etnografi a «connettiva» e «multisituata»16, costruen-do il proprio campo di osservazione includendovi ambienti differenti a partire da un comune argomento o tema di discussione (nel caso della Hine, una notizia di cronaca nera; per quanto ci riguarda, un prodotto-brand, un genere, una rete o una piattaforma, per esempio), con l’ovvia consapevolezza che qualsiasi forma di ‘chiusura’ del campione risulta sempre, perlomeno parzialmente, arbitraria. Per quanto riguarda il web televisivo, è possibile integrare tale proposta con una serie di accortezze procedurali tali da rendere il campione selezionato, se non il più rap-presentativo, perlomeno il più inclusivo possibile. La prima delle opera-zioni da compiere, in questo senso, è una ricognizione complessiva delle discorsivizzazioni in Rete relative all’oggetto di ricerca, mirata al massi-mo livello di apertura e inclusione dell’eterogeneo, sia dal punto di vista dei tipi di ambienti di interazione, sia da quello delle tipologie di utenza (così come risultano desumibili dalle conversazioni on line) e delle pra-tiche da esse performate on line, sia ancora rispetto all’alternativa ‘spa-zio esclusivamente dedicato all’argomento/spazio generalista’. A questo scopo, risulta particolarmente utile un uso integrato di motori di ricer-ca, aggregatori di blog (sorta di metablog che indicizzano gli interventi di altri blog, come Liquida.it) e di ricerche focalizzate in ambienti speci-fi ci, quali i principali social network, Second Life, i circuiti peer-to-peer e i siti-repositorio come YouTube (ma anche negli spazi per il download di applicazioni per dispositivi mobili).
A partire da tale prima panoramica, sono quindi possibili due ope-razioni complementari. La prima è quella di selezionare, secondo il cri-terio della ‘variazione tipologica’, uno o più luoghi di interazione da sottoporre a effettiva osservazione, in modo da includere nel campio-ne almeno un esempio per ogni tipo di spazio trovato (a), tipologia di utenza e di pratiche (b) e focus specifi co o generalista (c), tentando se possibile di saturare la matrice (a) * (b) * (c) con i casi più signifi cativi (per esempio, quelli in cui si registra un più intenso livello di scambio comunicativo).
Tale prima selezione è in secondo luogo integrabile in due modi: innanzitutto, secondo un approccio ispirato alla snowball strategy, è con-sigliabile estendere l’osservazione a tutti gli ambienti utilizzati congiun-
16 Multisituata in quanto il campo etnografi co risulta composto da ambienti virtuali differenti (ma nulla vieta di includervi anche media diversi, e fi nanche spazi off line di interazione); connettiva in quanto tali spazi risultano a vario titolo collegati tra loro (per esempio, attraverso un medesimo argomento di discussione, ma anche attraver-so link o riferimenti incrociati). Sull’etnografi a multisituata, cfr. Marcus (1995).
00_Tosoni.indd Sez3:7000_Tosoni.indd Sez3:70 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 71
tamente dal particolare ‘gruppo’ di persone che interagisce all’interno di ogni spazio incluso in prima battuta nel campione (per esempio, includendo una chat usata dagli utenti di un forum); secondariamente, è consigliabile anche includervi tutti gli spazi che emergono come cen-trali per rinvii, o link, presenti negli spazi già inclusi nel campione (per esempio, i siti più citati), in modo tale che sia la Rete stessa a defi nire i propri criteri di rilevanza. Ovviamente, è necessario calibrare la minu-ziosità di tale operazione sulle risorse che si è previsto di dedicare all’os-servazione, tenendo presente che – come vedremo – questa deve essere costante e ripetuta nel tempo. Ancora una volta, la ‘chiusura’ del campo etnografi co, con il completamento dell’operazione di assemblaggio del campione così descritto, non può non presentare un certo margine di arbitrarietà. In questo senso, è possibile ispirarsi al criterio della ‘satura-zione’ come principio guida per l’operazione di ‘chiusura’, terminando di assemblare il proprio campo etnografi co multisituato nel momento in cui ulteriori inclusioni smettono di restituire al ricercatore spazi e ambienti visibilmente ‘differenti’ rispetto a quelli già inseriti nel cam-pione (‘differenti’ sotto il punto di vista di una o più caratteristiche che hanno guidato la costruzione della matrice iniziale, o di nuove caratteri-stiche rivelatesi in un secondo tempo rilevanti).
Va infi ne tenuto presente che l’ambiente della Rete risulta tutt’altro che stabile e statico: gli spazi di comunicazione più importanti relativi a un particolare prodotto possono cambiare, moltiplicarsi o scompari-re; possono registrarsi migrazioni di utenza, come pure – in modo assai interessante per una ricerca di taglio etnografi co – nuove tipologie di utenza possono aggiungersi alla discussione, nei vecchi spazi o in spazi nuovi; allo stesso modo, alcuni spazi di conversazione centrali in una fase possono farsi via via periferici, e viceversa. Specie in caso di perio-di di osservazione prolungati (per esempio, quelli defi niti dalla durata della messa in onda di una particolare trasmissione) è perciò necessa-rio accertarsi periodicamente che il proprio campo etnografi co resti comunque adeguato, ripetendo i passaggi principali dell’operazione del suo primo assemblaggio ai fi ni di verifi ca e di integrazione.
2.2. Tempo e intensità
Una volta defi nito il proprio campo etnografi co, e ricostruita la strut-tura spaziale del web televisivo in osservazione, è necessario procedere all’analisi delle forme temporali che lo caratterizzano: è cioè necessario rendere conto, quali sue caratteristiche fondamentali, dei dinamismi e delle ritmicità che scandiscono la produzione discorsiva on line.
Tale operazione ha valore metodologico e sostantivo insieme: meto-dologico, perché è precisamente la ricostruzione di tale struttura tem-
00_Tosoni.indd Sez3:7100_Tosoni.indd Sez3:71 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
72 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
porale a permettere al ricercatore un’organizzazione ottimale delle proprie fi nestre di osservazione, tanto nell’arco della giornata, quanto lungo cicli temporali più lunghi (settimana, mese ecc.). Infatti è preci-samente la sincronizzazione temporale tra lo sguardo dell’osservatore e il farsi dei fenomeni osservati a caratterizzare l’etnografi a virtuale17, e a distinguerla dalla semplice analisi del contenuto on line (ove a essere analizzate sono le tracce rimaste in Rete di discorsi passati18). Da una parte, infatti, non tutte le pratiche o i discorsi on line hanno il carat-tere della permanenza: i contenuti di una chat, per esempio, risultano spesso effi meri, e dunque non intercettabili da un’analisi del contenuto posticipata. Dall’altra, e in modo ancor più rilevante, è solo tale forma di sincronizzazione a garantire che il ricercatore e i soggetti osservati con-dividano un contesto simbolico e mediale il più ampio possibile, quale condizione indispensabile per una comprensione profonda dei fenome-ni osservati: si pensi per esempio ai riferimenti (o addirittura ai mancati riferimenti) a eventi, fatti di cronaca o a prodotti-brand trasmessi nella fi nestra di osservazione.
La ricostruzione della struttura temporale del web televisivo ha però anche valore sostantivo, dal momento che la temporalità costituisce una delle sue caratteristiche fondamentali, e – come mostreremo nel corso del par. 3 – risulta correlata in modo complesso alle caratteristiche di genere, ma anche alle specifi cità, del relativo prodotto-brand: reality e fi ction danno per esempio vita a web televisivi con temporalità differen-ti, come pure risultano simili, ma distinguibili, le temporalità legate a reality diversi. Così risulta necessario indagare le forme di sincronizza-zione, o di mancata sincronizzazione, tra la temporalità e la ritmicità dei discorsi e delle pratiche registrati on line e la temporalità (o meglio – in fase di convergenza – le temporalità19) dell’offerta televisiva, includendo
17 Va chiarito che con ‘sincronizzazione’ non si intende necessariamente la contem-poraneità del tempo reale: per un forum, si può considerare ‘sincronizzata’ una rile-vazione che avviene mentre la discussione è percepita come ancora attiva dagli stessi membri dello spazio virtuale. Ciascuno spazio ha in sostanza le proprie forme di temporalità, e dunque i propri criteri di sincronizzazione.18 Ciò non signifi ca che non risultino utili, e in alcuni casi preziose, forme di recupero del passato che aiutino il ricercatore a orientarsi e situare oggetti e pratiche osserva-te. Sebbene la dimensione fondamentale sia quella del presente, l’eventuale perma-nenza dei contenuti in rete (anche coadiuvata da servizi di caching e archivio come WayBackMachine.org) offre al ricercatore la possibilità di un prezioso sguardo retro-spettivo, che può aiutarlo a evitare grossolani errori interpretativi.19 Si pensi per esempio alle serie televisive americane, che articolano almeno tre temporalità: una T1 relativa alla messa in onda americana (fruita in streaming o spesso tramite download illegale); una temporalità T2 relativa alla messa in onda a
00_Tosoni.indd Sez3:7200_Tosoni.indd Sez3:72 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 73
in questa anche eventuali forme di produzione discorsiva paratestuale (premi, eventi, campagne di promozione). E ciò, contemporaneamen-te, da un punto di vista micro (rilevando le forme di sincronizzazione su base quotidiana, come per esempio il tempo reale, tipico – per i rea-lity – del liveblogging), da un punto di vista meso (cui sono riconducibili i cicli settimanali della messa in onda), e da un punto di vista macro (i segmenti temporali di medio e lungo corso tracciati dalle varie fasi della messa in onda del prodotto-brand: per esempio, la fi nestra del pas-saggio su satellite o in chiaro di una serie TV). Si potranno così avere, per esempio, forme di discorsivizzazione live, in cui si scrive sul blog o forum mentre si guarda lo show, incorniciate da fasi di build-up (in cui ci si incontra nello spazio virtuale nei minuti precedenti alla messa in onda e si condivide l’attesa) e di release (in cui ci si abbandona a commenti dopo la messa in onda). Si riscontrano poi forme di discorsivizzazione ‘del giorno dopo’, e poi di ‘coda lunga’, che continuano per molto tem-po intorno a oggetti, personaggi o tematiche particolarmente signifi -cativi. Ogni temporalità tende peraltro a selezionare i propri registri e soprattutto i propri spazi di elezione (per esempio, la chat per la visione live dei telefi lm, il liveblogging per i reality e i talent), secondo processi che intrecciano, di nuovo, la temporalità, le caratteristiche dell’oggetto e quelle dello spazio.
Per completare l’analisi delle forme temporali del web televisivo, e contemporaneamente delle forme di dinamicità della sua struttura spa-ziale, è però necessario fare ricorso a un ulteriore concetto/strumento d’analisi: quello di intensità discorsiva – cui già si è fatto riferimento nel precedente paragrafo – quale criterio di inclusione degli ambienti vir-tuali nel campo etnografi co. Il concetto di intensità rinvia a una stima relativa del volume degli scambi registrati on line. Non si tratta in sostan-za di misurare, in assoluto, la quantità di discorso che prodotti differenti sono in grado di generare, ma – in primo luogo – di comparare la quan-tità di discorso prodotto nei diversi spazi che compongono il campo etnografi co: in tal modo sarà possibile completare l’analisi strutturale dello spazio riconoscendo, per esempio, alcuni spazi più periferici (a
pagamento dell’adattamento italiano; una temporalità T3 relativa alla messa in onda in chiaro sulle televisioni free. A questo si aggiungono poi temporalità relative alle repliche, che duplicano perlomeno T2 e T3. Nel caso di brand come «CSI», tali tem-poralità vanno moltiplicate per il numero delle stagioni e delle serie messe in onda. Il discorso on line può sincronizzarsi con ciascuna di queste temporalità, oltre che, come sempre, con la temporalità T0 relativa ai paratesti, particolarmente rilevante nelle fasi di ‘vuoto’ caratterizzate dall’assenza da palinsesto dell’oggetto o dalla pre-senza delle sole repliche, a muovere un fi lone di discorso (le ‘anticipazioni’) tipico della macro fase dell’‘attesa’.
00_Tosoni.indd Sez3:7300_Tosoni.indd Sez3:73 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
74 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
bassa intensità discorsiva e visibilità) e altri più centrali (ad alta intensità discorsiva e/o ad ampia visibilità in Rete). Così, per esempio, 100 com-menti a un video di YouTube relativo al «Grande Fratello» possono far sì che la piattaforma venga considerata, per le caratteristiche dell’ogget-to, uno spazio a densità discorsiva medio-bassa e dunque semiperiferico nello specifi co caso, mentre per un prodotto minore posso essere suffi -cienti poche decine di scambi all’interno di spazi dedicati (come le pic-cole forum community di fan con poche decine di iscritti) per qualifi carli come spazi ad alta intensità discorsiva, e dunque centrali.
In secondo luogo, il monitoraggio sistematico dell’intensità discor-siva nei diversi ambienti on line permette di intercettare, da una parte, ritmicità ricorrenti e, dall’altra, variazioni rilevanti che possono rinviare a trasformazioni nella struttura complessiva dello spazio del web tele-visivo: tutti eventi che meritano attenzione, risultando potenzialmente legati a spostamenti di audience, a caratteristiche specifi che delle diver-se fasi del ciclo della messa in onda del prodotto, o ad altri fenomeni rilevanti per gli scenari della convergenza.
2.3. Discorsi
Accanto e parallelamente a tale ricognizione delle strutture spaziali e temporali del web televisivo, il ricercatore dovrà concentrare la propria attenzione sui concetti sensibilizzanti identifi cati all’inizio del processo di osservazione, e in particolare su quelli che abbiamo defi nito ‘discorsi’ e ‘pratiche’20. Si tratta cioè, fi nalmente, di procedere a una lettura – e a un’analisi – il più sistematico possibile degli interventi presenti on line: operazione che spesso implica, da una parte, forme di deriva ipertestua-le, all’inseguimento di link e riferimenti discorsivi trasversali rispetto ai diversi spazi selezionati; e dall’altra, un’attenta selezione degli snodi comunicativi più interessanti per gli obiettivi della ricerca, vista l’inge-stibile mole di post a volte generata all’interno di campi etnografi ci pur accortamente selezionati. Considerato che la ricerca della massima ete-rogeneità possibile costituisce uno dei criteri di assemblaggio del cam-po etnografi co, il ricercatore si troverà peraltro a procedere all’analisi di forme testuali anche profondamente diverse tra loro: dai brevi fram-menti e dalle rapide annotazioni che caratterizzano le modalità comuni-cative di alcuni spazi, ai dialoghi e agli interventi più strutturati di altri, fi no a vere e proprie recensioni e articoli dal taglio semiprofessionale. All’interno di tali interventi, i discorsi rappresentano la ‘chiacchiera tele-
20 Un approfondimento teorico della complessità dei due termini è dato, per esem-pio, dal classico di De Certeau (1980).
00_Tosoni.indd Sez3:7400_Tosoni.indd Sez3:74 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 75
visiva’ on line, le differenti occasioni in cui ‘si parla’ dei programmi TV, dei personaggi che le popolano, delle proposte delle reti. In questo caso, il compito del ricercatore consiste nel procedere a una mappatura delle diverse tematiche presenti on line, approfondendo analiticamente quel-le che rispondono alle esigenze conoscitive a monte della ricerca21.
A un livello generale, è possibile distinguere almeno cinque diffe-renti tipologie di discorsi: una prima tipologia fa riferimento al singolo testo, isolato dal resto del fl usso TV. In questo caso, gli utenti/spettatori commentano le strutture narrative (le trame degli episodi di fi ction, i meccanismi di gara e di gioco nell’intrattenimento), seguono le vicende e i caratteri dei personaggi, in un ‘gioco’ di identifi cazione con il prota-gonista della fi ction preferita o con il concorrente per cui si tifa, oppu-re discutono criticamente le performance dell’attore o le incongruenze che svelano la costruzione del ‘tipo da reality’, o ancora analizzano lo sti-le del prodotto, dilungandosi in considerazioni sulla regia, sulla colonna sonora, sulla scenografi a e via dicendo. Una seconda tipologia di discor-si affronta il prodotto-brand in modo contestualizzato, tentando di col-locarlo all’interno di un modello (per esempio, facendo riferimento al format di origine e considerandone l’adattamento nazionale, o inseren-do il testo nella storia di un genere televisivo) e poi di un palinsesto (è il caso di tutte le discussioni sulle dinamiche della programmazione, che si allargano spesso a considerazioni generali sull’immagine della rete e della piattaforma ospite, o sulle politiche del gruppo editoriale). Sem-pre all’interno di questa seconda tipologia, particolarmente interessanti risultano i discorsi che rimandano a consumi altri rispetto al prodotto-brand (musica, videogame, libri, o anche altri prodotti televisivi), eppu-re a esso associati in una medesima dieta di consumo condivisa. Una ter-za tipologia tematizza invece le forme di produzione paratestuale, quali le strategie e le testualità promozionali, o le modalità di ricezione del prodotto da parte della critica TV: e ciò tanto in forma esclusiva, quanto congiuntamente a discorsi relativi al prodotto (in sé o contestualizzato). Assai spesso poi (e si tratta della quarta tipologia di discorso), il prodotto funge da stimolo, da pretesto o da occasione di rilancio per la discorsi-vizzazione di tematiche più generali ed eccentriche rispetto a quelle più direttamente collegate al prodotto stesso: può per esempio trattarsi del-la tematizzazione di argomenti d’attualità (si pensi alla fi ction di mafi a e alle frequenti discussioni sul sottile confi ne tra narrazione e apologia), di politica o di costume. Un’ultima tipologia di discorso può infi ne rinvia-
21 Nel caso di una ricerca amministrativa, l’analisi dei discorsi potrà per esempio for-nire utili chiavi di lettura per capire come un prodotto-brand è stato accolto in Rete, quali sono i suoi elementi di maggiore forza e quali invece le principali criticità.
00_Tosoni.indd Sez3:7500_Tosoni.indd Sez3:75 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
76 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
re in modo rifl essivo agli stessi soggetti o gruppi studiati, e perciò essere defi nita ‘autoriferita’: si tratta di off topic e metadiscussioni sul funziona-mento degli spazi on line stessi che, oltre a permettere di approfondire le dinamiche degli ambienti e di chi li ‘abita’22, acquisiscono talvolta una visibilità inaspettata, come quando un termine ‘da blog’ è usato nella trasmissione commentata (è successo, per esempio, con ‘ormonose’, comparso su TvBlog e usato da Simona Ventura a «X-Factor»).
Al di là della parzialità di ogni possibile classifi cazione, ciò che più conta è però quel processo circolare di progressiva specifi cazione delle domande di ricerca e di concomitante approfondimento analitico del-le tipologie discorsive individuate che a esse più da vicino rispondono, secondo modalità ispirate a quelle descritte dalla Grounded Theory di Glaser e Strauss23: processo, peraltro, che è parallelamente chiamato a riorientare l’osservazione e l’attenzione del ricercatore.
2.4. Pratiche
Le pratiche rappresentano invece le attività che i soggetti mettono in atto intorno a, e a partire da, risorse messe loro a disposizione dal medium televisivo: dimensione che costituisce, come anticipato24, uno degli assi centrali dei nuovi scenari della convergenza.
A livello generale – e ribadendo la necessità di un movimento cir-colare tra defi nizione delle categorie analitiche, domande di ricerca e osservazione – se ne possono individuare di tre tipi, ciascuna delle qua-li rimanda a una delle parole chiave della TV convergente: estensione, accesso e brand. Tra le pratiche di estensione rientrano tutte le forme di produzione o di fruizione di risorse e materiali aggiuntivi rispetto alla versione principale di un prodotto-brand: può trattarsi di risorse infor-mative o multimediali on line (uffi ciali o non uffi ciali), di blog dedicati, di espansioni narrative o diegetiche del prodotto (a cura della produ-zione o dei fan) come webisode, fan art o fan fi ction, di derivazioni del prodotto su altri media (fumetti, videogiochi, produzioni discografi che) o di merchandising, sviluppato anche in altri contesti nazionali. Possono essere fatte rientrare nella categoria di espansione anche tutte le for-me di interazione diretta del consumatore con il programma, come il televoto, la partecipazione a casting di reality (ma anche la loro fruizio-
22 Una rigida politica di gestione dei cosiddetti spoiler, o anticipazioni, può per esem-pio essere indice dell’esistenza di forme temporali complesse e stratifi cate all’inter-no dello spazio virtuale indagato.23 Cfr. Glaser - Strauss (1967).24 Cfr. supra, par. 1.
00_Tosoni.indd Sez3:7600_Tosoni.indd Sez3:76 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 77
ne, nel caso siano resi disponibili), la presenza a eventi come concerti e anteprime, il coinvolgimento in giochi e attività promozionali. Costi-tuiscono invece pratiche di accesso tutte le differenti forme e modalità di fruizione del prodotto-brand, da quelle più tradizionali a quelle più innovative (siano esse legali o meno) come la fruzione attraverso i siti delle emittenti, i canali di catch-up, lo streaming legale o illegale, i circuiti peer-to-peer, via DVD o media mobili. Sono infi ne riconducibili al brand tutte quelle pratiche che rappresentano forme di adesione (o, al contra-rio, di disaffezione) alle strategie comunicative adottate dal programma, dalla rete, dal bouquet di offerta o dalla piattaforma, quale la fruizione o il commento di promo, di ident, o della relativa comunicazione televisiva ed extratelevisiva.
Indipendentemente dalla loro tipologia, due sono i modi – diversi e complementari – in cui il ricercatore che faccia ricorso alla virtual ethnography può ricostruire le pratiche che prendono vita attorno al web televisivo. Innanzitutto, ciò può avvenire a partire dalla loro discorsiviz-zazione e tematizzazione: in sostanza un’ulteriore, e specifi ca, tipologia di discorsi consiste in testimonianze e racconti sulle forme di accesso, di rielaborazione, di fruizione attiva del prodotto (come pure del cana-le o della piattaforma che lo ospita). Nonostante non possa essere data per scontata la corrispondenza tra le pratiche effettivamente messe in opera dagli utenti e il loro racconto on line, tali verbalizzazioni risulta-no comunque preziose per la ricostruzione delle diverse attività degli utenti. Non meno preziose risultano, in secondo luogo, le risorse pre-senti on line che di tali pratiche costituiscono lo specifi co lascito, e che possono essere dunque considerate loro indici e indizi: è per esempio il caso della presenza di un programma nei circuiti peer-to-peer, della disponibilità in Rete di forme di fan fi ction (originali o risultato di rias-semblaggi del prodotto) o di spazi dedicati a pratiche ludiche con il programma (come avviene nelle raccolte di citazioni o di indovinelli su una particolare serie).
Ricostruite in tal modo le pratiche, è dunque possibile metterle in relazione ai discorsi, e assieme a questi alla struttura spazio-temporale del web televisivo, alla ricerca di pattern comuni e di similitudini, così come di casi ‘devianti’ di particolare interesse. Per capire meglio che cosa succede ai programmi TV sulla Rete.
3. Analisi del web televisivo: alcuni esempi
Per esemplifi care il funzionamento e le capacità euristiche dell’approc-cio appena presentato riportiamo alcuni casi di studio, relativi al web televisivo connesso a programmi in onda nel nostro Paese nella stagio-
00_Tosoni.indd Sez3:7700_Tosoni.indd Sez3:77 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
78 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
ne 2008/200925. Ciascuno dei casi è stato selezionato in quanto parti-colarmente signifi cativo per uno dei quattro punti in cui si articola la proposta metodologica fi n qui presentata, nonostante sia chiaramente impossibile – e anzi controproducente – isolare tali elementi focalizzan-do esclusivamente su di essi: ciascun caso di studio mette in luce le for-ti interrelazioni esistenti tra essi, e in particolare fra spazi e i tempi in «Uomini e Donne», tempi e pratiche in «Heroes», discorsi e spazi nel «Grande Fratello», pratiche e tempi in «Romanzo Criminale».
3.1. Gli spazi di «Uomini e Donne»
Programma dal lungo e duraturo successo, in onda ininterrottamente dal 1996 nel daytime di Canale 5 con risultati di audience sempre lusin-ghieri, «Uomini e Donne» rappresenta un caso di studio particolarmen-te interessante dal punto di vista della spazialità, articolando un pecu-liare spazio discorsivo on line policentrico. Ibrido di dating game, reality e talk show, il programma condotto da Maria de Filippi appare inter-cettare, anche grazie alla collocazione oraria, una signifi cativa audience nella fascia 15-35, particolarmente attiva on line. I sedici anni di attività del programma (ma più segnatamente a partire dalla revisione del for-mat avvenuta nel 2001, con cui il programma raggiunge la sua forma attuale con la dinamica fra ‘trono’, ‘pretendente’ e ‘opinionisti’) hanno sedimentato infatti una galassia discorsiva di ampia portata, altamen-te eterogenea e policentrica. Ciò in ragione del fatto che il discorso di «Uomini e Donne» appare sincronizzato con temporalità multiple: alla temporalità T1 sincronizzata con la messa in onda quotidiana (che ritma la discussione della puntata) si affi ancano numerosissime temporalità Tn che seguono i percorsi dentro e fuori dal programma dei protagonisti presenti e passati. I vari personaggi di «Uomini e Donne» (soprattutto a partire dal 2001) si trovano in questo senso collocati in un eterno pre-sente – il tempo del gossip, della chiacchiera – al quale sono ricondotte traiettorie esistenziali e biografi che, vicissitudini sentimentali e percorsi lavorativi. Tutti, con popolarità diversa, fanno parte dello stesso ‘pan-theon’; la temporalità T1 – e gli spazi che la seguono – non è, in questo senso, necessariamente quella fondamentale. Anzi, il discorso in Rete
25 Gli esempi a seguire sono stati scelti all’interno di un campione di dodici casi, analizzati triangolando metodologie sia desk che fi eld nell’ambito una ricerca – cui gli autori del presente saggio hanno partecipato occupandosi di virtual ethnography – commissionata da Mediaset/RTI e realizzata dal Ce.R.T.A., Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica di Milano. I risultati complessivi della ricerca sono consultabili in Grasso - Scaglioni (2010).
00_Tosoni.indd Sez3:7800_Tosoni.indd Sez3:78 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 79
su «Uomini e Donne» appare proseguire tranquillamente anche quan-do il programma non è in onda, alimentandosi prevalentemente con i circuiti dell’informazione, tramite materiale pubblicato su rotocalchi di gossip o anche autoprodotto dagli stessi utenti, per esempio con la segnalazione e discussione degli ‘avvistamenti’ dei personaggi fuori dal programma26.
In sostanza, il programma appare funzionare come macchina crea-trice di personaggi assai più che come prodotto narrativo in se stesso. Tali personaggi, semiautonomi ma per sempre legati a doppio fi lo al programma (come esemplifi cato dalla dicitura «di “Uomini e Donne”» che segue sempre il nome dei soggetti in questione quando le loro vicis-situdini vengono notiziate fuori dagli spazi del fandom), entrano quindi in un ‘pantheon’ regolato a un tempo dai codici della soap, della fi aba e del reality. Si registrano così fenomeni di ‘tifo’ perché una particola-re coppia si formi (o si dissolva), ma soprattutto periodiche invocazioni agli ‘autori’ perché di fatto ‘pieghino la realtà’ ai desideri del pubblico (modalità che torneremo a esaminare con il caso del «Grande Fratel-lo»): discorso che si muove ambiguamente sul crinale fra realtà e fi ction, e che utilizza il ‘reale’ – ossia quanto avviene nello spazio esterno allo studio – come cartina tornasole della veridicità di situazioni e atteggia-menti. La testimonianza diretta dei comportamenti ‘reali’ dei personag-gi acquisisce in questo senso grande valore all’interno del fandom; alla sua raccolta, socializzazione e disamina sono dedicati ampi spazi27.
Tale centralità del personaggio spiega la natura frammentata e poli-centrica dello spazio discorsivo. A ciascuno dei personaggi sono dedicati spazi specifi ci gestiti da fan (segnatamente nella forma delle forum com-munity, che attualmente appaiono la piattaforma preferita dal segmento teen), che talvolta ottengono l’imprimatur di ‘uffi cialità’ perché oggetto
26 Si consideri il seguente esempio: «Allora io ero andata a pranzo in un ristorante di san benedetto cn la mia famiglia e visto ke era pasquetta fi nito di pranzare deci-diamo di andarci a fare un giro per il corso di san benedetto e dopo diversi giri ki mi vedo di fronte al bar...eh si proprio lui marcelo le mie cuginette a momenti si sentivano male ahah lui stava fuori dal bar a parlare cn un signore... [...]» (Fonte: marcelofuentes.forumcommunity.net).27 Si consideri il seguente esempio: «allora ieri 19\19 a roma in centro via cola di rienzo al bar portofi no si trovava carmine con una ragazza e si baciavano.ma è vero oppure no questo programma???ma carmine non stava corteggiando elga????io ci ho anche parlato con carmine e sono sicurissima che era proprio lui si è presentato.se non ci credete andate a chiedere a quel bar del centro.quell uomo(carimne) non è sincero.e se questo programma è veramente vero come si dice mi sembra giusto prendere provvedimenti.un altra cosa carimne mi ha confermato che elga è un oca.. arrivederci» (Fonte: mondogossip.blog).
00_Tosoni.indd Sez3:7900_Tosoni.indd Sez3:79 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
80 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
di interazione diretta da parte dei personaggi stessi (che vi partecipano in chat o scrivendo post). Tale è la salienza di «Uomini e Donne» e la sua presa sull’immaginario che spazi informativi ‘alti’ (quali i quotidia-ni), ‘medi’ (blog specialistici sulla televisione come TvBlog.it) e ‘bassi’ (periodici scandalistici, sezioni ‘gossip’ dei portali) si occupano con continuità del ‘pantheon’ dei personaggi, generando un fl usso comu-nicativo transmediale (che comprende televisione, web, fonti a stampa, passaparola). Tale fl usso può essere metaforizzato con l’immagine di un fi ume: composto da innumerevoli rivoli (ciascuno dedicato a un perso-naggio), eternamente uguale a se stesso eppure sempre in scorrimento. La predominanza del tempo presente fa sì che la storicizzazione (la rac-colta sistematica e ordinata di materiali) in relazione a un personaggio risulti attività totalmente subordinata alla discussione effi mera ed estem-poranea delle sue vicende del momento.
L’esplorazione di tale spazio consente di sperimentare – esasperan-dole – le problematiche relative al taglio del campo etnografi co delinea-te nei paragrafi precedenti. Esso risulta uno spazio altamente mutevole e cangiante, che si appoggia su una molteplicità di piattaforme e sistemi. Parte di questi spazi sono dedicati alla fruizione in diretta o in differita del programma (segnatamente, i siti di streaming e una parte dei conte-nuti di quelli di video sharing); un’altra parte si occupa invece di ospitare il fl usso discorsivo, nella forma della discorsivizzazione asincrona (forum community, blog specialistici, blog generalisti, thread in forum dedicati ad altro, siti uffi ciali dei protagonisti, siti uffi ciali del programma, pagine sui social network, pagine web dedicate, aree commenti su siti di video sharing) e talvolta sincronizzata con la messa in onda del programma (soprattutto le chat delle forum community). Tali nodi, pur eterogenei, risultano però non disconnessi: a tenerli insieme sono da un lato l’iden-tità di brand, e dall’altro l’essere snodi per la circolazione di materiali identici (lanci di agenzia, articoli di giornale, fotografi e, spezzoni video, ma anche post dei protagonisti, trascrizioni di chat, montaggi video ecc.) che si replicano da uno spazio all’altro, venendo ripresi e ricontestualiz-zati. È lo stesso fl usso transmediale di «Uomini e Donne» a tenere uni-ta la propria galassia discorsiva, alimentandola continuamente. Proprio a causa della centralità della pratica del repost, fra gran parte dei punti d’accesso a questo universo vige un regime di sostanziale equivalenza. La densità degli scambi comunicativi appare quasi sempre alta o molto alta per via della popolarità del programma. Identifi care in queste con-dizioni uno spazio ‘esemplare’ diventa quindi estremamente diffi cile: si tratta di una galassia ampia e cangiante, in cui nuovi spazi vengono continuamente aperti. Viene in aiuto in questo senso la stessa comunità degli utenti, che produce periodicamente ‘mappe’ con cui orientare i nuovi arrivati. La modalità tipica vede il neofi ta porre domande su piat-
00_Tosoni.indd Sez3:8000_Tosoni.indd Sez3:80 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 81
taforme quali Yahoo!Answers o alcune pagine di Facebook, e ricevere come risposta elenchi di siti ‘importanti’28. La discussione intorno a que-ste mappe aiuta il ricercatore a orientarsi, anche a fronte di migrazioni e spopolamenti cui talvolta sono repentinamente sottoposti gli spazi in esame. Il crisma dell’‘uffi cialità’ rappresenta un’altra risorsa importan-te per orientarsi: l’interazione diretta dei protagonisti con uno spazio discorsivo (come la pubblicazione in un forum di un post a fi rma di un personaggio, o la sua partecipazione alla chat di una community) confe-risce a quello spazio un carattere di ‘uffi cialità’, e dunque di centralità nello spazio del web televisivo.
3.2. I tempi di «Heroes»
«Heroes» è stata insieme una delle serie più attese (e meglio lanciate) e una delle più grandi delusioni della televisione americana degli ultimi anni. In onda sul network NBC per quattro stagioni, tra il 2006 e il 2010, il prodotto voleva costituire – sulla base di esperienze precedenti, prima fra tutte «Lost» – un punto di incontro tra il pubblico generalista e la fantascienza, tra le graphic novel di supereroi e il mezzo televisivo, inteso in un’ottica transmediale e convergente: storie a fumetti, webisode e paro-die completavano una narrazione già focalizzata su un grande numero di personaggi, dotati di superpoteri, che man mano si accorgevano della presenza di altri ‘eroi’ loro simili (e di nemici che davano loro la caccia). L’eccessiva complessità dell’intreccio e una qualità di scrittura altalenan-te hanno però impedito grandi ascolti, dopo un’ottima partenza, e così contribuito alla chiusura anticipata della serie.
L’arrivo in Italia di «Heroes» somma a queste diffi coltà ulteriori com-plessità, con un lancio ambizioso a cui è seguita una serie di ‘ritirate strategiche’. La prima stagione è stata trasmessa, nell’autunno 2007, in prima serata da Italia 1, con due episodi ogni domenica. Ben presto, però, di fronte a dati di ascolto non entusiasmanti, gli episodi conse-cutivi sono diventati tre, e infi ne la serie è slittata in seconda serata. Le stagioni successive hanno seguito un’altra strada: gli episodi sono andati prima in onda a pagamento sul digitale terrestre, sul canale Steel/Sci-Fi di Mediaset Premium, a più di un anno di distanza dagli Stati Uniti, e
28 Si considerino i seguenti due esempi: «ciao a tutti!! spesso su Uomini & Donne (nel-le puntate di paola e valentina specialmente) si è parlato di una loro “chat” in cui loro stesse scrivono tutti i loro pensieri ecc ecc... sapete dov’è questo sito?? io x esem-pio sto cercando la chat di serena.....!! vi prego è urgente rispondete in tantix!!» (Fonte: Yahoo!Answers); «Per favore, mi potreste dire tutti i forum (circuito forum free, forum community e blog free) che conoscete su Uomini & Donne, tronisti e cor-teggiatori ?? GRAZIE!» (Fonte: Yahoo!Answers).
00_Tosoni.indd Sez3:8100_Tosoni.indd Sez3:81 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
82 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
solo dopo svariati altri mesi sono approdati sulla TV gratuita, su Italia 1 in seconda serata. Proprio questo complesso aggiustamento progressivo, con le conseguenti incertezze per gli spettatori italiani (e in particolar modo per gli appassionati), rende particolarmente interessante leggere i discorsi degli spazi web dedicati, o comunque relativi a questa serie, alla luce della loro dinamica temporale. Come conseguenza di questo ‘maltrattamento’, da un lato, e insieme del più generale interesse per le serie TV americane sviluppatosi negli ultimi anni, dall’altro, proprio il web ha giocato un ruolo essenziale per gli spettatori italiani di «Heroes»: da una parte, fornendo opportunità di visione della serie alternative alla messa in onda televisiva tradizionale; dall’altra, creando spazi di discor-so in cui mettere a tema, tra pari, proprio le complesse vicende della trasmissione italiana.
Su blog, forum e social network, i discorsi in cui i fan di «Heroes», fi n dalla prima stagione, si sono scatenati sono proprio quelli legati alla pro-grammazione29. In particolare, la collocazione nella prima serata dome-nicale a fi ne estate è una ‘sfortuna’ assai dibattuta, e viene ritenuta da alcuni all’origine dello scarso interesse italiano per questa serie. Viene poi contestata la collocazione in seconda (o terza) serata su Italia 1: si tratta di una scelta da alcuni addirittura interpretata come un invito a procurarsi al trove, anche per vie illegali, le puntate desiderate, da altri letta come una mossa tattica per aumentare gli abbonamenti della pay TV. Infi ne, anche gli spostamenti ‘in corsa’ della serie sono valutati nega-tivamente, come un chiaro segnale di mancato rispetto per i telefi lm e i loro spettatori. Sempre negli stessi spazi, la soluzione alle ristrettezze imposte dalla TV tradizionale è così indicata in altre possibilità di visione e accesso, da YouTube a forme illegali30. La modalità di ‘anticipazione’ della serie preferita è infatti il download, attraverso sistemi di fi le sharing come eMule: la Rete consente nuovi usi, tempi e possibilità di vedere il prodotto, e non c’è ra gione per rinunciarvi; qualche volta si forniscono persino dettagli tecnici, indicando siti con le scorciatoie per ot tenere i
29 Alcuni esempi: «In Italia non ha avuto la giusta collocazione [...]. Ormai siamo abi-tuati a questi scempi di telefi lm, pur troppo» (Fonte: TvBlog); «Già quando la misero di domenica in prima serata non la seguiva nessuno, fi guriamoci in seconda serata» (Fonte: forum di Itasa); «Probabilmente perché da noi (in Italia rispetto in America) non ha un grande successo, quindi è per questo ke lo mettono in seconda serata... Peccato» (Fonte: Facebook).30 Alcuni esempi: «Mi vedo le puntate in inglese sottotitolate il giorno dopo che sono uscite in Usa» (Fonte: forum non uffi ciale di «Heroes»); «Io la sto scaricando ades-so!» (Fonte: Facebook); «In lingua originale sono stupende. Il doppiaggio italiano, in quanto a Heroes, mi ha decisamente delusa. Magari me le scarico in italiano, ma resterò fedele ai sottotitoli» (Fonte: un forum).
00_Tosoni.indd Sez3:8200_Tosoni.indd Sez3:82 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 83
fi le o rivelando gli indirizzi di altri depositi on line. Legati a doppio fi lo con i discorsi sul download illegale sono poi quelli relativi ai sottotitoli, molto fre quenti sia negli spazi generalisti sia sui forum delle comunità di fansubber: qui scattano inevitabili i confronti con la versione origina-le, che riguardano le varie temporalità, la dif fi coltà del sottotitolo (che distrae dall’immagine) e soprattutto i difetti imputati al doppiaggio ita-liano31. Infi ne, sono frequenti i riferimenti allo streaming ille gale di sin-gole puntate, che riduce ancora di più i tempi rispetto all’America o comunque consente di evi tare le procedure macchinose del download.
Questa diversifi cazione dei tempi di visione di «Heroes», con la sepa-razione tra chi (in particolare dopo la fi ne della prima stagione su Ita-lia 1) segue il telefi lm in accordo al palinsesto americano, chi lo vede sul digitale terrestre a pagamento e chi invece aspetta Italia 1, porta il discorso on line a coagularsi attorno a tre distinte temporalità di sincro-nizzazione. In particolare sui forum, thread differenti e intere aree sono dedicate a chi sceglie ciascuna delle tre ‘strade’: i discorsi vengono così segmentati all’interno di sottocomunità dedite al commento degli episo-di (senza il rischio di spoiler, ossia di anticipazioni su puntate che altri fan magari hanno già visto). Gli spazi che presentano al loro interno mino-ri suddivisioni, come i blog o i social network, risolvono invece questa polarizzazione in due modi: da un lato, scegliendo una delle fi nestre di fruizione come prevalente, e concentrando la loro attenzione su di essa (complici le diffi coltà della messa in onda televisiva, il fandom di «Hero-es» si è decisamente sbilanciato sui tempi del download e dello streaming delle puntate originali); dall’altro, dedicando numerosi discorsi a sotto-lineare la natura e le ragioni di queste ‘fratture’, aprendosi così al dibat-tito sulle scelte di visione migliori, al confronto tra le varie possibilità e alla lamentela verso istituzioni TV percepite come ingiuste e distanti.
All’interno di questi spazi e sottospazi, poi, un’ulteriore scansione dei tempi è imposta dalla stessa natura seriale dell’oggetto di discorso, con i tempi dettati dal palinsesto televisivo prescelto (quale che sia), e quindi con i momenti di messa in onda alternati alle pause di program-mazione (hyatus). Nelle fasi in cui la serie non va in onda, gli spazi on line seguono il ritmo delle notizie e delle indiscrezioni, dei giudizi e del-le anticipazioni, del lancio di prodotti ancillari e delle interviste ad atto-ri e autori. Mentre la serie va in onda – soprattutto in corrispondenza della programmazione americana, ma in subordine anche in accordo alla messa in onda pay e a quella free italiane –, si può rile vare il tentativo spesso riuscito di sincronizzare il discorso web ai tempi della messa in onda stessa. Una volta scelta la fi nestra di riferimento della comunità,
31 Si veda, a proposito del fansubbing e del doppiaggio, Barra (2009).
00_Tosoni.indd Sez3:8300_Tosoni.indd Sez3:83 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
84 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
l’attesa per la pun tata e il commento immediatamente successivo seguo-no il ritmo dei palinsesti: la scansione può essere leggermente ‘sfasata’, dati per esempio i differenti tempi di download o il recupero attraverso le repliche sulla pay, ma rispecchia una suddivisione settimanale, con al centro l’‘appuntamento’, ossia la trasmissione del nuovo episodio. L’unica temporalità assente è quella del live: il discorso non è mai con-temporaneo alla puntata, ma confi nato al prima e al dopo. La visione di una serie complessa come «Heroes» non concede distrazioni, e così non ci sono commenti in tempo reale.
In defi nitiva, il web televisivo di «Heroes» si è strutturato cercando di ‘completare’ un’esperienza fruitiva che, se fosse rimasta legata al solo piccolo schermo, avrebbe rischiato di risultare problematica o persino ‘abortita’. Il discorso on line italiano si è così prevalentemente settato su una temporalità statunitense (sia in ambienti legati al fi le sharing e al subbing, sia in blog e forum televisivi), complici i ritardi, le lacune e la confusione della televisione ‘tradizionale’.
3.3. I discorsi del «Grande Fratello»
Come già «Uomini e Donne», anche «Grande Fratello» può contare su un vasto sedimento di discorso on line dovuto a un successo in grado di perdurare da dieci anni, e alla capacità di rivolgersi con forza alla fascia 15-40, particolarmente attiva on line. L’applicazione della virtual ethnography allo spazio discorsivo on line del «Grande Fratello» ha fatto emergere risultati particolarmente interessanti dal punto di vista della mappatura dei discorsi on line. Ciò a partire dalla caratteristica centrale del «Grande Fratello» in Italia, ossia la capacità del programma, nel tem-po della sua messa in onda, di dettare e rifl ettere allo stesso tempo i temi dell’agenda sociale e mediale: da un lato, quel che accade nel program-ma costituisce notizia per tutto l’apparato mediale; dall’altro, esso appa-re rifl ettere al suo interno alcune tematiche ‘forti’ presenti nel discorso sociale (nel caso dell’edizione oggetto di analisi, i temi dell’immigrazio-ne, dell’omosessualità, della chirurgia plastica e, più tangenzialmente, delle cure psichiatriche) che i personaggi incarnano o vivono.
L’aspetto più interessante del «Grande Fratello» è la sostanziale cor-rispondenza fra geografi a degli spazi e geografi a dei discorsi: una meta-fora calzante per sintetizzare lo spazio discorsivo del «Grande Fratello» potrebbe essere quella del fortino assediato. Da un lato, abbiamo un vastis-simo fuori (che comprende gli spazi tradizionalmente ‘alti’ della blogo-sfera, ma anche territori più ‘neutrali’ come i siti di fi le sharing, quelli di news e in generale tutti quelli che non sono dedicati espressamente al programma), dominato da un discorso fortemente critico, che potrem-mo defi nire ostile, rispetto a tutti gli elementi del programma (personag-
00_Tosoni.indd Sez3:8400_Tosoni.indd Sez3:84 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 85
gi, vicende, conduzione, mission, format, pubblico). Proprio per via della grande popolarità del prodotto, questo ‘fuori’ ostile risulta estremamen-te esteso e diffuso. A fargli da contraltare è un vero e proprio fortino, uno spazio protetto in cui gli appassionati del programma (numerosis-simi e molto attivi) si rinchiudono. Esso comprende quegli spazi speci-fi camente dedicati al «Grande Fratello» (segnatamente alcune grandi forum community e le loro community-satellite, più una grande quantità di spazi più piccoli – soprattutto piccoli blog – dedicati al programma e ai suoi personaggi) dove, oltre a discutere dei personaggi e delle situazio-ni, esiste ed è praticato un discorso critico sul programma assai peculia-re, e su cui torneremo a breve. I due spazi risultano sostanzialmente non comunicanti: i due discorsi non interagiscono, come pure i due gruppi di utenti. Da un lato perché i fan del «Grande Fratello» non hanno inte-resse a esporsi a critiche in spazi ostili, consci della pregiudiziale che vige sul programma: diffi cilmente un soggetto appartenente al gruppo del fortino interagisce nello spazio ostile, per esempio prendendo le difese del programma contro i detrattori; al massimo, i fan tendono a indicare il programma come ‘puro entertainment’, quindi ‘socialmente inoffensi-vo’ e pertanto non meritevole di critica32. Analogamente, il discorso dei detrattori è espunto dal fortino attraverso attente policy di moderazione, che eliminano rapidamente i post ostili; più generalmente, gli ostili ten-dono a non frequentare gli spazi specifi camente dedicati al programma. Quando, raramente, negli spazi condivisi (quali i blog televisivi) «Grande Fratello» viene raffrontato con i suoi concorrenti in palinsesto (segnata-mente, nella stagione in esame, «X-Factor»), il discorso dei fan usa come unica risorsa i risultati di audience (laddove, per esempio, i sostenitori di «X-Factor» insistono sulla qualità intrinseca del programma).
Il discorso critico esercitato dentro il fortino, cui si faceva riferimen-to poco sopra, si impernia invece sulla dinamica fra realtà, reality e game che abbiamo incontrato in «Uomini e Donne». Da un lato, i fan del pro-gramma riconoscono l’esistenza di una dimensione fi nzionale (di cui però difendono sempre, quasi per partito preso, l’autenticità di fronte ad accu-se di ‘falsità’ provenienti dall’‘esterno’ del fortino33). A essere ‘falso’ non è
32 «Prova a pensare per un attimo che forse qualche telespettatore del gf vive una realtà personale drammatica e pesante e ha diritto a un po’ di evasione per soppor-tare la propria croce senza impazzire» (Fonte: Forumfree). «Il gf può considerarsi valvola di sfogo per chi lavora 12h /24h e ha problemi di famiglia, a cui ogni tanto nn va di pensare. Se a te nn piace nn guardalo; ma nn criticare gli altri solo perchè hanno gusti differenti dai tuoi L’ignorante dimostri di essere tu in questo caso» (Fon-te: TvBlog).33 «Ragazzi basta, sono 9 edizioni che si fa sempre lo stesso discorso TRITO e RITRI-TO... è tutto fi nto... è tutto calcolato... hanno un copione... è tutto manipolato...
00_Tosoni.indd Sez3:8500_Tosoni.indd Sez3:85 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
86 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
però ciò che si vede avvenire nella casa, che è considerato, in linea di massi-ma, corrispondere allo spontaneo agire dei concorrenti. Semmai, gli stessi concorrenti sarebbero (con grado variabile di consapevolezza) manipolati dagli ‘autori’, in grado di orientarne gli atteggiamenti attraverso opportune stimolazioni (mostrando ai concorrenti video, per esempio, o interagendo nel cosiddetto ‘confessionale’) piegandone così (senza che i concorrenti ne abbiano consapevolezza) l’agire verso i ‘propri fi ni’. A questa pratica di ‘coltura behaviorista’ dei concorrenti nella casa si aggiunge anche la manipolazione del pubblico: infl uenzando il televoto, gli autori sarebbero responsabili di tutta una serie di aggiustamenti sul gruppo dei concorrenti, infl uenzando anche in questo modo le vicende della casa (con particolare riferimento alle relazioni sentimentali, che ai fan stanno particolarmente a cuore). In un certo senso dunque gli autori costituirebbero una speciale tipologia di personaggi in gioco, a fi anco di quella dei concorrenti. A fronte di ciò, l’appassionato necessita di vedere quanto più possibile del program-ma per capire cosa realmente accade. L’accesso al live (ossia alla diretta in tempo reale dall’interno della casa del «Grande Fratello», possibile solo su piattaforme pay) viene tematizzato come pilastro centrale di un accesso ‘in profondità’ al ‘vero’ programma, che rende possibile questa esperienza di detection. Si tratta necessariamente di un consumo multipiattaforma che comprende, oltre alla puntata settimanale, la diretta su Sky e/o Mediaset Premium, la striscia pomeridiana, i siti di video sharing e di streaming (da uti-lizzarsi come risorsa per argomentare le proprie tesi), le fonti informative e gli spazi del forum. Attraverso tale operazione di reframing, la comunità degli appassionati depotenzia (perlomeno all’interno del proprio perime-tro) la pregiudiziale esistente sul programma mettendolo al riparo dalla principale delle accuse mossegli, quella di ‘falsità’. Così inquadrata, l’artifi -ciosità non è infatti negazione del progetto comunicativo di un programma il cui genere fa direttamente appello alla ‘realtà’, ma viene incorporata nel progetto comunicativo stesso, opportunamente rinegoziato.
3.4. Le pratiche di «Romanzo Criminale»
Esperimento di fi ction ‘adulta’ di alta qualità, che narra, cambiando alcuni nomi, le vicende che hanno riguardato la Banda della Magliana, «Romanzo Criminale» si è dimostrato un oggetto in grado di restituire risultati particolarmente interessanti nei termini dell’analisi delle pratiche
decidono tutto gli autori... i ragazzi sono pilotati...è tutto falso.... Basta eh :)Ma non perchè “non si può dire” ma perchè è un argomento su cui si potrebbe discutere per generazioni senza ovviamente mai venirne a capo, è un pò un discutere sul nulla» (Fonte: Forumfree, 16 aprile 2009).
00_Tosoni.indd Sez3:8600_Tosoni.indd Sez3:86 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 87
articolate dal pubblico. Le pratiche che investono «Romanzo Criminale» testimoniano infatti la sua immediata cultizzazione: quello che si regi-stra è un forte investimento simbolico da parte del pubblico, che diventa investimento identitario e che, in quanto tale, punta a valorizzare il pro-prio feticcio distinguendolo da quanto gli è affi ne per genere, tematiche o provenienza (quali i telefi lm, il genere poliziesco, la fi ction italiana, la televisione italiana in toto, lo stesso fi lm Romanzo Criminale e così via).
Il programma ha conosciuto tre fi nestre d’accesso principali: a) una messa in onda sulla TV satellitare pay, di grande successo;b) una successiva messa in onda in chiaro su Italia 1, sostanzialmente
trascurata dal pubblico generalista;c) una circolazione on demand legale (dal sito di Sky, poi in DVD) e
illegale (sui circuiti dello streaming e del peer-to-peer), che ha preso piede con la fi ne della prima fase.
La maggior parte delle pratiche relative al programma si sono attivate durante la prima fase, e hanno saturato tutte e tre le categorie tipologi-che (accesso, espansione e brand) illustrate nei paragrafi precedenti. In relazione all’accesso, il pubblico di «Romanzo Criminale» ha anzitutto dato vita a forme di visione collettiva, secondo due principali modalità. La prima è la visione parallela, che prevede una sincronizzazione con il proprio gruppo di pari on line, e generalmente la creazione tramite chat o post di un build-up nei momenti precedenti alla messa in scena («Domani è in onda la seconda puntata»; «Fra pochi minuti inizia, non sto nella pelle»; «Inizia!»); e una release con commenti ‘a caldo’ imme-diatamente dopo. A tale modalità risultano affi ancarsi anche forme di visione collettiva, che prevedono la riunione fi sica di un gruppo di spet-tatori davanti alla televisione. L’attivazione di tale modalità, certamen-te più dispendiosa in termini di risorse di quella parallela, testimonia il valore aggiunto conferito a «Romanzo Criminale» dal proprio pubblico. Tale valore risulta ulteriormente testimoniato da due fattori: anzitutto, durante la messa in scena su Sky, le forme di accesso ritualizzate della messa in onda risultano aver surclassato quelle illegali, pure notevol-mente più comode. Tale predominanza non si registra in altri prodotti di fi ction (segnatamente quelli di origine americana, come testimonia il caso di «Heroes»), ove la fruizione on demand illegale appare preva-lente in tutte le fasi. Inoltre, la visione collettiva si è spinta oltre: dopo la fi ne della messa in onda su Sky, hanno iniziato a essere organizzate ‘maratone’ collettive di visione dell’intera serie, eventi spesso privati ma talvolta pubblicizzati on line34. In quanto feticcio-cult, «Romanzo Crimi-
34 «R.C. ha scritto alle 15.37 del 8 marzo 2009 ieri l’impresa: l’intera serie, tutta in una notte criminale! ringrazio tutti coloro ke con buona volontà e grande spirito di
00_Tosoni.indd Sez3:8700_Tosoni.indd Sez3:87 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
88 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
nale» oppone resistenza alle logiche dell’on demand spinto: richiede un impegno, un sacrifi cio (che ricompensa).
Terminata la messa in onda, l’utilizzo del download e dello streaming (legale tramite il sito di Sky o illegale) diventa funzionale al recupero della serie (in parte o in toto per chi la scopre tardi) e alla visione ripe-tuta degli stessi episodi. Tuttavia, ciò appare non infi ciare l’attribuzio-ne, da parte dei fan, di un forte valore simbolico all’eventuale acquisto del cofanetto DVD della serie, mostrando così il perdurare della logica del feticcio35.
A queste pratiche relative all’accesso si affi ancano pratiche di espan-sione che affi ancano la messa in onda. Alle espansioni articolate dalla produzione (come lo streaming degli episodi e il gioco on line dedica-to al programma, ambedue offerti dal sito di Sky) si affi ancano quel-le articolate e codifi cate spontaneamente dalla comunità dei fan. Tra queste, si segnala anzitutto la ricostruzione e il tracciamento delle car-riere degli attori protagonisti e di alcune maestranze (registi, sceneg-giatori ecc.). Assai interessante appare anche la costruzione collettiva di una bibliografi a che fornisca all’appassionato gli strumenti per ‘inter-pretare correttamente’ il telefi lm. Tale bibliografi a multimediale, che comprende fi lm, siti e programmi televisivi, è costruita tramite segna-lazione, recensione e discussione di ciascun elemento. Al suo centro troviamo il libro di Giancarlo De Cataldo da cui la serie è direttamente tratta; intorno a esso gravitano altri testi sulla Banda della Magliana e spezzoni di programmi televisivi sullo stesso argomento (postati su YouTube e linkati dall’interno dei gruppi36). Rientra tangenzialmente in questo corpus anche l’omonimo fi lm di Michele Placido del 2005, tratto dal medesimo romanzo: il raffronto risulta tuttavia quasi sem-pre perdente per il fi lm. La costruzione della bibliografi a costituisce, di
sacrifi cio hanno contribuito alla realizzazione della serata..un grazie particolare ai pochissimi sopravvissuti alla maratona.... (07-03-09 h23.00......08-03-09 h10.00)......e a tutti quelli ke penseranno ke nn c’avevamo niente altro da fà, ke semo cojoni o kis-sà quali altri cazzi...rispondo con una citazione del Bufalo “comè ke se dice sti cazzi in africano!!???!!!??” daje!» (Fonte: Facebook, gruppo «Romanzo Criminale»).35 «A.A. ha scritto alle 15.37 del 21 novembre 2008 Ma uscira’ sta’ serie in DVD????»; «L.B. ha scritto alle 11.30 del 28 novembre 2008 uscira in dvd secondo voi? lo sto guardando su sky, mase esci in dvd lo prendo subito» (Fonte: Facebook, gruppo «Romanzo Criminale»).36 Esempio: «se vai su youtube e cerchi “La Banda della magliana blu notte” c’è la puntata del programma di Carlo Lucarelli divisa in spezzoni. Mi pare ne siano 10 cir-ca. Lì ti spiega la storia della Banda. Se vuoi un libro consiglio “Ragazzi di malavita”. È il piu’ completo. Ma anche su internet si possono trovare notizie sulla Banda della Magliana» (Fonte: Facebook, gruppo «Romanzo Criminale»).
00_Tosoni.indd Sez3:8800_Tosoni.indd Sez3:88 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
ETNOGRAFIA VIRTUALE E CONVERGENZA 89
nuovo, un’espansione che segna la linea fra il fan (in grado di cogliere tutti i riferimenti alla storia d’Italia di cui il telefi lm è disseminato) e il non fan (che si deve ‘accontentare’ del racconto poliziesco). L’investi-mento simbolico innerva anche il tentativo di articolare forme di mobi-litazione collettiva relative al programma: fra quelle più visibili spicca quella orientata a far vincere al programma il premio per la miglior fi ction dell’anno 2009 nell’ambito dei TvBlog Awards organizzati dal sito TvBlog.it.
La terza e ultima tipologia raccoglie le pratiche che abbiamo ricon-dotto al brand: a segnalarsi è soprattutto il riconoscimento di elementi stilistici del programma, spesso isolati e analizzati attraverso pratiche di ‘disassemblaggio’ del prodotto. Di questo processo è oggetto soprattut-to la colonna sonora della serie, non commercializzata37: il brand del prodotto viene attribuito a pezzi musicali prima separati e indipendenti, che vengono unifi cati diventando ‘di’ «Romanzo Criminale»38. Identico processo avviene per le location della serie: la Roma reale e quella rap-presentata si sovrappongono, e le congruenze vengono segnalate (uti-lizzando anche piattaforme come Google Maps39). Anche la sceneggia-tura è oggetto di disassemblaggio: con il supporto di spezzoni pubblicati su YouTube, le scene considerate migliori vengono isolate, segnalate e commentate; le battute migliori subiscono identico processo40. Il mate-riale così prodotto diviene risorsa utilizzata dal gruppo per la propria autodefi nizione e il proprio autoriconoscimento, alimentando ulterior-mente lo statuto di ‘culto’ del prodotto.
37 Esempio: «non voglio pensare che sta per fi nire...l’altro giorno sono andata per-sino a comprarmi il cd di Califano per ascoltarmi TUTTO IL RESTO E’ NOIAAAAAA-AA! Che scena quando vanno ad ammazzare il Teribbile!» (Fonte: Facebook, gruppo «Romanzo Criminale»).38 Esempio: «le canzoni 70 80 della serie so troppo belle!!! CHI CONO SCE I TITOLI LI SCRIVA GRAZIE»; «Forse ero l’unico a nn saperlo.... ma ho fi nalmente trovato la canzone del Dandy.... “io sto carcerato e mamma more”........http://www.youtube.com/watch?v=0B2FNar-euw&feature=related» (Fonte: Facebook, gruppo «Romanzo Criminale»).39 Esempio: «sapete in che via è il bar dove si ritrovano i ragazzi della banda x caso?» (Fonte: Facebook, gruppo «Romanzo Criminale»).40 Esempio: «la scena più bella per me è quando vanno a rapinare il deposito degli sbirri e sotto partano i supertramp “goodbye stranger” Con libano che dice “e mo s’annamo a divertì” E il tutto viene magistralmente interrotto con l’omici-dio del nero, passando prima per il freddo che fa partorire il vitellino, gli sfrattati che trovano casa grazia a “rediRoma” e la buon costume che irrompe da patrizia. http://it.youtube.com/watch?v=Ys_Nxv2cMBk» (Fonte: Facebook, gruppo «Roman-zo Criminale»).
00_Tosoni.indd Sez3:8900_Tosoni.indd Sez3:89 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33
90 LUCA BARRA - MATTEO TARANTINO - SIMONE TOSONI
In questo senso, l’analisi delle pratiche articolate intorno alla serie evidenzia una rispondenza fra l’intento produttivo – chiaramente mira-to alla creazione di un prodotto cult (come evidente dalle scelte lingui-stiche, estetiche e tematiche del prodotto, che effettivamente lo distac-cano considerevolmente dal resto della serialità italiana e anche, per certi versi, da quella americana) – e il pubblico di riferimento. In questo senso, la virtual ethnography conferma la natura di ‘caso di successo’ di «Romanzo Criminale», in maniera diversa rispetto ai risultati di ascolto.
4. Conclusioni
Come si è tentato di mostrare, la proposta metodologica qui presenta-ta permette di cogliere, in modo fl essibile, l’articolarsi in Rete del web televisivo, ossia delle modalità in cui temi televisivi (programmi, generi, reti, piattaforme ecc.) strutturano settori riconoscibili della Rete, costi-tuendone una centrale risorsa discorsiva e il cuore di una serie ricono-scibile di pratiche. Nei casi presentati, tutti relativi a programmi-brand, si è anche mostrato come, organizzando l’analisi su un piano strutturale (spazio e tempo) e tematico (discorsi e pratiche), è possibile ricondurre alcune delle caratteristiche principali dei differenti web televisivi a carat-teristiche del genere di appartenenza del relativo programma-brand, come pure a sue specifi che peculiarità: contributo prezioso per l’analisi degli scenari della convergenza. Certo il metodo non è esente da diffi -coltà: da un lato, la costante esigenza di incrociare lo studio dei discorsi televisivi on line con le informazioni testuali, contestuali e relative a più ampi contesti di consumo invita alla triangolazione con altre metodolo-gie di ricerca; dall’altro, la vastità e i differenti livelli di accesso rischia-no sempre, nonostante tutte le cautele metodologiche, di generare coni d’ombra in un campo complesso come il mare aperto del web. Meglio di altre metodologie la virtual ethnography riesce però a rendere conto dei molteplici livelli di complessità (spazio-temporale, di relazione tra pratiche discorsive e pratiche fruitive) dell’incontro tra due media come la televisione e Internet, talora complementari, talora invece in aperta opposizione.
00_Tosoni.indd Sez3:9000_Tosoni.indd Sez3:90 11-11-2010 10:07:3311-11-2010 10:07:33