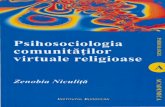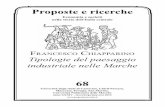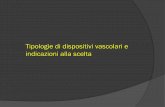Museo Virtuale della Valle del Tevere: le tipologie edilizie di età romana
Transcript of Museo Virtuale della Valle del Tevere: le tipologie edilizie di età romana
MUSEO VIRTUALE DELLA VALLE DEL TEVERE: LE TIPOLOGIE
EDILIZIE DI ETÀ ROMANA
Sofia Menconero
CNR – Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, [email protected]
ABSTRACTIl Museo Virtuale della Valle del Tevere è un progettopluriennale del CNR-ITABC che coinvolge diversiambiti disciplinari al fine di giungere ad una ipotesidi ricostruzione del paesaggio antico della mediaValle del Tevere, nella zona della Sabina laziale. Laricerca, nel suo complesso, prevede lo studio dell'areaa nord di Roma, compresa tra il Monte Soratte eFidene, Palombara Sabina e Sacrofano, investigandoe rappresentando la sua evoluzione geologica,antropologica e culturale attraverso le epochegeologiche che portarono alla formazione della vallealluvionale, in particolare in epoca preistorica, pre-romana/orientalizzante, romana, medievale e attuale.Il prodotto finale sarà un'applicazione di realtàvirtuale caratterizzata da interazione naturale,accessibile come installazione permanente in unmuseo della Capitale. Inoltre è previsto lo sviluppo diun sito web e applicazioni multimediali e di realtàvirtuale per i musei del territorio in oggetto e perdispositivi mobili, con l'obiettivo di supportare ilpubblico prima e durante la visita dei siti reali. Il miocontributo è stato quello di produrre modelli 3D ditipologie edilizie per l'età augustea, orientativamentetra I sec. a.C. e il I sec. d.C., con Blender, softwareOpen Source e multipiattaforma per la creazione 3D.
KeywordsMuseo virtuale; ricostruzione 3D; paesaggio antico;epoca romana augustea.
1. Il progetto generale
Introduzione
Il Museo Virtuale della Valle del Tevere è un ambiziosoprogetto a cui il CNR-ITABC sta lavorando da metà del2011 e che vedrà la sua conclusione nel 2014.
Il suo valore e la sua originalità sono fruttodell'approccio multidisciplinare che sta caratterizzando levarie fasi del lavoro. L'obiettivo è quello di scoprire ilpaesaggio come complesso di diverse componenti
culturali: geologica, naturale, storica, archeologica,evocativa e simbolica. Il progetto coinvolge un gruppo dilavoro estremamente diversificato, composto dairicercatori del CNR e universitari, professionisti privati(archeologi, storici dell'arte, geologi, informatici,rilevatori, grafici), ma anche da artisti e musicisti.
L'area della media Valle del Tevere presa inconsiderazione per gli studi è compresa tra il MonteSoratte a nord, Fidene a sud, Palombara Sabina a est eSacrofano a ovest, e attraversata dall'antica stradaconsolare Salaria (fig.1). Questo territorio è statoanalizzato attraverso diverse dimensioni interpretative edemozionali, a diversi livelli di scala, e considerando lasua evoluzione geologica, antropologica e culturale neidiversi periodi esaminati: preistorico, pre-romano/orientalizzante, romano, medievale e attuale.
Fig. 1 - Area di studio
Una delle priorità del progetto è stata quella di cercareun metodo convincente per simulare gli ecosistemi el'uso del suolo nel passato, finalizzato alla ricostruzionedel paesaggio antico potenziale della Valle del Teverenelle diverse epoche. Seguendo un approcciomultidisciplinare, sono state combinate una serie diinformazioni: valutazioni quantitative di dati geologici eecologici, studi storici, archeologici e demografici.
L'obiettivo finale del progetto è quello di accrescere emigliorare la conoscenza del territorio e il suopatrimonio culturale, e incoraggiare le persone a visitarealcuni luoghi belli ed importanti che sono al margine deipiù diffusi itinerari turistici focalizzati nella Capitale.
Il prodotto finale sarà un'applicazione di realtà virtualecaratterizzata da interazione naturale e uno stile artisticoed evocativo (fig.2), accessibile come installazionepermanente presso la Villa Poniatowsky (Museo di VillaGiulia, Roma). Inoltre è previsto lo sviluppo di un sitoweb e applicazioni multimediali di realtà virtuale per imusei del territorio in oggetto (Museo Fluviale diNazzano, Museo Archeologico di Lucus Feroniae) e perdispositivi mobili, con l'obiettivo di supportare ilpubblico prima e durante la visita dei siti reali. Le varieapplicazioni deriveranno da una serie di dati comune,con alcune modifiche nei formati comunicativi specifici,richieste dalle differenti condizioni di fruizione.
Approccio metodologico e descrizione delle fasi dilavoro
Per poter gestire l'ambiziosa quantità e varietà di input etrasformarli in un prodotto interessante e coinvolgente, èstato necessario studiare e proporre una pipeline dilavoro strutturata, dall'elaborazione dei dati GIS airendering 3D finali.
Come prima cosa è stato realizzato il DEM (DigitalElevation Model) del paesaggio attuale ad unarisoluzione di 10 metri, grazie alla collaborazionedell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. IlDEM è stato poi texturizzato con immagini satellitari(IRS) con risoluzione di 5 metri. Parallelamente è statoelaborato un DEM dell'area con una risoluzione di 5metri partendo dalla fotogrammetria aerea (fig.3). Perquesto scopo è stato utilizzato un set di 12 fotografieanalogiche IGM del 1954, prima della costruzione delledue maggiori infrastrutture moderne: la diga di Nazzano(1955) e l'autostrada A1 (1961). Il DEM è statorealizzato in collaborazione con la Fondazione BrunoKessler e costituisce la base per la modellazione 3D delterreno antico che, successivamente, è stato colorato in
modo realistico attraverso librerie grafiche 2D e 3D.
Per la creazione degli ecosistemi, i punti di partenzasono stati la carta archeologica e la land unit map;quest'ultima in particolare è stata utile per definire lacomposizione del suolo e la sua attitudine ad ospitarespecifici ecosistemi, sia naturali che antropizzati (incollaborazione con Digiter s.r.l.). Sono state fatte delleanalisi sulla geomorfologia e geologia del territorio, suipendii, l'orografia, l'accessibilità del fiume ed è statoipotizzato l'antico corso del Tevere e l'eventualepresenza di infrastrutture fluviali. I risultati sono staticonfrontati con i ritrovamenti archeologici e sono stateriscontrate buone corrispondenze.
Per quanto riguarda la definizione della vegetazionenaturale potenziale, si è presa in considerazione lacartografia tematica esistente elaborata dalla RegioneLazio e dalla Provincia di Roma, assumendo che lavegetazione naturale potenziale non sia cambiata inmodo sostanziale. Questi dati sono stati combinati con lacarta archeologica e con analisi demografiche di ogniepoca presa in esame, in modo da definire le areeinfluenzate dalla presenza di attività e insediamentiumani (buffer). Per la creazione dei buffer è stata seguitauna metodologia specifica, considerando diversi fattoriin relazione alla geografia e alla geomorfologia delterritorio, la distanza dalle infrastrutture (ad esempio lestrade), il modello economico, il livello tecnologico e ilmovimento potenziale della popolazione per laconduzione quotidiana del lavoro. Ognuno di questifattori possiede un certo livello o proporzione diimportanza nella relazione con gli altri, e questarelazione può cambiare nelle differenti epoche storiche.Per la caratterizzazione delle coltivazioni e delle specievegetali si è avuto il supporto degli studisull'alimentazione e il cibo delle epoche passate, che
Fig. 2 - Schema dell'applicazione di realtà virtuale
Fig. 3 - DEM delle età antiche, risoluzione 5 m
esiste in bibliografia, e di altre informazioni dalle analisidei pollini o dall'archeologia. Il risultato finale di questolavoro è l'elaborazione di una colormap che descrive ilpaesaggio antico, sia nelle aree naturale che in quelleantropiche (fig.4). Ciascun colore di questa mapparappresenta uno specifico ecosistema. Un ecosistemaconsiste in una serie varia di piante che si adattano aquello specifico suolo, clima, orientamento e così via. Lacombinazione e la disposizione delle piante in ciascunecosistema è naturale o collegata alle tecniche dicoltivazione esistenti in quel determinato periodo.
L'ultima fase è stata la conversione di questa descrizionesimbolica del paesaggio (GIS) in una rappresentazione3D realistica, attraverso potenti strumenti per lagenerazione e il disegno dei paesaggi.
La rappresentazione finale è di due tipi: un'applicazionereal time sviluppata in Unity 3D e un filmato realizzatoin Vue, pertanto i dati sono stati processati e ottimizzatidiversamente per i due output.
Nella divulgazione della rappresentazione 3D finale delpaesaggio gioca un ruolo fondamentale sia il livelloscientifico che la diffusione pubblica. In un ambiente 3Dsi hanno molteplici possibilità di analisi einterpretazione, poiché questo spazio simulato offre unadimensione percettiva e cognitiva simile a quella che sipercepisce nella vita reale. Il 3D è fondamentale per ilprocesso di conoscenza basato sull'esperienza, perchécrea relazioni dinamiche e differenti tra chi interagisce el'ambiente. All'interno di un ambiente 3D l'utente si sentecoinvolto fisicamente nel sistema; questaimpersonificazione costituisce una nuova frontiera dellacomunicazione e dei processi di apprendimento. Perquesta ragione è fondamentale definire un buonprotocollo per preservare l'originale affidabilitàscientifica dei dati e tradurre la rappresentazione 2D inun ambiente 3D simulato, adatto sia ad utenti esperti chead un pubblico del museo non specializzato.
La generazione del terreno in Vue per la ricostruzione3D del potenziale paesaggio antico della Valle delTevere prevede due tipologie di modellazione: il primo èun modello per la visione generale, il secondo, condimensioni più piccole e un maggior livello di dettaglio,è posizionato intorno agli insediamenti dove si habisogno di una rappresentazione particolareggiata.Entrambi i modelli confluiscono successivamente in ununico grande modello allo scopo di fornire agliinsediamenti uno sfondo realistico dal punto di vistageomorfologico.
I dati GIS prodotti che confluiscono in questa fase dilavoro sono di due tipi: la forma del terreno, importata inVue come un DEM, e la colormap, utilizzata perlocalizzare la vegetazione sul terreno: questa immagine èstata creata insieme ad una legenda, che assegna unecosistema ad ogni singolo colore, e allegata ad uncorrispondente file Excel che contiene la descrizionedelle piante presenti in ciascun ecosistema, lapercentuale di presenza, i dati dimensionali delle singoleessenze. Tutte queste informazioni sono utilizzate per lagenerazione 3D degli ecosistemi in Vue, dove possonoessere distribuiti secondo un approccio diprogrammazione procedurale (ad esempio la densità e lapresenza delle piante è calcolata in base della pendenzadel terreno, la nebbia in base all'altitudine, ecc.). Lespecie vegetali possono anche essere posizionatemanualmente, con un totale controllo sullalocalizzazione. I modelli della piante sono statiprocessati con uno strumento specifico di Vue (PlantEditor) che permette di creare e modificare una pianta edi replicarla come una istanza sempre differente,attraverso algoritmi chiamati SolidGrowth. Oltre allepiante per la composizione finale della scena, sono statiimportati in Vue una serie di animali, persone e oggetti,modellati e texturizzati in 3D Studio Max, Zbrush,Mudbox e Blender.
Fig. 4 - Colormap prodotta dal GIS per localizzare lavegetazione sul terreno (sopra) e risultato dell'applicazionedella vegetazione (sotto)
C'è un secondo filone di modellazione del terrenoindirizzata alle applicazioni real time e focalizzata sullaricostruzione del paesaggio attuale, implementataattraverso Unity Terrain Engine. In questo caso ilmodello generale del terreno è stato diviso in tile(tessere) per ottenere un terreno "paginato": unageometria dinamica che aumenta il numero di poligoni eil livello di dettaglio (LOD) in relazione alla distanzadella camera. Le tile sono generate attraverso l'uso dimappe di elevazione e vi viene poi applicata una texture.Unity Terrain Engine è uno strumento estremamentepotente: permette anche di "disegnare" modelli 3Dottimizzati della vegetazione direttamente sul terreno:queste geometrie della vegetazione si modificanodinamicamente da oggetti poligonali abbastanzacomplessi fino a semplici sagome, secondo la distanzadella camera. L'immagine utilizzata dalla sagoma è ilrendering della stessa pianta poligonale,prospetticamente coincidente con la posizione delmodello 3D della pianta inquadrato dalla camera.Aumentando la distanza della camera dalla pianta anchela sagoma scompare, lasciando visibile solo la texture delterreno (Pietroni et al. 2013).
2. La modellazione delle tipologie edilizie di età romana
Finalità
All'interno del progetto "Museo Virtuale della Valle delTevere" mi è stato assegnato l'incarico dellamodellazione 3D e texturizzazione di tipologie edilizie dietà augustea, tramite il software Blender, un programmaOpen Source multipiattaforma per la creazione 3D. Imodelli serviranno per raccontare il paesaggio dellaSabina laziale sulla sponda est e dell'agro falisco-capenate sulla sponda ovest del Tevere, orientativamentetra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.
Da una prima analisi del territorio attraverso il GIS, perquanto riguarda il collocamento delle strutture, eattraverso la carta archeologica, per cercare di dedurre letipologie edilizie e insediative, è stato possibileindividuare le strutture da modellare (fig.5), e la quantitàdi ognuna ha permesso di decidere quantediversificazioni della stessa tipologia utilizzare perrendere il paesaggio non ripetitivo.
L'inserimento delle tipologie edilizie romane non ha lapresunzione di descrivere la morfologia esatta dellearchitetture, poiché molto spesso i resti archeologicirinvenuti sono sufficienti soltanto a descriverne lafunzione e non la forma esatta. Per questo motivo si èoptato per una rappresentazione tipologica, iconica. Adogni modo, tramite ricerche bibliografiche e pareri diarcheologi classici, si è cercata il più possibile la fedeltàcon le morfologie dell'edilizia del periodo in esame.
Direttive
Le direttive fornitemi prevedono la visione dellearchitetture tridimensionali a volo d'uccello, da unadistanza tale da non doverle particolareggiareeccessivamente. Ad ogni modo si è deciso di dedicare aldettaglio la maggior cura possibile che la brevità deitempi poteva permettere, sia per consentire un eventualeavvicinamento della camera agli insediamenti in fase direndering, sia per creare una collezione di modelliutilizzabile per altri lavori futuri.
Un'altra indicazione avuta riguarda la compatibilità delformato di scambio, in quanto la successiva fase diimplementazione dei modelli nella scena territorialeavverrà in Vue o, per il real time, in Unity 3D. Questonon ha comportato alcun problema perché Blenderesporta in diversi formati tra cui dae, 3ds, fbx e obj; tra iformati a disposizione si è scelto quello con estensionefbx.
Inoltre è stato richiesto di modellare con il minor numeropossibile di poligoni, in quanto il prodotto finale saràprincipalmente di tipo filmico, la scena del paesaggio èmolto estesa e la vegetazione presente incrementanotevolmente il tempo di rendering. Tuttavia non sipreclude l'uso dei modelli anche in real time.
Fig. 5 - Evidenze archeologiche di età romana (insediamenti,viabilità, ville, fattorie, infrastrutture, porti, ponti,centuriazioni)
Organizzazione
La fase di modellazione è stata affiancata e supportata dauna fase di studio dell'architettura romana di epocaaugustea, attraverso la consultazione di letteraturaspecifica e del parere di archeologi e storici specializzatinel periodo in esame.
Inizialmente sono stati forniti dei vecchi modelli 3D daottimizzare per le finalità appena dette, ma in brevetempo ci si è resi conto che texturizzare o rivederepiccoli errori di geometrie prive di correttezza topologicaavrebbe portato via più tempo rispetto al modellarel'oggetto da zero.
Per organizzare i file prodotti e renderli accessibili inmodo semplice ai futuri fruitori, si è pensato di dare unoschema logico e dei nomi standard alle cartelle di lavoro,spiegati in un file allegato, così strutturato:
CARTELLA GENERALE* (nome del modello)
• file di Blender originale di lavoro contexture separate (nomemodello_orig.blend)
• texture singole (nomeoggetto_ao.jpg perl'ambient occlusion, nomeoggetto.jpg per latexture del materiale)
• REF*
• riferimenti bibliografici
• immagini di riferimento
• texture originali
• DEFINITIVI*
• file di Blender con texture unite(nomemodello_def.blen)
• file di Blender ridotto(nomemodello_low.blend)
• obj del file nomemodello_def enomemodello_low
• fbx del file nomemodello_def enomemodello_low
• max del file nomemodello_def enomemodello_low
• texture unite, ambient occlusion +materiale(nomemodello_nomeoggetto.jpg)
* i nomi maiuscoli corrispondono a cartelle.
Le tipologie realizzate sono le seguenti:
• acquedotto
• imbarcazione commerciale
• fornace
• fattoria
• passerella
• pozzo
• villa rustica
• insediamento (templi, foro, anfiteatro, terme,
isolati residenziali-commerciali)
Acquedotto
Si tratta di una campata da utilizzare come modulo(fig.6). La scelta della texture in laterizio è dovutaall'ambientazione rurale dell'oggetto, per questo motivo èverosimile che non fosse rivestito in pietra
I resti frammentari trovati sul territorio non hannopermesso di ripristinare fedelmente il tracciatodell'acquedotto per intero, ma si cercherà di ricostruireun percorso coerente anche se ipotetico, valutando i sitidove ne è stata attestata la traccia. A completare leinformazioni ottenute attraverso i resti archeologici giocaun ruolo fondamentale la bibliografia che ricorda chefino al tardo IV sec. a.C. Roma era rifornita di acquaproveniente da pozzi, sorgenti e acqua piovana raccoltain cisterne e all'inizio del III sec. a.C. fu costruito ilprimo acquedotto, l'Aqua Appia. Nel nostro periodo distudio, l'epoca augustea, il numero degli acquedottiaveva raggiunto la decina: tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.,oltre ai già asistenti Aqua Appia, Aqua Anio Vetus, AquaMarcia, e Aqua Tepula, videro la costruzione l'AquaJulia (33 a.C.), l'Aqua Virgo (19 a.C.), l'Aqua Alsietina(2 a.C.), l'Aqua Claudia (52 d.C.) e l'Aqua Anio Novus(52 d.C.) (fig.7).
Dato il dispendio necessario alla costruzione delle arcatee ai tracciati spesso adiacenti, i canali dell'Aqua Tepula e
Fig. 6 - Modello 3D della campata dell'acquedotto
Fig. 7 - Acquedotti di Roma antica
dell'Aqua Julia furono costruiti sopra a quelli dell'AquaMarcia, che nel tratto in prossimità di Roma avevaquindi una sezione ad arcate a tre piani. L'Aqua Virgo fuil primo acquedotto che entrava a Roma da nord, purattingendo alle sorgenti della valle dell'Aniene: la suarealizzazione fu voluta da Agrippa, per alimentare le suegrandi terme pubbliche nel Campus Martius, questo fu ilprimo caso in cui si progettò un acquedotto con un finespecifico. Augusto ordinò la costruzione dell'AquaAlsietina per alimentare la sua Naumachia sulla rivaoccidentale del Tevere, un grande lago artificialeutilizzato per mettere in scena finti combattimenti navalie altri spettacoli acquatici di grandi dimensioni. I duemaggiori acquedotti per portata d'acqua erano l'AquaClaudia e l'Aqua Anio Novus, il primo era alimentato dasorgenti della valle dell'Aniene poste più a nord di quelledell'Aqua Marcia, il secondo, come già l'Anio Vetus,attingeva direttamente dalle acque del fiume.
Anfiteatro
L'anfiteatro è stato creato partendo da un precedentemodello, il quale è stato molto semplificato a livello digeometrie, fino a ridurlo oltre la metà dei poligoni,texturizzato ex novo e modificato in alcuni particolari, adesempio è stato diviso il settore delle gradinate più basseriservate ai personaggi abbienti dal settore più alto per laplebe (fig.8).
Gli anfiteatri servivano ad ospitare i munera, i giochi deigladiatori, nati originariamente come celebrazionifunebri, nel tardo periodo repubblicano e agli inizi delprincipato persero la loro importanza religiosa ecommemorativa per l'aspetto politico e meramentespettacolare: l'élite iniziò a utilizzare gli spettacoli comeun modo per conquistare popolarità presso il popolo. Glispettacoli presero un'ampia serie di forme differenti: lecacce alle belve (venationes), i combattimenti digladiatori addestrati e le esecuzioni di criminalicondannati. Gli spettacoli gladiatori erano pubblici, eprima che venissero costruiti degli edifici appositi perospitarli si svolgevano spesso nel Circo Massimo e nelcentro sociale e rituale della città, il foro.
Per quanto riguarda la struttura, l'anfiteatro è costituitoda un'area pianeggiante a forma ellittica o, in alcuni casi,rotonda, come testimoniano i resti dell'anfiteatro trovatoa Lucus Feroniae (fig.9), coperta di sabbia a chiamata
arena. Tutto attorno si sviluppa la cavea, ossia l'insiemedelle gradinate dove prendevano posto gli spettatori, chevi entravano e ne uscivano attraverso apposite porteposte a vari livelli, che davano accesso a scale e corridoiche, settore per settore, davano su ingressi esternidifferenti (vomitoria), per far sì che le diverse classisociali potessero muoversi su percorsi anch'essi separati.Le gradinate terminavano esternamente con un muro checircondava tutto l'anfiteatro (summa cavea) che neglianfiteatri maggiori portava un anello di pietra con deifori in cui venivano posti dei pali che reggevano deivelaria, ovvero delle grandi tele che servivano a fareombra e che venivano manovrate da personalespecializzato, a volte marinai esperti. Nelle sostruzioni onegli spazi dentro la costruzione vi erano molti locali diservizio finalizzati agli usi più disparati: dalmagazzinaggio di attrezzature e scenari, alla ritenzionedegli animali destinati ai combattimenti (carceres), aivani destinati ai gladiatori quali palestre o terme (talvoltacollocati invece nei pressi dell'anfiteatro), e luoghi dipreghiera per coloro che si preparavano aicombattimenti. L'apparato per la gestione degli anfiteatriera enorme, comprendendo gli addetti allamovimentazione delle scene nell'arena (o sotto l'arena), imanovratori dei velari, i sorveglianti delle entrate e delleuscite, gli incaricati al nutrimento e alla cura deglianimali, e altri protagonisti di svariati servizi connessicon gli spettacoli quale, ad esempio, la rimozionedall'arena di uomini e animali feriti o uccisi nel corso deicombattimenti. A volte vi erano dei sistemi ingegnosi perfar entrare gli animali nell'arena senza che aggredisserogli addetti: vi erano dei corridoi che permettevano diinserire dei pali da una parete all'altra, attraverso dei foriposti a distanze regolari sulle pareti stesse; inserendo ipali dietro agli animali, si impediva che tornasseroindietro, e sfilando i pali davanti agli animali gli sipermetteva di progredire verso l'arena.
I materiali solitamente utilizzati erano: per le fondazionil'opus caementicium, cioè ciottoli e pietrisco legati conmalta di calce, la muratura poteva comprendere
Fig. 8 - Modello 3D dell'anfiteatro
Fig. 9 - Ortofoto dei resti dell'anfiteatro a pianta circolare diLucus Feroniae
componenti lapidee e marmoree, il paramento esterno, adarcate, era ornato con colonne, lesene e relativi capitellidi diverso stile con l'aumentare dell'altezza, come d'usoabituale nella contaminatio architettonica romana, convarie decorazioni e statue, in modo da conferire unaspetto monumentale e fastoso.
Imbarcazione commerciale
Non avendo riscontrato, nel GIS, un gran numero diponti carrabili, è possibile che il trasporto delle merciavvenisse soprattutto per via fluviale. Le barcheutilizzate per questo scopo avevano dimensioni variabilia seconda del carico, e, a differenza della barche daguerra, avevano un numero minimo di remi, in quanto lapropulsione avveniva per mezzo della vela o, nel casodelle naves caudicariae, attraverso il traino, dalla rivadestra del fiume, effettuato da animali da soma o daschiavi (fig.10).
La letteratura afferma che le differenti imbarcazionicommerciali spesso possedevano anche nomi diversi,corbita, gaulus, ponto, cladivata, ecc. che variavano aseconda della loro origine geografica e della forma delloscafo. Tuttavia, sul piano tecnico doveva esistere unacerta omogeneità determinata dai numerosi scambiattraverso il Mediterraneo. Grazie all'iconografia navale,è possibile ricostruire gran parte delle caratteristiche diquesta classe di imbarcazioni. La forma dello scafo, adesempio, poteva essere simmetrica o asimmetrica, laruota di poppa spesso terminava in una testa di cignorivolta all'indietro ed era contornata da una galleria asbalzo. La prua talvolta era concava per la presenza di untagliamare, non un rostro ma un dispositivo destinato amigliorare le qualità nautiche dell'imbarcazione. Ilsistema di governo era costituito da remi-timoni laterali,situati a poppa. Essi potevano essere regolati con unsistema di cavi e funzionavano per semplice rotazioneattorno al loro asse. Il comando della manovra avvenivaattraverso l'intermediario di una barra perpendicolare alfusto, il clavus. Questo timone antico era del tipocompensato, per tanto lo sforzo del timoniere eraestremamente ridotto. Infine, la maggior parte delle navida carico, sebbene le galere commerciali a propulsionemista (le actuariae) dovessero essere frequenti inambiente marino, erano velieri munite di uno, due o trealberi. Le vele erano quadre ed erano regolate da un
complesso sistema di manovre.
Il modello prodotto deriva da un vecchio modello,semplificato e texturizzato (fig.11).
Fornace
La fornace modellata è di piccole dimensioni, in quantonon risultano tracce di imponenti insediamenti adibiti atale scopo. Grandi blocchi sbozzati compongono lacamera e il prefurnio, mentre la copertura in laterizio, diforma emisferica, solitamente veniva costruita dopo aversistemato nel forno gli oggetti da cuocere, e venivasmantellata una volta ultimata la cottura, per rimuoveretali oggetti (fig.12).
Nel mondo romano la lavorazione dell'argilla per lafabbricazione dei laterizi prevedeva varie fasi: l'argillaestratta dalle cave veniva prima fatta riposare efermentare per diverso tempo (spesso anni), quindi eraimpastata, lavorata e sagomata mediante forme e infinefatta seccare in ambienti aerati e riparati, di solito tettoie.Una volta cotti i laterizi venivano immagazzinati per lasuccessiva vendita e utilizzo. La tipologia di fornace piùcomune era costituita da un prefurnio, una camera dafuoco e una camera di cottura. Il prefurnio serviva apreparare le braci che da qui venivano spinte nellacamera da fuoco, di norma interrata per conservaremeglio il calore. La camera da fuoco era dotata disupporti che reggevano o un piano forato (per far passareil calore) in materiale refrattario di diverso tipo, su cuierano posati i pezzi da cuocere, oppure elementi, disolito archetti, che in ogni caso potessero sostenere i vasio i mattoni da cuocere: era dotata di una copertura che,
Fig. 11 - Modello 3D dell'imbarcazione per trasporto merci
Fig. 10 - Affresco dell'Isis Geminiana (Ostia, II sec. d.C.) chemostra l'operazione di carico del grano su una naviscaudicaria
Fig. 12 - Modello 3D della fornace
smontata per estrarre i pezzi cotti e raffreddati, veniva disolito rifatta dopo ogni cottura.
Foro
Il foro è stato modellato per essere inseritonell'insediamento. Ne sono stati creati due per laprecisione, per la volontà di diversificaredimensionalmente anche gli insediamienti: uno piùpiccolo (fig.13), porticato su due lati e con botteghelungo il lato maggiore della piazza, ed uno più grande(fig.14), sempre porticato su due lati e con un altrocomplesso annesso che accoglie botteghe e altre funzionipubbliche.
Nel primo libro del suo trattato, Vitruvio spiega che ladefinizione di foro è di natura essenzialmente spaziale:essa dipende dall'arearum electio (la scelta previsionale),all'interno del tessuto urbano, delle zone libere destinateall'uso collettivo. È generalmente ammesso, con ledovute eccezioni, che nel sistema ortogonale delle cittàcoloniali fondate da Roma il foro si apra all'incrociodegli assi principali. Il foro rappresenta infatti il luogo incui si concentrano tutti i simboli della dignitàmunicipale. Nella forma in cui si trova nella maggiorparte delle città dell'Italia e delle province occidentali, sipresenta come una piazza rettangolare bordata da portici,con un tempio in posizione dominante, mentre tutti glialtri edifici sono variamente distribuiti negli spazicircostanti.
Fattoria
La fattoria era una tipologia insediativa rurale abbastanzadiffusa nell'agro romano antico e aveva funzioneproduttiva agricola e residenziale per coloro i qualilavoravano nelle terre di pertinenza. A differenza dellavilla rustica non prevedeva gli appartamenti dipersonaggi illustri, ma soltanto dei latifondisti e deglischiavi che si occupavano dei raccolti. Poteva prevederelocali di stoccaggio e lavorazione delle colture e stalle
per l'allevamento animale, intorno ad un ampio cortile.
L'edificio poteva essere costruito in pietra o in mattoni, aseconda della vicinanza di cave o fornaci. Vista la nostrazona di studio è verosimile che le fattorie fosseroedificate in mattoni, successivamente intonacati perpreservarne la durata (fig.15).
Passerella
Come già anticipato, la scarsa presenza di ritrovamentirelativi a infrastrutture quali ponti fa pensare che ilcommercio, e in generale gli spostamenti di grandiquantità di materiali, avvenissero per via fluviale.Tuttavia, anche se non restano tracce, è ipotizzabile lapresenza di passerelle di legno (fig.16), materialedeperibile, che permettessero l'attraversamento delTevere, in quei punti in cui le rive opposte erano piùvicine. Ma soprattutto le passerelle permettevano dioltrepassare gli affluenti durante il traino delle navescaudicariae dalla riva del Tevere.
Pozzo
Fig. 13 - Modello 3D del foro piccolo
Fig. 14 - Modello 3D del foto grande
Fig. 15 - Modello 3D della fattoria
Fig. 16 - Modello 3D della passerella
Fig. 17 - Modello 3D del pozzo
Per quanto riguarda il sistema di approvvigionamentoidrico, a parte il già citato acquedotto, è nota la presenzafrequente di cisterne e pozzi. Le prime, essendosolitamente interrate, non saranno visibili nellaricostruzione 3D del paesaggio, mentre i pozzi sarannorappresentati attraverso le loro vere, semplici costruzioniin pietra sbozzata (fig.17).
Tempio
Sono state modellate due versioni di tempio (fig.18, 19),entrambi di tipo prostilo, che verranno inserite all'internodegli insediamenti con questo criterio: il tempio piccoloper l'insediamento minore e il tempio grande perl'insediamento medio e maggiore.
Il tempio fu il più importante edificio sacro di Romaantica e il termine templum, non indicava tanto l'edificio,ma un luogo consacrato secondo una precisa ritualità euna dedica alla divinità, orientato secondo i punticardinali e secondo la divinità cui ci si rivolgeva.Nell'architettura romana il tempio si ispira inizialmenteai modelli etruschi, ma presto attinge all'architetturaellenistica. La più marcata differenza del tempio romanorispetto a quello greco è la sua sopraelevazione su unalto podio, accessibile da una scalinata spesso frontale.Inoltre si tende a dare maggiore importanza alla facciata,mentre il retro è spesso addossato a un muro direcinzione e privo dunque del colonnato.
Terme
Nelle commedie di Plauto la frequentazione dei bagnisembrava normale nella Roma del II sec. a.C., e forse iprimi stabilimenti sorsero già alla fine del III sec., servizia pagamento per il pubblico organizzati da privatiimprenditori ispiratisi ai greci. Infatti il nome balneumviene dal greco balanèion. All'inizio erano impiantimodesti che offrivano, con spesa irrisoria, un bagnocaldo, ma ebbero un grande successo e in breve nesorsero di più comodi e belli. Così nel IV sec. d.C. eranopresenti a Roma circa mille stabilimenti, senza contare leundici terme imperiali.
Nel nostro periodo di riferimento è plausibile che tutti gliinsediamenti più grandi, fuori dall'Urbe, potevanoospitare delle terme pubbliche, per questo motivo nei tretipi di insediamento che si propongono, verranno inseritesolo in quello di dimensioni maggiori (fig.20).
Essendo impianti pubblici erano date in appalto ad un"conduttore" (conductor), che aveva il diritto di esigeredai frequentatori una piccola tassa d'ingresso(balneaticum), ma i ragazzi erano dispensati dalpagamento. Questa tassa veniva riscossadall'amministratore (balneator) o da uno schiavo difiducia come il capsarius e l'arcarius, ai quali eraaffidata la sorveglianza della cassa e di tutto ciò cheveniva lasciato in deposito. In aggiunta al costodell'ingresso, venivano pagate altre somme per lacustodia dei vestiti, per i massaggi, per i bagni speciali egli olii profumati.
Per quanto riguarda la composizione funzionale e ladistribuzione dei vari ambienti, lo sviluppo interno tipicoera quello di una successione di stanze, con all'internouna vasca di acqua fredda, il frigidarium, seguita dalcalidarium, generalmente rivolto a mezzogiorno, conbacini di acqua calda. Tra il frigidarium e il calidariumvi era probabilmente una stanza mantenuta a temperaturamoderata, il tepidarium, e molto spesso presentavanouna copertura curva, a botte o a cupola. Le natationeserano invece le vasche usate per nuotare.
Villa rustica
La villa rustica, una tipologia frequente nell'area dellaSabina, si differenzia dalla fattoria in quanto, oltre adavere una funzione produttiva agricola, aveva anche unaparte adibita a residenza di qualche facoltosa famiglia.La villa era divisa in diversi settori: la pars dominica era
Fig. 18 - Modello 3D del tempio piccolo
Fig. 19 - Modello 3D del tempio grande
Fig. 20 - Modello 3D delle terme
la zona residenziale destinata al dominus e alla suafamiglia, la pars rustica era la zona destinata alla servitùe ai lavoratori dell'azienda, la pars fructuaria eradestinata alla lavorazione dei prodotti. La pars rustica efructuaria assieme formavano la pars massaricia.
Nell'impianto modellato (fig.21), che si riferisce ad unacostruzione standardizzata di medie dimensioni, siriconoscono i volumi dell'atrium con l'impluvium, iltablinum in asse con l'ingresso, e il peristylium,intonacati in bianco con fascia rossa alla base; mentre lazona di lavorazione e rimessa agricola è in mattoni. Perquanto riguarda i mosaici, sono stati scelti semplici egeometrici, in quanto le dimensioni medie della villa nonsi relazionano bene a finiture troppo ricche. Quelloinserito nell'atrium è stato trovato a Reggio Emilia erisale al I sec. d.C., dello stesso periodo è il mosaico delperistylium, rinvenuto a Brescia.
Il ritrovamento più importante di questa tipologia, neiconfini dell'area di studio, è la Villa dei Volusii a FianoRomano, di cui è stato fatto uno studio a parte all'internodel progetto per il Museo Virtuale della Valle del Tevere(fig.22, 23). Le evidenze archeologiche ne hannopermesso una ricostruzione specifica abbastanzaplausibile. Partendo da rilievi topografici sul campo(stazione totale, GPS, laser scanner, fotogrammetria) si ègiunti fino alla modellazione degli elevati ricostruiti infase augustea .
La Villa dei Volusii è venuta alla luce durante i lavori perla costruzione dell'Autostrada del Sole (1960) e si trovaqualche centinaio di metri a nord-est di Lucus Feroniae.Fu edificata ai piedi del monte Soratte intorno al 50 a.C.
da Quinto Volusio, membro della potente famigliasenatoria dei Volusii Saturnini, trasferitasi a Roma dalPiceno. La villa sorge sul pendio di un'altura: sul livellosuperiore si imposta la residenza signorile organizzatasecondo il consueto impianto con atrio, stanze sul latosinistro, cubicoli e triclinio su quello destro, tablino sulfondo. Il grande perestilio con il lararium si imposta sulfianco destro del quartiere signorile. La decorazione è dinotevole livello, come mostrano i resti dei mosaicipavimentali, alcuni dei quali policromi decorati conmotivi geometrici o soggetti naturali.
Insediamento
Fig. 21 - Modello 3D della villa rustica
Fig. 22 - Rilievo laser scanner della Villa dei Volusii (pianta)
Fig. 24 - Modello 3D dell'insediamento grande
Fig. 25 - Modello 3D dell'insediamento medio
Fig. 26 - Modello 3D dell'insediamento piccolo
Fig. 23 - Ipotesi di ricostruzione della Villa dei Volusii(pianta)
Sono state assemblate tre varietà di insediamento: unopiù grande (fig.24) composto da undici isolatiresidenziali-commerciali, il foro con il tempio e le terme;uno medio (fig.25) composto da nove isolati e il fororidotto con il tempio; e uno più piccolo (fig.26) con ottoisolati, il foro ridotto e un tempio più piccolo. Gli edificipubblici inseriti sono quelli precedentemente descritti,mentre gli isolati derivano da un'esportazione, rivista ecorretta, di architetture di tipo procedurale createattraverso il software City Engine.
Come già annunciato, gli insediamenti, ma anche tutte lealtre opere inserite nel paesaggio, non devono essereconsiderate come riproduzione esatta del paesaggiostorico, ma piuttosto come rappresentazioni iconiche diun passato che si cerca di descrivere nella maniera piùfedele possibile, documentando le scelte e facendolevalidare da esperti. Le scelte urbanistiche adottate per gliinsediamenti, quindi, si rifanno a quello che la letteraturapropone per le colonie romane, considerando che, sia lenuove fondazioni che gli ampliamenti Romani diinsediamenti precedenti, prevedevano anzitutto lunghirituali e cerimonie di fondazione, a cui seguivano delleoperazioni di organizzazione pratica del territorio cheavrebbero definito la morfologia dei luoghi, mantenendodei caratteri costanti per ogni insediamento: crearesistemi di drenaggio per le bonifiche, di irrigazione perl'agricoltura, costruzione di strade secondarie collegate aquelle principali, e la centuriazione, cioè la suddivisionedel territorio in appezzamenti uguali, da assegnare allefamiglie dei coloni. Il sistema di centuriazione piùfrequente si basava sul modulo della centuria, un'areaquadrata con lato di 20 actus (circa 710 m) e superficiedi 200 iugera (circa 50 ettari), che, ripetutoortogonalmente su tutta la zona, formava un reticolo dilinee parallele e perpendicolari dette decumani (da est aovest) e cardines (da nord a sud). Tutto ciò costituiva ilPomerium, l'area sacra entro cui non si potevano porresepolcri. All'incrocio tra cardo e decumano massimisorgeva la piazza del forum, di norma rettangolare, ilresto formava i quartieri urbani con le insulae e le vieminori. Tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C. i Romaniavevano già centuriato gran parte dei territori dellapenisola e in molte delle aree centuriate la suddivisionedel territorio venne impostata seguendo le direttricidell'asse viario più importante, ad esempio in EmiliaRomagna la via Aemilia e nel settentrione la viaPostumia.
L'opera di urbanizzazione più importante della nostraarea di studio è l'abitato di Lucus Feroniae (fig.26), dicui è stato fatto uno studio a parte che comprende anchela ricostruzione 3D (fig.27), poco distante alla già citataVilla dei Volusii.
Il Lucus Feroniae preromano era, non un tempio, ma unaintera località sacra della dea Feronia. Come tutti i luoghisacri, i loci, avevano di solito un bosco e una fonte,nonché un tempio e una via sacra. Qui vi si svolgevanoriti e processioni, con sacerdoti o sacerdotesse addettiappositamente a quel culto, che avevano il loromonastero non lontano dal luogo. Il Lucus di Feronia
sorgeva su una piattaforma di travertino e ha origini tantoantiche quanto sono le origini del culto della dea, unaGrande Madre, dea della natura e delle acque, del parto edella prolificità, della vita e della morte, nonché dellacura dei malati. Il Lucus sacro era famoso per lericchezze che i fedeli portavano per favorire la dea e chenessuno avrebbe osato toccare temendo la punizionedivina. Nessuno tranne Annibale che nel 211 a.C., nonsolo saccheggiò il tempio facendone un gran bottino, malo distrusse dandolo alle fiamme. Venne ricostruito, ma ilculto di Feronia decadde e il sito perse importanza fino ache Cesare nel 59 a.C. stabilì di stanziare in zona iveterani del proprio esercito, fondando la Colonia IuliaFelix Lucus Feroniae, la cui edificazione portò avantiAugusto, successore di Cesare.
Note tecniche sulla modellazione
Le tipologie sono state modellate suddivise in oggetti(object) in base alla funzione, nel caso in cui all'internodella stessa funzione fosse presente un solo materiale,oppure al materiale (es. tetto, scala, trave_ingresso,intonaco, laterizio, ecc.). Nella struttura degli oggetti,tutte le sotto categorie dell'oggetto hanno lo stesso nome:OGGETTO: tetto → MESH: tetto → MATERIALE:tetto → TEXTURE: tetto → IMMAGINE:nomemodello_tetto.jpg.
Fig. 27 - Ricostruzione 3D della Lucus Feroniae di epocaromana
Fig. 26 - Sito archeologico di Lucus Feroniae
La procedura seguita per arrivare al prodotto finale(nomemodello_def.max) è la seguente:
• Modellazione di tutte le geometrie seguendo iprincipi della topologia corretta. Nel caso in cuisi sono trovate delle geometrie ripetute, comead esempio le colonne della villa rustica, si èutilizzato il procedimento dell'instancing:creando una sola colonna e istanziandola neipunti individuati. Il vantaggio non consiste solonel dover modellare un singolo elemento delgruppo, quanto nella fase di UV-mapping,poiché è necessario eseguire il mapping solouna volta, per la colonna di riferimento.
• UV-mapping e texturing di tutti gli elementi delmodello. È stato assegnato un unico fileimmagine nomeoggetto.jpg per ogni oggettopresente nella scena. In alcuni casi è statonecessario modificare l'atlas in Gimp peraggiungere sporcature o correggere l'effettotiling di alcune texture. Successivamente si ècreato un nuovo file immagine dello stessoelemento per l'ambient occlusion(nomeoggetto_ao.jpg) utilizzando il comandoBake. Nel file nomemodello_orig.blend sonostate lasciate le due texture (materiale e ao)separate su due canali, mentre nel filenomemodello_def.blend sono state unite inGimp, per cui ogni oggetto ha una sola textureassegnata, nominatanomemodello_nomeoggetto.jpg. Questopassaggio è stato necessario in quantol'esportazione in obj o fbx non legge più di uncanale di texture.
• Decimazione del modello, per renderlo piùleggero, attraverso il modificatore Decimate. Ilfile così ottenuto è stato nominatonomemodello_low.blend ed è stato esportato infbx e in max per essere condiviso con chi sioccuperà di inserirlo nella modellazione delpaesaggio con Vue.
3. ConclusioniIn questo articolo viene descritto il processo di ideazionedi una valida metodologia per la ricostruzione 3D delpaesaggio potenziale antico lungo la Valle del Tevere anord di Roma, proposto dai ricercatori del CNR-ITABC.
Seguendo un approccio multidisciplinare, attraversovalutazioni quantitative di dati geologici ed ecologici,informazioni storiche, archeologiche e demografiche, sipropone una completa pipeline di lavorodall'elaborazione dei dati GIS ai renderingtridimensionali realistici finali.
Il mio contributo a questo progetto di ricerca pluriennaleconsiste nello studio e nella modellazione 3D e texturingdelle tipologie edilizie di età augustea, quindi una faseintermedia tra le operazioni in GRASS-GIS preliminari e
la successiva generazione del terreno in Vue e Unity 3D.L'utilizzo di un software Open Source come Blender inuna pipeline di lavoro che prevede anche l'utilizzo disoftware commerciali dimostra la perfetta integrabilitàdei file prodotti, e i risultati a livello di qualità dimodellazione sono del tutto paragonabili.
4. BibliografiaPIETRONI E., PALOMBINI A., ARNOLDUS-HUYZENDVELD A., DI IOIA M., SANNA V. 2013, Tiber Valley Virtual Museum: 3D landscape reconstruction in the Orientalising period. North of Rome. A methodological approach proposal, in ADDISON A.C. (EDS.), Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress. Volume 2, Marseille.
ANONIMO 1744, Pianta del corso del Tevere dalla confluenza del fiume Nera alla foce, Archivio Storico Capitolino, Cart. XI, 5; EUFROSINO DELLA VOLPAIA 1547, La campagna romana al tempo di Paolo III, mappa in scala ca. 55000, I.G.M., Firenze.
ARNOLDUS-HUYZENDVELD A., PELLEGRINO A. 2000, Development of the Lower Tiber Valley in historical times, in Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia, vol. LIV, Atti del II Convegno Internazionale del1996 sulla Conservazione del Patrimonio Geologico: Geotopi, Esperienze Internazionali e Italiane, Roma.
ARNOLDUS-HUYZENDVELD A., POZZUTO E. 2009, Una lettura storica del paesaggio attuale: il territorio di Castel di Pietra tra Antichità e Medioevo, in CITTER C. (ED.) Dieci anni di ricerche a Castel di Pietra, Edizione degli scavi 1997-2007, All'insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo (Firenze).
BELLOTTI P., CALDERONI C., DI RITA F., D'OREFICE M., D'AMICO C., ESU D., MAGRI D., PREITE MARTINEZ M., TORTORA P., VALERI P. 2011, The Tiber river delta plain (central Italy): Coastal evolution and implications for theancient Ostia Roman settlement, pubblicazione online.
CAMPORESI C., PALOMBINI A., PESCARIN S. 2007, GIS e 3DWebGis, in FORTE M. (ED.), La Villa di Livia, un percorsodi ricerca di archeologia virtuale, L'Erma di Bretschneider, Roma.
CONNOLLY P., DODGE Z. 1991, GIS approaches to regional analysis: a case study of the island of Hvar, Ljubjana.
GAFFNEY V., STANCIC H. 2000, La città antica. La vita quotidiana a Roma e Atene, Könemann, Köln.
GALLI M., PISANI SARTORIO G. (EDS.) 2009, Machina, tecnologia dell'antica Roma, Palombi Editori, Roma.
GROS P. 2001, L'architettura romana. Dagli inizi del III sec. a.C. alla fine dell'alto impero. I monumenti pubblici, Longanesi, Milano.
LE GALL J. 1953, Le Tibre: fleuve de Rome dans l'Antiquité, Presses Universitaires de France, Paris.
PASQUINUCCI M. (ED.) 2001, Architettura Romana, Electa, Milano.
PESCARIN S. 2009, Reconstructing ancient landscape, Archeolingua, Budapest.
WARD-PERKINS J.B. 2001, Architettura Romana, Electa, Milano.