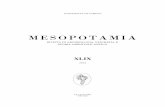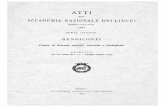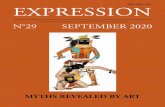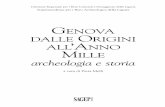Il lavoro e le risorse del territorio: zolfo, sale e metalli nel territorio agrigentino nella...
Transcript of Il lavoro e le risorse del territorio: zolfo, sale e metalli nel territorio agrigentino nella...
… lavora, Perse, stirpe divina, perché Fameti odî e t'ami l'augusta Demetra dalla bella corona,
e di ciò che occorre per vivere t'empia il granaio (Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 299-301, trad. it. Ettore Romagnoli.)
3
Soprintendenza BB.CC.AA. Agrigento
Le opere e i giorni Lavoro, produzione e commercio tra passato e presente
a cura di
Valentina Caminneci
Atti e Contributi del Corso di Formazione per DocentiProgetto Scuola Museo 2012-2013
Regione SicilianaAssesssorato Beni Culturali e Identità Siciliana
Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento. Via U. La Malfa, 5,Agrigento. [email protected]. R.P. Salvatore Donato. Progetto Valentina Caminneci.URP Adriana [email protected] tel.0922-552516 fax 0922401587
Progetto Scuola Museo Es. Fin. 2012 Cap.376525.Coordinamento Assessorato BB.CC. e I.S. Dipartimento BB.CC. e I.S.Servizio Valorizzazione. U.O. 24.
Copyright Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 2014
E’ fatto divieto di riproduzione e utilizzazione senza autorizzazione della SoprintendenzaBB.CC.AA. di Agrigento. Copia omaggio. Vietata la vendita
In copertina, Ade e Persefone in trono, pinax in terracotta da Locri Epizefiri, inizi V sec. a.C. Museo Nazionale dellaMagna Grecia di Reggio Calabria(da http://it.wikipedia.org/wiki/File:Locri_Pinax_Of_Persephone_And_Hades.jpg).
Sul frontespizio, Telemaco Signorini, L’alzaia, 1864(da http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Signorini,_Telemaco_-_L'alzaia_-_1864.jpg).
Le opere e i giorni: lavoro, produzione e commercio tra passato e presente : atti e contributi del corso di formazione per docenti / a cura di Valentina Caminneci. Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2014. - e-bookISBN 978-88-6164-225-61. Lavoro – Storia. I. Caminneci, Valentina.331.0945822 CDD-22 SBN Pal0260796
CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”
Indice
Presentazione
Assunta Lupo, Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana, Servizio Valorizzazione
Caterina Greco, Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento
Introduzione
I colori della terra Valentina Caminneci, Soprintendenza BB.CC.AA. Agrigento 1
Scienza e tecnica prima della storia
Cultura materiale, modi di produzione e organizzazione sociale della più antica metallurgia nella Sicilia preistoricaEnrico Giannitrapani, Coop. Arkeos, Enna 9
Il lavoro e le risorse del territorio: zolfo, sale e metalli nel territorio agrigentino nella preistoriaDomenica Gullì, Soprintendenza BB.CC.AA. Agrigento 37
La dimensione metaforica del lavoro
Le opere di Atena: identità femminile e philergia nella Sicilia grecaElisa Chiara Portale, Università di Palermo 63
Il mito di Trittolemo in Sicilia: immagini e contestiMonica De Cesare, Università di Palermo 105
Il ruolo della religione nelle complesse dinamiche del commercio antico: alcune note sulle Gorgoni di HimeraChiara Terranova, Università di Messina 129
Archeologia della produzione del commercio nell’antica Agrigento
Alla foce dell'Akragas. Storia e archeologia dell'antico Emporion di AgrigentoValentina Caminneci 151
Gli ergasteria di Akragas: nuove piste di ricercaMaria Concetta Parello, Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi 181
Produzioni agricole ed officine ceramiche ad Agrigentum in età tardoromanaMaria Serena Rizzo, Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi 203
Produzione e commercio dello zolfo ad Agrigentum e nel suo territorioLuca Zambito, Dottore di Ricerca Università di Messina 227
Artigianato, commercio e impresa tra Medioevo ed Età Moderna
L’operosità umana dalla terra al mare: il caricatore di Sciacca tra XIV e XV secoloMaria Antonietta Russo, Università di Palermo 249
Lavoratori agrigentini a Palermo nel Quattrocento Patrizia Sardina, Università di Palermo 283
Sulle tracce degli antichi vasai nisseni. Le produzioni ceramiche di Caltanissetta.Salvina Fiorilla, Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa 311
La tipografia ad Agrigento nei secoli XIX e XX dai documenti rinvenuti presso l’Archivio della Camera di CommercioPaola Giarratana, Maria Carmelina Mecca, Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 331
Percorsi didattici: la parola al passatoValentina Caminneci 355
Aërii mellis caelestia dona (Verg. georg. IV,1)
Lavoro e paesaggio nella pittura italiana dell’Ottocento
Conclusioni
Per una valorizzazione dei paesaggi storici della produzione: l’istituzione degli ecomusei in SiciliaValentina Caminneci 373
Appendice. La Scuola e la memoria
Un Museo nella Scuola. Il Museo della Civiltà Contadina di MontallegroDomenico Tuttolomondo, Rosanna Fileccia, Caterina Orlando, Istituto Comprensivo Ezio Contino di Cattolica Eraclea e Montallegro 393
Il lavoro e le risorse del territorio: zolfo, sale e metalli nel territorio agrigentino nella preistoria
DOMENICA GULLÌ
37
La storia del lavoro e la storia dell’umanità coincidono. I primi strumenti furono realizzati circa
tre milioni di anni fa nel territorio intorno al lago Vittoria (Africa) da ominidi ancora non
fisicamente simili agli umani attuali: si tratta di semplici ciottoli scheggiati, con un margine
tagliente, utile a tagliare e raschiare (chopper) (fig. 1). Questo semplice strumento da lavoro fu
l’unico utilizzato fino a circa 1,8 milione di anni fa, quando venne realizzato per la prima volta
uno strumento più complesso, una sorta di lancia, dal contorno a mandorla (amigdala),
scheggiato su entrambi i lati, con una estremità appuntita e una più tozza; questo prototipo di
una punta di lancia fu utilizzata per la caccia e come arma da offesa (fig. 2). Il chopper e
l’amigdala sono gli unici strumenti di cui si abbia notizia per un periodo lunghissimo, fino
quasi a 200.000 anni fa. Lo sviluppo della tecnica determinò il sempre maggiore controllo
dell’uomo sulla natura che si trasformò, lentamente, da preda a predatore.
Una vera e propria svolta si ebbe nel Paleolitico medio quando si raffinarono tecniche per
cacciare animali di grossa taglia; questo processo è fondamentale perché stimolò progressi
tecnici nella costruzione di utensili nuovi come i percussori e, soprattutto, sollecitò un’azione
di gruppo programmata che rese necessaria la comunicazione e lo sviluppo del linguaggio
(PFEIFFER 1969).
Importante progresso tecnologico rappresentò la scheggia, un manufatto molto più sottile e
38
piccolo, ma anche più tagliente, ottenuto attraverso il ritocco dei margini. Intorno a
40.000/35.000 anni fa venne perfezionata una tecnica di scheggiatura che consentiva
di ottenere schegge sottili dai margini rettilinei molto taglienti, strumenti più piccoli
e versatili utilizzati per una molteplicità di attrezzi (fig. 3). L’uomo pertanto si è
sempre confrontato con la natura, mezzo della sua sopravvivenza: caccia, pesca,
raccolta, approvvigionamento dell’acqua, ricerca di un riparo significa già trasformare
gli elementi naturali in risorsa.
L’economia di sussistenza che ha caratterizzato un lunghissimo periodo della storia
dell’uomo, fondata sulla caccia, pesca e raccolta, fu superata solo nel periodo che
convenzionalmente chiamiamo Neolitico (VI-V millennio a.C.), quando si determinò
il controllo diretto dell’uomo sulla riproduzione vegetale e animale, con la
conseguente creazione degli insediamenti stabili (fig. 4).
Il ciclo di lavorazione dei cereali porta alla creazione di strumenti nuovi come i
falcetti in selce, le macine in pietra (fig. 5) e strumenti come accette, zappe, picconi.
Iniziò la sistematica ricerca di fonti di approvvigionamento. Durante il Paleolitico la
raccolta avveniva prevalentemente lungo i corsi d'acqua, dove era possibile trovare i
ciottoli trasportati dalla corrente; a partire dal Neolitico, i metodi di ricerca della
selce subirono un cambiamento radicale, quando si scopri la possibilità di estrarre i
noduli di qualità migliore dagli strati in profondità, scavando gallerie sotterranee (fig.
6), servendosi di picconi e mazzuoli litici (fig. 7) che sono stati rinvenuti in
abbondanza all'interno delle gallerie. Nasce così la miniera, che richiede una
strutturazione organizzata e una specializzazione del lavoro.
40
2. Strumento in pietra bifacciale (amigdala).
3. Stacco di una lama da un nucleo di selce (disegno Manola Cotroneo).
41
Nel Neolitico la sedentarietà produce una sempre più accentuata specializzazione del lavoro: il
pastore, l’agricoltore, il ceramista (fig. 4).
La trasformazione dei cereali, probabilmente affidata alle donne, è testimoniata da numerose
macine e pestelli, così come la produzione dei prodotti caseari è testimoniata da vasi con
piccoli fori su tutto il corpo del vaso: alcuni esemplari sono stati sottoposti ad analisi
gascromatografiche che hanno accertato la presenza di tracce di caseina (fig. 8).
Un’attività specializzata divenne quella del vasaio: l’uomo scoprì che l’argilla impastata con
acqua diventa plastica, modellabile, e che con la cottura, la forma attribuita diventa
irreversibile. Questa, che è senz’altro una delle invenzioni più importanti del Neolitico,
diviene un’attività altamente specializzata, sia per la realizzazione del vaso, che richiede il
reperimento e la scelta della materia prima, le tecniche di cottura e soprattutto le tecniche di
decorazione (fig. 9).
Ovviamente le caratteristiche fisiche e le potenzialità del territorio hanno sempre determinato
le scelte per l’impianto degli insediamenti: la natura dei suoli innanzitutto, e la loro
conseguente potenzialità produttiva, la presenza di acqua, sono fra le risorse naturali quelle
certamente fondamentali all'impianto di comunità stabili.
Alcune tra le risorse naturali importanti e utilizzate sin dalla preistoria sono certamente il sale,
il bitume, lo zolfo. La primaria importanza del sale nell’antichità risulta naturalmente ovvia,
quando si pensa che la conservazione di carni, pesce e altri alimenti deperibili, è un momento
di fondamentale importanza nella gestione delle risorse alimentari. L’importanza della presenza
del sale in relazione alla distribuzione degli insediamenti è stata evidenziata in diversi studi
(STIGLITZ ET ALII, 847-874) e la concentrazione di insediamenti vicino a saline sembra un dato
42
4. Ricostruzione delle attività principali di un villaggio neolitico (disegno di Manola Cotroneo).
44
Importanti giacimenti di zolfo e salgemma sono notoriamente presenti nel territorio
agrigentino: la Sicilia centro meridionale ha delle caratteristiche geomorfologiche peculiari,
caratterizzata da affioramenti di rocce evaporitiche della serie gessoso-solfifera, che
contengono depositi di zolfo e salgemma. Nell’area della valle del Platani, tali elementi si
ritrovano facilmente in superficie perché le acque superficiali penetrano all’interno della roccia
granulare, variamente fessurata, inabissandosi nei meandri sotterranei derivanti dalla
dissoluzione dei gessi. Le acque raggiungono le formazioni saline e solfifere sottostanti
sciogliendole; arricchitesi di questi minerali, riemergono in numerose sorgenti appunto salate e
sulfuree (cosiddette acqua amara, o acqua mintina).
Alcune acque salate, che riemergono nel greto del fiume Platani, hanno un contenuto salino
altissimo, che talora raggiunge i 200 gr per litro (figg. 10-11). I ricchi depositi di sale presenti
praticamente lungo tutta la valle del Platani, consentono la facile raccolta del minerale che si
deposita in superficie in spesse incrostazioni (fig. 12): depositi di spessore notevole si trovano
in contrada Borangio, variamente ricordata nella storiografia naturalistica, a Raffadali,
Cattolica Eraclea, contrada Salina, in contrada S. Barnaba, a Sud di S. Angelo Muxaro,
Cianciana, dove il sale in molti filoni è affiorante e di facile raccolta in superficie; più a Nord
importanti depositi salini si trovano nell' areale fra Cammarata e S. Giovanni Gemini.
A SO di Cianciana, nei pressi del vallone Intronata, affiora un corpo salino con uno spessore
di oltre 40 metri e una lunghezza di 700 metri. Sulla destra idrografica i corpi in affioramento
sono due ed hanno una lunghezza singola di m 250 con uno spessore in affioramento di 30-40
metri.
Il vallone Intronata, nei periodi poco piovosi, rideposita lungo l’alveo patine di sale per effetto
47
della evaporazione delle acque di dissoluzione del sale.
Tale caratterizzazione geofisica definisce un paesaggio unico, dominato dal corso del fiume e
dalle continue incrostazioni e accumuli di sale, sia sul fiume, le cui acque superficiali appaiono
spesso ricoperte da una crosta di sale, ma anche nei numerosi accumuli che crescono intorno
alle innumerevoli sorgenti di acqua salata.
Anche se l’utilizzo del sale durante la preistoria è naturalmente ovvio, solo per l’età
medievale disponiamo di documentazione sulla sua produzione e commercializzazione
in vari siti della valle fluviale come a Raffadali, Cammarata, Platanella.
Il paesaggio è definito anche dalla presenza diffusa dello zolfo. Filoni solfiferi si
riscontrano sia nell'ambito di ammassi gessosi che in quelli calcarei. Ai noti depositi di
Cozzo Disi e di contrada Rossi, coltivati fino a qualche decennio fa, fanno riscontro
estese incrostazioni di zolfo presenti praticamente su tutto il territorio, da contrada
Roveto, alle pendici meridionali di Rocca Ficarazze, al vallone Mandravecchia.
Lo zolfo, la cui utilizzazione e commercializzazione sin dall’antica età del Bronzo è
ormai provata dagli scavi di Monte Grande, ha un largo utilizzo, in ambito terapeutico
e sacro.
La prima conferma archeologica all’ipotesi della ricerca e del commercio dello zolfo
nella regione agrigentina prima del periodo romano, è costituita dalle scoperte di
Monte Grande di Palma di Montechiaro (fig. 13), dove è stato portato in luce un
complesso di recinti interpretato come un grande santuario consacrato al culto della fertilità e
della prosperità, datato, in base ai materiali rinvenuti, indigeni ed egei, al XVI sec. a.C.
Connesse ai recinti, erano fornaci per la fusione dello zolfo (fig. 14), rinvenimento
48
9. Vaso con decorazione a roker realizzata con conchiglia da Licata (disegno di Lucia Alongi); vaso con decorazione a stampo stile Stentinello (da MANISCALCO 2004).
50
davvero straordinario che conferma la pratica della fusione dello zolfo già nell’antica età del
Bronzo. Questa scoperta costituisce la prima conferma archeologica all’ipotesi della ricerca e del
commercio dello zolfo nella regione agrigentina sin dalla preistoria. I numerosi ed eccezionali
materiali votivi rinvenuti in un area vastissima, hanno fatto supporre che il grande santuario
fosse il luogo di culto non di una singola comunità ma un santuario federale di tanti villaggi.
Monte Grande con il grande santuario e le officine annesse finalizzate alla fusione dello zolfo,
nell’ambito della cultura di Castelluccio, rappresentò un centro di fondamentale importanza per
gli intensi rapporti mercantili a livello panmediterraneo nel XVI e XV sec. a.C., come dimostrato
dalla ceramica egea rinvenuta (CASTELLANA 1998; 1999).
Poco distante da una fornace, in un contesto datato al Bronzo antico, si è rinvenuto, oltre a
ceramica dipinta dello stile di Castelluccio e frammenti egei, un panetto di zolfo fuso di forma
tronco piramidale con base piana e pareti oblique, costituito da zolfo puro al 100% (fig. 15). Le
indagini archeometriche indicano che la tecnica della fusione dello zolfo nel forno denominato
“calcarone” non sia una tecnica moderna ma utilizzata almeno dall’antica età del Bronzo
(GIARDINO 1998).
L’associazione dei materiali egei con le tracce delle strutture destinate alla fusione dello zolfo a
Monte Grande, indicano che lo zolfo, di cui si conoscono i molteplici usi nel mondo antico,
dall’ambito farmacologico a quello cultuale, fu oggetto di traffici transmarini per la sua ricerca e
approvvigionamento, e quindi elemento importante nell’economia della Sicilia centro-
meridionale già in questa fase della preistoria.
Un frammento di un panetto simile si è rinvenuto recentemente su Monte Roveto a
Casteltermini, confermando la pratica del confezionamento dello zolfo fuso in panetti sin dalla
53
Un altro aspetto molto importante dell’utilizzo e trasformazione delle risorse naturali è la
metallurgia. Le uniche, modeste risorse metallifere dell’isola sono costituite dai giacimenti
della regione dei Monti Peloritani, dove si trovano filoni contenenti mineralizzazioni in ferro,
piombo, rame, argento, ferro, arsenico, antimonio, conosciute e sfruttate in antico fino al XIX
secolo (GIARDINO 1999).
Oggi l’estrazione e la lavorazione dei minerali ferrosi è documentata nella media valle del
Platani, nel territorio di Casteltermini. I minerali ferrosi sono particolarmente concentrati
lungo un punto di faglia da Rocca Ficarazze a Monte Roveto, ma presenti, in mineralizzazioni
superficiali, su una vastissima area. La presenza diffusissima di minerali di ferro, anche di
notevole spessore, rimanda al toponimo locale, appunto Rocca Ferro, di origine relativamente
recente e determinato evidentemente da questa particolare caratteristica naturale che doveva
essere di una certa portata se è stata registrata e fissata in un toponimo (GULLÌ 2003; 2005).
Negli anni Novanta del secolo scorso si rinvenne, sulla sommità di Monte Roveto, un
ripostiglio di oggetti di bronzo e ferro (fig. 17). Molto significativa, tra gli oggetti del ripostiglio,
la presenza di semilavorato siderurgico: si tratta del cosiddetto blumo o spugna di ferro,
prodotto di scarto del processo metallurgico che utilizzava all’origine minerali ferrosi presenti
sul luogo, come l’ematite (fig. 18). (GULLÌ c.d.s.).
Le scorie hanno una struttura molto spugnosa con grossi vacuoli e tracce di carbone e zolfo,
visibili anche ad occhio nudo. Il carbone era indispensabile per l’operazione di riduzione dei
minerali, che era di tipo diretto, cioè riscaldando il minerale ad alte temperature insieme al
carbone di legna e allo zolfo probabilmente per la sua azione infiammabile.
Il blumo viene poi battuto a caldo per espellere le scorie e ottenere la massa di ferro.
55
14. Palma di Montechiaro. Monte Grande. Ricostruzione di un calcarone per la fusione dello zolfo e panetto di zolfo(da CASTELLANA 1998).
15. Panetto di zolfo da Casteltermini.
56
La conservazione deliberata dei semilavorati siderurgici è indice del valore che ad essi veniva
attribuito.
La presenza di attività di fonderia è certamente uno degli aspetti più interessanti che la ricerca
archeologica nel territorio di Casteltermini ha evidenziato; è documentata la presenza
massiccia di frammenti metallici, aes rude, scorie di fusione, piccoli lingotti, e soprattutto di
una grande quantità di ferro, sia allo stato naturale che lavorato, allo stato di blumo o piccoli
masselli di ferro dolce (fig. 19).
La presenza diffusa di metallo informe, segnalata da Vincenzo La Rosa alla fine degli anni
Settanta del secolo scorso, si configurò da subito come un palese indicatore archeologico della
ricchezza del centro, in quanto rimanda chiaramente ad operazioni di fonderia e quindi, alla
lavorazione del metallo in loco. Da allora, le ricognizioni effettuate sull’intero territorio di
Casteltermini, scoperte fortuite e in seguito a scavo regolare, hanno accresciuto in maniera
davvero straordinaria le attestazioni della presenza di manufatti in metallo, bronzo e ferro, e di
una ingente quantità di metallo informe, tipo aes rude, lingotti, del tipo a barra o discoidali
piano-convessi, che rimanda senza dubbio ad operazioni di fonderia.
Appare evidente come non si possa prescindere dalle analisi metallurgiche dei lingotti, in
modo da stabilire se siano prodotti di rifusione o lingotti da estrazione, questione di non poco
conto che può fornire indicazioni preziose sulle fonti di approvvigionamento del metallo
grezzo. I lingotti in ferro, la presenza delle scorie e delle gocce di fusione, suggeriscono pertanto
la presenza di officine siderurgiche attive, che si approvvigionavano, forse anche solo in parte,
del ferro locale. É in programma la mappatura e campionatura di tutti gli affioramenti dei
minerali di ferro, presenti nell’intero territorio: questo consentirà di verificare la composizione
59
19. Aes rude, scorie di fusione e semilavorato siderurgico rinvenuti in superficie a Monte Roveto.
60
radioisotopica dei minerali locali e poterla così confrontare con quella delle scorie e dei lingotti.
Sin dalla più antica attestazione di realizzazione di “strumenti”, quindi di applicazione di una
tecnica che viene condivisa e trasmessa, la natura è mezzo di sussistenza, teatro di continue
sperimentazioni per dominare gli elementi e ricavarne sempre nuovi e maggiori benefici. Le
specializzazioni del lavoro sono pertanto strettamente collegate alle risorse di ciascun territorio,
frutto della capacità dell’uomo preistorico a capire e sfruttare le potenzialità del suo habitat naturale.
BibliografiaCLARK G. 1992, L’economia nella preistoria, Roma.CASTELLANA G. 1998, Il santuario castellucciano di Monte Grande e l’approvvigionamento dello zolfo nelMediterraneo nell’età del Bronzo, Agrigento.CASTELLANA G. 1999, La produzione dello zolfo nel santuario castellucciano di Monte Grande e i contatti conil mondo egeo-levantino, in LA ROSA V., PALERMO V., VAGNETTI L. (a cura di), Atti Simposio Italiano diStudi Egei dedicato a L. Bernabò Brea e G. Pugliese Carratelli, Roma.DE MIRO E. 1999, Un emporio miceneo sulla costa sud della Sicilia, in LA ROSA V., PALERMO V.,VAGNETTI L. (a cura di), Atti Simposio Italiano di Studi Egei dedicato a L. Bernabò Brea e G. PuglieseCarratelli, Roma, 439-449.GIARDINO C. 1998, Resti castellucciani di lavorazione dello zolfo a Monte Grande: indagini archeometriche, inCastellana 1998, 408-427.GULLÌ D. 2003, Recenti scavi a Rocca Ficarazze e Monte Roveto di Casteltermini, in Studi di archeologiamediterranea. Atti in onore di Ernesto De Miro, Roma, 375-399.GULLÌ D. 2005, Caratteri di un centro indigeno nella valle del Platani. Nuove ricerche, in Sicilia Antiqua 2, 2005, 9-62.MANDOLESI A. 1999, La “Prima” Tarquinia. Insediamento protostorico sulla Civita e nel territorio circostante.Grandi contesti e problemi della protostoria italiana, 2, Firenze, 200-202.MANISCALCO L. 2004, Ambiente e vita quotidiana nella preistoria. Progetto Scuola Museo, Palermo.PFEIFFER E. 1969, The emergence of Man, Roma.STIGLITZ A., MANCA DEMURTAS L., DEMURTAS S., Ipogeismo e territorialità. Appunti sulla geografia degliinsediamenti antichi del Sinis (Sardegna centro-occidentale), in L’ipogeismo nel Mediterraneo II, 847-874.
Finito di stampare nel Giugno 2014
Progetto grafico e redazioneValentina Caminneci
Claude Monet, Covoni alla fine dell’estate, 1890-1891, Louvre, Parigi(da http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet._Haystack._End_of_the_Summer._Morning._1891._Oil_on_canvas._Louvre,_Paris,_France.jpg)
Dunque, se l’animo tuo nel cuore vagheggia ricchezze,fa’ come io ti dico, fa’ che lavoro s’aggiunga a lavoro
(Esiodo, Le opere e i giorni, vv.. 381-382, trad. it. Ettore Romagnoli).
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali. Via U.La Malfa,5. Agrigento. [email protected] Donato. Progetto Valentina CaminneciURP Adriana Cascino. [email protected] fax 0922401587
Regione SicilianaAssessorato Beni Culturali e Identità SicilianaDipartimento Beni Culturali e Identità SicilianaSoprintendenza Beni Culturali e AmbientaliAgrigento