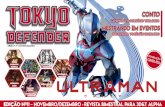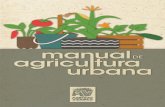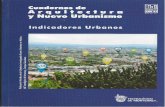Il disegno della forma urbana
-
Upload
cityspacearchitecture -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Il disegno della forma urbana
Il progetto di digitalizzazione e georeferenziazione di
cartografie e fotografie storiche, descrittive di vaste por-
zioni territoriali, avviato qualche anno fa dall’Istituto per
i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna, rappresenta un’evoluzione significativa di co-
noscenza nello studio dell’urbanistica, del paesaggio e
della modificazione degli assetti morfologici e naturali
del territorio.
Il raffronto diacronico di cartografie e immagini foto-
grafiche storiche è uno strumento largamente utilizzato
per lo studio dell’evoluzione dell’insediamento umano
e dell’ambiente naturale e costruito. Tale raffronto per-
mette di individuare in senso statico le invarianti morfo-
logico-territoriali e gli elementi di permanenza dell’edifi-
cato storico consolidato e di definire, in senso dinamico,
le direzioni delle trasformazioni urbane e antropiche,
secondo diverse tipologie e morfologie insediative, e il
progressivo consumo di suolo e di risorse in relazione
all’ecosistema ambientale-paesaggistico.
La possibilità di utilizzare cartografie e fotografie sto-
riche digitalizzate e georeferenziate, unitamente a ma-
teriali ortofotografici e fotogrammetrici, anch’essi geo-
referenziati, permette di rendere l’analisi diacronica più
significativa e strutturata: una volta inseriti tali materiali
in un sistema informativo, su una piattaforma di tipo GIS
(Sistema Informativo Geografico), che ne permette un’a-
gile sovrapposizione, è possibile arricchire la lettura im-
portando set di dati provenienti da studi e ricerche diver-
si, permettendo di incrociare, in senso multidisciplinare,
le informazioni e le fonti. In questo modo il territorio
risulta investigato e ricostruito in maniera approfondita
nella sua evoluzione storica, geomorfologica, ambientale
e urbanistica, attraverso un valido strumento di gestione
e controllo delle informazioni, raccolte in maniera omo-
genea all’interno della stessa piattaforma. Lo scopo è
quello di realizzare un contenitore che racchiuda al suo
interno i dati di conoscenza a più livelli, messi a sistema
in maniera trasversale, necessari per promuovere attività
di tutela e gestione territoriale e paesaggistica, per la
redazione dei contenuti e delle azioni di piani urbanistici
di intervento, per la salvaguardia di patrimoni naturali e
culturali.
Vengono di seguito presentati due casi di studio in grado
di esemplificare le modalità di approfondimento di un
determinato contesto urbano e territoriale, attraverso
l’analisi diacronica e sincronica dei documenti cartogra-
fici e dei materiali fotografici: il caso di Ravenna, inve-
stigato da Luisa Bravo, mette in luce le trasformazioni
del paesaggio nella porzione di territorio compresa fra
la città e la costa, e il caso di Bologna, illustrato da Anna
Gianotti, si riferisce all’apertura della via Roma (attuale
via Marconi) all’inizio del secolo scorso.
RAVENNA: L’EVOLUZIONE DEL RACCONTO URBANO DALLA CITTÀ ALLA COSTAAll’inizio del Novecento Ravenna è una città di terra,
silenziosa e isolata, fondata su una cultura contadina:
l’Adriatico, che in epoca romana lambiva l’ampia laguna
costiera al centro della quale sorgeva la città, si è pro-
gressivamente ritirato, mantenendo una lingua d’acqua
come approdo navigabile al centro cittadino, il porto-
canale Candiano, e aprendosi in paludi e piallasse, attra-
verso vasti terreni bonificati.
… urbanisticaIL DISEGNO DELLA FORMA URBANA
Luisa Bravo, Anna Gianotti
215
216
ESPE
RIEN
ZE A
CO
NFR
ON
TO: C
ARTE
, FO
TO E
... La forma dell’edificato urbano è chiaramente definita
dalla cerchia delle mura, segno di confine rispetto alla
campagna, al cui interno si è venuta sviluppando, in una
stratificazione di interventi realizzati in periodi successivi,
un’architettura urbana estremamente ricca, espressione
di un’identità e di un passato di grande splendore: all’area
centrale di piazza del Popolo, con il palazzo comunale, il
palazzo del governo e la piazza del teatro, polo delle atti-
vità amministrative e di scambio, si affianca il polo della
vita religiosa, definita dal duomo, dall’Arcivescovado e da
un gran numero di chiese e monasteri sparsi sul territorio
(di cui i quattro principali San Vitale, Santa Maria in Porto,
San Giovanni e Classe), il polo della vita culturale, con la
Biblioteca Classense, l’Accademia di Belle Arti e la rete dei
musei, collocati per lo più all’interno dei monasteri, e il
polo delle attività cittadine, con la piazza del mercato e il
foro boario, e delle attività commerciali, sviluppate lungo
via Cavour e via Diaz.
1. Carta di Ravenna (settore nord-est), Istituto Geografico Militare, 1892.
217
IL D
ISEG
NO
DEL
LA F
ORM
A U
RBAN
AU
RBA
NIS
TICAAll’esterno delle mura, la darsena di città, elemento di testa
e di innesto urbano del canale Candiano, ospita la stazione
ferroviaria e le prime attività industriali.1 Il tessuto connet-
tivo è costituito da edifici residenziali, sviluppati intorno a
palazzi solidi di monumentalità simbolica, molto semplici,
per lo più case a lotto gotico, con il lato minore rivolto
sulla strada, basse di colore marrone-rosso se lasciate con
il mattone in vista o di colore rosa e pesca se dipinte, di
«purezza rusticana», come si legge nelle descrizioni di Hen-
ry James,2 aggregate a definire «piccole piazze» e «angoli
romantici», nelle impressioni di Herman Hesse.3
I viaggiatori rimasti affascinati dal canto di Francesca da
Rimini, all’arrivo in città si dirigono a esplorare la tom-
ba di lei e il tempietto del sommo poeta Dante, presso
la basilica di San Francesco, muovendosi lungo le strade,
realizzate sempre con il selciato di ciottoli di fiume, nella
trama preziosa di scorci sempre diversi in cui risaltano le
memorie del passato. Il territorio compreso fra la città e
la costa è caratterizzato da vaste porzioni di paesaggio
agricolo con case sparse nei diversi poderi, attraversato
da canali, scoli e cavedagne, dalla fascia boschiva della
Pinarella e dalla Piallassa del Piombone. Sul mare si af-
faccia un ambiente naturale integro, una fascia di pineta
che si sviluppa lungo circa 40 chilometri, interrotta solo
a nord dalla Bocca di Porto Corsini, ispirazione di poeti e
letterati, come Boccaccio e Byron, che all’ombra dei pini
dalla chioma sempre verde scrissero novelle e racconti.
L’ambiente naturale appare senza soluzione di continuità,
fatta eccezione per il piccolo nucleo dello scalo portua-
le di Porto Corsini, che con il nuovo faro, costruito nel
1863, e lo stabilimento balneare impiantato dalla «Società
balnearia» nel 1872 testimoniano la nascita dell’interesse
verso lo sviluppo del porto e delle attività a esso correlate
per il sostegno dell’economia locale.
L’analisi delle trasformazioni del territorio ravennate
nell’arco del Novecento, nella fascia di terra che sepa-
ra la città dal mare, viene sviluppata mediante l’uso di
cartografie e fotografie che documentano l’evoluzione
delle matrici morfologico-naturali e urbane, per succes-
sive soglie temporali. Vengono utilizzate la Carta d’Italia
dell’IGM del 1892, riferita alla porzione nord-est del ter-
ritorio ravennate; la fotografia aerea dell’IGM del 1937 –
ottenuta dalla mosaicatura, realizzata in una piattaforma
GIS, di immagini georeferenziate – della porzione di ter-
ritorio compresa fra la città di Ravenna e l’insediamento
costiero, da Porto Corsini fino a Punta Marina, passando
dalla colonia Croce Rossa collocata all’interno della pine-
ta di San Vitale; e la cartografia IGM del 1994, riferita al
settore nord-est.
Scorrendo queste carte è possibile leggere, attraverso un
raffronto diacronico, l’evoluzione del disegno della forma
urbana. In particolare la lettura fa emergere nuovi assetti,
legati alle preesistenze morfologiche del territorio e alla
trama del tessuto costruito, esito delle direzioni di svi-
luppo delle espansioni urbane, particolarmente estese e
pressanti sulla città storica già a partire dall’immediato
dopoguerra: a ovest/nord-ovest, in corrispondenza della
strada per Bologna e Faenza, a prosecuzione del borgo
storico di San Biagio; a sud, a cavallo delle strade per Forlì
e Rimini, come saldatura dei due borghi di San Rocco e
Porta Nuova; a est, fra la ferrovia e il canale, nel quar-
tiere Darsena. Più ridotta la dilatazione topografica dei
settori nord e nord-est, per le difficoltà di collegamento
frapposte dalla ferrovia e dal canale; in qualche punto
la campagna lambisce ancora la circonvallazione, ossia
le mura. Permangono i segni e le invarianti dell’insedia-
mento storico – il contorno delle mura, sostituito quasi
ovunque da percorsi stradali e a est dalla ferrovia, risulta
discretamente percepibile – e al contempo si evolvono
le tipologie paesistiche, con la progressiva erosione del
sistema naturale a favore di un’urbanizzazione costiera
e di uno sviluppo industriale che lentamente si è impos-
sessato di porzioni, anche pregevoli, delle matrici e delle
patches4 del paesaggio.
1. Gabriele Gardini, L’architettura dell’antiretorica, «Polis idee nella città», Ravenna,
II, 7, 1996, pp. 7-11.
2. Henry James, Italian hours, Maine (USA), Bangor, 1909.
3. Hermann Hesse, Aus italien. Reisetagebuch 1901, in idem, Dall’Italia. Diari, poesie,
saggi e racconti, Milano, Mondadori, 1990.
4. ricHard T.T. Forman, micHael Godron, Landscape ecology, New York, Wiley, 1986.
218
ESPE
RIEN
ZE A
CO
NFR
ON
TO: C
ARTE
, FO
TO E
...
2. Mosaicatura, realizzata in una piattaforma GIS (con il software open source QuantumGis), di fotografie dell’Istituto Geografico Militare del 1935,
georeferenziate dall’IBC, relative alla fascia di territorio ravennate compresa fra la città e Porto Corsini (elaborazione di Luisa Bravo, nell’ambito della
Convenzione di ricerca stipulata tra l’Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Architettura e Pia-
nificazione Territoriale dell’Università di Bologna, 2009-2011).
219
IL D
ISEG
NO
DEL
LA F
ORM
A U
RBAN
AU
RBA
NIS
TICALa dinamica del cambiamento dei caratteri morfologici del
territorio è certamente riconducibile all’azione di trasfor-
mazione urbanistica e di programmazione delle linee di
sviluppo e di espansione urbana promossa dalle ammini-
strazioni locali, mediante politiche e strumenti di gover-
no del territorio. Subito dopo la guerra, il PRG di Ravenna
del 1945 è finalizzato a interventi di tutela per il centro
storico, nel suo patrimonio archeologico, architettonico
e monumentale, di sviluppo delle attività del porto lun-
go i 12 chilometri di estensione del canale Candiano, e di
conservazione dei caratteri ambientali e delle biodiversità
naturalistiche delle pinete, delle zone umide lagunari e del
litorale. Negli anni Cinquanta lo sviluppo quantitativo, in
conseguenza dell’insediamento della raffineria SAROM e
dell’impianto ANIC, della nuova domanda di infrastruttu-
re di trasporto, di autostrade per il collegamento diretto
a Bologna e di idrovie, delle opere di potenziamento del
porto per opera della SAPIR, determina un enorme con-
sumo di suolo, per far fronte a una decisa concentrazione
urbana. Il piano regolatore di Quaroni, adottato nel 1962,
conferma nei numeri questa impostazione di «ipertrofia
magniloquente»:5 prevede aree edificabili per 290 ettari,
conferma a destinazione industriale 2.000 ettari assegna-
ti alla SAPIR, destina 1.440 ettari all’attività turistica, con
possibilità di edificare circa 20 milioni di metri cubi – pari
a circa 3.000-4.000 posti letto turistici – destina solo 140
ettari alle attrezzature pubbliche, applicando un regime di
salvaguardia per il centro storico che consente numerose
demolizioni e ricostruzioni.
Negli anni Cinquanta e Sessanta a Ravenna si innesca
dunque un processo di crescita, legato al boom economi-
co del contesto nazionale, che rompe gli equilibri tra spa-
zio costruito, aree agricole e paesaggio naturale. Ma con
il PRG del 1973 viene posta l’attenzione sull’esigenza di
conoscere e difendere le ‘unità ambientali’ di importanza
naturalistica (valli, piallasse e pinete) per le quali il piano
prevede l’esatta delimitazione delle aree edificate o in via
di edificazione con l’individuazione di una fascia costiera
inedificabile, il ripopolamento faunistico e la tutela del-
le formazioni dunali, con un drastico ridimensionamento
delle residenze turistiche previste dalla variante al PRG del
1966; allo stesso tempo il piano mira a tutelare il patri-
monio architettonico e urbano, con risanamento edilizio e
restauro conservativo degli edifici, e alla riorganizzazione
del tessuto sociale, con un consistente aumento delle aree
pubbliche o di uso pubblico pari complessivamente a 1.470
ettari (di cui 1.330 indicati nelle tavole di piano e 140 da
definire all’interno delle aree di espansione), integrando al
contempo il centro urbano con i centri minori del forese,
nei quali risiede circa il 40% della popolazione comunale,
mediante un sistema infrastrutturale esteso per lo svilup-
po equilibrato dell’intero territorio comunale.
Il PRG del 1983, forte di una situazione territoriale messa
a punto negli anni precedenti nei suoi elementi costituen-
ti, si propone come piano della qualità, delle occasioni di
sviluppo, dell’efficienza e gestione del territorio. Uno degli
obiettivi fondamentali è la riqualificazione del tessuto ur-
bano, in particolar modo delle periferie, sviluppatesi, come
in tutte le città italiane, in completa contrapposizione con
la città consolidata e prive di qualità urbana e di luoghi
centrali in cui concentrare le funzioni urbane e le relazioni
sociali. In tal senso il piano promuove la creazione di un si-
stema di percorsi e di piazze destinato ad accogliere attività
commerciali, uffici pubblici e privati, artigianato di servizio,
attrezzature ricettive, residenza e servizi pubblici, secondo
‘tessuti integrati’ che consentano di superare i limiti dello
zoning monofunzionale. È inoltre prevista la creazione di
aree attrezzate a gestione pubblica e privata a servizio del
turismo estivo, che possano essere utilizzate per lo svolgi-
mento di attività ricreative e sportive negli arenili.
È con il PRG del 1993 che, attraverso un nuovo disegno
delle infrastrutture e la valorizzazione della qualità am-
bientale e urbana, viene indicato come obiettivo strategico
il raggiungimento di uno specifico «rango urbano», vale a
dire l’esigenza di evidenziare e far valere, sia nell’ambito
5. marcello ViTTorini, Franco sTrinGa, Continuità e innovazione nei piani regolatori
di Ravenna (P.R.G. ’73-’83-’93), in Progetto Ravenna ’93, Ravenna, Danilo Montana-
ri, 1994. Relativamente al Piano Quaroni per Ravenna si veda luisa braVo, Ravenna:
il futuro ha un cuore antico, in Edifici alti in Emilia-Romagna, a cura di Annalisa
Trentin, Bologna, Clueb, 2006, pp. 41-51.
220
ESPE
RIEN
ZE A
CO
NFR
ON
TO: C
ARTE
, FO
TO E
...
delle dinamiche territoriali regionali che nella competizio-
ne tra sistemi di città, il peso, il ruolo e il valore di una
realtà come quella di Ravenna che, seppure di dimensione
demograficamente relativamente contenuta (circa 135.000
abitanti), dispone di un territorio complesso e molto vasto,
di oltre 66.000 ettari, del secondo porto dell’Adriatico, in
settori merceologici tra i più significativi, di emergenze di
valore assoluto, con riferimento sia alla storia urbana (dal
1996 otto monumenti decorati a mosaico sono stati inse-
riti nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco), che alla
dotazione di risorse naturalistiche, di realtà produttive di
grande valore, di un sistema importante di turismo bal-
neare. A tal fine il piano prevede il recupero e la riconver-
sione della Darsena di città, a seguito della programmata
e graduale dismissione delle funzioni portuali negli ultimi
due chilometri del canale Candiano, al fine di insediare usi
urbani, residenziali, produttivi e di servizio, secondo una
politica urbanistica di tipo integrato, tenendo conto della
centralità che questo ambito urbano sta acquisendo nel
quadro del nuovo disegno delle infrastrutture ferroviarie
e stradali. Per la Darsena di città il Piano definisce chiara-
mente lo spazio pubblico di relazione, costituito da strade
e piazze, inteso come elemento strutturante della futura
edificazione, sviluppato a partire dai caratteri del tessuto
urbano esistente.6
L’azione di governo locale del territorio assume il carattere
di valorizzazione consapevole e sostenibile delle qualità lo-
cali attraverso il Piano strutturale comunale del 2003 (vale
a dire la nuova formulazione del PRG secondo la Legge re-
gionale 20/2000). All’interno del quadro conoscitivo viene
sviluppato il processo di lettura del territorio, indicandone
le linee di forza, le componenti strutturali, i temi di svi-
luppo, lo stato di attuazione della pianificazione locale,
dei processi evolutivi che lo hanno caratterizzato e delle
criticità, con approfondimenti sulla densità abitativa, sui
caratteri dell’insediamento del sistema territoriale, suddi-
viso nei diversi ambiti e unità di paesaggio, per indirizzare
le azioni e previsioni strategiche di sviluppo, ispirate a prin-
cipi di partecipazione, equità e trasparenza, mediante una
programmazione concertata.
Il Piano mira a rispondere all’esigenza fondamentale di
preservare e valorizzare la risorsa ‘territorio’
quale realtà complessa ed integrata, median-
te l’uso controllato delle risorse naturali e il
raggiungimento di livelli di qualità urbana
sotto il profilo ecologico, morfologico, este-
tico, storico-artistico, dell’accessibilità e della
mobilità, della qualità residenziale e insedia-
tiva.
Allo stesso tempo intende
sostenere un ruolo pedagogico-culturale nei
confronti degli abitanti per indirizzarli ad un
uso consapevole delle risorse come esito di
una corretta lettura e valutazione dell’alta
qualità insita nel territorio ravennate.7
Nel progetto urbano, la riqualificazione della città consoli-
data e il rafforzamento dell’identità dei centri sono affidati
in modo particolare al sistema dei servizi e al disegno in-
tegrato degli spazi collettivi. Si vede, quindi, come l’elabo-
razione del Piano tenda progressivamente a integrare nella
logica della pianificazione obiettivi di qualità ambientale e
naturalistica, urbana e sociale diffusa, anche nella gestione
quantitativa dell’insediamento, affiancando alle esigenze
degli indici territoriali la presenza di funzioni pubbliche, del
sistema del verde e la qualificazione dello spazio urbano.
Accanto all’espansione morfologica del sistema insediativo
si definiscono i temi propri della città, i valori del ‘fare città’
letti attraverso la storia, con la consapevolezza che la storia
del territorio è la sola che possa permettere di ritrovare
la vera realtà del territorio stesso, divenendo identità del
processo di pianificazione. Così gli «studi per una operante
storia urbana» tendono a rintracciare «il senso della tradi-
zione, che è insieme senso della realtà stessa delle cose,
la legge che ha reso possibile questa tradizione e questa
realtà e matrice di sviluppo non distruttivo».8
L’analisi urbanistica del territorio per raffronto diacronico
221
IL D
ISEG
NO
DEL
LA F
ORM
A U
RBAN
AU
RBA
NIS
TICA
può ovviamente avvalersi anche di altri materiali cartogra-
fici e fotografici, reperiti direttamente presso i Comuni e
gli enti territoriali competenti, per estendere il racconto
dello sviluppo urbano e della trasformazione del paesaggio
alla storia di una comunità, divenendo specchio
dei modi in cui la società ha posto le sue basi
in un territorio, di come lo ha fatto suo pos-
sesso, lo ha conosciuto, utilizzato, di come
in esso abbia trovato i modi di organizzar-
si, evolvendosi e cercando via via i migliori
adattamenti all’ambiente naturale.9
L’utilizzo delle piattaforme GIS permette oggi di arric-
chire l’analisi derivata dal raffronto diacronico delle car-
tografie e delle fotografie attuali e storiche attraverso
un migliore e più adeguato livello di approfondimento
3. Carta di Ravenna (settore nord-est), Istituto Geografico Militare, 1994.
6. Comune di Ravenna, Programma di riqualificazione urbana della Darsena di città,
a cura di Giovanni Crocioni, Franco Stringa, supplemento al n. 107 di «Urbanistica»,
1997 (Urbanistica Quaderni).
7. Relazione generale allegata al PSC del Comune di Ravenna, 2003.
8. saVerio muraTori, Studi per un’operante storia urbana di Venezia, «Palladio», IX,
III-IV, luglio-dicembre 1959.
9. euGenio Turri, Il paesaggio e il silenzio, Venezia, Marsilio, 2004, pp. 189-190.
222
ESPE
RIEN
ZE A
CO
NFR
ON
TO: C
ARTE
, FO
TO E
...
dei documenti e dei dati acquisiti, relativi al territorio,
all’urbanistica, al paesaggio, ai beni culturali, alla geo-
grafia, alla geologia, all’archeologia, all’agricoltura: le
cartografie e fotografie storiche, digitalizzate e geore-
ferenziate, possono essere messe a sistema con tutte le
informazioni relative al territorio e al paesaggio, con ri-
ferimento anche all’evoluzione demografica nelle diverse
porzioni urbanizzate, alle modifiche degli ambiti e degli
elementi naturalistici, all’analisi e alla gestione dei rischi
dovuti a fenomeni naturali, alla gestione delle reti, alla
protezione civile, ecc. secondo un modello fortemente
strutturato e sempre georeferenziato. Il ricorso al GIS
permette di esplorare tutti gli scenari possibili che deri-
vano dalle scelte di gestione e pianificazione territoriale,
prefigurando l’impatto delle nuove edificazioni residen-
ziali, delle costruzioni degli elementi infrastrutturali,
della conservazione dei tracciati e delle forme naturali,
del consolidamento del suolo, simulando, anche tridi-
mensionalmente, gli effetti di determinate politiche di
gestione e trasformazione del territorio, mediante map-
pe, analisi statistiche, tabelle e grafici, ponendosi quindi
come strumento indispensabile a sostegno dei processi
decisionali.
Ecco perché il GIS negli ultimi anni è diventato uno stru-
mento indispensabile per le pubbliche amministrazioni
per sviluppare i contenuti di piani strutturali, piani rego-
latori, piani territoriali, piani paesistici, piani di recupero,
piani operativi: l’informazione in essi contenuta è omo-
genea, coerente, costantemente aggiornata e permette
la gestione dei dati a più livelli operativi. Ecco perché
la disciplina urbanistica, sempre più, si avvale di questi
strumenti: per sviluppare attività di pianificazione terri-
toriale e di progettazione urbana, per le analisi morfolo-
giche di espansione degli assetti e delle matrici territoria-
li, per documentare il patrimonio storico, architettonico
e urbano e, soprattutto, per legare e far dialogare questi
studi con le analisi territoriali e i contenuti dei piani svi-
luppati dalle pubbliche amministrazioni, permettendone
la sovrapposizione e il confronto, in maniera versatile,
senza frammentazione o perdita di contenuti.
LO SVILUPPO URBANISTICO DI BOLOGNA NEGLI ANNI TRENTA E QUARANTASi può datare l’inizio della storia urbanistica della moder-
na Bologna al piano del 1889. Gli eventi che dall’ultima
decade del XIX secolo alla metà di quello appena chiu-
so hanno mutato il volto di Bologna sono numerosi e di
estremo interesse sia storico che sociale, oltre che urba-
nistico, e sono variamente documentati. Per una migliore
comprensione di questi sviluppi si può mostrare, e questo
è il nostro scopo, accanto alle immagini storiche, alla do-
cumentazione tecnica in pianta e a quella amministrativa
disponibile negli archivi, anche la documentazione foto-
grafica aerea.
In questa applicazione specifica le foto aeree acquisi-
scono infatti grande utilità, anche quando provengono
da fonti che avevano finalità belliche o non unicamente
documentarie; esse consentono una rilettura dotata di
grande efficacia e immediatezza delle conseguenze sul
tessuto urbano non solo del piano di cui sopra ma anche
delle varie fasi che caratterizzano un periodo.
L’osservazione del Piano Regolatore della Città evidenzia
intenzioni di cui potremo verificare l’attuazione analiz-
zando le foto aeree, accertando anche come col mutare
dei tempi sono cambiate le forme di progettualità; an-
che questo è visibile con l’osservazione dei progetti che
si sono succeduti nelle varie fasi di rilancio del piano. Un
piano regolatore infatti è per sua natura un progetto che
identifica un punto di arrivo, senza tuttavia sancire né
fasi né tempi precisi di attuazione. Un vincolo comunque
dello strumento giuridico configurato dal Piano Regola-
tore del 1889 è la sua attuabilità trentennale: nel nostro
caso si volle riprenderlo nel 1927 al limitare della sca-
denza per poterlo prorogare. Vi è un esempio ‘principe’
del funzionamento di tutti quei meccanismi politici, am-
ministrativi e poi economici e sociali che sottendono l’e-
secuzione di un piano che modifica una città: la trasfor-
mazione di una via cittadina, Borgo delle Casse, in arteria
moderna denominata prima Principe Amedeo, poi Roma
e infine Marconi.
223
IL D
ISEG
NO
DEL
LA F
ORM
A U
RBAN
AU
RBA
NIS
TICA
Sarà più facile comprendere le trasformazioni urbanistiche
subite dalla città se si cerca di entrare nello spirito che ha
animato gli anni che vanno dal 1889 alla Grande Guerra,
spirito da una parte ancora legato a concezioni ottocente-
sche e dall’altra sensibile alle istanze dei movimenti moderni,
nella cultura oltre che nella politica. È in quel periodo che la
città delle chiese e dei conventi, e anche in parte delle caser-
me e delle piazze d’armi, comincia a diventare la città dei cit-
tadini: divengono importanti la viabilità, i trasporti pubblici,
l’allacciamento alla rete distributiva del gas, a quella elettrica
e a quella telefonica, oltre alla creazione di un sistema idrau-
lico e fognario adeguato. La città in quel tempo è già un
importante nodo ferroviario, è notevole la sua Borsa agraria
e acquista sempre più importanza l’industria manifatturiera
legata a quelle competenze meccaniche che l’ormai scom-
parsa industria serica aveva lasciato in eredità.
La trasformazione della porzione dell’antico decumano,
dall’odierna via San Felice alle Due Torri, la costruzione della
grande arteria di collegamento con la stazione ferroviaria e
l’apertura dell’asse trasversale per collegare porta San Do-
nato a piazza VIII Agosto e ai viali presso porta Lame erano
stati gli episodi preparatori del grande passo del 1902: allora
Bologna con un gesto quasi liberatorio e, per la sensibilità
dell’epoca, poco contrastabile, si libera della cinta muraria.
4. Piano regolatore del 1889. Si osservino in particolare gli ampliamenti previsti e in parte già realizzati sugli assi est-ovest e nord-sud delle odierne vie
Irnerio e Marconi. Quando nel 1927 stavano per scadere i termini di validità del primo Piano Edilizio Regolatore e di ampliamento della città, terminato
nel 1885 e divenuto legge dello Stato nel 1889, allo scopo di richiederne una proroga, venne effettuata una dettagliata verifica delle previsioni in esso
contenute distinguendole in ‘già realizzate’, ‘da modificare’ e ‘ancora da eseguire’.
224
ESPE
RIEN
ZE A
CO
NFR
ON
TO: C
ARTE
, FO
TO E
...
Molti cittadini la vedevano ormai come un giogo soffocante,
simbolo della miseria che aveva colpito la città a partire dalla
Restaurazione, del tifo, che era endemico a causa della con-
taminazione idrica e della scarsa igiene presente nella parte
più centrale dove i canali erano aperti, della promiscuità de-
gli alloggi che già erano considerati insufficienti nel 1870.
L’adozione di un piano regolatore giuridicamente vincolante
aveva voluto essere una risposta a problemi molto concreti
oltre a un vero e proprio atto di fede nella modernità:
A Bologna l’entità dello sviluppo demografico,
la prospettiva ormai imminente di un debor-
dare casuale della città oltre le mura, il biso-
gno crescente di suolo per servizi, impianti e
istituzioni consigliano l’adozione del nuovo
strumento giuridico. Tanto più che la città si
va sempre più qualificando in senso moderno:
ne dà prova la grande esposizione universa-
le tenutasi nel 1888, con la sua funicolare e i
padiglioni liberty forniti di elettricità, strutture
effimere da cui però si traggono molti auspici
sullo sviluppo imminente.10
Simbolo di modernità e di necessità di cambiamento è cer-
tamente all’inizio del secolo il completamento della rete di-
stributiva del gas, prima in ambito pubblico e poi domesti-
co. La costruzione del palazzo del Gas costituisce un passo
importante nell’attuazione del Piano Regolatore. Sventrare
e costruire il moderno non necessitarono, data l’epoca, di
ottenere il consenso di una città che già dal 1909 aveva as-
sistito a rilevanti abbattimenti di allargamento su via Riz-
zoli e alla fine della Grande Guerra, non senza polemiche,
all’atterramento di tre torri medievali (Artenisi, Guidozagni e
Riccadonna) per ottenere il risultato prospettico desiderato.
Sempre il Ricci ci ricorda che «la Bologna fascista si distin-
gue da quella liberale […] per la maggiore aggressività con
cui furono giustificati gli sventramenti».11 E così tra il 1924 e
il 1930 il principale corso cittadino, nel tratto di via Ugo Bas-
si, fu ulteriormente allargato sul lato meridionale. L’immagi-
ne aerea del 1933 costituisce un chiarissimo documento di
questa fase, sicuramente intermedia rispetto al più corposo
intervento su via Principe Amedeo.
Nel 1926 la carica di Sindaco viene sostituita con quella di
Podestà, e l’ordinamento comunale viene modificato attri-
buendo molta responsabilità a quest’ultimo e sottraendo po-
tere ai funzionari comunali: il rischio che si correva era quel-
lo di sacrificare ai principi del rinnovamento anche aspetti di
estetica e di composizione sociale del tessuto urbano che si
sarebbero potuti salvaguardare senza particolari sprechi ed
eccessivi compromessi. Le demolizioni e i lavori di copertura
dei canali di Reno e Cavaticcio furono dunque avviati nel
1932 e nel 1936 il tracciato della nuova arteria, via Roma, è
completato; in novembre compare il bando di concorso per
un progetto di sistemazione della nuova via Roma, di fronte
a piazza Malpighi, e della zona adiacente, che elencava tre
esigenze prioritarie: viabilità, igiene e decoro.
Con l’istituzione del concorso l’Amministrazione cittadina
assume il ruolo di committente.
È bene sottolineare che il tema del concorso
non era architettonico […] il bando imponeva
ai concorrenti di astenersi dal fornire indica-
zioni troppo dettagliate […] e di limitarsi piut-
tosto a disegnare il volume degli edifici previ-
sti. Tuttavia, scorrendo l’elenco degli elaborati
obbligatori si nota che era richiesta una sola
planimetria in scala 1.1000 e numerosi elabo-
rati di tipo prospettico e assonometrico: con-
siderando che il formato delle tavole era stato
fissato in un metro per un metro […] se ne
potrebbe dedurre […] la completa indifferenza
verso la dimensione territoriale dei problemi
viabilistici e il ruolo preminente assegnato alla
percezione visiva. La progettazione doveva es-
sere finalizzata alla realizzazione di uno spazio
dimensionato su aspirazioni monumentali-
stiche: il volume degli edifici, la vastità delle
piazze e la larghezza delle sezioni stradali era-
no gli strumenti per ottenere l’impatto sceno-
grafico ricercato.12
225
IL D
ISEG
NO
DEL
LA F
ORM
A U
RBAN
AU
RBA
NIS
TICA
Furono tre i progetti premiati, su 19 presentati, e si decise
di far eseguire ai gruppi vincitori ex-aequo un piano defi-
nitivo sotto la direzione di Marcello Piacentini. Alla viabilità
viene assegnato un ruolo fondamentale.
Come si evince dalle citazioni del testo della Legnani la ca-
rica valoriale contenuta nella prassi scelta per i concorsi era
fortemente condizionata sia dalle necessità del regime di
dimostrare monumentalmente la capacità di superamen-
to dei problemi della città, sia dalle tre regole orientative
che stavano alla base della modernità come la si concepiva
all’epoca. La storia non fu generosa né con la città né con
i progettisti che parteciparono a quella epopea più ricca di
intenzioni che di fatti. Di tutte le decisioni che furono pre-
se, sul piano progettuale, furono ben poche le realizzazioni
concrete: si dovevano sventrare zone di via Pratello ritenu-
te «in condizioni deplorevoli per vetustà e per disposizioni
interne contrarie ad ogni norma d’igiene e della vita civile
e come anzi parecchie di dette case siano ricettacolo della
malavita». Si doveva migliorare il collegamento con le por-
te Saragozza e Sant’Isaia e si doveva creare una vera esedra
all’incrocio Lame-Roma. Alla fine furono costruiti gli edifici
a ponente dell’attuale via Marconi e poco altro.
10. GioVanni ricci, Le città nella storia d’Italia. Bologna, Roma, Laterza, 1980, p. 139.
11. Ivi, p. 148.
12. Federica leGnani, Via Roma, 1936-1937, in Norma e Arbitrio. Architetti e Inge-
gneri a Bologna. 1850-1950, a cura di Giuliano Gresleri, Pier Giorgio Massaretti,
Venezia, Marsilio, 2001, p. 288.
5. Progetto per la sistemazione della nuova via Roma (bando di concorso, 1936). A sinistra, assonometria dell’architetto Alberto Legnani, a destra
assonometria dell’architetto Marcello Piacentini. Materiali appartenuti all’architetto Alberto Legnani, ora conservati presso la cartoteca dell’IBC della
Regione Emilia-Romagna.
226
ESPE
RIEN
ZE A
CO
NFR
ON
TO: C
ARTE
, FO
TO E
...
6. Progetto per la sistemazione della nuova via Roma (bando di concorso, 1936). Vista prospettica. Materiali appartenuti all’architetto Alberto Legnani,
ora conservati presso la cartoteca dell’IBC della Regione Emilia-Romagna.
227
IL D
ISEG
NO
DEL
LA F
ORM
A U
RBAN
AU
RBA
NIS
TICA
7. Fotografia aerea dell’Istituto Geografico Militare, 1933. Si noti lo stato (cerchiato in rosso) ancora indefinito dello slargo antistante il futuro palazzo
del Gas mentre via Ugo Bassi ha già acquisito la sua forma definitiva. È visibile (evidenziato in azzurro) il tracciato del canale di Reno, ancora non tom-
bato, che taglia in direzione quasi ortogonale via Roma. «Del piano regolatore restava ancora da realizzare la via fra Piazza San Francesco e la stazione
di cui esisteva solo un troncone in corrispondenza di piazza Umberto I (l’odierna Piazza dei Martiri). I lavori di demolizione cominciarono nel 1932,
stimolati dalla passione viabilistica e dagli intenti di bonifica sociale del fascismo, e portarono presto alla definizione degli allineamenti di via Roma,
che troviamo tutta tracciata già nella pianta del Touring Club del 1935 e più tardi alla edificazione in stile pesantemente littorio del suo lato occidentale
(quello orientale lo sarà nel dopoguerra). Qualche problema pose l’imbocco meridionale dell’arteria e l’incrocio con via delle Lame, poi risolto con un
edificio d’angolo indicato da un concorso di idee del 1936» (Ricci, 1980).