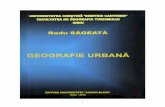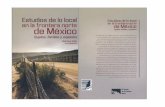Archeologia urbana a Durres
Transcript of Archeologia urbana a Durres
Ricerche archeologiche in Albania
Atti dell’incontro di studiCavallino–Lecce, – aprile
a cura di
Gianluca Tagliamonte
Volume stampato con il contributo del Dipartimento di Beni Culturali – Università del Salentoe della Banca Monte dei Paschi di Siena.
Copyright © MMXIVARACNE editrice S.r.l.
via Raffaele Garofalo, /A–B Roma()
----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: novembre
Indice
Avvertenza editoriale
IntroduzioneGianluca Tagliamonte
L’archeologia politica di Luigi Maria UgoliniAndrea Pessina
Alla ricerca delle «ancora oscure vestigia illiriche»Gianluca Tagliamonte
Networks e società nell’Albania dell’età del BronzoFrancesco Iacono
Sulle tracce del Periegeta. Prospettive, contatti e interazioni nella descri-zione dell’Illiria meridionale nelle fonti geografiche grecheFlavia Frisone
L’Istituto Archeologico Albanese e la ricerca archeologica in AlbaniaShpresa Gjongecaj
Archeologia urbana a DurrësSara Santoro
Recherches coroplathiques en Illyrie méridionale et en Épire du NordBelisa Muka
Résultats et prospectives des fouilles franco–albanaises d’Apollonia d’Illy-rieJean–Luc Lamboley, Faïk Drini
Nuove indagini intorno al teatro di ApolloniaHenner von Hesberg
Il monastero della Dormizione della Vergine ad ApolloniaMarina Falla Castelfranchi
Indice
Aspetti urbanistici, cultura e società di Phoinike dalle origini al I sec. a.C.Sandro De Maria
Hadrianopolis e la valle del Drino tra ellenismo ed età tardo–anticaRoberto Perna
Management and conservation aspects at Butrint National Park – AlbaniaAlbana Hakani
Porti, approdi e itinerari dell’Albania meridionale dall’Antichità al Me-dioevo. Il ‘Progetto Liburna’Giuliano Volpe, Giacomo Disantarosa, Danilo Leone, Maria Turchiano
Ceramiche e commerci nel Canale d’Otranto tra X e XI secolo. Rifles-sioni sulla cultura materiale bizantina tra Salento e Albania meridionaleMarco Leo Imperiale
La ceramica invetriata tra il Salento e l’Albania dall’età angioina alla finedel MedioevoMarisa Tinelli
Abbreviazioni bibliografiche
Abstracts/Përmbledhjet
Ricerche archeologiche in AlbaniaISBN 978-88-548-7245-5DOI 10.4399/97888548724558pag. 123–158 (novembre 2014)
Archeologia urbana a Durrës
S S
. Archeologia e sviluppo urbano in Albania e a Durrës nel XX secolo
In Albania, dopo il consistente inurbamento avvenuto nei primi trent’anni del XXsecolo, lo sviluppo urbanistico modesto del quarantennio del regime comunistanon aveva posto in modo impellente il problema della salvaguardia del patrimonioarcheologico nelle città storiche a continuità di vita, come Valona/Vlorë (Aulona),Elbasan (Scampinus), Berat (Antipatreia), Scutari/Shkodër (Scodra/Colonia Scuta-rinorum), se non nel caso di Durazzo (Durrës), l’antica Epidamnos–Dyrrachium,la cui imponente stratificazione archeologica sottostante la città contemporaneaera nota fin dagli inizi del secolo.
Fra il e il le indagini archeologiche condotte in occasione di lavorimilitari nel ‘centro storico’ della città di Durrës dai due archeologi austriaci C.Praschniker e A. Schober, e l’elenco topografico dei rinvenimenti della città finoad allora avvenuti, stilato successivamente da quest’ultimo (Fig. ), avevano resoevidente che la città ottomana, circoscritta dalle mura ‘bizantine’ e denominataBazar nella schematica pianta realizzata da L. Heuzey quarant’anni prima (Fig. ),e l’Exobazar esterno ad essa, con la grande spianata per il mercato del bestiamecorrispondente all’attuale piazza Liria (sheshi Iliria), coincidevano topografica-mente con la città antica di Dyrrachion/Dyrrachium. La scoperta, da parte di C.Praschniker, del mosaico ellenistico di ciottoli detto la ‘bella di Durazzo’ alcunecentinaia di metri più a nord della piazza e a metri di profondità aveva fattocomprendere anche che la città antica era stata assai più estesa, verso nord, diquella ottomana e moderna e che gli strati di epoca greca e romana erano sepoltidall’enorme crescita della sedimentazione archeologica, composta dalla presenzadi livelli relativi alle diverse fasi di vita della città postclassica.
Gli anni immediatamente successivi alla Prima guerra mondiale furono unperiodo di grande instabilità politica, per l’Albania: la definizione dei confini dellostato a livello internazionale avvenne solo nel , dopo due anni di totale anarchia,a cui seguirono governi effimeri, che si succedettero con estrema frequenza fino alcolpo di stato di Ahmet Zogolli (Zogu) del gennaio .
Questa situazione di forti tensioni politiche si rifletteva anche a livello locale, som-mandosi alle considerevoli trasformazioni in atto nella città di Durrës: l’inurbamento
. P, S , –; S .
. H, D , ss.; per gli acquerelli: pl. , fig.; la pianta è nell’album (vol. II, pl. H).
. P –, .
Sara Santoro
Fig. . Carta dei rinvenimenti archeologici di Durrës in S .
dalle campagne e dalla montagna ne aveva moltiplicato abitanti ed estensione, e losviluppo commerciale del porto imponeva urgenti e radicali interventi di adeguamen-to delle attrezzature dello scalo e di razionalizzazione dell’intera struttura urbana.In quegli anni si deve all’intervento di un sindaco particolarmente attivo e cultural-mente sensibile, K. Paftali, il salvataggio e recupero di numerosi beni archeologici inoccasione di interventi edilizi e dello smantellamento di vecchi edifici e di parti dellemura bizantine e ottomane. Il passaggio in città di alcuni archeologi stranieri cheavrebbero avuto poi un grande ruolo nell’archeologia albanese, Léon Rey e LuigiMaria Ugolini, contribuì a rendere più evidente l’importanza della stratificazionearcheologica durazzina fornendo nuovi e più puntuali dati.
Léon Rey, arrivato in Albania già nel , a Durrës si interessò anzitutto allemura, di cui proprio in quegli anni erano stati abbattuti alcuni tratti, a nord–ovest,nord–est e sud–est, e anche il Bastione Meridionale, nel quadro di interventi dirazionalizzazione urbanistica. Dagli smantellamenti era venuto un consistentegruppo di materiali epigrafici di varia epoca. Negli anni e l’archeologofrancese compì alcuni sondaggi nella città, nell’ambito delle attività della Missione.Di questo soggiorno durazzino furono frutto due articoli, il primo riguardante isondaggi condotti dal Rey nella città, il secondo dedicato alle mura.
. M , –.
. M , .
. R a; R b.
Archeologia urbana a Durrës
È interessante soffermarsi sul primo articolo, nella parte dedicata ai Sondages àDurazzo, perché attraverso la registrazione puntuale delle stratigrafie, esso forni-sce un quadro delle potenzialità dei bacini archeologici, in termini di profondità edensità dei materiali antropici, pur se con alcune incongruenze determinate dallanon corrispondenza fra testo e piante: nella pianta (Fig. ) i sondaggi sono sei,nel testo ne sono descritti sette. I dati non sono immediatamente utili per unconfronto con la situazione attuale, in quanto la carta fornita è troppo generica peruna localizzazione precisa dei rinvenimenti e fa riferimento ad una situazione urba-nistica assai diversa dall’attuale, sia per configurazione topografica che per quote. Iriferimenti topografici forniti dall’autore sono oggi scomparsi e ricostruibili solosu carte d’archivio, con molte incertezze per le numerose trasformazioni subitedalla città ottomana proprio in quegli anni; le quote delle strade e piazze sonosensibilmente diverse da quelle di un secolo fa a causa di interventi di spianamentoe rifacimento. Nonostante ciò, quei vecchi dati sono comunque interessanti perchéindicano significative differenze da zona a zona, corrispondenti a differenti situa-zioni di apporti colluviali e ad una morfologia ‘naturale’ dei pendii a quei tempiancora riconoscibile e danno conto con precisione delle sequenze stratigrafichedel bacino archeologico e della loro potenza. Inoltre, essi sono confrontabili conquelli forniti da alcuni recentissimi scavi di emergenza, più o meno nelle stessezone.
Nel suo testo, Rey parte dai risultati dei sondaggi di Praschniker nel (iln. in carta è la ‘bella di Durazzo’, che era stata riseppellita per conservarla e dicui si riafferma la profondità a - m, verificata nel successivo recupero e distacco,nel secondo dopoguerra) e di quelli condotti dal sindaco Paftali nel (n. in carta), che aveva rintracciato resti di abitazioni di cui la più antica ancora a -m di profondità, con materiali databili al IV sec. a.C., presso la strada principaled’ingresso alla città moderna, via (rruga) A. Goga. Rey descrive poi la serie disondaggi, da lui stesso condotti come Missione Francese. Nel saggio n. sulla carta,all’interno della città murata, presumibilmente nei pressi della moschea Fatih eaccanto alla casa che fu poi del celebre attore shakespeariano Alexander Moisiu, lasequenza stratigrafica rilevata dal Rey era la seguente: fra e -, m di profondità:macerie ottomane; fra -, e -, m: muri e base di una colonna appartenenti allachiesa bizantina che egli propone di riconoscere nella chiesa cattedrale di S. Nicola;a - m: due monete di Basilio II (X–XI sec. d.C.).
Il sondaggio è localizzato all’esterno della cinta muraria ottomana, a marginedella grande piazza e all’imboccatura della via verso Porto Romano, sul lato dellacollina, in una posizione certamente interessata da forti colluvi. In effetti, fra -,e - m di profondità il Rey intercettò un muro in filari di laterizi intervallati daspessi letti di malta bianca e dura, che l’A. non interpreta ma che dalla descrizione
. R a, –.
. Credo che ciò dipenda dal fatto che il sondaggio n. presenta strati (da a ), e la numerazione delsuccessivo saggio è diventata per errore .
. C, C .
. M , .
Sara Santoro
Fig. . Carta dei rinvenimenti archeologici di Durrës in R a.
sembra essere simile alla tecnica delle mura ‘bizantine’, datate fra la fine del V e laprima metà del VI sec. d.C.
Il successivo sondaggio, che reca il numero , si localizza bene sulla carta fornitada Rey, sia alla fig. che alla pianta delle mura, a p. della stessa rivista, in quantocondotto nella corte del Monopolio, lungo il muro del giardino della gendarmeria:siamo dunque fuori dalla cinta ottomana delle mura, sul lato ovest dell’attualepiazza principale della città, dove ora si trova la Prefettura. La sequenza stratigraficadel sondaggio riporta a -, m di profondità una tomba in lastre di pietra affioranteal livello di un pavimento di laterizi di una chiesa bizantina.
Il sondaggio n. è nel testo indicato come eseguito nella stessa strada, davantialla gendarmeria e di fronte alla moschea, quella vecchia e piccola, che stavasul lato nord della piazza e che fu sostituita dalla nuova, quella attuale, che erain quegli anni in costruzione e fu inaugurata nel . Questo sondaggio nonpuò quindi essere il n. della pianta, che è del tutto spostato verso est e verso lapalude. Il sondaggio n. intercettò un muro in mattoni che affiorava a livello delmarciapiede: si trattava dell’abside, orientata, tre volte rifatta, pertinente ad unedificio probabilmente cristiano, secondo il Rey lo stesso rintracciato nel sondaggioprecedente (e adiacente). Il pavimento si trovava a -, m, circa la stessa quota delsondaggio precedente. A -, m erano comunque due tombe in tegole e a -, muna base di colonna.
Archeologia urbana a Durrës
L’ultimo sondaggio, con il n. nel testo, forse identificabile con il n. della carta,riguarda un terreno, «lungo il muro sud della prefettura [di allora — n.d.r.]», in cuinel era stato scoperto il sarcofago di Meleagro. Lo scavo non produsse i risultatisperati. La sequenza stratigrafica era la seguente: da a -, m di profondità: terravegetale smossa; da -, a -, m: ceramica bizantina; a -,/-, m: tombe integole; a -, m e fino a -, (?) m: muro in pietre, intonacato sui due lati, posatosu strato di sabbia, vergine; da -, m compariva ceramica sigillata, romana. Illivello di falda in questo punto era -, metri.
In conclusione, il Rey fornisce alcuni dati medi di profondità della stratigrafiadell’area centrale (attuale piazza Liria) della città: fra e -, m terreno vegetale emateriali moderni; fra -, e -, m: strato bizantino; fra -, e - m: strato roma-no; a partire da - m: strato ellenistico, greco e suoli naturali. La gran profondità deilivelli più antichi è giustificata, dall’archeologo francese, sia dalla continuità di vitae quindi dai continui rifacimenti della città, sia dall’abbassamento del suolo e daifenomeni di colluvio dalla collina soprastante. Circa la diffusa presenza di tombealla cappuccina, ripetutamente trovate da lui stesso, da Paftali e da Praschniker, aprofondità differenti ( fra -, e -, m), giustamente il Rey attribuisce le differen-ze di quota alla lunghissima persistenza di questo modo di seppellimento, che vadall’epoca tardo imperiale all’età bizantina tarda (fino al XIV secolo, come si evincedall’affermazione del Rey circa la presenza in esse di ceramica che riconosciamodalle descrizioni come graffita tardo–medievale e rinascimentale).
Il passaggio di Luigi Maria Ugolini a Durrës nel suo primo e contrastato viaggioin Albania, nel , non fu altrettanto fruttuoso di dati: Ugolini fece alcune fotodelle mura di Durazzo, in località Porto Romano, a km a nord della città (quellegià ricordate da Ciriaco d’Ancona nel e nuovamente da Heuzey), foto che pub-blicò nel I volume di Albania Antica. Dopo questo ‘assaggio’, tuttavia, la missioneitaliana si focalizzò su altri obiettivi, Phoinike e poi Butrinto, città abbandonatee sepolte la cui riscoperta avrebbe dato notorietà e quindi impulso alle ricerche,con meno difficoltà tecniche rispetto allo scavo in una città a continuità di vita,come Durazzo, dove l’espansione edilizia, la profondità degli strati archeologiciantichi, le tensioni sociali interne all’area urbana e quelle diplomatiche dovute alleprecedenti indagini austriache e francesi pregiudicavano nuove ricerche.
Nonostante la suggestione esercitata dal suo essere stata il celeberrimo campo dibattaglia di Cesare e Pompeo e di Alessio I Comneno e Roberto il Guiscardo, Du-razzo non si prestava a ricerche sistematiche ed estensive. La città fu quindi esclusada progetti complessivi di indagine, tanto italiani quanto di altri paesi europei, e laconoscenza del suo passato rimase affidata all’occasionalità delle scoperte legateall’attività edilizia e agli scavi di emergenza. Fiorirono invece i progetti urbanistici,dovuti ad architetti italiani, in particolare l’imponente realizzazione del nuovoporto (–) e una serie di interventi nella città, assai mal documentati, checonfluirono poi nel nuovo Piano Regolatore Generale degli architetti L. Carmagna-ni e F. Poggi, del . Le trasformazioni radicali dell’immagine urbana che essi
. U a, , .
. ‘Piano Regolatore di Durazzo, relazione’, Tirana, luglio , manoscritto a firma di Leone Carmignani,
Sara Santoro
comportarono furono rese possibili anche dalle estese distruzioni provocate dalviolento terremoto che colpì la città il dicembre . Quanto di antico si salvòin quelle attività edilizie fu soprattutto materiale architettonico ed epigrafico,recuperato da vecchi edifici demoliti e raccolto in quello che poi diventerà, neldopoguerra, il Museo Archeologico della città.
Come scrive N. Ceka, in una acuta revisione dello sviluppo delle ricerche ar-cheologiche in Albania nel XX secolo, alla fine della Seconda guerra mondiale ilpatrimonio archeologico ereditato dalle spedizioni italiane e francesi che avevanooperato nella prima metà del Novecento era concentrato nelle tre città antichedi Phoinike, Apollonia e Butrinto, che non avevano avuto prosecuzione di vitaurbana dopo l’età tardo antica. Nei quarant’anni successivi, l’archeologia alba-nese si concentrò in modo efficace sugli insediamenti del retroterra illirico, conricognizioni sistematiche e scavi in numerosi centri urbani (Amantia, Byllis, Klos,Lissos, Antigoneia) e fortificazioni (Dimal, Belsh, Selcë, Zgërdhesh, Dorëz, Mar-gëlliç, Mashkjezë). Queste attività erano dettate dall’interesse per un nuovo temadi ricerca, quello della comparsa del fenomeno urbano in ambito illirico, lettotuttavia in chiave fortemente ideologica: riprendendo spunti già presenti neglistudi dei processi etnogenetici della prima metà del Novecento (soprattutto su baselinguistica), si enfatizzava la componente illirica autoctona a discapito degli apporticoloniali greci e romani. Nonostante questo, l’attenzione per ‘Durrës città–museo’non venne meno.
Come ha ricordato in questo convegno S. Gjongekaj, la struttura della tutelaarcheologica pubblica, facente capo inizialmente al Museo di Tirana (), poiall’Istituto Storico–Linguistico (), quindi al Centro di ricerca archeologica(), pur con mezzi molto limitati e con metodi non aggiornati, garantì unanotevole attenzione allo scavo ed al recupero delle testimonianze antiche. Permotivi ideologici, tuttavia, alcune epoche (in particolare l’età della dominazioneottomana e più in generale la fase medievale) erano ritenute poco o per nullainteressanti e dunque i materiali relativi erano scartati, per giungere rapidamente,nello scavo, alle fasi romana e greca. La situazione, ad essere sinceri, non era poimolto diversa da quella italiana: l’affermazione dell’archeologia postclassica è stataanche da noi molto tardiva rispetto all’Europa settentrionale e centrale.
La situazione della tutela della stratificazione archeologica urbana diventò dicolpo drammatica con la transizione alla democrazia, dopo il : l’improvvisaliberalizzazione e l’abolizione di numerosissime leggi e regolamenti urbanisticiportarono ad un vero e proprio boom edilizio, in gran parte di natura speculativa,in una situazione di sostanziale anarchia che colpì soprattutto Durrës, le cui attivitàportuali erano decollate molto rapidamente, contemporaneamente ad una nuovaondata di inurbamento, con una crescita esponenziale. La struttura della tutela,affidata nel all’Istituto di Archeologia, facente parte dell’Accademia delleScienze, composto da dipartimenti decentrati nelle principali città ma dotati di poco
architetto progettista, e di Ferdinando Poggi, architetto consulente, Archivio delle Costruzioni di Tirana.
. Vedi S .
. C , .
Archeologia urbana a Durrës
personale e scarsissimi mezzi tecnici, si trovò sopraffatta dalla quantità di ‘scavi diemergenza’ da realizzare, sia in città che nelle periferie. L’intrico di competenzecon l’Istituto dei Monumenti di Cultura, a cui spettavano i restauri delle strutturearcheologiche messe in luce e la loro valorizzazione, e con le autorità municipaliresponsabili delle concessioni edilizie fu abilmente sfruttato dagli speculatori perprocedere alle costruzioni con concessioni comunque ottenute, distruggendo unaquantità imponente di strutture antiche che gli scavi d’emergenza, realizzati incondizioni di estrema difficoltà, avevano tuttavia posto in luce. Si trattava peraltrodi scavi che, eliminando a pala meccanica gli strati dal contemporaneo all’etàmedievale, scendevano senza registrazione di dati fino all’età romana o addiritturagreca e si arrestavano solo in presenza di superfici continue (pavimenti) o strutturemurarie riconoscibili e significative. I materiali, accumulati senza alcuna distinzionestratigrafica, rappresentano tuttora un volume enorme, stivato nei depositi delmuseo, ormai privo di capacità informativa per la perdita dei contesti e delleinformazioni di scavo.
L’urgenza di provvedere ad una diversa gestione della tutela era comunquesentita, sollecitata e supportata anche dagli organismi internazionali operanti nellafase di post–emergenza del paese e diede luogo ad una nuova legge (la n. del..) che imponeva la verifica preventiva dell’interesse archeologico delle areeper le quali si richiedeva una concessione edilizia e che fossero poste all’internodelle zone definite a rischio archeologico. I costi per tali indagini preventive eranoa carico dell’imprenditore edile: per la prima volta, nella legislazione albanese,l’archeologia diventava un rischio imprenditoriale a fronte del quale, tuttavia, loStato attraverso i suoi organi specifici, e in particolare l’Istituto dei Monumentidi Cultura, si assumeva l’impegno di fornire le necessarie informazioni relativeal rischio stesso, realizzando per tutte le antiche città albanesi a continuità di vitadelle ‘carte del rischio archeologico’, sul modello di quanto era stato realizzato,appunto nel , nell’ambito del ‘Progetto Durrës’ e che riprendeva, a sua volta,l’esperienza delle carte del rischio archeologico italiane ed europee. Si integrava intal modo la pianificazione urbanistica, di competenza degli Enti locali, con la tuteladel patrimonio archeologico, culturale ed ambientale, di competenza dello Stato.Lo scopo era quello di coniugare la salvaguardia del patrimonio della collettivitàcon le esigenze di sviluppo di quella stessa comunità.
. La Carta del Rischio Archeologico di Durrës
La zonizzazione a scopo di tutela aveva avuto un precedente illustre, a Durrës, allafine degli scorsi anni Ottanta in un articolo di A. Baçe, che con acuta sensibilitàavvertiva l’estremo pericolo che minacciava lo straordinario ‘museo sepolto’ dellacittà e proponeva una serie di provvedimenti, anche legislativi, per la sua tutela.Nel tumultuoso periodo di transizione alla democrazia e alla liberalizzazione
. B . Un’ulteriore definizione di questa zonizzazione a scopo di tutela, cercandone l’avallo sulla basedi indagini geoelettriche, è in K, A .
Sara Santoro
economica quella proposta non aveva avuto seguito, ma quindici anni dopo, fa-cendosi sempre più urgente l’esigenza di regolamentare lo sviluppo edilizio checoinvolgeva il centro storico della città, un’azione di cooperazione internazionaledecentrata svolta da UNOPS PASARP Durrës, Università di Parma, Musei Civicidi Udine e Dipartimento di Archeologia di Durrës (DAD), denominata ‘Proget-to Durrës’, aveva ripreso quell’obiettivo progettando e realizzando la Carta delRischio Archeologico (CRA) dell’area urbana centrale.
Il ‘Progetto Durrës’ partiva dall’esigenza di una conoscenza migliore, quan-titativa e qualitativa, del patrimonio archeologico della città, come strumentoindispensabile alla sua tutela. I numerosi scavi e le scoperte occasionali in queglianni di sviluppo economico ed edilizio incontrollato erano tutti nati dall’emer-genza, non da un’attività di ricerca programmata né da un protocollo di diagnosipreventiva del rischio archeologico sistematicamente applicato. La situazione digrave carenza di mezzi tecnici in cui scavi e scoperte si erano svolti aveva portatoa non documentare sufficientemente quanto trovato: moltissimo restava affidatoalla memoria dei protagonisti di quelle scoperte, in una situazione estremamenterischiosa di conservazione dei dati. Non era stato possibile mettere in relazione lestrutture ridisegnando una planimetria urbana che ne consentisse la comprensioneattraverso le relazioni reciproche, costruendo una visione organica della città anticae permettendo quindi una qualche previsionalità del rischio archeologico. Anche imonumenti già posti in luce erano minacciati dalle nuove costruzioni e soffocatida queste, senza aree di rispetto che ne consentissero una valorizzazione e unafruizione pubblica, con grave pregiudizio delle possibili vocazioni turistiche dellacittà.
La Carta del Rischio Archeologico si proponeva, quindi, di raccogliere tuttele informazioni disponibili relative ai rinvenimenti nell’area urbana, vagliarnel’attendibilità, provvedere a localizzarli con precisione e a catalogarli, rendendoquindi le informazioni disponibili ad amministratori e imprenditori, elaborandoconcretamente una proposta di gradazione dei provvedimenti di tutela preventivaed esercitando contestualmente una forte pressione, tramite le agenzie interna-zionali e un’opinione pubblica opportunamente sensibilizzata, affinché fosseroadottate le misure legislative necessarie per attuarla.
Le esigenze di tutela e di programmazione urbanistica prevalevano dunquesu quelle propriamente scientifiche. Pertanto, la Carta del Rischio Archeologico,realizzata su piattaforma GIS e redatta nelle due lingue, italiano ed albanese (nellaversione del ), era dotata di schede di catalogazione dei rinvenimenti (la partepiù propriamente archeologica) molto sintetiche ma con riferimenti bibliografici edocumentali che giustificavano le proposte di tutela. Essa era concepita anzitutto
. United Nation Office for Project Service (http://www.unops.org) è un’agenzia delle Nazioni Uniteche opera con progetti diretti allo sviluppo umano. In Albania ha gestito il progetto ‘PASARP’ (Programme ofActivities in Support of Albanian Regions and Prefectures) nelle regioni di Durrës (Durazzo), Shkodër (Scutari)e Vlorë (Valona). Il progetto ‘PASARP’, un programma ponte fra l’emergenza e lo sviluppo, è stato finanziatodal Ministero degli Affari Esteri italiano attraverso fondi per la cooperazione internazionale e da alcune Regioninell’ambito della cooperazione decentrata.
. Sui concetti–chiave e il quadro istituzionale del ‘Progetto Durrës’ vedi B .
Archeologia urbana a Durrës
come strumento di gestione urbanistica per gli amministratori della città e comestrumento di conoscenza e informazione per gli imprenditori edili, perché fosseroconsapevoli dei rischi che affrontavano intraprendendo costruzioni soprattutto nelcentro storico della città. (Figg. e )
Fig. . Carta dei rinvenimenti archeologici di Durrës (CRA ).
In linea generale, una carta del rischio archeologico deve registrare e docu-mentare con rigore scientifico la collocazione, profondità, ingombro e natura dellestrutture archeologiche intercettate nel tempo. Essa è qualcosa di più di un ordinato
Sara Santoro
ed esaustivo catasto dei ritrovamenti archeologici, che è pure una delle funzioniprincipali della cartografia archeologica. Può infatti valutare le potenzialità di que-sto ‘archivio sotterraneo’ anche attraverso elaborazioni previsionali, fondate sullaprevedibilità dei comportamenti insediativi in ambienti determinati, sulla strutturae densità abitativa e sulla sequenza stratigrafica. Quest’ultimo aspetto non è statosviluppato nelle edizioni del e del e nei suoi successivi aggiornamenti,bastando a definire le aree di rischio le numerosissime attestazioni di struttureeffettivamente intercettate. Per l’emissione del vincolo, infatti, occorre la concretaindividuazione del bene da preservare, non la presunzione della sua esistenza. Gliaspetti previsionali e le riflessioni ed elaborazioni di carattere più propriamentestorico–archeologico finalizzate ad una conoscenza più compiuta e organica deldivenire storico dell’abitato, furono dunque rinviate ad un momento successivo dielaborazione scientifica.
Realizzata nel corso del , consegnata nel febbraio , pubblicata in linguaitaliana con un’ampia premessa metodologica nel , la Carta del RischioArcheologico di Durrës è stata aggiornata con le nuove scoperte fino al ,quando il Dipartimento di Archeologia di Durrës fu sciolto nell’ambito dellariforma degli organi di tutela albanesi che ha creato un’apposita agenzia di ricercaarcheologica (ASA: Archaeological Service Agency), dipendente dal Ministerodella Cultura (MTKRS) e dal National Council of Archaeology, separando questaattività da quella di ricerca realizzata da scavi programmati che resta invece affidataall’Istituto Nazionale di Archeologia, a sua volta scorporato dall’Accademia delleScienze e divenuto ora parte del Centro di Studi Albanologici.
In quello stesso anno la Carta del Rischio Archeologico è stata interamenterecepita nel Master Plan dell’area centrale urbana, redatto da una équipe italo–albanese vincitrice di un concorso internazionale, di cui costituisce la tav. e ilrelativo quaderno (Fig. ). Il nuovo piano regolatore dell’area centrale di Durrësassume non solo le proposte di tutela della Carta ma anche quelle di valorizzazioneattraverso percorsi turistico–culturali attrezzati che si snodano nella città. Infine, unestratto della Carta con le ultime integrazioni ad essa apportate, relativo a piazzaLiria, cioè la piazza centrale della città, è stata fra i documenti preliminari forniti nelconcorso internazionale di architettura per la rivitalizzazione della piazza stessa.
. CRA .
. CRA ; S, M .
. ‘Plan for the Central Area of the town of Durrës’, approvato dal Territory Adjusting Council of theAlbania Republic il .., team leader prof. Piero Rovigatti.
. International Competition ‘Revitalization Liria Square’, promossa da INARCH e dal Forum delle cittàadriatico–ioniche, indetta dall’Amministrazione municipale di Durrës e svolta fra giugno e gennaio , percui vedi R , in part. –.
Archeologia urbana a Durrës
Fig. . Carta dei livelli di rischio archeologico sulla base del potenziale informativo (CRA ).
Archeologia urbana a Durrës
Fin dalla sua prima configurazione, la Carta del Rischio Archeologico dell’areaurbana centrale di Durrës registra e documenta i rinvenimenti archeologici distrutture e stratigrafie (escludendo quindi i soli reperti mobili) sulla base dellabibliografia, albanese e internazionale, della documentazione d’archivio del Dipar-timento di Archeologia di Durrës e degli archivi personali e delle testimonianzedei collaboratori (in particolare, A. Hoti ed E. Shehi), delle fotografie dell’archiviostorico aerofotografico dell’Istituto Geografico Militare di Firenze (voli e). Il Dipartimento di Archeologia di Durrës era garante della correttezza edesaustività della propria documentazione. La valutazione dei dati è stata condottain collaborazione fra il Dipartimento stesso e l’Università di Parma.
Il posizionamento e l’indicazione degli ingombri è stato fatto sulla carta cata-stale in scala :, nel più recente aggiornamento utilizzabile in quel momentoe risalente agli anni Novanta, fornita dal Municipio di Durrës, che ne garantival’accuratezza. Ulteriori misure e rilievi topografici sono stati condotti dai tecniciitaliani e integrati nella carta, georeferenziati e posizionati anche sulla fotografiaaerea. L’impianto scientifico della carta, il coordinamento e la progettazione delsistema informativo sono stati realizzati dagli operatori dell’Università di Parma (S.Santoro, A. Monti). La carta integra, per l’area urbana, la ricognizione sistematicadi superficie condotta nella sola area collinare fra la città e Porto Romano nel – dall’International Center of Albanian Archaeology di Tirana, avvalendosidi un pool di studiosi anglo–americani e albanesi delle università di Cambridge,Cincinnati, Tirana, con il sostegno del Packard Humanities Institute. La Cartafornisce, infine, valutazioni sul rischio e sulle potenzialità delle risorse archeologi-che della città. Propone di conseguenza provvedimenti di tutela opportunamentegraduati, secondo un concetto qualitativo oltre che quantitativo.
Nella sua attuale configurazione, la Carta (indicata d’ora in avanti con la siglaCRA), si è trasformata da strumento di gestione e programmazione a strumentodi ricerca, di interpretazione della storia urbanistica e di previsione del rischioarcheologico. Attraverso l’ implementazione dei dati tratti dalla lettura geomor-fologica e geoarcheologica delle stratigrafie, la Carta oggi permette non solo dieffettuare previsioni di rischio notevolmente più affidabili, ma anche di potenziarela conoscenza delle trasformazioni morfologiche intervenute attraverso i secoli,causate dai terremoti e bradisismi, da variazioni di livello del mare, dal dissestodei versanti della collina sovrastante la città: queste trasformazioni nei duemilae settecento anni di storia urbana sono state molto rilevanti e una loro miglioreconoscenza consentirà una progettazione edilizia più adeguata alla prevenzionedei rovinosi effetti delle catastrofi naturali, a cui la città è andata soggetta più voltenel corso della sua lunga storia. Da un punto di vista tecnico, inoltre, l’intera archi-tettura della piattaforma GIS si è trasformata, passando da un sistema basato sullapredominanza di livelli informativi raster bidimensionali ad un sistema vettorialee tridimensionale. Lo scopo è quello di realizzare un modello tridimensionale
. D et alii .
. In corso di stampa, è aggiornata al ; mancano tuttavia i più recenti rinvenimenti operati dallaArchaeological Service Agency.
Sara Santoro
della città antica e delle sue trasformazioni nel tempo, correlando le evidenzearcheologiche e quelle ambientali.
. Le trasformazioni della città e la complessità dei depositi archeologici ur-bani di Durrës
Uno dei più affascinanti e attuali temi di ricerca è la trasformazione delle cittànel tempo: in esso si condensano gli aspetti della modificazione del clima e del-l’ambiente, oggi così urgenti e sentiti, e dell’evoluzione delle economie, dellesocietà, dei comportamenti, dei modi dell’abitare e di sfruttare il territorio e lesue potenzialità. Declinata in tal senso, la ricerca archeologica costituisce la baseconoscitiva per la programmazione urbanistica, il controllo ambientale, il turismoculturale, che sono le chiavi di uno sviluppo sostenibile nel tempo. La disciplinache affronta specificamente la trasformazione della città nel tempo è l’archeologiaurbana, con i suoi concetti–chiave e i suoi metodi specifici.
Nella definizione corrente, l’archeologia urbana è una ricerca archeologicaglobale su una città tuttora esistente (e nel nostro caso anche tuttora abitata),ossia che si rivolge all’intera sequenza insediativa a partire dalla fondazione fino ainostri giorni, senza privilegiare un periodo rispetto a un altro o un’evidenza piùmonumentale rispetto ad uno strato di sola frequentazione. Essa utilizza molteplicifonti informative e ogni tipo di indagine diagnostica geofisica utile e interpretabilearcheologicamente; il suo specifico strumento d’indagine è comunque lo scavostratigrafico.
Nata nella Londra del dopoguerra, in occasione della ricostruzione dei quartieribombardati, l’archeologia urbana ha per oggetto i depositi urbani pluristratificati,per indagare i quali si avvale oggi di tecniche di indagine sistematica. In particolare,essa affronta due problemi centrali: la complessità di questi depositi e le dinamiche,antropiche e naturali, dei loro processi di formazione. Ciò si traduce in un’analisiparticolarmente accurata delle sequenze stratigrafiche verticali, in termini di po-tenza, e dei contesti, in termini di caratterizzazione geoarcheologica della matricee cronotipologica dei materiali e delle strutture. Questa dimensione verticale siassocia alla determinazione tridimensionale degli ingombri delle strutture e allavalutazione dell’estensione orizzontale dell’insediamento che ne risulta, articolataper fasi (complessi di azioni collegate da rapporti, in un lasso di tempo).
È evidente che in questa dimensione diacronica tutte le fasi sono fondamentali,e in particolare quelle un tempo trascurate dall’archeologia tradizionale, cioèquelle post–classiche nelle quali la città antica si è trasformata fino alla sua formaattuale, attraverso processi di sedimentazione causati da vari fattori, sia naturaliche antropici, caratterizzati da differenti velocità. Accanto all’indagine sui bacinideposizionali, l’archeologia urbana considera anche, nelle dinamiche di evoluzioneurbanistica, la conservazione selettiva di monumenti antichi rimasti in alzato,
. Utilizzo qui, modificandola un poco, la definizione data da B .
Archeologia urbana a Durrës
attraverso il loro riuso e rifunzionalizzazione, e la riproposizione di percorsi eparcellizzazioni antiche anche se con modificazione delle funzioni (calchi urbani).
Come le altre forme di ricerca archeologica, anche l’archeologia urbana utilizzaun ampio ventaglio di fonti combinate fra loro, da quelle archivistiche alle tecnichediagnostiche geofisiche di cui valuta di volta in volta la differente efficacia in rap-porto alla situazione urbana, fino allo scavo programmato di siti campione. Unostrumento essenziale di questo tipo di ricerca è costituito dalla cartografia tematica:del rischio archeologico, che come abbiamo visto nel caso della CRA di Durrës do-cumenta i depositi conservati; degli spessori dei depositi, che è fondamentale nellavalutazione d’impatto delle attività edilizie attuali e di cui possiamo considerare unprecedente l’articolo sopra ricordato e commentato di L. Rey; delle potenzialitàarcheologiche dei depositi, che ha invece scopo predittivo e si costruisce sulla basedi altri tematismi, sia ambientali, come le pendenze, le insolazioni, la ventositàe la prossimità idrica, che antropici, come le vocazioni funzionali delle aree e lestrategie insediative per periodo, estese non solo all’area urbana, ma all’interoterritorio.
È evidente, infatti, che per comprendere una città, soprattutto quando si trattidi una città che ha avuto successo nel tempo, essendo ancor oggi abitata, occorreconoscerne il territorio di riferimento. Ciò determina una moltiplicazione di datiambientali, storici, archeologici, non tutti graficizzabili e documentabili allo stessomodo e nello stesso dettaglio, oggi gestibili nella loro forma differenziata dallepiattaforme GIS di ultima generazione. Relativamente a Durrës, area centrale, èquanto sta già facendo da alcuni anni la Missione Archeologica Italiana, erede del‘Progetto Durrës’ e operativa dal , proponendosi di estendere in un futuro assaiprossimo questo sistema informativo all’intero territorio dell’antico municipium.
In una strategia di ricerca adeguata alla conoscenza e comprensione di un’interacittà a continuità di vita, fra le fonti informative rientrano certamente anche gli scaviarcheologici, sia quelli estensivi che le differenti forme di indagine a campione,come le trincee e i carotaggi, integrati dai dati recuperati degli scavi di emergenza,assimilabili a campionature casuali.
. Stratigrafie dagli scavi di emergenza e preventivi
Fra e , l’équipe italiana si è trovata ad affiancare occasionalmente ilDipartimento di Archeologia di Durrës (DAD) in alcuni scavi di emergenza parti-colarmente complessi, nei quali ha messo a disposizione dei colleghi albanesi leproprie strumentazioni e competenze. In alcuni di questi casi, la sequenza strati-grafica rilevata è confrontabile con le sequenze indicate dal Rey nell’articolo sopracitato nei sondaggi e .
Il primo sito (sito CRA) si trova nel quartiere n. , in una situazione mor-fologica pianeggiante pienamente urbana, nell’area Ex–cinema Iliria, compresafra le due principali strade della città che confluiscono verso la piazza centrale
. Vedi CRA , n. .
Sara Santoro
(piazza Liria) e cioè via A. Goga (a ovest) e Bulevardi Kryesor (a est). Gli scavid’emergenza, condotti dal Dipartimento di Archeologia di Durrës sotto la direzio-ne del prof. A. Hoti, si sono svolti nel su una superficie di m e hannomesso in luce una situazione pluristratificata, comprendente pozzi e muri di etàottomana, tombe alto–medievali, un complesso monumentale tardo–antico estrutture murarie di età romana (Fig. ). Le strutture rimesse in luce sono statesuccessivamente coperte e distrutte dalla costruzione dell’edificio residenziale apiù piani che era stato programmato.
Ad una fase inquadrabile all’età ottomana (XVII–XIX sec. d.C.) appartenevanodue setti murari a corsi irregolari di pietrame di varia dimensione, quasi privo dilegante, a una profondità di -, m dal piano di calpestio.
La fase più evidente per il suo aspetto monumentale si trovava alla profonditàdi -,/-, m dal piano di calpestio attuale ed era costituita da una porzione diuna grandissima abside con una curvatura molto aperta (m di corda ricostrui-bile), appartenente ad un grandioso edificio, e da quattro setti murari affiancatiall’abside. Era riconoscibile un peribolo o corridoio interno che definiva un set-tore centrale pavimentato in lastre rettangolari, marmoree o di calcare, di cui erarimasta l’impronta ma che erano state interamente asportate in antico. La tecnicaedilizia dei muri era in opera laterizia a corsi orizzontali legati con alti letti dimalta contenente abbondanti frustuli laterizi. Le strutture proseguivano oltre illimite di scavo. Particolarmente interessante era il punto di congiunzione fra laparte curvilinea dell’edificio e il muro rettilineo che la chiudeva, realizzata comescala a chiocciola che sale attorno ad un possente pilastro, simile per concezionearchitettonica alle torri della facciata della Basilica di S. Vitale a Ravenna (a cuisomiglia anche nella tecnica edilizia) e a un ninfeo dal Palazzo di Galerio a Tessa-lonica. In base alla tecnica edilizia e alla morfologia di alcuni elementi scultorei didecorazione architettonica (capitelli, capitelli d’imposta) riteniamo che si trattassedei resti di un edificio monumentale, pubblico piuttosto che di culto cristiano(ingresso monumentale di un palazzo residenziale ufficiale?), degli inizi del VI sec.d.C., riferibile cioè a quell’età giustinianea che sembra particolarmente ricca direalizzazioni nella città adriatica.
Muri più tardi, caratterizzati da una tecnica edilizia che fa ampio uso di materialedi recupero legato con cattiva malta, si erano appoggiati a questo edificio. Sul livellopavimentale dell’edificio absidato e poco più sopra, erano tombe alla cappuccinaorientate E–O, senza oggetti di corredo, che proseguivano anche oltre i limitiimposti dallo scavo. I materiali ceramici riferibili a questo livello appartengono aisecoli VII–X d.C.
Esternamente all’abside, a m di profondità rispetto alla rasatura del muro e a-, m dal piano stradale, furono messi in luce resti murari in laterizi legati conmalta di un ambiente o cortile pavimentato in lastre di marmo o calcare e riferibileall’età romana medio imperiale. Sul pavimento poggiava una grande statua inmarmo pentelico, acefala, di dimensioni superiori al naturale, che rappresentauna dea seduta su un trono, in grembo alla quale sono assisi due genietti informe infantili e vari frutti dal significato simbolico (melograni, uva, capsule dipapavero); sui braccioli del trono sono assisi due eroti in miniatura, recanti una
Archeologia urbana a Durrës
Fig. . Sito : ex cinema Iliria: localizzazione su foto satellitare (www.googlemap) e su CRA ;panoramica della prima estensione dello scavo, in cui si nota la porzione della grande abside; statuadi Tellus; rilievo planimetrico finale delle strutture.
Sara Santoro
cornucopia ciascuno. La parte posteriore della statua è piatta e non rifinita, per unacollocazione contro una parete. Si tratta di un’eccezionale versione tridimensionaledell’iconografia della Tellus dell’Ara Pacis. Alcuni dettagli della lavorazione edelementi stilistici suggeriscono una datazione agli inizi del II sec. d.C., in quella etàtraianea che pure fu un momento di grande sviluppo della città. Considerato cheil blocco marmoreo della scultura nella parte inferiore, quella del basamento dellafigura, è irregolare, è probabile che la posizione in cui la statua è stata trovata nonsia quella originale ma appartenga ad una ricollocazione. Ulteriori indagini per lacomprensione della natura di questo importante contesto sono state impossibiliper l’affioramento dell’acqua di falda, incontenibile con i mezzi a disposizione.Tuttavia si è potuto raccogliere un insieme limitato di materiali ceramici, che sonostati riconosciuti e confermano le datazioni sopra indicate.
Un secondo sito dalla stratigrafia complessa (sito di CRA), rilevata dallaéquipe italiana, si trova in via (rruga) H. Troplini, nelle immediate adiacenze ( m)a est della piazza principale (piazza Liria), verso mare, subito fuori dalla linea dellemura ottomane (Fig. ) Si tratta di un’area pluristratificata con strutture pertinentiad una torre farea di età tardo–classica, magazzini e banchine portuali di età tardo–ellenistica e romana, una canalizzazione di età imperiale di grandi dimensioni,pavimentazioni pertinenti forse ad un balneum e sepolture di età alto–medievale.Le strutture proseguono oltre l’area del cantiere. Lo scavo di emergenza, condottonel dal Dipartimento di Archeologia di Durrës sotto la direzione del prof.A. Hoti, era ampio m e ha raggiunto i m , di profondità senza arrivare alvergine, in presenza della falda già -, metri.
Sotto l’attuale manto stradale, nel lato sud dell’area di scavo, una fitta serie diriporti alternati a piani d’uso di epoca post–medievale (fino a una profondità di -m), e medievale (fino a -, m) coprivano una serie di sepolture alto–medievalidi VII–VIII secolo d.C. Alcune di queste poggiavano, e altre tagliavano, una pavi-mentazione in lastre di calcare rosato (a una profondità di -,/-, m) riferibileal periodo tardo–antico (V–VI secolo d.C.) e pertinente al balneum.
Le sottostanti strutture edilizie erano variamente interrelate fra loro; quelle amaggior profondità sono le pavimentazioni in lastre di terracotta dei magazzinitardo–ellenistici (II–I sec. a.C.), a quota -, metri. La base della torre farea prose-gue ulteriormente in profondità, ma non si è giunti al suo spiccato. La presenza dibanchine e moli, del faro e dei magazzini, si giustifica con la vicinanza del battentemarino antico, oggi distante circa m, e con la particolare natura del porto diDurrës: quest’ultimo ancora alla fine del XIX secolo era caratterizzato da fondalibassi, con necessità di ancorare al largo le navi e di scaricare le merci con barchinipiatti che potevano risalire i canali, con un sistema diffuso in antico in molti portidelle coste sabbiose dell’Adriatico, come Ravenna e Aquileia.
Quanto alla linea di costa, essa è stata soggetta a oscillazioni dovute al diversocombinarsi di vari fattori: in generale un diffuso fenomeno di regressione marinadella costa albanese settentrionale rispetto all’antichità e un fenomeno di progressi-
. Per Tellus, G . Per l’identificazione del soggetto e la proposta di datazione, S c. s.
. Per una descrizione e interpretazione delle strutture individuate, vedi S, S, H .
Archeologia urbana a Durrës
Fig. . Sito : via (rruga) H. Troplini: localizzazione su foto satellitare (www.googlemap) e suCRA ; rilievo planimetrico finale delle strutture (elab. B. Sassi) e panoramica.
va subsidenza, ma con fasi alterne, ipotizzato per la parte centrale del graben e chesarebbe all’origine della laguna e delle oscillazioni della sua ampiezza. I forti appor-ti colluviali dal disfacimento del plesso collinare soprattutto dall’età tardo–antica ealto–medievale, accentuati da alcuni catastrofici eventi sismici, hanno sicuramenteallontanato la linea di costa in alcuni tratti urbani, fra cui questo dove si trovavauno dei fari di questo celebre porto antico.
Sara Santoro
Fra gli scavi di emergenza più recenti condotti dal Dipartimento di Archeologiadi Durrës riveste particolare importanza, ai nostri scopi, quello eseguito fra e in via A. Goga (nn. e di CRA), nel quartiere n. , poco più a norddel sito di rinvenimento della statua di Tellus sopra ricordato. Gli scavi archeolo-gici, diretti dal prof. A. Hoti con la collaborazione dei drr. A. Anastasi e E. Shehi,hanno interessato, in due tempi, un’area complessiva di m, raggiungendola profondità di -, m (Fig. ). Essi hanno posto in luce i resti di un edificio dietà arcaico–classica, che ha subito molteplici trasformazioni nel tempo, compren-dendo, in età ellenistica, anche attività produttive (coroplastica) fino a diventare,in età romana una vera e propria insula . Le quote degli strati riferibili all’etàarcaica e proto–classica sono molto profonde (-, m) e sono state raggiuntesolo perché, fortunosamente, in quest’area la falda era, al momento degli scavi,assai più bassa che nel resto della città. Ciò indica una situazione di circolazionedelle acque sotterranee diversificata da zona a zona anche nella pianura, come delresto c’è da attendersi in una città posta ai piedi di un plesso collinare di naturaprevalentemente argillosa. Uno strato di combustione, a -, m, chiudeva questafase. Le strutture furono riutilizzate nella fase successiva, propriamente classica,aggregando ad esse nuovi ambienti; in quella proto–ellenistica i vecchi muri furonosoprelevati con mattoni legati con argilla, tecnica questa ampiamente utilizzata nelperiodo.
Questo riutilizzo di murature precedenti, che denota il conservatorismo degliassetti e degli orientamenti del primo impianto urbano, è un fenomeno riscontratoin numerosi altri casi in città. Dalle unità stratigrafiche di questo periodo proto–ellenistico proviene un ricco materiale numismatico, la maggior parte del qualedi zecca durazzina. Il ritrovamento di un tesoro di monete d’argento, del tipo‘Eracle–Pegaso’ con legenda ΔΥ e ΔΥΡ, indicate come una produzione della finedel IV sec. a.C. (– a.C.), associate a stateri d’argento di Alessandro Magno,dedicati al padre Filippo II, indica l’alto rango degli abitanti di questo edificio chesi trovava, d’altra parte, nello stesso quartiere della casa in cui il già menzionato,bellissimo mosaico di ciottoli detto ‘la bella di Durazzo’ decorava un ambientecurvilineo o forse una vasca. Il mosaico si trovava, come si ricorderà, a -, m diprofondità, mentre qui il livello corrispondente stava a -, m dal piano di calpestio.La lunga fase successiva di vita del complesso comprende poi l’età romana, nellaquale i vari edifici precedenti sembrano aggregarsi in una grande insula. Un piccolomosaico a meandro in bianco e nero, databile alla metà del I sec. d.C. si trova ad unaquota di -, m dal piano di calpestio. La distruzione di questo edificio, segnalatadal crollo degli intonaci dipinti con motivi a Tapetenmunster, sembra da collocarsientro la metà del IV sec. d.C., stando ai materiali ceramici rinvenuti, e potrebbequindi essere riferibile ai vasti danni del terremoto del d.C., noto appuntocome ‘terremoto di Durazzo’. Ulteriori crolli e riporti in alcuni vani, contenenti
. S , .
. C, C .
. La sistematica raccolta di dati, letterari e scientifici, relativi agli antichi terremoti, di G ; G-, C, T ; G, C ha permesso di stilare una sequenza sufficientemente
Archeologia urbana a Durrës
Fig. . Sito : via (rruga) A. Goga: panoramica dello scavo.
fra l’altro due spathèia completi e venticinque colli, datati al primo venticinquenniodel V sec. d.C., sono forse da riferirsi alla violenta conquista della città da partedegli Ostrogoti, nel d.C. Successivamente a tali eventi, alcune strutture furonoaggiunte nell’area a margine dell’edificio più antico. Esse si trovano a , m aldisopra del livello romano ma non hanno restituito materiali datanti. Una serie disepolture alto–medievali, in gran parte alla cappuccina e alcune in nuda terra, sonostate identificate fra i -, e i -, m di profondità. Il sondaggio n. di L. Rey, unpoco più a est ma non molto distante da questo sito, segnalava le tombe bizantine
attendibile di sismi che hanno interessato la città: – a.C. (P., Cic. .): terremoto e maremoto; / o (evento riferito anche al o ; E., Hieron. chron. .–): noto come ‘terremoto di Durazzo’; /
(evento riferito anche al o ; M. –; T. .–; C. ); (evento riferito anche al/ e ); ; dicembre ; aprile .
Sara Santoro
a -, m di profondità e la comparsa di ceramica romana a -, m, la falda a -,metri.
Stando alle non molte notizie fin qui rese pubbliche, un’importante sequenzastratigrafica è stata rilevata dagli scavi preventivi realizzati nell’area ex SIP e XHEMFltd, compresa fra Lagjia , piazza (sheshi) Demokracia, via (rruga) P. Meksi, pocopiù a nord rispetto al sito sopra citato, e incluso infatti nell’area B della zonizzazionearcheologica. Gli scavi, realizzati fra e dall’impresa A.K.Er. ltd. sotto lasupervisione della Archaeological Service Agency, hanno riguardato un’ampia areadi quasi m. Il primo dato importante fornito da questi scavi, che hanno postoin luce strutture di età bizantina, romana, greca e anche livelli precoloniali, è chela città ellenistico–romana si estendeva fin qui ed anzi questo era un quartieredensamente popolato, di carattere fortemente artigianale. Si tratta dunque di undato importante dal punto di vista urbanistico– topografico. L’area è interessatada un incrocio di strade di età romana, di cui la principale con direzione nordest–sudovest, pavimentata in pietre e larga almeno metri. Non dovrebbe trattarsipropriamente della via Egnatia, quanto piuttosto di un asse parallelo a questa. Lasede stradale è fiancheggiata da canalizzazioni e, almeno in alcuni tratti, da porticicolonnati. L’impianto della rete stradale e delle canalizzazioni dovrebbe risalireall’età tardo–ellenistica.
Il quartiere sembra improntato ad un carattere fortemente commerciale e arti-gianale: gli edifici che affacciano su questo asse stradale appartengono alla tipologiadelle case–bottega, con lo spazio commerciale ad accesso diretto dalla strada, l’areadi lavoro nello spazio retrostante e l’abitazione vera e propria al primo piano. Sottoquesto quartiere databile all’età augustea, sono stati trovati edifici delle fasi prece-denti, addirittura precoloniali, fondati su palificazioni, a - m di profondità. Unaltro dato importante dal punto di vista stratigrafico, inoltre, è che dell’età bizantinasi sono trovate solo fondazioni, a circa -, m di profondità, ed esse avrebberorasato le pavimentazioni di età romana: sembrerebbe dunque che quest’area nonsia stata soggetta agli imponenti depositi di colluvio riscontrati nell’area centrale,precedentemente esaminata, almeno in età postclassica. Si attende dunque conmolto interesse la pubblicazione scientifica dei dati di un così vasto quartiere.
Altri scavi di emergenza condotti dal Dipartimento di Archeologia di Durrës, acui l’équipe della Missione Archeologica Italiana ha prestato assistenza, localizzatiin aree particolari, per assetto naturale (pendici collinari, margini della laguna) ofunzione (aree funerarie), sono ugualmente interessanti per il nostro assunto relati-vo alla potenza e complessità delle stratigrafie dell’antica città, in quanto fornisconodati relativi alle trasformazioni geomorfologiche, da un lato, e al conservatorismofunzionale, dall’altro.
Dal punto di vista geomorfologico, la città storica attuale, e quella antica al disotto di essa, si colloca parzialmente sulle pendici del versante orientale del lungoplesso collinare orientato nord–sud che contraddistingue questa ‘quasi penisola’ esoprattutto ai piedi di essa, fra la collina e la costa. La linea di questa è sicuramentediversa, oggi, rispetto alla situazione antica a causa di cospicui fenomeni naturali di
. Prokop Meksi .
Archeologia urbana a Durrës
apporto colluviale e antropici di regolarizzazione e attrezzatura del porto, questiultimi nell’ultimo secolo. Il versante orientale è modellato da una serie di bacini idri-ci, orientati est–ovest con drenaggio verso est, all’interno dei quali si accumulanodepositi di colluvio superficiale potenti fino a – metri. I colluvi sono intercalatida suoli sepolti brunastri, che testimoniano momenti di stabilità dei versanti. Ilversante meridionale (tra Villa Zog e il sito di cui si parlerà subito sotto) èinteressato invece da frane caratterizzate da nicchie di distacco con morfologia adarco aperto verso la linea di costa ed elevate pendenze nella parte alta.
In via (rruga) Durrsaku, nell’immediata pendice orientale della collina prospi-ciente il mare, la cosiddetta ‘acropoli’, a q. (sito CRA), nel uno scavoesteso su circa m ha rivelato un’area funeraria terrazzata (Fig. ), attraversatada una via processionale di prima età ellenistica che conduce ad un monumentorettangolare, probabilmente del tipo a naìskos; l’area risulta definita da un grossomuro perpendicolare alla via processionale, lungo cui corre un’altra strada ad an-damento nord–sud. Da questa Grabenterrasse provengono, a una profondità di -,m dal piano di calpestio, terrecotte architettoniche di stile corinzio, con inusualiinserti vetrosi, pertinenti probabilmente ad un tempio posto a quota superiore,databili al secondo quarto del VI sec. a.C. La vocazione funeraria del sito proseguein età romana, con una serie di tombe a camera in laterizio, databili fra I e IIIsec. d.C., nonostante un’interruzione e risistemazione dell’area avvenuta agli inizidell’età romana (II–I sec. a.C.). Tutta l’area collinare meridionale fu sede di piccolenecropoli di età romana imperiale e anche tardo–antica e alto–medievale.
Fig. . Sito : via (rruga) Durrsaku: panoramica dello scavo.
In via (rruga) S. Efendiu (sito CRA), nel quartiere n. , sulle prime pendicicollinari volte verso est, un altro scavo di emergenza condotto su un’area ampia m, a circa -, m di profondità, ha individuato una porzione di un cortile oandròn (, x , m) dotato di una cisterna, pertinente ad un edificio residenziale,
Sara Santoro
probabilmente disposto su terrazze (Fig. ). La pavimentazione messa in luceera articolata in differenti settori, uno in grosse tessere laterizie e uno in scaglie dicalcare con emblema in tessere irregolari raffigurante un rosone inscritto in unquadrato con due delfini negli spazi di risulta, databile all’ultimo venticinquenniodel II sec. a.C. L’edificio era stato sepolto da una frana ed era in parte franatoesso stesso. Nella sezione esposta, a monte dell’area indagata, erano ben visibili lestratificazioni pertinenti a questo evento, cui era sovrapposta una pavimentazionein malta e laterizi e un livello di crollo cui era sovrapposto un altro notevolespessore di frana, al di sopra della quale erano strutture murarie labili, in pietralegata da poca malta, riferibili ad un’occupazione semi–rurale di età ottomana,praticamente affioranti. Ciò sta ad indicare la notevole instabilità di questo versante,particolarmente accentuata nel periodo tardo–ellenistico e post–bizantino.
Fig. . Sito : via (rruga) S. Efendiu: pavimento musivo.
Entrambi questi due ultimi scavi di emergenza, insieme ad alcuni altri rinveni-menti già noti, localizzati sulle prime pendici del plesso collinare ai piedi del qualesta la città moderna, in particolare quello di una casa a pastàs nel Parku Rinia di
Archeologia urbana a Durrës
III–I sec. a.C., indicano che l’abitato in età tardo–ellenistica comprendeva anchequest’area collinare, probabilmente con un’occupazione più rarefatta e di un certopregio. Dimostrano inoltre la forte instabilità del pendio, almeno a partire dall’etàellenistica e soprattutto in epoca post–classica, in grado di produrre e depositarecolluvi con spessori di diversi metri, che hanno modificato in modo notevole lamorfologia di superficie e con essa l’aspetto della città, indirizzandone lo sviluppoverso aree differenti. Per una migliore comprensione di questi fenomeni nel ,è stata effettuata una ricognizione geoarcheologica e geomorfologica di superficiedei rilievi collinari tra Dautë e Villa Zog, a ovest del centro di Durrës, i cui risultati,unitamente alla lettura geoarcheologica di alcune colonne stratigrafiche negli scavidi emergenza citati, sono in corso di pubblicazione.
Alcuni scavi d’emergenza hanno riguardato poi l’area ai margini di quella la-guna, oggi prosciugata, sulla cui esistenza in antico moltissimo si è discusso e checostituisce uno dei nodi per la comprensione dell’urbanistica antica della città,essendo strettamente legata all’individuazione dell’antico porto. Le opinioni degliarcheologi e dei geomorfologi sono, su di essa, contrastanti, non tanto sulla suaesistenza in età antica, che è fuori discussione sulla base delle numerose fonti chela citano, quanto piuttosto sulla sua ampiezza, pari o minore di quella modernaprecedente alla bonifica. I geomorfologi ritengono che l’espansione della lagunasia piuttosto recente, da porre in relazione con fenomeni di regressione marinaregistrati nel XV–XVI secolo. Alcuni dati archeologici confermano questa ipotesi:nell’area della laguna ‘moderna’ sono stati trovati, infatti, resti di villae, necropolie impianti artigianali antichi. Nelle recenti ricostruzioni della situazione anticadella città proposta da P. Cabanes e da A. Gutteridge, A. Hoti, H. R. Hurst, inve-ce, il plesso collinare in età antica avrebbe formato una lunga penisola, compresafra mare aperto e una vasta laguna aperta sul mare verso nord (Capo Palit) e incomunicazione con il mare aperto, a sud, solo attraverso un piccolo canale.
In via (rruga) Dëshmorëve – Ex fabbrica di farina (n. CRA), nel quartiere, a fianco del palazzo dello sport, a circa m in linea d’aria dall’attuale lineadel porto, in un’area di m, sono state rimesse in luce dagli scavi d’emergenzadel – alcune strutture edilizie ellenistiche (IV–III sec. a.C.), con successivecanalizzazioni romane di II–III sec. d.C. Lo strato ellenistico si trovava a -, m diprofondità, quello romano una ventina di centimetri più in alto (il dato tuttavia è didifficile valutazione, trattandosi di canalizzazioni in laterizio). Sottili strati di sabbiainterposti potrebbero indicare fasi di ingressione marina o lagunare.
Un poco più a nord–ovest, e dunque più all’interno, in via (rruga) Bashkimi(sito CRA), nel quartiere n. , nel uno scavo d’emergenza in un’area
. CRA , sito .
. P, S c. s.
. Sul tema, vedi S, S, H ; S –; S, S, H .
. T. .; L. . ; C., civ. .; A., nat. .; P. G. –.
. M , .
. C .
. G, H, H .
Sara Santoro
di m, a una profondità di -, m ha messo in luce un edificio ellenisticoorientato nord–sud. Esso comprendeva un cortile (, x , m) pavimentato agrandi tessere laterizie dotato di pozzo; in giacitura secondaria, vi si trovava unmagnifico capitello di fine IV sec. a.C. Attigui al cortile erano due vani con muri inlaterizi legati con malta. I materiali inquadrano le fasi di vita dell’edificio tra gli inizidel II sec. e la fine del I sec. a.C. Nel I sec. d.C., su un riporto spesso circa cm, ilcortile fu ripavimentato in mattoni e sul lato nord si realizzò una vasca rettangolarerivestita in cocciopesto. A -,/- m di profondità, furono invece intercettate tretombe alla cappuccina, con inumati privi di corredo (VII–XII secolo). Un lungosetto murario ad andamento nord–sud senza connessione con altre strutture, forseuna delimitazione di proprietà risalente alla tarda età bizantina o alle prime fasiottomane (XIV–XVI sec.) chiudeva l’area dalla parte della laguna in una zonadella città che, in età medievale e post–medievale, risulta allo stato attuale delladocumentazione totalmente rurale.
L’insieme dei dati forniti da questi scavi di emergenza dimostra la potenzae complessità del bacino stratigrafico dell’area centrale di Durrës e l’estensioneareale della città antica. Dimostra inoltre che gli assetti e gli orientamenti del primoimpianto urbano furono stati sostanzialmente rispettati fino all’età tardo–antica,così come la vocazione funzionale dei quartieri (funeraria, sacrale, commerciale eartigianale, residenziale), che rimase più o meno la stessa fino al terremoto del d.C. I disastrosi effetti di questo, in un momento di crisi e di cambiamenticulturali epocali, di modificazioni delle rotte commerciali e delle stesse gerarchieurbane nel Mediterraneo, comportarono sul piano urbanistico la prima rottura delsistema urbano unitario e avviarono la sua polarizzazione in città portuale bassa ecittà fortificata alta.
. I dati dagli scavi programmati
Concludono questa panoramica di dati recenti e recentissimi, quelli emersi da duescavi programmati.
Il primo, anglo–albanese, è consistito in una serie di sondaggi condotti nelmacellum/forum bizantino, la straordinaria piazza porticata circolare scoperta nel dietro il teatro A. Moisiu, nel centro della città e la cui pavimentazione inlastre di marmo proconnesio si trova a -, m di profondità dal piano stradaleattuale. Il confronto icnografico più stringente è con il foro circolare costruito daCostantino a Costantinopoli, tuttavia il materiale architettonico e in particolare lamagnifica serie di colonne e capitelli in marmo proconnesio rimanda piuttostoal periodo giustinianeo. Una prima datazione alla fine del V sec. d.C. era stataindicata sulla base del considerevole complesso ceramico rinvenuto in due dellebotteghe. Le indicazioni relative alla stratigrafia riconosciuta al di sopra della
. Per una sintesi degli scavi precedenti e per i dati stratigrafici qui presentati vedi H et alii , in part.fig. t.
. S b.
Archeologia urbana a Durrës
pavimentazione marmorea sono piuttosto sommarie nella edizione dello scavoe nei documenti d’archivio. Essa era costituita da uno strato nero di circa m dispessore, contenente materiale ceramico residuale; su questo era un altro strato diargilla giallastra di circa m , di potenza, contenente almeno tombe distribuitesull’intero sito. Un ulteriore strato bruno, di circa cm, che arrivava al livellodella strada attuale, conteneva ancora ceramica e frammenti laterizi. Sulla basedei dati raccolti, l’edificio sembra defunzionalizzato alla fine del VII sec. (tombe) ecrollato nel IX–X sec., benché l’area sia stata poi risistemata e frequentata, comedimostrano le ceramiche pertinenti ai secc. XIII–XIV .
Alcuni sondaggi sono stati realizzati dall’équipe anglo–albanese fra e ,finalizzati alla conoscenza delle fasi precedenti la costruzione dell’edificio monu-mentale e alla sua più precisa datazione. Essi hanno dato luogo al riconoscimentodi una stratigrafia assai articolata, sottostante la pavimentazione del foro e hannostabilito con considerevole precisione, sulla base dei contesti ceramici rinvenuti,che il monumento fu costruito alla fine del V sec. d.C. e dunque all’interno delprogramma edilizio propagandistico dell’imperatore Anastasio I, nativo di Dyrra-chium. I sondaggi hanno intercettato una sequenza di livelli di età romana, fino aquota -, m, pertinenti a strutture (muri e pavimentazioni) di abitazioni di etàaugustea e proto–imperiale e sottostanti livelli di occupazione ellenistici di II–I sec.a.C., questi ultimi non associati a strutture e la cui potenza non è specificata. Lestrutture residenziali proto–imperiali ebbero continuità di vita fino alla fine delIII– inizi del IV sec. d.C., quando furono abbandonate e successivamente demolite,forse in rapporto al terremoto del d.C.; un’azione di livellamento precedettela costruzione del macellum, fra la fine del V e gli inizi del VI sec. d.C. Nell’inter-pretazione di J. Wilkes, questo lungo periodo di stasi, in un’area posta nel cuoredella città antica che sarebbe rimasta per un secolo e mezzo occupata da ruderi estrutture demolite, potrebbe corrispondere ad una fase di crisi della città, dopo ilterremoto del , causata dalla turbolenta presenza, nella regione, dei Visigoti diAlarico e successivamente degli Ostrogoti di Teoderico, fino alla ripresa dovuta adun forte intervento imperiale motivato da ragioni strategiche.
L’altro scavo programmato nel centro storico della città è quello condottodal dalla équipe italo–albanese nel settore meridionale dell’anfiteatro (Figg., , ). Si tratta, in questo caso, di uno scavo estensivo, di m, che haraggiunto la profondità di -,/- m dal piano stradale attuale, tenendo contoche si tratta di un terreno in pendenza il cui assetto è comunque molto recente enon corrisponde a nessuna superficie naturale o antica: lo scavo, infatti, riguardaun’area compresa all’interno del monumento romano e nel suo immediato esterno.Secondo gli studi architettonici sul monumento, le strutture poste in luce dagliscavi, inserite al livello del maenianum secundum, si troverebbero a , m circa,sopra il piano di calpestio di età romana corrispondente alla galleria del pianoterreno dell’anfiteatro. Lo scavo, dunque, in questo particolare caso non fornisce
. H .
. H et alii , .
. S, H, S ; S, S, H ; S, H c. s.
Sara Santoro
informazioni sulle fasi precedenti l’edificio, quanto piuttosto su quelle successivealla sua defunzionalizzazione, abbandono, parziale demolizione, trasformazioneselettiva, per un periodo che va dalla seconda metà del V alla fine del XX secolo. Sitratta di un caso realmente definibile come archeologia urbana, anche se non èpossibile considerarlo esemplificativo delle vicende della città nel suo complesso, acausa della peculiarità del monumento in cui l’area indagata è inserita e del settoreurbano in cui il monumento si trova, piuttosto marginale rispetto al cuore dellacittà antica, come era prassi per questo tipo di edifici.
Fig. . Anfiteatro: rilievo con indicazione delle aree di scavo della Missione Archeologica Italo–Albanese (–).
La vicenda dell’anfiteatro di Durrës, considerato nella sua interezza, è comun-que emblematica delle trasformazioni post–classiche subite dalla città, dovute
Archeologia urbana a Durrës
Fig. . Anfiteatro: grande galleria settentrionale: sezione del colmamento di terra.
tanto a fenomeni naturali di colluvio, frane e terremoti quanto ai cambiamentidella struttura urbanistica, a partire dall’ età tardo–antica, determinati dalle crescen-ti necessità difensive, dalla crisi demografica ed economica e dalla conseguenteretractio urbana, dal sorgere di nuovi poli di aggregazione di natura religiosa, alter-nativi e sostitutivi di quelli pubblici della città romana, e poi in età alto–medievaledall’ingresso delle sepolture e degli spazi rurali nella città in un paesaggio di rovinecannibalizzate o rifunzionalizzate con strutture labili, fino alla ripresa agli inizidel IX sec. e alle successive fasi edilizie, via via sempre più consistenti, legatealle vicende molto complesse di questa città. Essa fu spesso contesa fra potenzecontrapposte, Bizantini e Normanni, Veneziani e Angioini, e infine Ottomani, esempre caratterizzata da una forte vocazione commerciale, portuale, che la reseaperta ai traffici, agli uomini e alle culture, con la presenza di fondachi veneziani,amalfitani, ragusei, orientali. Il modello del processo di trasformazione e del pas-saggio dalla città antica alla città medievale, e poi moderna, è simile nelle sue lineegenerali nelle città mediterranee ma segue poi modalità e tempi diversi in ognunadi esse.
L’anfiteatro, costruito in epoca traianea, subì danni nel terremoto del d.C.,
Sara Santoro
Fig. . Anfiteatro: scavo del settore meridionale (panoramica da est).
Fig. . Anfiteatro: scavo del settore meridionale (panoramica da ovest).
Archeologia urbana a Durrës
ai quali si cercò di porre qualche rimedio (si riconoscono nelle murature alcuniinterventi di consolidamento) prima che le leggi teodosiane vietassero i combatti-menti gladiatori e soprattutto il gusto del pubblico facesse preferire le corse deicarri degli ippodromi alle venationes, che ancora nel primo venticinquennio del Vsec. vi avevano luogo episodicamente. Come quasi tutti gli anfiteatri del Mediter-raneo, cessata la sua funzione di edificio per spettacolo, anche l’anfiteatro di Durrësdivenne cava di pietra, prima di essere inglobato all’interno delle mura costruitefra la fine del V e gli inizi del VI secolo. Queste, secondo le nostre indagini geofi-siche e i calcoli e le ricostruzioni architettoniche, ne utilizzarono una porzionedell’anello esterno come fondazione; per la loro costruzione furono probabilmentecalcinati i materiali lapidei delle gradinate. Demolito nella sua superficie esterna,il suo scheletro in opus coementicium era diventato contemporaneamente, nellasua struttura interna, un quartiere urbano: le gallerie, compresa la grande galleriasettentrionale, furono occupate da poverissime abitazioni, da necropoli e da edificidi culto cristiano, anche se sulla datazione della celebre cappella di S. Stefano, esoprattutto della sua decorazione musiva, il dibattito è tuttora aperto. I risultatidello scavo del settore meridionale agganciano questa situazione, databile al passag-gio fra VI e VII sec., documentando la sequenza delle fasi successive fino ai giorninostri. Si tratta di una finestra assai ridotta quanto ad estensione areale, ma è perora l’unica che consenta una visione diacronica degli ultimi quindici secoli dellacittà, pur se parziale e fortemente condizionata dalla monumentale presenza in cuiè inserita.
A partire dal momento della defunzionalizzazione del monumento, frane, col-luvi e scarichi intenzionali hanno determinato nel tempo il colmamento, da unlato, della conca dell’anfiteatro e dall’altro della retrostante valletta a nord–est delcastello turco, su cui usciva la grande galleria settentrionale posta sull’asse mag-giore dell’anfiteatro stesso. Una lettura geoarcheologica, realizzata dalla nostraéquipe (F. Pavia, B. Sassi) della sezione esposta del colmamento interno di questagalleria, parzialmente scavata da V. Toçi negli anni Sessanta del XX secolo e da altrisuccessivi interventi non meglio documentati (Fig. ), ha consentito di riconoscerela successione stratigrafica fino a m , di altezza dall’attuale piano di calpestiodella galleria. Questo piano è del tutto recente e relativo agli scavi sopra citati;i sondaggi archeologici da noi effettuati all’interno della galleria settentrionalenel indicano che esso si trova a , m sopra il piano pavimentale anticodella galleria, in scaglie di calcare, che a sua volta si trova a quota , m slm. Ildeposito sottostante il piano attuale di calpestio è costituito da una successionedi livelli colluviali e antropici di discarica contenenti materiale ceramico di etàromana imperiale, intonaci, residui carboniosi e ceneri. In connessione con questi,alcuni muri in materiale lapideo di riempiego definiscono ambienti di ridottedimensioni, pertinenti ad una fase di rioccupazione a scopo abitativo degli spaziinterni dell’anfiteatro, fase riferibile al periodo tardo–antico e alto–medievale (V–
. C et alii ; G, G .
. Da ultimo B, M .
. La quota più bassa dell’arena raggiunta dagli scavi di V. Toçi era di , m slm.
Sara Santoro
VII sec. d.C.). A partire dal piano attuale, invece, la stratigrafia del colmamentodella galleria è composta da un’alternanza di strati a matrice argillosa, contenentirari frammenti laterizi e ceramici, con strati a matrice sabbiosa contenenti abbon-danti macerie e ceramiche di età tardo–romana. Alcuni strati presentano superficiconcave canaliformi. Sulla base delle caratteristiche di tessitura, colore, caratteripedologici e reperti archeologici diagnostici sono state individuate diverse UUSSraggruppate in sette macrofasi, che sintetizzano i principali momenti di erosionee sedimentazione responsabili del riempimento della galleria. Gli strati a matriceargillosa con scarsa presenza di elementi ceramici dovrebbero corrispondere amomenti di erosione–deposizione che intaccarono una stratigrafia posta a mon-te, scarsamente antropizzata e potrebbero riferirsi quindi a fasi di dissesto delversante collinare (frane, colluvi). Gli strati più antropizzati, invece, potrebberocorrispondere ad azioni di movimentazione e scarico intenzionale di depositi dietà romana e tardo–romana. La stratigrafia appare dunque come un’alternanza diepisodi naturali e antropici che vedono la grande galleria trasformata in una sortadi canale dove indirizzare scarichi provenienti da aree esterne e poste più in altorispetto al monumento, in occasione di interventi edilizi a quota superiore quali,probabilmente, la costruzione del castrum, trasformato poi in castello medievale eturco.
Nel settore meridionale, la struttura dell’anfiteatro alla fine della tarda antichitàdoveva essere già in gran parte crollata e demolita, nei suoi due anelli più esterni:si trattava infatti della porzione completamente sostruita, e non appoggiata allacollina, e dunque più fragile; inoltre trovandosi ai piedi del pendio, aveva ricevutonel tempo la spinta devastante dei colluvi, delle frane e dei terremoti. Nell’areae alla quota dello scavo restano solo le arcate delle gallerie radiali, con la loroalternanza di scale e sostruzioni voltate chiuse. Restava inoltre parte della galleriameridionale, voltata: infatti, sotto i grandi blocchi del piano cementizio sovrappo-sto ad essa, crollati nel terremoto del , erano focolari e sistemazioni ligneepertinenti ad abitazioni di età precedente, medievale. In quest’area, dunque, frala fine del V e il VII sec. d.C. le macerie e i ruderi del monumento, parzialmenteriempiti di terra di colluvio (come indicano le indagini geofisiche), costituivanoormai una superficie pressoché continua, abbastanza stabile, da cui si elevavanoancora blocchi e porzioni delle potenti strutture romane; le arcate delle gallerie,che ancora restavano, potevano offrire riparo a uomini, merci e animali.
Una fornace per la produzione ceramica trovava posto fra questi ruderi, a sud–est dell’area dello scavo: ne è stata individuata in parte la struttura della camera dicottura e alcuni prodotti di scarto sono compresi fra il molto materiale ceramico delriporto di una quarantina di centimetri che fu steso su questa superficie, piuttostoirregolare, per regolarizzarla, nella prima metà dell’VIII secolo. Su di esso fucostruito un lungo muro, probabilmente di divisione dello spazio in due diverse
. D F et alii , in part. fig. : il modello tridimensionale del campo di velocità delle onde P, elaboratoutilizzando tutte le sezioni sismiche a rifrazione realizzate nella prospezione sismica, indicava la presenza distrutture più superficiali distaccate da altre a maggior profondità da spessori variabili, anche potenti alcuni metri,di terreno decoeso (riporti, colluvi).
Archeologia urbana a Durrës
pertinenze. Questa situazione di occupazione parzialmente rurale e comunquediscontinua sembra superata nel secolo successivo, agli inizi del IX, quando ilmuro fu dismesso e ricoperto da un riporto e il settore si strutturò in sensomaggiormente urbano, con la realizzazione di una canalizzazione accuratamentecostruita, che sfiorava le poderose strutture antiche, ancora presenti nell’angolosud–est del settore di scavo e che erano state certamente riutilizzate (Fig. ), comevediamo nell’anfiteatro di Arles. La canalizzazione si dirigeva, in leggera pendenza,verso sud convogliando le acque del quartiere abitativo che nel tempo si eravenuto formando sul lato est, sui ruderi meglio conservati in alzato dell’anfiteatro,rispettando la partizione in cunei come si può osservare ancora oggi nel calcourbano tuttora presente ed abitato.
Il IX secolo costituì una fase di ripresa, economica e demografica, per la città,sancita dall’assunzione al ruolo di capitale del thèma. In questo secolo, e nel X,l’intero anfiteatro, compresa quest’area meridionale, acquisì sempre più il caratte-re di centro religioso e funerario, con sepolture di rango superiore rispetto allenumerosissime tombe alla cappuccina quasi sempre prive di corredo e sepolturein nuda terra, messe in luce dagli scavi di V. Toçi, che già in età alto–medievalene avevano occupato gli spazi interni ed esterni. Secondo la recente e convin-cente disamina degli elementi archeologici, architettonici e storico–artistici di J.Mitchell, è questo il momento in cui venne decorata con prestigiosi mosaicila cappella funeraria nota come cappella di S. Stefano, che doveva contenere unsarcofago e accanto alla quale è una grande tomba bisoma in cassa litica e unacappella–ossuario, utilizzata fino alla metà del XVI secolo. Una seconda cappellasul lato opposto dell’anfiteatro, quello orientale, assolveva probabilmente analoghefunzioni funerarie in connessione con un luogo di culto posto a livello superiore.Lo strato inferiore, più antico delle pitture da cui era decorata, oggi pressochéevanide, stilisticamente e per stratigrafia muraria sembra riferibile a questa fase.
Nel settore meridionale oggetto dello scavo, alcune sepolture alla cappuccina,plurime, furono disposte sui gradini della galleria a scala VI: la cassa era costituitada laterizi di reimpiego, di cui uno decorato con un pesce. La datazione di questedeposizioni è circoscritta, dalle analisi al C, agli anni – d.C. Intorno al d.C. si data un’ulteriore sepoltura di una giovane donna, ricavata in un tratto dellacanalizzazione oramai dismessa. La defunta aveva orecchini ad anello, in bronzo,un anello digitale in ferro e una moneta in bocca. Con la tipica commistionemedievale di abitazioni, attività produttive, edifici religiosi e tombe, sempre nelX sec. nell’area venne costruita un’abitazione, con fondazioni in pietra legate conterra e alzato retto da pali lignei. L’edificio ebbe una seconda fase, caratterizzata dauna differente tecnica edilizia che riutilizzava grossi blocchi di muri dell’anfiteatro,recuperati e disposti come elementi costruttivi. Questa fase si data fra la fine dell’XIe gli inizi del XII secolo ed è concomitante con la presenza di una vetreria (resti
. T .
. B, M .
. S, H, S , (C. Boschetti).
Sara Santoro
della fornace, scorie e elementi di soffiatura) posta qualche metro più a ovest.Sono questi gli anni che vedono Durazzo sanguinosamente contesa fra Roberto
il Guiscardo e Alessio I Comneno. Come ricorda Anna Comnena in città c’eraun’importante presenza di fondachi veneziani e amalfitani, anzi, a detta della storicabizantina, ‘tutti’ gli abitanti della città erano veneziani o amalfitani, e la città fuconquistata dai Normanni proprio per il tradimento di uno di questi ultimi. Alla fineprevalse la componente veneziana, grazie all’appoggio navale dato all’imperatore.Un secondo tentativo di conquista da parte dei Normanni si ebbe ad opera diRuggiero II, che riuscì a prendere la città nel per riperderla però ad operadell’imperatore Isacco II Angelo poco tempo dopo.
L’edificio messo in luce dagli scavi venne intenzionalmente smantellato nellaseconda metà del XII sec. per costruirne al suo posto un altro, più ampio, dallemura possenti, realizzate con una tecnica inusuale a lunghi conci parallelepipedi dicalcare grigio; il grande ambiente unico era affiancato da un cortile con tettoia.
Nel , quando la flotta crociata proveniente da Zara approdò a Durazzo,conquistandola, la città era ancora bizantina; due anni dopo, nel l’occupazioneveneziana era già stabile: in città venne installata una guarnigione e un governatoreveneziano; del è la prima attestazione del ducato veneziano di Durazzo.Tuttavia, i mutamenti politico–economici legati agli esiti della IV crociata, inparticolare in Macedonia e Tessaglia, modificarono le rotte e i percorsi dell’areabalcanica, privando Durazzo della sua importanza internazionale come snodocommerciale; Venezia si liberò dunque alla svelta del fardello della gestione dellacittà cedendola nel al despota dell’Epiro Michele Dukas.Una nuova fase siaprì nel , allorquando il figlio di Federico II, Manfredi, si impadronì della costaalbanese e anche di Durazzo, ma di lì a poco lo stesso Manfredi fu sconfitto erimpiazzato da Carlo I d’Angiò sul trono del Regno di Sicilia.
Una seconda fase edilizia del palazzo è da porsi intorno alla metà del XIII, qual-che decennio prima del disastroso terremoto che nel ridusse la fiorente città,da poco passata nelle mani degli Angioini, ad un borgo di rovine abitato da pochecentinaia di persone, come descritto nel dal pellegrino francescano Simon Fi-tzsmons. Gli effetti drammatici di questo terremoto sono stati ben constatati negliscavi, che hanno posto in luce non solo i grandi crolli delle parti ancora conservatein alzato della grande galleria meridionale dell’anfiteatro romano, ma anche levittime schiacciate da questi e soffocate dalla polvere, all’esterno e all’interno delpalazzo. Ne sono state recuperate complessivamente undici.
Sappiamo da fonti d’archivio che, successivamente al terremoto, Carlo I d’An-giò intervenne ripetutamente inviando denaro e manodopera dalla Puglia per laricostruzione, in particolare delle fortificazioni di questa piazzaforte così importan-te, finalmente acquisita al regno e fondamentale per l’ambizioso progetto angioino
. B et alii .
. Alex., ..; .. e .
. Le notizie storiche qui di seguito riportate e le datazioni, non sempre concordanti, sono tratte da D
; H , –; H , –.
. M , .
Archeologia urbana a Durrës
di attacco all’impero bizantino, progetto ben presto fallito: nel Durazzo vennenuovamente presa dai Bizantini d’Epiro, e poi dai Serbi, nel , i quali la tenneroalmeno fino al , allorquando tornò in mano angioina. Intorno al tutta l’areadurazzina era in mano ai signori albanesi, Musachi e Thopia, guadagnando di fattol’autodeterminazione a partire da questa data, seppure fosse ancora formalmentesotto il governo angioino. In quel tempo la costa albanese era ormai stabilmenteentrata a far parte del circuito economico adriatico dominato da Venezia, e conessa Durazzo, che ne divenne uno dei capisaldi commerciali e militari. La città,tuttavia, non si era ripresa dalla gravissima crisi del terremoto e continuò ad esseresoggetta ad un continuo fenomeno di spopolamento, dovuto al peggioramentodelle condizioni ambientali seguite all’estendersi delle lagune; in particolare, lapenuria d’acqua diventava sempre più grave. I numerosi provvedimenti di agevola-zioni fiscali ai nuovi residenti e di interventi idraulici e portuali, a dire il vero piùproposti che realizzati, documentati negli archivi della Serenissima, non sortironogli effetti desiderati.
Nonostante queste vicende politicamente e militarmente tumultuose e la crisidella città, il palazzo fu ricostruito fin dai primi anni del XIV secolo, rialzandonei muri, e divenne una costruzione complessa, costituita da diversi ambienti piùpiccoli, ortogonali fra loro, residenziali, cortilizi e di circolazione, in cui la sovrap-posizione dei piani pavimentali, i riporti, il rifacimento dei focolari, l’apertura echiusura di porte seguono il tipico modello di accrescimento delle stratigrafieurbane degli interni. L’area circostante sfruttava le strutture dell’anfiteatro ancoraesistenti, opportunamente approntate e spianate, come depositi e magazzini, men-tre una gran quantità di pozzi/rifiutaie venivano progressivamente aperti, manmano che i precedenti si riempivano.
Forti colluvi riconosciuti nell’area dello scavo, determinati da un peggioramen-to climatico e dal disboscamento e dall’instabilità dei versanti superiori all’anfitea-tro, coincidono con l’ulteriore indebolimento demografico della città che MarinoSanudo, nell’aprile del , dice abitata da soli uomini atti alle armi, serratientro le mura, terrorizzati dai Turchi che li assediavano: la caduta definitivaavvenne nell’estate successiva. Nel , il Contarini, comandante della flotta vene-ziana bombardò ancora la città, divenuta turca e abbondantemente fortificata dainuovi signori: «... il Contarino, ripieno di sdegno, assaltò il luogo con l’arme e conl’artiglieria di modo, che presto andò in terra una gran parte della muraglia, rovinòancora la Moschea dentro alla quale morirono assai Turchi, del uno e del altrosesso, per il che fuggirono tutti dalla Città...». Nel nostro scavo la macrostoria silega alla microstoria: una delle palle da mortaio, in ferro, di quel bombardamentoè stata rinvenuta accanto ad una delle strutture di divisione parcellare dell’area,divenuta un intrico di orti, cortili, magazzini pertinenti all’abitazione in cui si era
. Per l’analisi di alcuni di questi documenti, relativi soprattutto agli interventi di fortificazione, vedi M
c.s.
. Diarii, III (anni –), (edito a Venezia nel ).
. DHS (Dokumente për Historinë e Shquipërisë –, Accademia delle Scienze d’Albania–Istituto di Storia, Tirana). XVI – XVII, fr. , p. .
Sara Santoro
trasformato l’antico palazzo medievale. Ancor più tardi, nella prima metà del XVIIsecolo, sotto ad un battuto pavimentale dell’ambiente A–B qualcuno nascose inuna brocchetta in ceramica invetriata dipinta di XVI secolo un deposito monetalecostituito da monete d’argento (grossi) della zecca di Ragusa. Il deposito copreun arco cronologico che va dalla seconda metà del XVI secolo al ed è dunqueposteriore a tale data.
Le abbondanti discariche del XVII, XVIII e XIX secolo indicano una tendenzaalla ruralizzazione dell’area. All’inizio del XX secolo si data la ristrutturazionedell’abitazione che in effetti è ricordata come locanda per i marinai del porto; viebbe poi sede una macelleria, con annessa stalla, dismessa e smantellata nel .Questo intervento di bonifica urbana e di recupero dell’area, ricompresa nellospazio pubblico dell’anfiteatro, consentì l’avvio di questo scavo di archeologiaurbana, aprendo una finestra su una storia millenaria. Nei progetti di restauroe rifunzionalizzazione dell’anfiteatro, elaborati dalla Missione, si propone lamusealizzazione di quest’area, come museo della città cresciuta su se stessa.
Referenze grafiche e fotografiche
Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’, Chieti–Pescara: Dipartimento di Scienze Psicologiche,Umanistichee del Territorio; [email protected]
Fotografie e disegni sono opera della Missione Archeologica Italo–Albanese attiva a Durazzo (Durrës).La Fig. è tratta da S ; la Fig. , da R a.
Sara Santoro
. H, B .
. C. Varagnoli, F. Armillotta, C. Santacroce, ‘Masterplan – Ipotesi e scenari per la rifunzionalizzazionedell’anfiteatro di Durrës’, Istituto dei Monumenti di Cultura e Progetto pilota ‘Scavi, ricerche e valorizzazionedell’anfiteatro romano di Durrës – Conservazione, restauro, valorizzazione’, Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’Chieti–Pescara, Facoltà di Architettura – .
Ricerche archeologiche in AlbaniaISBN 978-88-548-7245-5DOI 10.4399/978885487245519pag. 363–405 (novembre 2014)
Abbreviazioni bibliografiche
A = D. A, Economia mercantile nel Mediterraneo Occidentale: commercio locale ecommercio internazionale nell’età di Alfonso il Magnanimo, in La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonsoil Magnanimo. I modelli politico–istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci, gliinflussi sulla società e sul costume, Atti del XVI congresso internazionale di storia della Coronad’Aragona (Napoli–Caserta–Ischia, – settembre ), a cura di G. D’A, G. B,Napoli , –.
A = D. A, Mercati e mercanti nella Corona d’Aragona: il ruolo degli imprenditoristranieri, in La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII–XIV e VII Centenari de la SentènciaArbitral de Torrellas, –, Actes del XVIII congrés internacional d’história de la Coronad’Aragó (Valencia, – setembre ), a cura di R. N V, Valencia , –.
A = S. A, F. Halbherr e G. De Sanctis. Pionieri delle Missioni Archeologiche Italiane aCreta e in Cirenaica (dal carteggio De Sanctis –), Roma .
A = S. A, F. Halbherr e G. De Sanctis (nuove lettere dal carteggio De Sanctis –),Roma .
Adriatico = L’Adriatico tra Mediterraneo e penisola balcanica nell’antichità, Atti del convegno(Lecce–Matera, – ottobre ), Taranto–Napoli .
AHF = Albanian Heritage Foundation. Archaeology Field School, summer , http://www.albanianheritage.net/
A = R. A, Brindisi medievale. Natura, santi e sovrani in una città di frontiera, Napoli.
A = G. E. A, Descrjttione del paese circonvicino a Canina, et alla Valona, congl’avvenimenti che lo resero rimarcabile, Venezia .
A = S. A, Tuma e Rehovës, Korçë .
A = B. A, Greek gods and figurines. Aspects of anthropomorphic dedications, Uppsala.
A = D. A, L’Adriatico nei frammenti degli storici greci, in Greci in Adriatico ,–.
A = R. M. A, The sanctuary of Santa Venera at Paestum, II. The votiveterracottas, Ann Arbor .
A = R. M. A, Children at risk: Votive terrecottas and the welfare of infantsat Paestum, in Constructions of childhood in ancient Greece and Italy, ed. A. C, J. B. R(Hesperia Suppl., ), Princeton (NJ) , –.
A, C, D = S. A, H. C, E. D, Corpus des inscriptions latinesd’Albanie (Coll. École Française de Rome, ), Rome .
A, V = A. A, G. V, Archeologia subacquea in Albania, in ASub .–, ,–.
A = M. A, La decorazione pittorica degli edifici cristiani di Efeso: la chiesa diSanta Maria e il complesso di San Giovanni, in Efeso Paleocristiana e bizantina – Frühchristliches
Abbreviazioni bibliografiche
und Byzantinisches Ephesos (Archaeologische Forschungen, ), hrsg. R. P, O. K, F.K, E. R, Wien , –.
A = Z. A, Kultura ilire e tumave në pellgun e Korçës, Tiranë .
A, B = A. A, J. B, Das Theater von Apollonia (Albanien).Ein Vorberich, in MDAIR , , –.
A et alii = C. A et alii, Gherardo Ghirardini nel centenario della nascita, Padova .
A = L. A, Cadmo ed Eracle al cospetto di Apollo. Echi di propaganda intorno a Delfiarcaica, in Hesperìa, , Roma , –.
A = Lo spazio ionico e le comunità della Grecia nord–occidentale. Territorio, società, istituzioni,Atti del convegno internazionale (Venezia, – gennaio ), a cura di C. A, Pisa .
Archeologo = L’archeologo scopre la storia. Luigi M. Ugolini (–), Atti della giornata internazio-nale di studi (Bertinoro, settembre ), Bertinoro .
A = L. A, Nuove ipotesi a partire dalla rilettura dei dati archeologici: la Sicilia orientale, inLa Sicile de Byzance à l’Islam, éd. A. N, V. P, Paris , –.
A, A = L. A, F. A, La ceramica dipinta in rosso in Sicilia, in Laceramica dipinta in rosso. I contesti laziali a confronto con altre realtà italiane, Atti del VI convegno distudi sulle ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna (Segni, – maggio ),a cura di E. D M, Roma , –.
A et alii = Roma dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e storia nel Museo Nazionale della CryptaBalbi, a cura di M. S. A, P. D, L. P, M. R, L. S, L. V, Roma.
A, H, T = P. A, H. H, M. T, Changes in Byzantine glazingtechnology from the ninth to thirteenth centuries, in La céramique médiévale en Méditerranée, éd. G.D ’A, Aix–en–Provence , –.
Art albanais = L’art albanais à travers les siècles, catalogo della mostra, Paris .
Arte albanese = L’arte albanese nei secoli, catalogo della mostra, Roma .
A = P. A, Amphorae for bulk transport, in D’A, W , –.
A = P. A, Islam and the Terra d’Otranto: some archaeological evidence, in Papers fromthe EAA third annual meeting at Ravenna , II. Classical and Medieval, ed. M. P, M. T,Oxford , –.
A = P. A, Riflessioni intorno ad alcune produzioni di anfore tra la Calabria e la Puglia inetà medievale, in Contenitori da trasporto e da magazzino tra Tardo Antico e Basso Medioevo, Atti delXXX convegno internazionale della ceramica (Albisola, – maggio ), Firenze , –.
A = P. A, Un saggio di scavo in proprietà Previtero (), e la cronologia di ceramiche dietà bizantina ad Otranto, in StAnt , , –.
A = P. A, I Balcani e il Salento nel Medioevo, in L’archeologia dell’Adriatico dalla preistoriaal Medioevo, Atti del convegno internazionale (Ravenna, – giugno ), a cura di F. L,Firenze , –.
A = P. A, Ceramica in Terra d’Otranto tra VIII e XI secolo, in P U ,–.
A = P. A, L’Albania e la Terra d’Otranto nel Medioevo: tre casi studio, in Illiri ,–.
A = P. A, Economic expansion in Byzantine Apulia, in Histoire et culture dans l’Italiebyzantine. Acquis et nouvelles recherches, éd. A. J, J.–M. M, G. N, Rome , –.
Abbreviazioni bibliografiche
A = P. A, L’archeologia del villaggio medievale in Puglia, in Vita e morte dei villaggi ruralitra Medioevo ed età Moderna. Dallo scavo della villa de Geriti ad una pianificazione della tutela e dellaconoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna, a cura di M. M, Firenze , –.
A a = P. A, Verso un modellamento del paesaggio rurale dopo il Mille nella Pugliameridionale, in AMediev , , –.
A b = P. A, Riflessioni intorno alla produzione e circolazione della ceramica nel bassoAdriatico, in M et alii , –.
A, A = P. A, R. A, A search for Italian wine: Middle Byzantine andlater amphorae from Southern Puglia, in InstNautAQ ., , –.
A, A = P. A, R. A, Chi l’ha vista?, in ASub ., , –.
A, D M, L = P. A, C. D M, E. L, Nuovi appunti sullacircolazione delle merci in Apulia fra Tardoantico e Altomedioevo, in G, N , –.
A, L I c. s. = P. A, M. L I, Le ceramiche di età bizantina (fine VII–XIsecolo), in A, L I, T c. s.
A, L I, T c. s. = P. A, M. L I, M. T, Apigliano. Unvillaggio bizantino e medioevale in Terra d’Otranto. I reperti mobili, a cura di P. A, M. LI, M. T, Galatina c. s.
A, = D. A, Erodoto. Le Storie. Libro I. La Lidia e la Persia, Milano .
A, C = D. A, A. C, Erodoto. Le Storie. Libro VIII. La vittoria di Temistocle,Milano .
A = R. A, Gli approdi minori del Salento Adriatico: il contributo della ricercaarcheologica subacquea, in Z , –.
A = R. A, Salentum a salo. I. Porti, approdi, merci e scambi lungo la costa adriaticadel Salento. II. Forma Maris Antiqui, Galatina .
A = R. A, Produzioni orientali, in M , –.
A = A. A, Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle: changement et persistance, Paris .
B = A. B, Vështrim mbi qendrat e banuara antike dhe mesjetare në luginën e Drinos (Gjirokastër),in Monumentet , , – (riass. in franc., Aperçu sur les agglomérations antiques et moyenageusesde la vallée du Drinos (Gjirokaster), –).
B = A. B, Qendrat e fortifikuara të Vlorës në antikitet, in Monumentet , , – (riass. infranc., Les centres fortifies du Golfe de Vlore dans l’antiquité, –).
B = A. B, Vështrim mbi arkitecturën e fortifikimeve antike në vendin tonë, in Monumentet ,, – (riass. in franc., Aperçu sur l’architecture des fortifications antiques dans notre pays, –).
B = A. B, Kështjella e Paleokastrës, in Iliria ., , – (riass. in franc., La forteresse dePaleokastra, –).
B = A. B, Studim mbi zonifikimin arkeologjik të qytetit të Durrësit, in Monumentet , ,– (riass. in franc., Étude sur la definition de la zone archéologique de la ville de Durrës, ).
B – = A. B, Griechische Theater des . bis . Jahrhunderts in Illyrien und Epirus, in BJb–, –, –.
B = Tesori del patrimonio culturale albanese, catalogo della mostra, a cura di A. B, Roma.
B, P, P = Hadrianopolis, I. Il Progetto TAU, a cura di A. B, G. P, R. P, Jesi.
Abbreviazioni bibliografiche
B = S. C. B, Between Illyrians and Greeks: The cities of Epidamnos and Apollonia,in Iliria ., , – (riass. in alban., Midis Ilirëve dhe Grekëve: qytetet Epidamn dhe Apoloni,–).
B = Actes du VIIe congrès international sur la céramique médiévale en Méditerranée (Thessalo-niki, – octobre ), éd. Ch. B, Athènes .
B = R. B , Strabon. Géographie. Livre VII, Paris .
B = M. B, Croisades et Orient latin. XI–XIV siécle, Paris .
B = M. B, Carlo I d’Angiò e lo spazio mediterraneo, in Le eredità normanno–sveve nell’etàangioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno, Atti delle quindicesime giornate normanno–sveve (Bari, – ottobre ), a cura di G. M, Bari , –.
B = A. B, Una scoperta archeologica del console francese A. Degrand, nell’Albaniasettentrionale, in BollSocGeogrIt , , – .
B a = A. B, Itinerari albanesi (–), con uno sguardo generale all’Albania e allesue comunicazioni stradali, Roma .
B b = A. B, Divagazioni intorno alla Regione di sbarco di Giulio Cesare nellaAcroceraunia, in RivMarittima, novembre , – (estratto).
B = A. B, I Daorsi e Val Daorso nella Acroceraunia, in RivMarittima, marzo ,– (estratto).
B () = A. B, Le Soleil et le Tartare. L’image mythique du monde en Grècearchaïque, Paris (trad. it., Il Sole e il Tartaro. La visione mitica del mondo nella Grecia arcaica,Vicenza ).
B, G = K. B, L. G, Hartografia. Pîrî Reis dhe brigjet shqiptare në vitin ,in Monumentet , , – (riass. in ingl., Piri Reis cartography and the Albanian coast, –).
B = J.–C. B, Curia Ordinis. Recherches d’architecture et d’urbanisme antiques, Brüssel .
B = G. B, Halbherr, Pigorini e la nascita della Missione Archeologica Italiana in Creta, inLa figura e l’opera di F. Halbherr, Atti del convegno (Rovereto, – maggio ), Padova ,–.
B = M. B, L’archeologia degli Italiani, Roma .
B = E. B, Albania. Monografia antropogeografica, Roma .
B = G. B, The pottery, in B, D , –.
B, D = G. F. B, F. H. J. D, Yassi Ada. A seventh–centuryByzantine shipwreck, I, College Station (TX) .
B, D L = I. B, M. D L, Oggetti votivi e oggetti rituali: terracotte figuratee thymiateria nel santuario lucano di Torre di Satriano, in Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italiameridionale tra Indigeni e Greci, Atti delle giornate di studio (Matera, – giugno ), a cura diM. L. N, M. O, Bari , –.
B = J. D. B, The significance of votive offerings in selected Hera sanctuaries in thePeloponnese, Ionia and Western Greece (BAR Int. Ser., ), Oxford .
B = R. L. B, Greek influence in the Adriatic Sea before the fourth century B.C., inJHS , , –.
B = L. B, Mbi praninë e qeramikës mikene në Shqipërinë Jugore dhe probleme lidhur me të,in Iliria .–, , – (riass. in franc., A propos de la presence de la céramique mycenienne enAlbanie du Sud et des problemes lies avec elle, –).
Abbreviazioni bibliografiche
B = L. B, Some problems of the Middle and Late Bronze Age in Southern Albania, in BALond, , –.
B – = L. B, Zakone mortore në bronzin e vonë të Shqipërisë Junglindore, in Iliria ,–, – (= Mortuary customs in the Late Bronze Age of South–Eastern Albania, –).
B = L. B, Mycenaean presence and influence in Albania, in C, C, K , –.
B = L. B, Life and death in the periphery of the Mycenaean world: Cultural processes in theAlbanian Late Bronze Age, in Ocnus , , –.
B, H = New directions in Albanian archaeology. Studies presented to Muzafer Korkuti, ed. L.B, R. H, Tirana .
B = M. B, Morgantina studies, : The terracottas, Princeton (NJ) .
B D’E = P. B D’E, Puglia romanica, Milano .
B et alii = G. B, A. C, S. M, F. D, B. S, Legrotte sommerse della penisola del Karaburun (Albania): primi dati, in ThalassiaSalentina (Suppl.),, –.
B = C. B, Vita di bordo in età romana, Roma .
B – = V. B, Gërmime në Triport, in Iliria –, –, – (riass. in franc., Lesfouilles à Triport, ).
B = V. B, Vendbanimi ilir në Triport të Vlorës, in Iliria ., , – (riass. in franc.,Une agglomération illyrienne à Triport de Vlore, ).
B = V. B, Amfora transporti të zbuluara në vendbanimin e Triportit, in Iliria .–, ,– (riass. in franc., Amphores de transport découvertes dans l’habitat de Treport. Les fouilles àTriport, ).
B = V. B, Gjurmë të fortifikimeve në vendbanimin në Treport, in Iliria .–, , –(riass. in franc., Traces de fortifications dans l’habitat de Treport, ).
B = V. B, Le site antique de Treport, port des villes des Amantins, in C , –.
B et alii = V. B, G. C, J–P. D, S. S, C. Z, Orikos. Premierecolonie grecque en Adriatique? La premiere campagne de fouille albano–suisse, in L, C a, –.
B–A = Epire, Illyrie, Macédoine. . . Mélanges offerts au Professeur Pierre Cabanes, éd.D. B–A (Coll. Erga, ), Clermont–Ferrand .
B = L. B, La cultura antiquaria italiana a Creta: premessa di un impegno scientifico, inCreta antica , –.
B = M. B, Italia Meridionale e mondo miceneo. Ricerche su dinamiche di acculturazionee aspetti archeologici, con particolare riferimento ai versanti adriatico e ionico della penisola italiana,Firenze .
B = A. B, Storia dell’Albania dalle origini ai giorni nostri, Milano .
B = G.B. B, La via iperborea, in RFil , , –.
B – = N. B, Elefenore e il nostos degli Abanti, in InvLuc –, –, –.
B et alii = C. B, G. C, M. C, P. D, Aspetti geologici egeomorfologici dell’alta valle del fiume Drino, in B, P, P , –.
B = E. B, The Mycenaeans in Italy: A minimalist position, in BSR , , –.
B D’A = I. B D’A, La ceramica medievale di contrada ‘Badìa’ inCutrofiano (LE) (Quad. Mus. Ceramica Cutrofiano, ), Galatina .
Abbreviazioni bibliografiche
B = D. B, Ausgrabungen in Apollonia in Illyrien (), in Klio , , –.
B, I = V. D. B, S. I, Iliriskaja Apollonia, Moskva , – ( = Apolloniae Ilirisë, –; Apollonia d’Illyrie, –).
B, I = V. D. B, S. I, Gërmime në Apolloni dhe Orik gjatë vitit , inBulUniversShtetërTiranës , , – (riass. in franc., Fouilles d’Apollonie et d’Orichum. Travauxde , –).
B = C. B, Lindos. Fouilles de l’Acropole, –. Les petits objets, Berlin.
B = J. B, The finds, in Excavations in Chios –. Byzantine emporio, ed. M.B, J. B, S. C, S. H (BSA Suppl., ), London , –.
B = N. B, Pazhok (Elbasan), in Iliria , , –.
B = N. B, Rreth kronologjisë së qeramikës së pikturuar mat të kohës së vonë të bronzitdhe të hekurit, in Iliria ., , – (riass. in franc., Sur la chronologie de la céramique peinte matede l’âge du Bronze Récent e du Fer, –).
B = N. B, Rreth origjinës dhe bartësve të qeramikës së pikturuar mat të kohës së vonëtë bronzit dhe asaj të hekurit, in Iliria ., , – (= Sur l’origine et les porteurs de la céramiquepeinte mate de l’Âge du Bronze Récent et du Fer, –).
B = J. B, Note su Phoinike in età romana, in D M, G , –.
B = J. B, Le fortificazioni di età ellenistica di Çuka e Aitoit (Epiro), in Ocnus , ,–.
B – = J. B, Çuka e Ajtoit: një kontribut i ri, in Iliria , –, – (riass.in ingl., Çuka e Ajtoit: A new assessment, –).
B = J. B, Note su alcuni siti fortificati di età ellenistica della media valle del Pavla, Epiro,in Ocnus , , –.
B, G = J. B, E. G, Saggi stratigrafici nelle mura (aree A , B ), in DM, G , –.
B, G = J. B, E. G, Assetto del territorio e popolamento in Caonia. Il caso diPhoinike, in L, C a, –.
B–A, U, W–O = Çanak. Late Antique and Medieval pottery and tiles inMediterranean archaeological contexts, Proceedings of the conference (Çanakkale, – June ),ed. B. B–A, A. O. U, J. W–O (Byzas, ), Istanbul .
B = M. G. B, Antonio Baldacci. Una passione balcanica tra affari, botanica e politicacoloniale. Il fondo Antonio Baldacci nella Biblioteca dell’Archiginnasio (–), Bologna .
B = M. B, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique (BAR Int. Ser., ),Oxford .
B = G. B, La cooperazione internazionale alla salvaguardia del patrimonio archeologico neipaesi in transizione: il ‘Progetto Durrës’, in www.cooperazione.unipr.it (sito del Centro universitarioper la cooperazione internazionale dell’Università di Parma), .
B = G. B, Carlo I d’Angiò e il Mediterraneo. Politica, diplomazia e commerciointernazionale prima dei Vespri (Coll. École Française de Rome, ), Roma .
B et alii = C. B, C. L, A. C, P. I, M. M, E. S,S. S, B. S, Glass–working evidences at Durres, Albania: An archaeological and archaeometricstudy, in JCulturalHeritage , , eee.
B = W. B, Epirus Vetus. The archaeology of a Late Antique province, London .
Abbreviazioni bibliografiche
B et alii = W. B, R. H, K. L, D. B, A. C, O. G, S.M, J. M, L. P, P. R, Roman and Late–Antique Butrint. Excavations andsurvey –, in JRA , , –.
B, H, L = W. B, R. H, K. L, The Anglo–Albanian project at Butrint,in Iliria .–, , – (= Rezultate të projektit anglo–shqiptar në Butrint, –).
B, M = K. B, J. M, The main chapel of the Durres amphiteater, in MEFRA., , –.
B, P = W. B, L. P, The Baptistery, in H, B, L, –.
B = L. B, Grecità adriatica, Bologna .
B = L. B , Hellenikòs Kolpos. Supplemento a Grecità adriatica (Hesperìa,), Roma.
B, S. G = La Dalmazia e l’altra sponda. Problemi di archaiologhía adriatica, Atti delconvegno (Venezia, – gennaio ), a cura di L. B, S. G, Firenze .
B = B. B, Architettura monastica dei primi secoli: retorica versus realtà, in B. B,Architettura e immagini del sacro nella Tarda Antichità (Fondazione CISAM – Studi e ricerche diArcheologia e Storia dell’Arte, ), Spoleto , –.
B = G. P. B, s.v. Archeologia urbana, in Dizionario di archeologia, a cura di R.F, D. M, Roma–Bari , –.
B = M. B, Italia–Albania nella politica del ‘buon vicinato’. L’avvio delle relazioniculturali con la restituzione della ‘Dea di Butrinto’, in Centenario dell’indipendenza dell’Albania –. L’influenza delle relazioni con l’Italia nella nascita della coscienza nazionale albanese, in Il Veltro.–, –.
B = C. B, An island archaeology of the early Cyclades, Cambridge .
B = Byzantium in the ninth century. Dead or alive?, Papers from the thirtieth springsymposium of Byzantine studies (Birmingham, March ), ed. L. B, Aldershot .
B = A. B, L’inscription du monument des Agonothètes, in Albania , , –.
B = P. B, Recherches sur les cultes de Délos à l’époque hellénistique et à l’époqueimpériale, Paris .
B = B. B, Le anfore da trasporto, in La ceramica e i materiali di età romana. Classi,produzioni, commerci e consumi, a cura di D. G, Bordighera , –.
B = Z. B, Byzantine amphorae (th to th century) from Eastern Adriatic underwater sites,in AJug , , –.
B = Z. B, Ranosrednjovjekovni nalazi iz hrvatskog podmorja, in ArchAdriatica , ,–.
B = D. B, Gërmimet në teatrin antik t’Orikut, in StudimeHistor , , – (riass. infranc., Fouilles au theater antique d’Oricum, –).
B = D. B, Antigonée, in Iliria , , –.
B = D. B, La carte archéologique de la Vallée du Drino, in Iliria , , – .
B = D. B, Oricum à la lumière des données archéologiques, in Jadranska obala u proto-historiji: kulturni i etnicki problemi, Simpozij odrzan u Dubrovniku (–..), Zagreb ,–.
B = D. B, Foinike në kërkimet e reja arkeologjike, in Iliria ., , – (riass. infranc., Phoinicé à la lumière des recherches archéologiques récentes, –).
Abbreviazioni bibliografiche
B, H, S = H. B, H. H, S. S, GeophysikalischeProspektionen in der südlichen Unterstadt von Apollonia (Albanien), in RM , , –.
B = M. B, Sui rapporti tra Alto Adriatico e costa albanese (I secolo a.C. – I secolo d.C.), inB, S , –.
B = M. B, L’idea degli Illiri nella storiografia italiana e dell’Italia nordorientale dalla finedell’Ottocento al Novecento, in Illiri , –.
B = M. B, Etnogenetica balcanica, in Identità , –.
B, S = Progetto Durrës. L’indagine sui beni culturali albanesi dell’Antichità e del Medioevo:tradizioni di studio a confronto, Atti del primo incontro scientifico (Parma–Udine, – aprile), a cura di M. B, S. S (Antichità Altoadriatiche, LIII), Trieste .
B, S = Progetto Durrës. Strumenti della salvaguardia del patrimonio culturale: carta delrischio archeologico e catalogazione informatizzata. Esempi italiani ed applicabilità in Albania, Attidel secondo incontro scientifico (Udine–Parma, – marzo ) e Alte tecnologie applicateall’archeologia di Durrës, Atti del terzo incontro scientifico (Durrës, giugno ), a cura di M.B, S. S (Antichità Altoadriatiche, LVIII), Trieste .
B, B = H. e H. B, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien.Byzantiner, Normannen und Serben im Kampf um die Via Egnatia, Wien .
C = P. C, L’Épire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine (– av. J–.C.), Paris.
C = P. C, Les recherches archéologiques en Albanie dans les trente dernières années, inDialHistAnc , , –.
C = P. C, Notes sur les origines de l’intervention romaine sur la rive orientale de la merAdriatique, – avant J.–C, in Adriatico , –.
C = P. C, Recherches archéologiques en Albanie, –, in RA , –.
C = L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’antiquité, Actes du colloque international (Clermont–Ferrand, – octobre ), éd. P. C, Clermont–Ferrand .
C a = P. C, Le développement des villes en Illyrie méridionale à partir du e siècle avantJ.–C., in BAntFr , –.
C b = P. C, Les Illyriens de Bardylis à Genthios IVe–IIe siècles avant J.–C., Paris .
C = P. C, L’organisation de l’espace en Épire et Illyrie méridionale à l’époque classique ethellénistique, in DialHistAnc ., , –.
C = P. C, La montagne lie de vie et de rencontre en Epire et en Illyrie méridionale dansl’antiquité, in La montagne dans l’antiquité, éd. G. F, Pau , –.
C = L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’antiquité II, Actes du IIe colloque international(Clermont–Ferrand, – octobre ), éd. P. C, Paris .
C = P. C, Le monde hellénistique de la mort d’Alexandre à la paix d’Apamée (–),Paris .
C = P. C, La montagne, lieu de vie et de rencontre, en Épire et en Illyrie méridionale dansl’antiquité, in Gebirsland als Lebensraum, Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie desAltertums, (Stuttgart, –..), hrsg. E. O, H. S (Geographica Historica,), Amsterdam , –.
C a = P. C, Social and economic history of Epirus, in S , –.
C b = P. C, The growth of the city, in S , –.
Abbreviazioni bibliografiche
C c = P. C, Epirus in the Roman period ( B.C.– A.D.), in S ,–.
C d = P. C, Social, economic and cultural developments, in S , –.
C = P. C, Regards sur ans d’archéologie albanaise, in Iliria , , –.
C = L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’antiquité III, Actes du IIIe colloque international(Chantilly, – octobre ), éd. P. C, Paris .
C = P. C, Les ports d’Illyrie méridionale, in Z , –.
C a = P. C, La tradition de la migration troienne en Épire et en Illyrie mèridionale, inGreci in Adriatico , –.
C b = P. C, L’Illyrie à travers les historiens de l’Antiquité, in Points de vue sur les Balkans.De l’Antiquité à nos jours, éd. J.–L. L (Cahiers CRHIPA, ), Grenoble , –.
C – = P. C, L’œuvre de Léon Rey en Albanie (–), in Iliria .–, –,– (= Vepra e Leon Reyt në Shqipëri (–), –).
C = P. C, L’Épire et le royaume des Molosses à l’époque d’Alexandre le Molosse, inAlessandro il Molosso e i ‘condottieri’ in Magna Grecia, Atti del XLIII convegno di studi sulla MagnaGrecia (Taranto–Cosenza, – settembre ), Taranto–Napoli , –.
C = P. C, Les Chaones et l’Épire, de l’indépendance à l’association (Ve–IIe siècles avantJ.–C.), in D M, G , –.
C = P. C, Greek colonisation in the Adriatic, in Greek colonisation. An account of Greekcolonies and other settlements overseas, ed. G. T, II, Leiden–Boston , –.
C = P. C, Institutions politiques et développement urbain (IVe–IIIe s. avant J.–C.):reflexions historiques a partir de l’ Épire, in A , –.
C = P. C, Les diasporas grecques en Adriatique et dans la mer Ionienne (VIII–III s. av.J.–C.), in Les diasporas grecques. Du détroit de Gibraltar à l’Indus (VIIe s. av. J.–C. à la fin du IIIe s. av.J.–C.), éd. S. B, Saint–Just–la–Pendue , –.
C et alii = Carte archéologique de l’Albanie, éd. P. C, M. K, A. B, N. C,Tirana .
C, L = L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’antiquité IV, Actes du IVe colloqueinternational (Grenoble, – octobre ), éd. P. C, J–L. L, Paris .
C, K, T = S. C, A. K, F. T, Les routes de l’Adriatique antique.Géographie et économie / Putovi antickog Jadrana. Geografija i gospodarstvo, Bordeaux–Zadar .
C = D. L. C, The meaning of the veil in ancient Greek culture, in Women’s dress in theancient Greek world, ed. L. L–J, London , –.
C = Manuale di archeologia dei paesaggi. Metodologie, fonti, contesti, a cura di F. C, Roma.
C, C, K = Grcki utjecaj na istocnoj obali Jadrana / Greek influence along the EastAdriatic coast, Proceedings of the international conference (Split, September th–th ), ed.N. C, S. C, B. K, Split .
C = V. G. C, Presenze monetali in area albanese, in AnnInstItNum , , –.
C = M. G. C, Gli scavi di Piazza Castello, Palazzo Pignatelli a Spinazzola, in Storia diSpinazzola. Gli uomini, le cose, gli eventi. Le origini, a cura di L. B L, Martina Franca, –.
C = G. C, La politica estera dell’Italia fascista (–), Bari .
Abbreviazioni bibliografiche
C, P M, B = M.–B. C, S. P M, C. B, Leanfore da pesce adriatiche, in P M, C , –.
C = V. C, La ceramica grezza, in Testimonianze di epoca altomedievale a Benevento. Loscavo del Museo del Sannio, a cura di A. L, Napoli , –.
C = M. C, Le vocabulaire de la colonisation en grecque ancien. Étude lexicologique: lesfamilles de κτίζω et de οἰκέω–οἰκίζω, Paris .
C = M. C, Le vocabulaire du mélange démographique: mixobarbares et mixhellènes, inOrigines gentium, éd. V. F, S. G, Bordeaux , –.
C, L F, P = R. C, C. L F, L. P-, La ceramica in Puglia dal Tardoantico al Basso Medioevo tra Occidente e Oriente: nuovi dati, inItalia, Medio ed Estremo Oriente: commerci, trasferimenti di tecnologie e influssi decorativi tra BassoMedioevo ed età moderna, Atti del XL convegno internazionale della ceramica (Savona–AlbisolaMarina, – maggio ), Firenze , –.
C = S. C, Macedonia, Thrace and Illyria. Their relations to Greece from the earliest timesdown to the time of Philip, son of Amyntas, Oxford .
C = M. P. C, Il programma coloniale di Periandro: Potidea e l’Illiria Meridionale,in I Traci tra l’Egeo e il Mar Nero, a cura di P. S, Milano , –.
C = M. P. C, Cadmos–serpent en Illyrie. Itinéraire d’un héros civilisateur, Pisa.
C = M. P. C, La ‘voie hyperboréenne’ et Artémis. Réflexions sur le voyage, lanature et la destination des offrandes de Delos, in Forgerons, élites et vojageurs d’Homere a nos jurs, éd.M.–C. F, M. P. C, F. L L, Grenoble , –.
C et alii = F. C, M. D F, S. M, B. T, Prospezioni geofisiche(microgravimetria e sismica), in S, H, S , –.
C = N. C, Vuka antike mbi tjegulla në trevën ndërmjet Aosit dhe Genusit, in Iliria ., ,– (riass. in franc., Timbres antiques trouvés dans la contrée entre Aôos et Genusus, –).
C = N. C, Lindja e jetës qytetare tek ilirët e jugut, in Iliria ., , – (riass. in franc.,La naissance de la vie urbaine chez les Illyriens du sud, –).
C = N. C, Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes, Actesdu colloque de Cortone (– mai ), Pise–Rome , in Iliria ., , – (riass. in franc.,Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes, Actes du colloque de Cortone(– mai ), Pise–Rome , –).
C = N. C, Qyteti ilir pranë Selcës së Poshtme, Tiranë .
C = N. C, Le koinon des Billiones, in C , –.
C = N. C, Butrint. A Guide to the city and its monuments, London .
C = N. C, Ricerche nel settore delle antichità in Albania. Risultati e problemi, in B,S , –.
C a = N. C, Byllis. Its history and monuments, Tirana .
C b = N. C, Cesare in Acroceraunia: luoghi e tracce, in Illiri , –.
C c = N. C, The Illyrians to the Albanians, Tirana .
C = N. C, Nascita ed evoluzione dei centri urbani nell’Illiria del Sud, in D M et alii, –.
Abbreviazioni bibliografiche
C, Z = N. C, M. Z, Kërkime nënujore në vijën bregdetare dhe ujrat e brendshme tëvendit tonë, in Monumentet , , – (riass. in franc., Fouilles soumarines le long de la côte etdans les eaux de notre pays, –).
Ceramica medievale = La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, Atti del convegnointernazionale (Siena–Faenza, – ottobre ), Firenze .
C = G. C, L’Odissea epicorica di Itaca, in MedAnt ., , –.
C = C. A. C, Albania past and present, New York .
C a = E. C, Early Byzantine period (fourth–sixth centuries), in S ,–.
C b = E. C, Slavic invasions and settlements (sixth–seventh centuries), in S, –.
CIGIME = Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Epire, .. Inscriptions d’Epidamne–Dyrrhachion, dir. P. C (Etudes épigraphiques, ), Paris .
CIGIME = Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Epire, .. Inscriptions d’Apolloniad’Illyrie, dir. P. C (Etudes épigraphiques, ), Paris .
CIGIME = Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Epire, . Inscriptions de Bouthrôtos,dir. P. C (Etudes épigraphiques, ), Paris .
C, F = S. C, F. F, Le anfore romane di Opitergium, Cornuda .
C, M = S. C, S. M, Produzioni anforarie dell’Italia alto emedioadriatica in età romana, in Ceramica romana nella Puglia adriatica, a cura di C. S. F,Bari , –.
C = S. A. C, Epidamno tra Corinto e Corcira: Th., I, –, in L, F, –.
C = A. M. C, Luigi Maria Ugolini, in BCom , , .
Ç = D. Ç, Il sito fortificato di Malçani ed il Koinòn dei Caoni, in D M, G, –.
Ç et alii = D. Ç, E. G, M. P, A. G, La « Casa dei due peristili » e laripresa delle ricerche nel quartiere a terrazze di età ellenistica, in D M, G , –.
Ç, P = D. Ç, R. P, Hadrianopolis (Sofratikë – AL), nascita e sviluppo della cittàsulla base delle recenti indagini archeologiche, in D M et alii , –.
C, D = G. C, J.–P. D, Alcuni risultati preliminari degliscavi albano–svizzeri – sul sito di Orikos–Oricum, in D M a, –.
C = A. C, I nomi dell’Adriatico, in Greci in Adriatico , –.
C = G. C, Cenni generali intorno ad un viaggio nella bassa Albania, Epiro ed a Tripoli diBarberia, Torino .
C, M = A. C, S. M, Erodoto. Le Storie. Libro IV. La Scizia e la Libia,Milano .
C = F. C, Antichi viaggi per mare, Pordenone .
C = P. C, Le Périple du Pseudo–Scylax et l’Adriatique, § –, in C, K,T , –.
CRA = S. S, A. H, A. M, E. S, Carta del rischio archeologico della città di Durrës/ Harta e rrezikut arkeologjik e Qytetit te Durrësit, Durrës .
Abbreviazioni bibliografiche
CRA = S. S, A. M, A. H, E. S, Repertorio dei rinvenimenti archeologici: database e carte tematiche, in B, S , – e CD allegato.
Creta antica = Creta antica. Cento anni di archeologia italiana (–), catalogo della mostra,Roma .
C = F. C, Porti, approdi e traffici nello spazio marittimo ionico–adriatico tra VIe IV sec. a. C. Un saggio sull’applicazione della network analysis, tesi di dottorato, Università delSalento – Lecce, .
C = A. C, Venetian Butrint, Rome .
C G = E. C G, Eschilo e l’Occidente, in E. C G, G.V, L. B, I Tragici greci e l’Occidente, Bologna , –.
C et alii = A. C, A. G, G. L, B. M, La necropoli e le areelimitrofe, in D M, G , –.
C = S. C, Architecture in the Balkans. From Diocletian to Suleyman the Magnificent, NewHaven (CT) .
C, C = O. C, U. C, Restauration et installation de trois mosaiques au MuséeHistorique Nationale, in Monumentet , , –.
C = F. A. C, L’insediamento tra VIII e XI secolo. Strutture, oggetti, culture, in Il Castello diSanta Severina, II. Ricerche archeologiche, a cura di R. S, Soveria Mannelli , –.
D’A = E. D’A, Glazed White Ware in the Italian peninsula: Proposals for a study, inB–A, U, W–O , –.
D’A = F. D’A, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in Salento arcaico,Atti del colloquio internazionale (Lecce, – aprile ), Galatina , –.
D’A = F. D’A, Ricerche archeologiche nel Salento, in Siris e l’influenza ionica in Occidente,Atti del XX convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, – ottobre ), Taranto–Napoli, –.
D’A = F. D’A, Il Salento nell’VIII e VII sec. a.C.: nuovi dati archeologici, in ASAtene , n.s. , , –.
D’A = F. D’A, Nuovi dati sulle relazioni fra Daunia e Messapia, in Studi in onore di DinuAdamesteanu, Galatina , – (= Atti del III convegno sulla preistoria, protostoria, storia dellaDaunia (San Severo, – novembre ), San Severo , –).
D’A = F. D’A, Nuovi dati sulle relazioni tra gli Illiri e le popolazioni dell’Italia meridionale,in Iliria ., , – (riass. in alban., Të dhëna të reja për lidhjet ndërmjet Ilirëve dhe popullatave tëItalisë së jugut, –).
D’A = F. D’A, Problèmes du commerce archaïque entre la Mer Ionienne et l’Adriatique, inC , –.
D’A = F. D’A, Documenti del commercio arcaico tra Ionio ed Adriatico, in Magna Grecia, –.
D’A = Castrum Minervae, a cura di F. D’A, Galatina .
D’A, W = Excavations at Otranto, II: The finds, a cura di F. D’A, D. B.W, Galatina .
D = B. D, La cité illyrienne de Dimale, in Iliria , , –.
D = B. D, Një rrugë kryesore në Apolloni, in Monumentet –, , – (riass. in franc.,Une rue principale à Apollonia, –).
D = B. D, Dimale à la lumière des données archéologiques, in Iliria , , –.
Abbreviazioni bibliografiche
D – = B. D, Vështrim mbi rrjetin rrugor antik të zbuluar në Apoloni, in Iliria ,–, – (riass. in franc., Une des rues principales d’Apollonia, –).
D = M. D, Epicorum Graecorum Fragmenta, Göttingen .
D = J. K. D, A wholly non–Aristotelian universe: The Molossian as ethnos, state andmonarchy, in Alternatives to Athens, ed. R. B, S. H, Cambridge , –.
D et alii = J. L. D, A. H, I. P, S. R. S, A. D. W, P. E. A,J. W. H, The Durrës Regional Archaeological Project: Archaeological survey in the territory ofEpidamnus/Dyrrachium in Albania, in Hesperia , , –.
D B = A. D B, L’epica perduta. Eumelo, il Ciclo, l’Occidente (Hesperìa, ), Roma .
D B = A. D B, Esiodo e l’Occidente (Hesperìa, ), Roma .
D G = E. D G, L’Epiro. Relazione d’un viaggio da Gianina a Valona, Roma.
D G = E. D G, Cenni sull’Epiro e sulla sua nuova carta, Roma .
D = E. D, La Géographie dans les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes, Bordeaux–Paris.
D C = P. D C, The Cetina group and the transition from Copper to Bronze Age inDalmatia, in Antiquity , , –.
D et alii = O. D, J.–L. L, P. L, F. Q, A. S, S. V,B. V, La ville haute d’Apollonia d’Illyrie: étapes d’une recherche en cours, in B–A, –.
D M a = S. D M, Il sito, la città, la storia, in D M, G , –.
D M b = S. D M, Scavi e ricerche a Phoinike: da Luigi M. Ugolini agli anni Novanta delNovecento, in D M, G , –.
D M c = S. D M, Il «Thesauròs»: una revisione, in D M, G , –.
D M = S. D M, La Missione Archeologica Italiana a Phoinike, in B, S ,–.
D M – = S. D M, Léon Rey, Luigi Ugolini e le origini dell’archeologia albanese, in Iliria.–, –, – (= Léon Rei, Luigi Ugolini dhe origjinat e arkeologjisë shqipëtare, –).
D M = S. D M, Nuove ricerche archeologiche nella città e nel territorio di Phoinike, inC, L , –.
D M = S. D M, Ricerche e scavi archeologici a Phoinike (Epiro), in ASAtene , s. III.,, –.
D M = S. D M, Butrinto e Fenice a confronto, in Roman Butrint. An assessment, ed. I. L.H, R. H, Oxford , –.
D M = S. D M, Phoinike d’Epiro in età ellenistica, in ArchAdriatica , , , .
D M = S. D M, Genesi e sviluppo della città nella Caonia antica. Nuovi dati dagli scavi diPhoinike, in D S S, I , –.
D M a = S. D M, Le ricerche delle missioni archeologiche in Albania. Nella ricorrenzadei dieci anni di scavi dell’Università di Bologna a Phoinike (–), Atti della giornata di studi(Bologna, novembre ), a cura di S. D M, Bologna .
D M b = S. D M, Dieci anni di attività archeologiche a Phoinike. Ricerca, formazione,valorizzazione, in D M a, –.
Abbreviazioni bibliografiche
D M c = S. D M, La ricerca archeologica fra Italia e Albania: un secolo di collaborazioni, inB , –.
D M et alii = S. D M, D. Ç, A G, M. P, R. V, Prosecuzionedelle ricerche al teatro, in D M, G , –.
D M et alii = S. D M, G. L, B. M, F. T, La necropoli meridionale, in DM, G , –.
D M, G = S. D M, E. G, Note sull’urbanistica di Phoinike, in D M,G , –.
D M, G = Phoinike I. Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche , acura di S. D M, S. G, Firenze .
D M, G = Phoinike II. Rapporto preliminare sulla campagna di scavi e ricerche , acura di S. D M, S. G, Bologna .
D M, G = Phoinike III. Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche–, a cura di S. D M, S. G, Bologna .
D M, G = Phoinike IV. Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche–, a cura di S. D M, S. G, Bologna .
D M, G = Phoinike V. Rapporto preliminare sulle campagne di scavi e ricerche –,a cura di S. D M, S. G, Bologna .
D M, G = S. D M, S. G, Vitruvio e la Casa dei due peristili a Phoinike, inOcnus , , –.
D M, G, P = S. D M, E. G, G. P, Osservazioni sulle stele funerarieellenistiche di Phoinike, in D M, G , –.
D M, M = S. D M, L. M, Testimonianze e riflessioni sul culto di Artemide aPhoinike, in B–A , –.
D M, P = S. D M, M. P, La basilica paleocristiana di Phoinike (Epiro): dagliscavi di Luigi M. Ugolini alle nuove ricerche, in Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneoorientale (IV–X secolo): il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche, Atti delconvegno internazionale (Bologna, – novembre ), a cura di R. F C et alii,Bologna , –.
D M, R = S. D M, S. R, Scavi e ricerche a Phoinike: da Luigi M. Ugoliniagli anni Novanta del Novecento, in D M, G , –.
D M, V, Ç = S. D M, R. V, D. Ç, Urbanistica e aree monumen-tali di Phoinike, in L, C a, –.
D M et alii = I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica, ed. G. D M,G. M. F, G. P, R. P, M. S (BAR Int. Ser., ), Oxford .
D = E. D, Cicéron et les hommes d’affaires romains d’Illyrie e d’Epire, in C ,–.
D = Le Canal d’Otrante et la Méditerranée antique et médiévale, Actes du colloque (Paris,– novembre ), éd. E. D, Bari .
D’E = M. C. D’E, Archeologia e politica fascista in Adriatico, in AnnPisa s. V, ., ,–.
D S S, I = Sulla rotta per la Sicilia: l’Epiro, Corcira e l’Occidente, a cura di G. DS S, M. I, Pisa .
D S c. s. = A. D S, The limestone quarries of Karaburun peninsula (Southern Albania), inAsmosia , c. s.
Abbreviazioni bibliografiche
D F et alii = M. D F, M. D N, F. C, S. M, S. S,Anfiteatro romano di Durazzo: rilievi geofisici ed emergenze geologiche, in Attività, studi e ricerchegeo–archeologiche in campo internazionale, a cura di F. A, in Geo–Archeologia ., –.
D, L, Q = Apollonia d’Illyrie, . Atlas archéologique et historique, éd. V. D, P.L, F. Q (Coll. École française de Rome, ), Rome .
D N = E. D N, Mussolini e la politica estera italiana (–), Padova .
D, M = G. D, M. M, Progetto Liburna. Archeologia subacqueain Albania (Campagna ). Parte II, in ASub, ., , –.
D V = A. D V, –: cento anni di archeologia italiana a Creta, in Creta antica ,–.
D = A. D, Al fianco di Ugolini: le memorie di Dario Roversi Monaco, in Archeologo ,–.
D’O = M. D’O, Roma e Aquisgrana, Roma .
D = F. D, Les iscriptions de Grammata, in C , –.
D = A. D, L’Albanie entre Orient et Occident aux XIe et XIIe siécles. Aspects politiqueset économiques, in CahCivilisMediévale , , –.
D = A. D, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Age. Durazzo et Valona du XIe
au XVe siècle, Thessalonique .
D–M et alii = M. D–M, S. H–H, S. G, B. M,A. M, E. S, F. T, I. T, Artémis à Dyrrhachion. Guides de Durrës , Tiranë .
D, F, N = D. D, A.–M. F, G. N, A propos decéramique ‘RMR’: problèmes de définition et classement. Problèmes de répartition, in Ceramica medievale, –.
D = P. D, Archaic East Greek trade amphoras, in R. C, P. D, East Greekpottery, London , –.
D = P. D, Lesbiaca I. Données archéologiques préliminaires sur les amphores du type deLesbos, in Synergia pontica & aegeo–anatolica, éd. P. D, V. L, Galati , –.
D = M. E. D, High Albania and its customs in , in JournRoyalAnthropInstGreatBri-tainIreland , , –.
D = D. D, Welcome to the Mediterranean semi– periphery: The place of Illyricum in book ofStrabo, in ŽivaAnt , , –.
D = D. D, Deconstructing ‘Illyrians’: Zeitgeist, changing perceptions and the identity ofpeoples from ancient Illyricum, in CroatianStudiesRev , , –.
D = D. D, Illyricum in Roman politics, BC–AD , Cambridge .
D = D. D, Contesting identities of Pre–Roman Illyricum, in AncWestEast , , –.
F = P. F, La date de la rédaction du Périple de Scylax, in EtCl , , –.
F C = M. F C, I monasteri bizantini in Italia meridionalee Sicilia fra tradizione e innovazione. Studio preliminare, in Dall’habitat rupestre all’organizzazioneinsediativa del territorio pugliese (secoli X–XV), Atti del III convegno internazionale sulla civiltàrupestre (Savelletri di Fasano, BR, – novembre ), a cura di E. M, Spoleto ,–.
F C = M. F C, Gioco di specchi. I clipei dell’Exultet di Bari e leloro associazioni, in Tempi e forme dell’Arte. Miscellanea di studi offerta a Pina Belli D’Elia, a cura di L.D, C. G, Foggia , –.
Abbreviazioni bibliografiche
F = U. F, Tucidide. La guerra del Peloponneso. Libro II, Pisa .
F = P. F, San Lorenzo in Carminiano: studio preliminare della ceramica raccolta in superficie(ricognizione ), in Fiorentino. Campagne di scavo –, Galatina , –.
F = A. F, Sanctuaries marins du Canal d’Otrante, in D , –.
F T = F. F T, La cosiddetta ‘Riforma Euclidea’, in Epigrafica , ,– .
F = A. F, Il viaggio missionario in Albania nel secolo XVII, in S, R ,–.
F = E. F, Das Theater in Megalopolis (Antike griechische Theaterbauten, ),Stuttgart .
F et alii = M. F, S. F, S. G, H. H, V. H, B. L, S.–P.P, F. Q, E. S, B. S–R, Neue Forschungen zum hellenistisch–römischenTheater von Apollonia (Albanien), in RM , , –.
F = G. F, Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens,de à av. J.–C. environ. Premier bilan (BAR Int. Ser., ), Oxford .
F = K. F, Barbaren–Köpfe. Zur Imitation Alexanders der Grosse in der mittlerenKaiserzeit, in The Greek renaissance in the Roman empire, Papers from the tenth British Museumclassical colloquium (London, ), ed. S. W, A. C (BICS Suppl., ), London ,–.
F et alii = B. P. F, M. C. H, D. P. K, T. A. T, Aspects ofancient Greek trade re–evaluated with amphora DNA evidence, in JASc ., , –.
F, R = E. F, I. R, Evocation des fouilles d’Apollonia en Albanie –, in Virtual Retrospect , éd. R. V, C. D (Archéovision, ), Bordeaux ,–.
F = E. F, Dynamiques paléo–environmetales en Albanie à l’Holocène, in L’Albanie dansl’Europe préhistorique, Actes du colloque (Lorient, – juin ), éd. G. T, J. R(BCH Suppl., ), Athènes–Paris , –.
F et alii = E. F, G. G, S. M, P. N, L. D, Dynamique géomorpholo-gique et évolution de la navigation maritime depuis l’antiquité dans les deltas du Seman et de la Vjosë(Région d’Apollonia, Albanie), in Z , –.
F – = L. C. F, Centrality in social networks conceptual clarification, in SocialNet-works , –, –.
F = F. F, I Greci e la Puglia meridionale in età arcaica, in Greci in Adriatico ,–.
F = F. F, Ionios Poros: storie, rotte e percorsi nella genesi di uno spazio geografico, inHesperìa, , Roma , –.
F, L = F. F, M. L, Periferie? Sicilia, Magna Grecia, Asia Minore, inStoria d’Europa e del Mediterraneo. Il mondo antico . La Grecia. . Grecia e Mediterraneo dall’VIII sec.a.C. all’età delle guerre persiane, a cura di M. G, Roma , –.
F, M, H = P. F, N. M, B. H, Epeiros, in H,N , –.
G et alii = Between the Aegean and Baltic Seas. Prehistory across borders, Proceedings of theinternational conference (Zagreb, – April ), ed. I. G, H. T, Y. G, R.L (Aegaeum, ), Liege–Austin .
G = A. G, L’Albania, Roma .
Abbreviazioni bibliografiche
G = A. G, L’Albania nei suoi rapporti con la storia e la civiltà d’Italia, Città di Castello.
G = M. G, Die Lebenswelt eines Sophisten. Untersuchungen zu den Bauten und Stiftungen desHerodes Atticus, Mainz .
G = A. G, Ceramiche a vernice nera di Phoinike: considerazioni tipologiche ecronologiche, in Ocnus , , –.
G = A. G, Le ceramiche a vernice nera di Phoinike (Albania meridionale). Aspetticronologici ed economico–produttivi, in ReiCret Fautores , –.
G, V = A. G, E. V, Aspetti economico–produttivi di Phoinike edel suo territorio in età ellenistica attraverso lo studio dei reperti ceramici, in L, C a, –.
G V, B C = E. G V, D. B C, Ánforas de la Bética,in Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión, a cura di D. B C, A. R L, Cádiz , –.
G a = V. G, Fabrics of the North Aegean Area, in FACEM (version ..: http://www.facem.at/project--papers.php).
G b = V. G, Fabrics from Chios, in FACEM (version ..: http://www.facem.at/project--papers.php).
G = G. G, Ugolini e il suo tempo, in Archeologo , –.
G = S. G, Ceramiche e commerci nel Mediterraneo orientale nel Tardo Medioevo (XII–XIII secolo), in La Grecia insulare tra Tardoantico e Medioevo, XXXVIII Corso di cultura sull’arteravennate e bizantina (Ravenna, – marzo ), Ravenna , –.
G = La ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l’Italia, Atti delseminario (Certosa di Pontignano, Siena, – marzo ), a cura di S. G, Firenze .
G = Atti del IX congresso internazionale sulla ceramica medievale nel Mediterraneo (Venezia,– novembre ), a cura di S. G, Firenze .
G, H = From one sea to another. Trading places in the European and Mediterranean EarlyMiddle Ages, Proceedings of the III international SAAME conference (Comacchio, th–thMarch ), ed. S. G, R. H, Turnhout .
G, N = La circolazione delle ceramiche nell’Adriatico tra Tarda antichità e Altomedioevo,Atti del III incontro di studio CER.AM.IS. (Venezia, – giugno ), a cura di S. G, C.N, Mantova .
G = E. G, Fascismo di pietra, Roma–Bari .
G = G. G, La Venezia Giulia agli albori della Storia, in MemStorForogiuliesi ,–.
G = E. G., s.v. Tellus, in LIMC VII, , Zürich–München , –.
G, G = P. G, A. G, Rilievo e studio architettonico, in S,H, S ,–.
G = A. G, L’Albania dall’indipendenza all’unione con l’Italia (–), Varese.
G, V = Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, a cura di A. G, A.V, Bari .
G = G. Q. G, Luigi Maria Ugolini VIII Settembre MDCCCXCV–IV Ottobre MCMXXXVI,Roma , edizione privata.
Abbreviazioni bibliografiche
G a = The Theatre at Butrint. Luigi Maria Ugolini’s excavations at Butrint – (Albaniaantica, IV), ed. O. J. G, London .
G b = O. J. G, Luigi Maria Ugolini and the Italian Archaeological Mission to Albania, inG a, –.
G – = O. J. G, The rivals? Leon Rey, Luigi Ugolini and their predecessors, in Iliria .–,–, – (= Rivalët? Leon Rey, Luigi Ugolini dhe paraardhësit e tyre, ).
G et alii = O. G, A. C, R. H, K. L, J. V, Medieval Butrint:Excavation at the Triconch Palace –, in AMediev , , –.
G, L = O. G, K. L, Excavations at the Triconch Palace, in H, B, L, –.
G, M = O. J. G, L. M, The myth of Aeneas, the Italian Archaeological Mission inAlbania, –, in PublicArch , , –.
G, M = O. J. G, L. M, The Ugolini Archive: Surviving documents relating to theItalian Archaeology Mission to Albania and their location, in G a, –.
G, P = O. J. G, B. P, Bibliography of the Italian Archaeological Mission, in G a, –.
G = E. G, Ricerche e ricognizioni nel territorio, in D M, G , –.
G = E. G, Osservazioni sul rilievo degli elevati e sulle tecniche costruttive, in D M,G , –.
G a = E. G, Il sistema Phoinike: nuove acquisizioni dal rilievo topografico del sito edall’analisi cartografica del territorio, in C, L , –.
G b = E. G, Analisi preliminare sull’appoderamento agrario di due centri romani dell’Epiro:Phoinike e Adrianopoli, in AgriCentur , , –.
G = E. G, Problemi metodologici per lo studio del paesaggio antico. Considerazioni sulterritorio di Phoinike in epoca romana, in B, H , –.
G, B = E. G, J. B, Ultime ricerche nella valle del Drinos, in G,V, B , –.
G, B a = E. G, J. B, Un sito rustico nel territorio di Phoinike: l’insediamentodi Matomara, in D M, G , – .
G, B b = E. G, J. B, I siti d’altura nel territorio di Phoinike. Un contributo alpopolamento della Caonia in età ellenistica, in Ocnus , , –.
G, B = E. G, J. B, Il territorio di Phoinike in Caonia. Archeologia delpaesaggio in Albania meridionale, Bologna .
G et alii = E. G, M. P, D. Ç, F. B, Conclusione degli scavi nella Casa deidue peristili, in D M, G , –.
G et alii = E. G, M. P, A. M, F. B, M. S, L’edificio a portico delquartiere a terrazze, in D M, G , –.
G, V, B = Nuove ricerche archeologiche in Albania meridionale a ottanta annidai primi scavi di Phoinike (–), Atti del seminario internazionale (Acquaviva Picena, –novembre ), in Archeologia tra Piceno, Dalmazia ed Epiro (Groma, ), a cura di E. G, E.V, J. B, Bologna .
G = I. G, Nga muzeu arkeologjik–etnografik tek muzetë e profilizuar arkeologjik, in Iliria, .–, – (riass. in ingl., New horizons, –).
Abbreviazioni bibliografiche
G – = I. G, Kërkime prehistorike në Shqipërinë Jugperëndimore, in Iliria , –,– (riass. in ingl., Prehistoric research in the Southwestern Albania, –).
G = S. G, Nuovi dati numismatici da Phoinike (scavi –), in D M,G , –.
G = S. G, La circolazione delle monete a Phoinike, in D M, G ,–.
G = S. G, Storia delle ricerche archeologiche a Phoinike, in D M a, –.
G = A. W. G, A historical commentary on Thucydides, I, Oxford .
G = M. G, Who are the Illyrians? The use and abuse of Archaeology in the construction of nationaland trans–national identities in the Southwestern Balkans, in Archaeology and the (de)construction ofnational and supra–national polities, ed. R. Ó R, C. N. P, in ArchRewCambridge ., ,–.
G = R. E. A. G, Archaeology and the social history of sheeps, Cambridge .
G = S. G, Networks, agent–based models and the Antonine Itineraries. Implications forRoman archaeology, in JMedA , , –.
G = M. G, Plus de vin, moins d’huile? Retour sur les amphores corinthiennes dans la Méditerranéedu VIIe s., in La Méditerranée au VIIe s. av. J.–C., éd. R. E, Paris , –.
G, T, B = M. G, H. T, H. B, Mégara Hyblaea . La ville archaïque,Rome .
Greci in Adriatico = I Greci in Adriatico, , Atti del convegno internazionale (Urbino, – ottobre) (Hesperìa, ), Roma .
G = T. E. G, Local and imported medieval pottery from Isthmia, in G ,–.
G, K = T. E. G, P. N. K, Geophysical and surface surveys in theByzantine Fortress at Isthmia –, in Hesperia , , –.
G, G, M = G. C. G, E. G, V. M, Caratterizzazione minero–petrografica del materiale lapideo utilizzato nelle costruzioni di età ellenistica e romana, in D M,G , –.
G, V = E. G, S. V, Le prospezioni geosismiche, in B, P P, –.
G = M. G, L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Roma .
G = I terremoti prima del Mille in Italia e nell’area mediterranea. Storia, archeologia,sismologia, a cura di E. G, Bologna .
G, C = Catalogue of earthquakes and tsunamis in the Mediterranea area from theth to the th century, a cura di E. G, A. C, Bologna .
G, C, T = E. G, A. C, G. T, Catalogue of ancientearthquakes in the Mediterranean area up to the th century, Roma .
G = N. G, Recherches sur les amphores byzantines dans les musées turcs, in Recherches, –.
G = N. G, Les amphores byzantines (X–XIII siècles): typologie, production, circulationd’apres le collections turques, Paris .
G = N. G, L’épave di Camalti Burnu I (île de Marmara, Proconnèse): resultats desannées –, in AnatAntiqua , , –.
Abbreviazioni bibliografiche
G = N. G, Ganos wine and its circulation in the th century, in Byzantine Trade,th–th Centuries. The archaeology of local, regional and international exchange, Papers of the thirty–eighth spring symposium of Byzantine studies (Oxford, March ), ed. M. M M,Farnham , –.
G = E. G, Approvvigionamento e uso della pietra in Phoinike ellenistica e romana. Dati econsiderazioni dalle analisi litologiche, in D M, G , –.
G, H, H = A. G, A. H, H. R. H, The walled town of Dyrrachium(Durrës): settlement and dynamics, in JRA ., , –.
H = W. H, Dinasti latini in Grecia e nell’Egeo (secoli XII–XVII), Torino .
H et alii = A. H, J. R, S. S, P. C, Les inscriptions de Grammata(Albania), in REG , , –.
H = J. F. H, Byzantium. A history, Stroud .
H = H. H, Itinera principium. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen imrömischen Reich, Stuttgart .
H = J. M. H, Ethnic identity in Greek antiquity, Cambridge .
H = J. M. H, Contested ethnicities: Perceptions of Macedonia within evolving definitions ofGreek ethnicity, in M a, –.
H = J. M. H, Hellenicity: Between ethnicity and culture, Chicago .
H = N. G. L. H, Epirus. The geography of the ancient remains, the history and thetopography of Epirus and adjacent areas, Oxford .
H = N. G. L. H, The Illyrian Atintani, the Epirotic Atintani and the Romanprotectorates and North–West Greeks, in JRS , , –.
H = N. G. L. H, Illyrians and North–West Greeks, in The Fourth Century B.C. (CAHVI), ed. D. M. L, J. B, S. H, M. O, Cambridge , –.
H = M. H. H, Hekataios’ use of the word polis in his Periegesis, in Yet more studies in theancient Greek polis, ed. T. H N, Stuttgart , –.
H, N = M. H. H, T. H. N, An inventory of archaic and classical poleis,Oxford .
H = A. H, Economic expansion in the Byzantine Empire –, Cambridge .
H = M. H, Les limites de l’expansion macèdonienne en Illyrie sous Philippe II,in C , – .
H = M. H, Le probléme des Atintani et le peuplement de la vallée de l’Aoos, inC , –.
H = M. H, Nouvelles données sur le déclin de la cité d’Apollonia, in L,C a, –.
H = J. W. H, Pottery: stratified groups and typology, in Excavations at Carthage , conductedby the University of Michigan, I, ed. J. H. H, Tunis , –.
H = J. W. H, The Villa Dionysos Excavations, Knossos. The pottery, in BSA , , –.
H = J. W. H, Excavations at Saraçhane in Istanbul II. The pottery, Princeton (NJ) .
H = W. H, Studien über die älteste italische Geschichte, in Hermes , , –.
H = D. H, Gli scavi al foro, in G, V, B , –.
H = L. H, La ville d’Oricum et le sanctuaire des Dioscures dans les monts Acrocérauniens,in CRAI ., , –.
Abbreviazioni bibliografiche
H = L. H, Les operations militaires de Jules César, Paris .
H, D = L. H, H. D, Mission archéologique de Macédonie, Paris .
H = H. H, Gërmime në nekropolin e Dyrrahut – Kodrat e Dautës (viti ), in Iliria ., ,– (riass. in franc., Fouilles de dans la necropole de Dyrrah (Secteur des colines de Dautës),–).
H = S. H, Materiale arkeologjike nga bazilika e Arapajt, in Iliria .–, , – (riass.in franc., Materiaux archéologiques provenant de la basilique d’Arapaj, ).
H, F, c. s. = V. H, S. F, The architecture of the Greek theatre of Apollonia in Illyria(Albania) and its transformation in Roman times, in The architecture of the ancient Greek theatre,Proceedings of the international conference (Athens, January – ), forthcoming.
H = R. H, The rediscovery of Butrint (Albania). A microcosm of Mediterranean history, inApollo , July, –.
H = R. H, Eternal Butrint. A Unesco World Heritage site in Albania, London .
H = R. H, The rise and fall of Byzantine Butrint / Shkëlqimi dhe rënia e Butrintit bizantin,London–Tirana .
H, B, L = R. H, W. B, K. L (ed.), Byzantine Butrint. Excavationsand surveys –, Oxford .
H et alii = R. H, S. K, M. L, J. V, The sack of Butrint, c. AD , inAntiquity , (project gallery: http:// antiquity.ac.uk/projgall/hodges).
H, M = R. H, S. M, The making of the Butrint National Park –, inLa tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto, a cura di F. M, Napoli , –.
H, V = R. H, J. V, Late Antique and Early Medieval ceramics from Butrint,Albania, in G, N , –.
H, P = P. H, N. P, The Corrupting Sea: A study of Mediterranean history,Oxford .
H = B. H, The phenomenon of Mattpainted pottery in the Northern Aegean. Introduction,overview and theories, in Aegean and Balkan Prehistory, ed. P. P, B. H, (http://www.aegeobalkanprehistory.net/article.php?id_art=).
H = S. H, A commentary on Thucydides, I: Books I–III, Oxford .
H = A. H, Some features of the Early Medieval pottery in Albania (th–th centuries), in B, –.
H = A. H, Epidamnos–Dyrrahachion, Tiranë .
H, B = A. H, P. B, Notizie preliminari sul rinvenimento di un deposito di grossiragusei nell’anfiteatro di Durazzo, in S, H, S , –.
H et alii = A. H, E. M, B. S, J. W, The Early Byzantine circular forumin Dyrrachium (Durrës, Albania) in and –: Recent recording and excavation, in BSA ,, –.
H, M, S = A. H, E. M, E. S, Gërmime arkeologjike Durrës –,in Candavia , , – (riass. in franc., Campagnes de fouilles: Durrës –, –).
H, S c. s. = Dyrrachium II. Scavi d’emergenza nella città di Durazzo –, a cura di A.H, S. S, c. s.
H, S = A. H, A. S, Notizie attorno ai bacini murati nelle chiese medievali in Albania, in Ibacini murati medievali. Problemi e stato della ricerca, Atti del XXVI convegno internazionale dellaceramica (Albisola, – maggio ), Firenze , –.
Abbreviazioni bibliografiche
H = Otranto nel Medioevo tra Bisanzio e l’Occidente, a cura di H. H, Galatina .
H, W = W. W. H, J. W, A commentary on Herodotus, Oxford .
H = S. H, La Dame au Polos thasienne. Établissement d’une série, in M a, –.
H = S. H, Terres cuites animales dans les nécropoles grecques archaïques et classiquesdu bassin méditerranéen, in Figurines animales des mondes anciens, Actes de la journée d’études(Lille, juin ), éd. B. G, A. M, D. P, in Anthropozoologica , , –.
H–H = S. H–H, La mort avant le mariage. Superstitions et croyances dansle monde grec à travers les images en terre cuite déposées dans les tombes d’enfants et de jeune gens, inCroyances populaires. Rites et représentations en Méditerranée orientale, Actes du colloque (Lille, –décembre ), èd. C. B, C. E, T. M, A. M, Athènes , –.
H–H = S. H–H, Les figurines en terre cuite de l’Artèmision de Thasos.Artisanat et piété populaire à l’époque de l’archaïsme mûr et récent (Études thasiennes, ), Athènes.
H–H, M = S. H–H, A. M, Déesses et/ou mortelles dans laplastique de terre cuite. Réponses actuelles à une question ancienne, in Pallas , –
H, I = V. H, A. I, Carte antiche d’Albania. Un viaggio nella memoria, in S,R , –.
ICCROM = Regional course on archaeological conservation for Southeast Europe: Diagnosis andconservation, – October .
Identità = Le identità difficili. Archeologia, potere, propaganda nei Balcani, in PortolAdriatico ., .
Illiri = Gli Illiri e l’Italia, Atti del convegno internazionale di studi (Treviso, ottobre ),Treviso .
I a = Foundation and destruction. Nikopolis and Northwestern Greece. The archaeologicalevidence for the city destructions, the foundation of Nikopolis and the synoecism, ed. J. I, Athens.
I b = J. I, Eremia in Epirus and the foundation of Nikopolis, in I a, –.
I = S. I, La ville illyrienne à Zgërdhesh de Krujë, in Iliria , , –.
I = S. I, Koka e «Hyjneshës» së Butrintit u ktyhe në atdhe / La tête de la «déesse» de Butrintretournée à sa patrie, in Iliria ., , –.
I, C = S. I, H. C, Nouvelles données sur l’antiquité illyrienne en Albanie, in StAlb ,, –.
J = A. J, Une mention d’Ugento dans la Chronique de Skylitzès, in REByz , , –.
J = D. J, Changing economic pattern in Latin Romania: The impact of the West, in TheCrusades from the perspective of Byzantium and the Muslim world, ed. A. E. L, R. P. M,Washington D.C.–Dumbarton Oaks (WA) , –.
J S S = La politica dell’Italia in Albania nelle testimonianze del Luogotenente delRe Francesco Jacomoni di San Savino, Bologna .
J = S. J, The Archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past and present, London.
J = L. J, Cooking pots as indicators of cultural change: A petrographic study of Byzantineand Frankish cooking wares from Corinth, in Hesperia , , –.
J = B. J, Germime ne¨ tumat nr. dhe të Fushës së Shtojit, in Iliria .–, , –(riass. in franc., Fouilles des tumulus et de la plaine de Shtoi, –).
Abbreviazioni bibliografiche
Julia Felix = AA.VV., Operazione Julia Felix. Lo scavo subacqueo della nave romana rinvenuta al largodi Grado, Mariano del Friuli .
K = Z. K, Archaeological research and researchers in Albania, in BALond , , –.
K = Z. K, Nga historiku i muzeve dhe koleksioneve arkeologjike në Shqipëri, inArkeologjia , , –.
K, A = L. K, R. A, Zonifikimi arkeologjik i qytetit të Durrësit me anën emetodave gjeofizike, in Iliria ., , –.
K = O. K, LR: a container for the military annona on the Danubian border?,in Economy and exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity, Proceedings of theconference (Oxford, th May ), ed. S. K, M. D, Oxford , –.
K = G. K, Identifikimi i stacionit rrugor ‘Akrokeraunia’, in Monumentet , ,– (riass. in ingl., The identification of the road station ‘Akrokeraunia’, –).
K = V. K, Epirus in the Roman period, in I a, –.
K = A. K, Il trattato del ottobre fra Filippo I di Taranto e Giovanni IOrsini di Cefalonia per la conquista dell’Epiro, in ASP , , –.
K = A. K, I Principi di Taranto e la Grecia (–/), in ASP , ,–.
K–D = I. K–D, Die Schwerter in Griechenland (außerhalb Der Peloponnes),Bulgarien und Albanien (PBF, ), Stuttgart .
K = B. K, The Greeks in Central Dalmatia: Some new evidence, in Greek colonists andnative populations, Proceedings of the first Australian congress of classical archaeology in honourof A. D. Trendall (Sidney, July – ), ed. J.–P. D, Canberra–Oxford .
K = E. K, Dulcia Bacchi munera quae Gaza crearat,/quae fertilis Africa mittit. Com-mercio del vino in epoca protobizantina (s. IV–VI), in L’avventura del vino nel bacino del Mediterraneo.Itinerari storici ed archeologici prima e dopo Roma, Atti del simposio internazionale (Conegliano, settembre – ottobre ), a cura di D. T, C. C, Treviso , –.
K = A. B. K, Archaeology and Ethnicity: A dangerous liason, in KypA , , –.
K = C. K, An archaeology of interaction. Network perspectives on material culture andsociety, Oxford .
K = J. K, Fortifikimet parahistorike në bregdetin kaon, in Iliria .–, , – (riass. infranc., Les fortifications préhistoriques de la côte chaonienne, ).
K = C. G. K, Corinth A and B Transport Amphoras, Ph. D. thesis, PrincetonUniversity (NJ) .
K = C. G. K, Corinthian developments in the study of trade in the fifth century, inHesperia , , –.
K = J. K, La conoscenza dei territori dell’Europa centrale nel mondo greco (VI–V sec.a.C.), in Dall’Indo a Thule. I Greci, i Romani, gli altri, a cura di A. A, L. D F, Trento ,–.
K = D. K, Ekspozita «Arti shqiptar në shekuj», in Iliria ., , – (= L’exposition«L’art albanais à travers les siècles», –).
K = D. K, Εφυαλωμένη κεραμική από πόλεις και κάστρα της Ηπείρου
(Epirus vetus, Epirus Nova). Εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις, in B , –.
K = M. K, Vendbanimi prehistoric i Trenit, in Iliria , , – (riass. in franc.,L’agglomération préhistorique de Tren, –).
Abbreviazioni bibliografiche
K = M. K, vjet Arkeologji Shqiptare, in Iliria , , – (= years of Albanianarchaeology, –).
K = M. K, Qytetërimi Neolitik dhe Eneolitik në Shqipëri, Tiranë .
K, B, C = M. K, A. B, N. C, Kalaja e Sopotit (Borshi), in C etalii , –.
K, P = M. K, K. M. P, Archaeology in Albania. Triport, in AJA , ,–.
K = H. K, Die alten Balkanillyrischen geographiscen Namen, Heidelberg .
K = H. K, Lexicon altillyrischen Personennamen, Heidelberg .
K = H. K, Indogermanische Sprachwissenschaft, Berlin .
K = P. K, Einleitung in der Geschichte der griechischen Sprache, Göttingen.
K = L. K, Gërmimet arkeologjike të vitit . Orik, in Iliria ., , –.
L = O. L, An overview of extensive and intensive survey in Albania (–), in B,H , –.
L F = C. L F, La ceramica medievale di Castel Fiorentino, dallo scavoal museo, Bari .
L = The economic history of Byzantium: From the seventh through the fifteenth century, ed. A. E.L (Dumbarton Oaks Studies, ), Washington D.C. .
L–T – = A. E. L–T, The Byzantine economy in the Mediterraneantrade system. Thirteenth–fifteenth centuries, in DOP –, –, –.
L = K. L, Të dhëna për disa banesa dhe sterna të shek. II–VI të e.sonë të zbuluara në qytetin eSarandës (Onhezëm–Ankiazëm), in Iliria .–, , – (riass. in franc., Quelques habitations etciternes découvertes à Saranda (Onhesme–Ankiasme), ).
L = J.–L. L Le Canal d’Otrante et les relations entre les deux rives de l’Adriatique, inC , –.
L = J.–L. L, Les cultes de l’Adriatique méridionale à l’époque républicaine, in Lescultes polytheists dans l’Adriatique romaine, éd. C. D, F. T, Bordeaux , –.
L = J.–L. L, Les fouilles actuelles, in D, L, Q , –.
L, C a = L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’antiquité, V, Actes du Ve colloqueinternational (Grenoble, – octobre ), éd. J.–L. L, M. P. C, Paris .
L, C b = J.–L. L, M. P. C, Nostoi troiani in Epiro e MagnaGrecia, in D S S, I , –.
L, D, S = J.–L. L, F. D, A. S, Etonnante découverte àApollonia d’Illyrie, in Archéologia , , –.
L, V – = J.–L. L, B. V, Les travaux de la Mission épigraphique etarchéologique française. Les fouilles franco–albanaises d’Apollonia: –, in Iliria .–, –,– (= Punime të Misionit epigrafik dhe arkeologjik Francez. Gërmimet franko–shqiptare në Apoloni:–, –).
L R = L’archeologia italiana nel Mediterraneo fino alla Seconda guerra mondiale, Atti delconvegno di studi (Catania, – novembre ), a cura di V. L R, Catania .
L, M = Porti, approdi e linee di rotta nel Mediterraneo antico, Atti del seminario distudi (Lecce, – novembre ), a cura di G. L, C. M, Lecce .
Abbreviazioni bibliografiche
L = L. L, Luigi M. Ugolini, in StRomagn , , –.
L = W. M. L, Travels in Northern Greece, London .
L G = B. L G, Théâtre et cités à l’époque hellénistique. Mort de la cité, mort du théâtre?, inREG , , –.
L I = M. L I, Otranto, cantiere Mitello: un centro produttivo nel Mediterraneobizantino, in P U , –.
L I c. s. = M. L I, La pietra ollare, in A, L I, T c. s.
L = E. L, Ricerche sull’antico Epiro. Le origini storiche e gli interessi greci, Napoli .
L = G. L, La necropoli di Phoinike, in C, L , –.
L = G. L, Problemi di interpretazione delle necropoli antiche: il caso di Phoinike, in B,H , –.
L = G. L, La necropoli meridionale di Phoinike: il nuovo settore monumentale, in L,C a, –.
L et alii = P. L, S. O, A. P, A. T, Settlement organisation andsocial context in the SW Balkan peninsula (Epirotic and Albanian coasts) and Northern Italy during thetransitional period between the Late Bronze Age and the Early Iron Age (c. th–th B.C.), in Dall’Egeoall’Adriatico. Organizzazioni sociali, modi di scambio e interazione in età postpalaziale (XII–XI sec.a.C.), Atti del seminario internazionale (Udine, – dicembre ), a cura di E. B, P.C G, Roma , –.
L, T = P. L, G. T, Sovjan (Albanie), in BCH , , –.
L, T, O – = P. L, G. T, C. O, Ndihmesa e gërmime-ve të Sovjanit për kronologjinë absolute të prehistorisë shqiptare, in Iliria , –, – (riass. infranc., La contribution des fouilles de Sovjan à la chronologie absolue de la préhistoire albanaise, –).
L = L. L, Domitia Lucila mère de Marc Aurèle, in MEFRA , , –.
L = E. L, La documentazione archeologica, in E. L, S. G, M. N,Taranto (Culti greci in Occidente, I), Taranto , –.
L–J = L. L–J, Aphrodite’s tortoise. The veiled woman of ancient Greece,Swansea–Oakville (CT) .
L = P. L, The Franks in the Aegean, –, London .
L = M. L, Lo psephisma di Lumbarda: note critiche e questioni esegetiche, inHesperìa , Roma , –.
L = M. L, La colonizzazione adriatica in età dionigiana, in La Sicilia dei dueDionisî, Atti della settimana di studio (Agrigento, – febbraio ), a cura di N. B, L.B, E. D M, Roma , –.
L = M. L, I Greci a Kerkyra Melaina (Syll. ), in C, C, K ,–.
L = M. L, Il Canale d’Otranto tra il IV e il III secolo, in La pirateria nell’Adriaticoantico, Atti dell’incontro di studio (Venezia, marzo ), (Hesperìa, ), Roma , –.
L a = M. L, I Greci in Dalmazia. Presenze e fondazioni coloniali, in Rimini el’Adriatico nell’età delle guerre puniche, Atti del convegno (Rimini, – marzo ), a cura di G.S, Ravenna , –.
L b = M. L, The psephisma of Lumbarda: a new fragment, in Illyrica antiqua. Obhonorem Duje Rendic–Miocevic, Proceedings of the international conference (Zagreb, November– ), ed. M. Š, I. M, Zagreb , –.
Abbreviazioni bibliografiche
L = M. L, Modelli e dinamiche ‘coloniali’ nell’area ionico–adriatica, in L,F , –.
L = M. L, Enertha Epidamno in una iscrizione arcaica da Olimpia e i più antichiinsediamenti greci in adriatico, I, in L’indagine e la rima. Scritti per Lorenzo Braccesi, a cura di F.R, con M. B, A. D, E. P (Hesperìa, ), Roma , –.
L, F = Colonie di colonie: le fondazioni sub–coloniali greche tra colonizzazione ecolonialismo, Atti del convegno internazionale (Lecce, – giugno ), a cura di M. L,F. F, Galatina .
L = M. L, Il Nord dell’Albania descritto da viaggiatori illustri tra fine Ottocento e inizioNovecento: Baldacci, Mantegazza, Roth, Morpurgo, in S, R , –.
L, M = I. L, I. M, Sulle tracce di Venezia e dei Veneziani in Albania. Storia di unarelazione lunga sei secoli, in S, R , –.
L = M. L, Rapporti tra le sponde dell’Adriatico in età classica e i traffici con la Grecia e MagnaGrecia, in B, G , –.
L = A. L, Il calendario eortologico per il ciclo delle feste fisse del tipico di S. Nicola di Casole,in Atti della giornata di studio in ricordo di Enrica Follieri (Roma, maggio ), in RStBiz n. s. ,, –.
M = P. M, Produzioni italiche, in M , –.
M = F. M, Bari, Archivio del Capitolo Metropolitano, Exultet , in Exultet. Rotoliliturgici del Medioevo meridionale, a cura di G. C, Roma , –.
Magna Grecia = Magna Grecia, Epiro e Macedonia, Atti del XXIV convegno di studi sulla MagnaGrecia (Taranto, – ottobre ), Taranto–Napoli .
M = S. M, Butrinto, Virgilio e l’immaginario antico, in Archeologo , –.
M = S. M, In Albania sulle orme di Roma. L’archeologia politica di L. M. Ugolini, inIdentità , –.
M = I. M, The returns of Odysseus: Colonization and ethnicity, Berkeley–Los Angeles–London .
M a = Ancient perceptions of Greek ethnicity, ed. I. M, Cambridge (MA) .
M b = I. M, Greek ambiguities: ‘Ancient Hellas’ and the ‘Barbarian Epirus’, in M a, – .
M = I. M, A small Greek world. Networks in the ancient Mediterranean, Oxford .
M = G. K. M, A Hellenistic sanctuary at Ano Poli, Thessalonica. The terracotta figurines,in Egnatia , , –.
M = D. M, Lezioni di archeologia, Roma–Bari .
M et alii = D. M, L. P, A. M, M. R, D. R, La ceramicamedioevale di Roma nella stratigrafia della Crypta Balbi, in Ceramica medievale , –.
M, P = Le fornaci romane di Giancola (Brindisi), a cura di D. M, S.P, Bari .
M = A. M, Rezultatet e kërkimeve per zbulimin e theatrit antik të Apollonise. Germime të vitit, in BuletinArkeologjik , , –.
M = A. M, Teatri i Apollonise. Rezultatet e germimeve të vitit , in BuletinArkeologjik ,, –.
Abbreviazioni bibliografiche
M – = A. M, Teatri antik i Apollonisë, in Iliria .–, –, – (riass. iningl., The ancient theatre of Apollonia, –) (= Apolonia e Ilirisë. Kërkime dhe studime arkeologjike,a cura di A. M, Tiranë , –).
M, D – = A. M, B. D, Teatri antik i Apollonisë. (Germime të vitit ), inIliria –, –, – (riass. in franc., Le théâtre antique d’Apolllonia, –).
M, D = A. M, B. D, Teatri i Apollonisë. (Rezultatet e fushatës së pestë të gërmimeve),in Iliria ., , – (riass. in franc., Le théâtre d’Apollonie. Résultats de la cinquième campagnede fouilles, –).
M = J. M, Seaborne contacts between the Aegean, the Balkans and the central Mediterraneanin the rd millennium B.C. The unfolding of the Mediterranean world, in G et alii , –.
M = C. M, Kerkyra nelle linee di rotta di età greca e romana tra la Grecia e l’Italia,in L, M , –.
M = D. M, Les géographes grecs, I. Introduction générale. Pseudo–Scymnos, Circuitde la terre, Paris .
M = M. M, Tucidide e la frontiera settentrionale dell’Hellenikon, in L, C a, –.
M = Y. M, Pline et l’Adriatique orientale: quelques problèmes d’interprétation d’HistoireNaturelle .–, in Geographica Historica, éd. P. A, P. C, Bordeaux–Nice ,–.
M = Y. M, Strabon et l’Illyrie. Essai de cartographie, in C, K, T ,–.
M = Butrint National Park development study, ed. S. M, Tirana .
M = A. M, Erodoto. Le Storie. Libro IX. La sconfitta dei Persiani, Milano.
M = C. M, Otranto e il mare nel tardo Medioevo, in H , –.
M = A. M, L’ambra e l’Eridano. Studi sulla letteratura e sul commerciodell’ambra in età preromana, Este .
M = T. M, The early churches of Constantinople. Architecture and liturgy, London .
M = K. P. M, Commerce, trade, markets, and money: Thirteenth–fifteenth centuries,in L , –.
M = H. M, Le pétrole en Albanie, in Albania , , –.
M = S. M, Le anfore con collo ad imbuto: nuovi dati e prospettive di ricerca, inP M, C , –.
M = O. M, Primo rapporto sulla ceramica medievale in Albania, in Faenza ,, –.
MC = M. MC, The Imperial Edge: Italo–Byzantine identity, movement and integra-tion, AD –, in Studies on the internal diaspora of the Byzantine Empire, ed. H. A, A. E.L, Washington D. C. , –.
M = A. M, Dy ndërtime të tipit trekonkësh, in Monumentet –, , – (riass. infranc., Deux constructions du type à trois conques, –).
M = A. M, Të dhëna për historinë e hershme mesjetare të Shqipërisë (fundi i shek. VI – fillimi ishek. XI), in Iliria ., , – (riass. in franc., Données sur l’histoire médiévale ancienne del’Albanie, –).
Abbreviazioni bibliografiche
M et alii = LRCW: Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterra-nean. Archaelogy and archaeometry: comparison between Western and Eastern Mediterranean, ed. S.M, M. P, S. S, G. G (BAR Int. Ser., ), II, Oxford .
M a = L. M, Nuove sculture di Phoinike, in D M, G , .
M b = L. M, Sculture e scultori a Phoinike tra ellenismo ed epoca romana, in Ocnus ,, –.
M = A. M, A note on the principal coins of the Epirote League (– B.C.), in B, H, –.
M = E.A. M, The inscriptions of Dodona and a new history of Molossia, Stuttgart .
M = L. M, L’eredita del passato, in Un piano per Durazzo, a cura di P. R (Piano,Progetto, Città Suppl., ), Pescara , –.
M = L. M, La tacita alleanza: le relazioni tra Italia e Albania durante la guerrafredda. Una proposta interpretativa, in Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i Balcani, a cura di I. G,L. M, M. B, Nardò , –.
M = Z. M, . I materiali, in S, H, S , –.
M, N, Z = V. M, M. C. N, E. Z, Leceramiche a vernice nera di Phoinike (Albania). Studio minero–geochimico a fini archeometrici, inReiCret Fautores , –.
M = G. M, Prime considerazioni sui dati antropologici delle sepolture, in D M,G , –.
M = L. M, Ugolini and Aeneas: the story of the excavation of the theatre at Butrint, in G a, –.
M, Z = L. M, M. Z, Conceptual changes in Albanian archaeology, in Antiquity ,, –.
Modes de contacts = Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes /Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche, Atti del convegno (Cortona, –maggio ), Pisa–Roma .
M c. s. = A. M, Stato degli studi e nuove prospettive di ricerca sulle fortificazioni bizantine,veneziane e turche di Durazzo, in H, S c. s.
M = S. J. M, Rhodian amphoras: Developments in form and measurements, inChronologies of the Black Sea area in the period c. – BC., ed. V. S, L. H, Aarhus, –.
M = N. K. M, The skeuophylakion of Aghia Sophia, in CArch , , –.
M = J.–C. M, Théâtre et société dans la Grèce antique, Paris .
M = C. M, La Sicile byzantine: une lueur dans les siècles obscurs, in NumAntCl ,, –.
M = Trieste antica. Lo scavo di Crosada, II, a cura di C. M, Trieste .
M C = L. M C, Identità e prassi storica nel Mediterraneoantico, Milano .
M, P = S. M, E. P, Manastiri i Shën Kollit, Mesopotam (Sondazhe ), in Candavia, , – (riass. in ingl., The monastery of Saint Nicholas at Mesopotam: Trial trenches ,).
M = B. M, Terres cuites de type grec en Illyrie méridionale et en Épire du nord, thèse dedoctorat, Université Charles–de–Gaulle–Lille , a. .
Abbreviazioni bibliografiche
M a = B. M, Lokalizimi i punishteve të prodhimeve qeramike në zonën gjeografike të Ilirisë sëjugut dhe Epirit në antikitet dhe tipologjia e tyre, in Iliria , , – (riass. in franc., La localisationet la tipologie des atèlirs de production céramique en Illyrie méridionale et en Épire dans l’Antiquité,–).
M b = B. M, Nécropole de Phoinikè. La frise en terre cuite du monument : essai d’analyse etd’interprétation, in L, C a, –.
M = K. M, Geographi Graeci Minores, ed. Paris .
M = A. M, Les terres cuites votives du Thesmophorion. De l’atelier au sanctuaire (Étudesthasiennes, ) Paris .
M a = Le moulage en terre cuite dans l’Antiquité. Création et production dérivée, fabrication etdiffusion, Actes du colloque (Lille, – décembre ), éd. A. M, Villeneuve d’Ascq .
M b = A. M, Description et analyse des productions moulées: proposition de lexiquemultilingue, suggestions de méthode, in M a, –.
M = A. M, Les atelier de coroplathes thasiens. État des connaissances et questions, inThasos. Matières premières et technologie de la Préhistoire à nos jours, Actes du colloque international(Liménaria, Thasos, – septembre ), éd. C. K, A. M, S. P, Paris, –.
M = A. M, Artisans, techniques de production et diffusion: le cas de la coroplathie, inL’artisanat en Grèce ancienne: les productions, les diffusions, Actes du colloque (Lyon, – décembre), éd. F. B, A. M, Villeneuve d’Ascq , –.
M = A. M, Le tout ou la partie. Encore les protomés: dédicataires ou dédicantes?, in Ledonateur, l’offrande et la déesse. Systèmes votifs dans les sanctuaires de desse du monde grec, Actes ducolloque (Lille, – décembre ), éd. C. P, S. H–H (Kernos Suppl., ),Liège , –.
M et alii = A. M, F. T, I. T, M. D–M, S. H, B. M,Les terres cuites votives de la colline de Dautë à Dyrrhachion. Projet d’étude et de publication, in B,S , –.
M et alii = A. M, F. T, M. D–M, S. H, B. M, I. T, Lesterres cuites votives du sanctuaire de la colline de Dautë, in BCH –, –, –.
M et alii = A. M, F. T, M. D–M, S. G, S. H–H,B. M, E. S, I. T, Les offrandes de l’Artémision de la colline de Dautë. Campagnes et, in BCH , , –.
M, T = A. M, F. T, L’Artémision de Dyrrhachion: offrandes, identification,topographie, in CRAI , –.
M, T, T = A. M, F. T, I. T, Les terres cuites votives du ‘sanctuaired’Aphrodite’ à Dyrrhachion. Artisanat et piété populaire, in C, L , –.
M = G. M, L’espansione urbana di Bari nel secolo XI, in QuadMediev, , , –.
M = D. M, Viaggiatori ed archeologi italiani in Albania, in Romana ., , –.
M = D. M, L’opera di Luigi M. Ugolini, in Rivd’Albania, ., , –.
M = D. M, L’illiricità del popolo albanese, in Rivd’Albania ., , ss.
M = H. M, Të dhëna mbi shtrirjen e Dyrrahut në pjesën jugëperëndimore të ‘Kënetës’, inMonumentet , , – (riass. in franc., Données sur l’etendue de Dyrrachium dans la partiesud–occidentale du ‘Marais’).
M = H. M, Un luogo di culto con altare a gradini a Durazzo, in StAnt ., , –.
Abbreviazioni bibliografiche
M = H. M, Albania archeologica. Bibliografia sistematica dei centri antichi, Bari .
N – = E. N, Léon Rey, pionier i arkeologjisë franceze në Shqipëri, in Iliria .–,–, – (= Léon Rey, pionnier de l’archéologie française en Albanie, –).
N et alii = F. N, S. D M, A. C, B. M, G. L, M. C, L.C, M. C, S. R, M. R, A. G, La necropoli meridionale, in D M,G , –.
N = G. N, Ecatei Milesii Fragmenta, Milano .
N = G. N, Per una definizione della ΙΑΠΥΓΙΑ, in AnnPisa s. III, ., , –.
N = G. N, Erodoto. Le Storie, vol. V, Milano .
N = R. V. N, Type, group and series. A reconsideration of some coroplastic fundamentals,in BSA , , –.
N = D. M. N, The despotate of Epiros –. A contribution to the history of Greece in theMiddle Ages, Cambridge .
N = W. N, ‘La costruzione dell’altro’, in I Greci. Storia, cultura, arte, società, . Noi e iGreci, a cura di S. S, Torino , –.
N = N. N, Appunti sulle anfore adriatiche d’età repubblicana: aree di produzione e dicommercializzazione, in Z , –.
N, K = T. S. N, R. K. K, Prayer, illumination, and good times. The exportof Byzantine wine and oil to the North of Russia in the Pre–Mongol times, in Byzantium and the North(Acta Byz. Fennica, VIII), Helsinki , –.
N, K = T. S. N, R. K. K, Wine and oil for all the Rus’! The importationof Byzantine wine and olive oil to Kievan Rus’, in Byzantium and the North (Acta Byz. Fennica, IX),Helsinki , –.
N = F. N, Ceramica e alimentazione. L’analisi chimica dei residui organicinelle ceramiche applicata ai contesti archeologici, Bari .
N = G. N, La céramique peinte glaçurée, la protomajolique et les sites de production en Capitanateaux XIIe et XIIIe siècles: problèmes de métodologie et perspectives de la recherche, in Federico II e Fiorentino,Atti del I convegno di studi medievali della Capitanata (Torremaggiore, – giugno ), acura di M. S. C M, Galatina , –.
O = E. O, Traffici micenei nell’Alto Adriatico e nel Basso Ionio. Modalità di scambio aconfronto, in Origini , , –.
O = P. O, Iscrizioni dell’Albania, in ArchEpigrMittOesterreich–Ungarn , , –.
O = S. O, Ein kleiner mittelkaiserzeitlicher Depotfund aus der Theatergrabung von Apollonia(Albanien), in RM , , –.
O = M. O, Sulla deposizione di statue in contesto sacro. Le teste di Pantelleria nel lorocontesto di ritrovamento, in Caesar ist in der Stadt: die neu entdeckten Marmorbildnisse aus Pantelleria,Tübingen , –.
O = G. O, Storia dell’Impero bizantino, Torino .
O = R. O, Master builders of Byzantium, Princeton (NJ) .
P = B. P, Frustuli illirici, in ASAtene , –, –.
P = B. P, Gli scavi archeologici di Albania (–), in RendLinc s. VIII, , , –.
P = V. P, Mosaici e pittura in Albania (VI–XIV secolo). Stato degli studi e prospettive di ricerca,in B, S , –.
Abbreviazioni bibliografiche
P = C. P, Taranto: la ceramica tra il periodo tardo–bizantino e normanno da Largo San Martino,tesi di laurea specialistica in Archeologia, Università del Salento – Lecce, .
P – = C. P, La Grotta Porcinara al Capo di S. Maria di Leuca. I. Le iscrizioni, inAnnLecce , –, –.
P = C. P, La Grotta Poesia di Roca (Melendugno–Lecce). Note preliminari, in AnnPisas. III, , , –.
P = C. P, Santuari costieri, in I Messapi, Atti del XXX convegno di studi sullaMagna Grecia (Taranto–Lecce, – ottobre ), Taranto–Napoli , –.
P = C. P, Oriente e Occidente: considerazioni su alcune anfore ‘egee’ di età imperialea Ostia, in Recherches sur les amphores grecques, Actes du colloque international (Athènes, –septembre ), éd. J.–Y. E, Y. G (BCH Suppl., ) Athénes–Paris , –.
P = C. P, Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, in Storia di Roma, III.. L’etàtardoantica. I luoghi e le culture, a cura di A. C, L. C R, A. G, Torino, –.
P = C. P, Anfore e archeologia subacquea, in Archeologia subacquea. Come operal’archeologo sott’acqua. Storie dalle acque, Atti dell’VIII ciclo di lezioni sulla ricerca applicata inarcheologia (Certosa di Pontignano, Siena, – dicembre ), a cura di G. V, Firenze ,–.
P = C. P, Le anfore di età imperiale del Mediterraneo occidentale, in Céramiqueshellénistiques et romaines, III, éd. É. G, Besançon–Paris , –.
P = C. P, Roma, il suburbio e l’Italia in età medio e tardo–repubblicana: culturamateriale, territori, economie, in Facta , , –.
P = J. P, Considerazioni sulla dea di Butrinto, in Archeologo , –.
P, B, M = J. K. P, L. B, S. P. M, Excavations at theprehistoric burial tumulus of Lofkënd in Albania. A preliminary report for the – seasons, in AJA, , –.
P = P. P, The numismatic evidence from Southern Adriatic (th – th
centuries): some preliminary observations and thoughts, in G, H , –.
P, T = B. P, K. T, Late Byzantine ceramics from Arta: someexamples, in G , –.
P a = L. P, La cité illyrienne de Klos, in Iliria , , –.
P b = L. P, Disa monumente të arkitekturës në qytetin antik në Klos, in Monumentet ,, – (riass. in franc., Monuments architecturaux de la ville antique à Klos, –).
P = L. P, Teatri i qytetit ilir në Klos të Mallakastrës dhe punimet restauruese në të, inMonumentet , , – (riass. in franc., Le théâtre de la ville illyrienne à Klos de Mallakastër et lestravaux de restauration qui y ont été effectués, –).
P = F. P, Les origines et la destinée de l’État illyrien: Illyrii proprie dicti, inHistoria , , –.
P = F. P, The Central Balkan tribes in Pre–Roman times. Triballi, Autariatae,Dardanians, Scordisci and Moesians, Amsterdam .
P = R. P, Iscrizioni romane di Doclea e Tusi, in BCom , , –.
P a = La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia, Atti del seminario (Certosadi Pontignano, Siena, – febbraio ), a cura di L. P, Firenze , –.
P b = L. P, Ceramiche invetriate da un contesto dell’VIII secolo della Crypta Balbi – Roma,in P a, –.
Abbreviazioni bibliografiche
P = P. P, Italia e Albania –. Origini diplomatiche del Trattato di Tiranadel novembre , Firenze .
P U = S. P U, La Protomaiolica. Bilancio e aggiornamenti (Quad.AMediev, ), Firenze .
P U = La ceramica altomedievale in Italia, a cura di S. P U (Quad.AMediev, ), Firenze .
P = C. P, Das Sandschak Berat in Albanien (Schriften der Balkankommission des Akad.der Wissenschaften in Wien, Antiquarische Abteilung, III), Wien , coll. –.
P = H. P, La ceramica invetriata altomedievale e medievale di produzione italiana ebizantina di Otranto (Puglie), in P a, –.
P = H. P, Contatti commerciali e culturali ad Otranto dal IX al XV secolo: l’evidenzadella ceramica, in G , –.
P, W = H. P, D. W, Medieval domestic pottery, in D’A,W , – .
P = C. P, Altitalische Forschungen III, Leipzig .
P, S c. s. = F. P, B. S, Indagini geoarcheologiche in alcuni scavi di emergenza a Durazzo, inH, S c. s.
P = H. P, The sanctuaries of Hera Akraia and Limenia, –, Oxford .
P = L. P, Thucydides and the geographical tradition, in ClQ , , –.
P = A. P, Analisi funzionale della ceramica e alimentazione medievale, in AMediev , ,–.
P, S, C = A. P A., L. S, F. C, Residue analysis of some late Romanamphora coming from the excavations of the historical center of Florence in M et alii ,–.
P = Y. P, Problèmes de topographie et de geographie historique en Thesprotie, in C, –.
P = A. P, Teopompo e Pseudo–Scilace, in StClOr , , –.
P = A. P, Il Periplo di Scilace. Studio sul primo portolano del Mediterraneo, Pisa .
P = A. P, Dati storici e distanze marine nel Periplo di Scilace, in StClOr , , –.
P = La politica culturale del fascismo nel Dodecaneso, Atti del convegno (Padova, – novembre), a cura di M. P, Padova .
P = R. P, Nuove indagini per lo studio del teatro di Hadrianopolis, in B, P, P, –.
P = R. P, Le indagini archeologiche ad Hadrianopolis (Sofratikë) e nel territorio della valle delDrino (campagne –). Per una prima sintesi storica dei risultati, in D M a, –.
P c. s. = R. P, Caonia e Piceno: due modelli di occupazione del territorio in età romana aconfronto, in Adriatlas e la storia dello spazio adriatico antico (VI sec. a.C.–VIII d.C.), Atti del colloquiointernazionale (Roma, – novembre ), in corso di stampa.
P, C, T = R. P, C. C, V. T, Primi dati sulle ceramiche comuni,da fuoco e sulle anfore provenienti dagli scavi di Hadrianopolis (Sofratikë – Albania), in M etalii , –.
P, Ç = R. P, D. Ç, Nuovi dati dalle indagini archeologiche ad Hadrianopolis e nelterritorio della valle del Drino, in L, C a, –.
Abbreviazioni bibliografiche
P, Ç = Hadrianopolis, II. Risultati delle indagini archeologiche –, cura di R. P,D. Ç, Bari .
P et alii = R. P, C. C, S. C, V. T, Hadrianopolis e la valle del Drino(Albania) tra l’età tardoantica e quella protobizantina. Le evidenze ceramiche dagli scavi –, inLate Roman and Early Byzantine pottery. The end or continuity of the Roman production?, Proceedingsof th congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores (Belgrad, – September ), inReiCretActa , , –.
P et alii c. s. = R. P, D. Ç, C. C, B. L, S. S, D. S, V. T, B.S–R, Ceramiche d’uso Comune ed anfore provenienti dall’Edificio termale di Hadrianopolis(Sofratikë – Albania), in LRCW : Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Medi-terranean. Archaeology and Archaeometry: Comparison between Western and Eastern Mediterranean,Proceedings of the international conference (Thessaloniki, – April ), c. s.
P = R. P, L’Italia alle soglie della storia, Roma–Bari .
P M, C = Olio e pesce in epoca romana. Produzione e commercio nelle regionidell’Alto Adriatico, Atti del convegno (Padova, febbraio ), a cura di S. P M,M.–B. C, Roma .
P = G. P, Pellegrino Claudio Sestieri, in Dizionario biografico dei SoprintendentiArcheologi (–), Bologna , –.
P, V = A. P, N. C. V, Luigi Maria Ugolini. Un archeologo italiano a Malta /An Italian archaeologist in Malta, Malta .
P, V . . = Malta and Mediterranean Prehistory. The archaeological activities of Luigi MariaUgolini between the two World Wars, ed. A. P, N. C. V, Malta c. s.
P = M. P, Le missioni archeologiche italiane nel Mediterraneo, in L R ,–.
P = M. P, Archeologia e Mare Nostrum: le missioni archeologiche nella politicamediterranea dell’Italia –, Roma .
P = D. P, Le commerce du vin oriental à l’epoque Byzantine (Ve–VIIe siècles): le témoignage desamphores en Gaule, Beyrouth .
P = V. P, Il problema illirico (tentativo di delimitazione), in Pannonia , , –.
P = R. P, Die Urnenfelderkultur und ihre Bedeutung für die europäische Kulturentwic-klung, in P , ss.
P, M, M = M. P, A. M, L. M, L’area del tempio in antis e dellabasilica paleocristiana, in D M, G , –.
P = J. P, Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier, Halle .
P = V. P, Les témoins archéologique des invasions avaro–slaves dans l’Illyricum byzantine,in MEFRA , , –.
P = V. P, Byzantins, Slave, et Autochtones dans les provinces de Prévalitane et NouvelleEpire, in Villes , –.
P = S. P, The trapeza in cenobitic monasteries. Architectural and spiritual contexts, inDOP , , –.
P, R = E. C. P, I. R, Contenitori da trasporto, in Gortina V.. Lo scavo delPretorio (–). I materiali, a cura di A. D V, Padova , –.
P = F.–C.–H.–L. P, Travels in Epirus, Albania, Macedonia and Thessaly,London .
Abbreviazioni bibliografiche
P – = C. P, Muzakhia und Malakastra, in ÖJh –, –, Beiblattcc. –.
P, S = C. P, A. S, Archäologische Forschungen in Alba-nien und Montenegro (Schriften der Balkankommission des Akad. der Wissenschaften in Wien,Antiquarische Abteilung, VIII), Wien .
P = J. P, The Latin kingdom of Jerusalem. European colonialism in the Middle Ages,London .
P = F. P, The prehistory of Albania, in The prehistory of the Balkans, the Middle East andthe Aegean world, tenth to eight centuries BC (CAH III, ), ed. J. B, I. E. S. E, N. G.L. H, E. S, Cambridge , –.
P, S = F. P, A. S, Les domus d’Apollonia, in D, L,Q , –.
P = N. P, Enchéléens, Dassarètes, Illyriens. Sources littéraires, épigraphiques et archéologi-ques, in C , –.
Prokop Meksi = A.K.Er. ltd, ASA, RDNC Durrës, View of the rescue excavations in the constructionarea in “Prokop Meksi” street, Durrës, in ASA Report Vjertor/Annual Report , –.
P = F. P, Prima di Strabone: materiali per uno studio della geografia antica comegenere letterario, in Strabone. Contributi allo studio della personalità e dell’opera, a cura di G. M,I, Perugia , –.
P = F. P, Sul concetto geografico di Hellas, in Geografia storica della Grecia antica, acura di F. P, Roma–Bari , –.
P, S = M. P, J.–C. S, Amphores greques, in Dictionnaire des céramiqueantiques (VIIème s. av. n.è. – VIIème s. de n.è.) en Méditerranée nord–occidentale (Provence, Languedoc,Ampurdan), éd. M. P (Lattara, ), Lattes , –.
Q = V. Q, Nuovi ritrovamenti archeologici nella valle del Drino, in B, P, P, –.
Q, Q = S. e F. Q, Le déplacement du temple d’Athéna Polias en Chaonie.Remarques sur les cosiddetti ‘temples voyageurs’, in B–A , –.
Q = F. Q, L’aguieus d’Apollon à Apollonia d’Illyrie, in L, C a,–.
R = C. R, Nuovi dati sulle produzioni ceramiche nella Calabria altomedievale: ilcaso del castrum bizantino di Santa Maria del Mare, in AMediev , , –.
R = S. R, Testimonia Urbis Phoenices, I. Raccolta ragionata delle fonti antiche sullacittà di Phoinike, in D M, G , –.
R = S. R, Testimonia Urbis Phoenices, III. Lo Pseudo–Michele Nepote e i viaggiatoriin Epiro (secoli XI–XX), in D M, G , –.
R–B = M. R–B, Loncarstvo rucnoga kola (katalog izložbe), Zagreb .
RCA = Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degliarchivisti napoletani, voll., Napoli –.
ReiCret Fautores = Proceedings of the th congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores (Dürres, September– October ), in ReiCretActa , .
Recherches = Recherches sur la céramique byzantine, Actes du colloque (Athènes, – avril ),éd. V. D, J.–M. S (BCH Suppl., XVIII), Athènes–Paris .
R–M = D. R–M, I Greci in Dalmazia e il loro rapporto col mondo illirico,in Modes de contacts , –.
Abbreviazioni bibliografiche
R–M = D. R–M, Anticki Grci na našem Jadranu i neka pitanja naseljavanjapriobalja Manijskog zaljeva, in Adrias , , – (riass. in ingl., Ancient Greeks on the EasternAdriatic and some questions concerning settling of the coast line of Manios Bay).
R = C. R, Trade as action at a distance. Questions of integration and communication,in Ancient civilization and trade, ed. J. S, C. C. L–K, Albuquerque ,–.
R = G. R, L’architecture des monastères byzantins et postbyzantins en Albanie, in L’Albaniadal Tardoantico al Medioevo: aspetti e problemi di archeologia e storia dell’arte, XL Corso di culturasull’arte ravennate e bizantina (Ravenna aprile – maggio ), Ravenna , –.
R a = L. R, Fouilles de la Mission Francaise à Apollonia d’Illyrie et à Durazzo (–), in Albania, , –.
R b = L. R, Les remparts de Durazzo, in Albania , , –.
R = L. R, Mélanges, in Albania , , .
R = L. R, Le monument des Agonothètes, in Albania , , –.
R = L. R, L’Odéon, in Albania , , –.
R = P. R, The Medieval amphorae, in H, B, L , –.
R = P. R, Trade networks of the East, rd to th centuries: the view from Beirut(Lebanon) and Butrint (Albania). (Fine wares, amphorae and kitchen wares), in M et alii ,–.
R, H, Ç = P. R, D. R. H, D. Ç, Excavations in theRoman forum of Bothrotum (Butrint): First to third century pottery assemblage and trade, in ReiCretFautores , –.
R = A. R, La canonizzazione di Gregorio Palama () ed alcune altre questioni, in RStBiz n. s., , –.
R = D. M. R, Excavations at Olynthus IV. The terracottas of Olynthus found in ,Baltimore–London .
R = H. R, The Athenian Agorà. Pottery of the Roman period, V, Princeton (NJ) .
R = J. S. R, The edges of the Earth in ancient thought: Geography, exploration, and fiction,Princeton .
R – = A. R, Per l’onomastica antica dei mari (IV–X), in StItFilCl n. s. , –,– e –.
R = A. R, Italia e Albania: relazioni finanziarie nel ventennio fascista, Bologna .
R = M. R, Crumbs from the rich man’s table: Byzantine finds in Lund and Sigtuna,c. –, in Visions of the Past. Trends and traditions in Swedish Medieval Archaeology, ed. H.A, P. C, L. E (Lund Studies in Mediev. Arch., ), Stockholm , –.
R = B. R, L’Adriatico greco. Culti e miti minori, Roma .
R–T = G. R–T, Vita di Sant’Elia il Giovane (Vite dei Santi Siciliani, III), Palermo.
R = A square for the city. Images, studies and projects for Liria Square in Durrës, a cura di P.R, Roma .
R a = J. G. R, Albanian Coastal Survey Project: field season, in InstNautAAnnual ,–.
R b = J. G. R, Description and analysis of the finds from the Turkish Coastal Survey:Marmaris and Bodrum, in InstNautAAnnual , –.
Abbreviazioni bibliografiche
R = J. G. R, Illyrian Coastal Exploration Program. The campaign, in InstNautAAnnual, –.
R = J. G. R, Illyrian Coastal Exploration Program (–). The Roman and Late Romanfinds and their context, in AJA , , –.
R = M. R, Ceramica e coroplastica dalla Magna Grecia nella collezione De Brandis,Udine .
R = P. R, Peuples, fictions? Ethnicité, identité ethnique et sociétés anciennes, in REA , ,–.
R = S. R, Storia delle crociate, I–II, Torino .
R = A. R, Navi, marinai e dei in epigrafi greche e latine scoperte in due grotte del Garganonord–orientale, in L, M , –.
S = Epirus. years of Greek history and civilisation, ed. A. S, Athens .
S = G. K. S, X. The weighing implements, in B, D , –.
S a = G. S, An overview of the new chronology for th to th century pottery at Corinth,in B , –.
S b = G. S, Recent developments in the chronology of Byzantine Corinth, in W,B , –.
S = M. S, Prime considerazioni sulla presenza di pietra ollare nel Salento, inStAnt , , –.
S – = S. S, Fra città e porto: le installazioni portuarie di Epidamnos/Dyrrachium,in Macella, tabernae, portus. Les structures matérielles de l’économie en Gaule romaine et dans les régionsvoisines, éd. R. B, in Caesarodunum –, –, –.
S c. s. = S. S, La Tellus di Durazzo, in H, S c. s.
S, H c. s. = Dyrrachium III. L’anfiteatro romano di Durrës (Albania). Scavi e ricerche –,a cura di S. S, A. H c. s.
S, H, S = Dyrrachium I. L’anfiteatro di Durazzo. Studi e scavi –, a cura di S.S, A. H, B. S, in ASAtene , s. III., , –.
S, H, S = L’anfiteatro di Durazzo. Report degli scavi –, a cura di S. S,A. H, B. S, in ASAtene , s. III., , –.
S, M = S. S, A. M, Carta del rischio archeologico della città di Durrës:metodologia di realizzazione e istruzioni per l’uso, in B, S , – (con CD–rom).
S, S, H, = S. S, B. S, A. H, . . . ex continente visi... un probabile faronel porto antico di Durazzo (Albania), in Torre de Hércules: finis terrae lux. Simposio sobre los farosromanos y la navegacion occidental en la antiguedad (A Coruña, junio ), in Brigantium , ,–.
S, S, H = S. S, B. S, A. H, Una nuova immagine dell’urbanistica diEpidamnos/Dyrrachium dagli scavi e dalle ricerche del Dipartimento di Archeologia e della MissioneArcheologica Italiana a Durrës, in L, C a, –.
Š K = M. Š K, Mythological stories concerning Illyria and its names, in C,L , –.
Š K = M. Š K, Appian and Illyricum, Ljubljana .
Š K = M. Š K, Ethnic manipulation with ancient Veneti and Illyrians, in Identità ,–.
Abbreviazioni bibliografiche
Š K = M. Š K, Peoples on the Northern fringes of the Greek world: Illyria as seen by Strabo,in L, C a , –.
S = B. S, Le fasi cronostratigrafiche, in S, H, S , –.
S = A. S, Zur Topographie von Dyrrachium, in ÖJh ., , –.
S, R = Questioni odeporiche. Modelli e momenti del viaggio adriatico, a cura di G.S, R. R, Bari .
S = J. S, Social network analysis: A handbook, London .
S M, Z = C. S M, F. Z, Le pitture nell’Abbazia di Nonantola. Unrefettorio affrescato di età romanica, Modena .
S = P. C. S, Vita pubblica e monumenti di Durazzo di età romana attraverso le iscrizioni,in Epigraphica , , –.
S = E. S, Contributo per la topografia di Dyrrachium (III secolo a.C. – IV secolo d.C.), inJournAncTop , , –.
S a = B. S, Ceramics from Late Roman contexts in Durrës, in BSA , , –.
S b = B. S, Ceramica tardoantica dal Macellum–Forum di Dürres, in QuadFriulA ,, –.
S = S. S, Aspetti della romanizzazione a Phoinike, in D M, G ,–.
S, S = A. S, G. S, Gruppo di folles bizantini dell’XI secolo:ripostiglio ‘da borsellino’ o ‘di emergenza’?, in La Specchia Artanisi (Ugento). Campagna di scavo , acura di A. M. B S, G. S, Ugento , –.
S = M. S, Il porto di Brindisi dal Medioevo all’Unità, in ASP , , –.
S = A. S, La ville d’Athéna à Apollonia d’Illyrie: chronologie et techniques deconstruction, in C, L , –.
S = A. S, L’édifice à mosaïque d’Apollonia d’Illyrie, in L, C a, –.
S = J.–P. S, L’habitat urbain en Grèce à la veille des invasions, in Villes , –.
S = J.–P. S, The transformation of cities in Late Antiquity within the provinces of Macedoniaand Epirus, in The Transition to Late Antiquity, on the Danube and Beyond, ed. A. P, Oxford, –.
S = K. S, Presenza micenea in Albania ed Epiro. Problemi ed osservazioni, in Iliria .,, – (= Prania mikenase në Shqipëri në Epir. Probleme dhe vëzhgime, –).
S = J.–C. S, Les amphores commerciales de la nécropole de Rifriscolaro àCamarine. Remarques préliminaires sur les productions corinthiennes de type A, in Camarina annidopo la fondazione: nuovi studi sulla città e sul territorio, Atti del convegno internazionale (Ragusa, dicembre ; – aprile ), a cura di P. P, G. D S, L. D L, Roma, –.
S = J.–C. S, La diffusion des vins grecs d’Occident du VIIIe au IVe s. av. J.–C.,sources écrites et documents archéologiques, in La vigna di Dioniso: vite, vino e culti in Magna Grecia, Attidel XLIX convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, – settembre ), Taranto–Napoli, –.
S = P. S, The historical sources for Butrint in the Middle Ages, in H, B,L , –.
S = H. S, La ville haute–medievale albanaise de Shurdhah (Sarda), in Iliria , , –.
Abbreviazioni bibliografiche
S – = H. S, Monedha bizantine të shekujve V–XIII, të zbuluara në territorin e Shqipërisë,in Iliria –, –, – (= Monnaies byzantines des Ve–XIIIe siècles découvertes sur le territoirede l’Albanie, –).
S = W. G. S, The mineral industry of Albania, USGS Minerals Information (http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country//.pdf.)
S M = T. S M, More Byzantine and Frankish pottery from Corinth, inHesperia , , –.
S MK = T. S MK, Pottery of the Frankish period: th and early thcentury, in W, B , –.
S = A. S, Arte degli Illiri, Milano .
S = A. S , Gli Illiri, Milano .
S = L. S, Le anfore, in Con la terra e con il fuoco. Fornaci romane nel Riminese, acura di L. S, Rimini , –.
S = G. S, Gli attuali teatri di guerra balcanici e la campagna di Giulio Cesare nell’anno a.C., in NuovaAntologia (LettScArti) , s. VI, , –.
S = G. S, Luigi M. Ugolini: storia e passione di un archeologo, in Archeologo , –.
T = G. T, L’iscrizione CIE da Vico Equense, in Sorrento e la PenisolaSorrentina tra Italici, Etruschi e Greci nel contesto della Campania antica, Atti della giornata di studioin omaggio a P. Zancani Montuoro (Sorrento, maggio ) a cura di F. S, M. R,Roma , –.
T = P. T, La ceramica invetriata policroma nel basso Salento, in La ceramica inve-triata tardo–medievale dell’Italia Centro–Meridionale. Bilanci e aggiornamenti, Atti del IV congressodi archeologia medievale (Roma, – maggio ), a cura di S. P U, Firenze ,–.
T = P. T, Lecce: uno scarico di fornaci della fine del Quattrocento. Primi dati, inAMediev , , –.
T = Barrington Atlas of the Greek and Roman World, II, ed. R. J. A. T, Princeton (NJ).
T = A. M. T, s. v. Typikon, monastic, in The Oxford Dictionary of Byzantium, III, NewYork–Oxford , .
T = M. T, Commercio e navigazione nel Medioevo, Roma–Bari .
T = M. T, Appunti sui rapporti tra archeologia preistorica e fascismo, in Origini ,, –.
T = F. T, Amforat e Muzeut arkeologjik të Durrësit (përpjekje për një katalog të tyre), inIliria ., , – (riass. in franc., Les amphores du Musée Archéologique de Durrës (essai d’endresser un catalogue), ).
T = F. T, Një varrezë e mesjetës së hershme në Durrës, in Iliria ., , – (riass.in franc., Un cimètiere du Haut Moyen–Age à Durrës, ).
T = F. T, Godinë e lashtë banimi në sheshin e parkut «Rinia», Durrës, in Iliria ., ,– (riass. in franc., Une maison antique sur la place du parc «Rinia» à Durrës, ).
T = T. F. T, Bronze Age landscape and society in Southern Epirus, Greece, Oxford.
T = R. T, Ethnicity, genealogy and Hellenism in Herodotus, in M a, –.
Abbreviazioni bibliografiche
T, C H = Byzantine monastic foundation documents. A complete translationof the surviving founders’ Typika and Testaments, ed. J. T, A. C H, I–V,Washington (DC) .
T = J. T, Sur la réalité historique des offrandes hyperboreennes, in Studies presented toD. M. Robinson, II, Saint Louis , –.
T = M. T, Evoluzioni e trasformazioni dell’anfora dipinta dal Medioevo al Rinascimento.Osservazioni dal Salento, in Atti del IV congresso di Archeologia Medievale (Abbazia di San Galgano,Chiusdino–Siena, – settembre ), a cura di R. F, M. V, Firenze ,–.
T = M. T, Produzione, commercio e consumo delle ceramiche invetriate tra il Salento, ilLevante e l’Adriatico, tesi di dottorato, Università del Salento – Lecce, .
T a = M. T, Dal Salento all’Adriatico orientale: commercio e consumo delle ceramicheinvetriate da mensa, in Atti del VI congresso nazionale di archeologia medievale (L’Aquila, –settembre ), a cura di F. R, A. F, Firenze , –.
T b = M. T, La genesi della graffita nel Salento: la protograffita e l’incontro tra duetradizioni tecnologiche?, in La ceramica post–medievale nel Mediterraneo. Gli indicatori archeologici:secoli XVI–XVII, Atti del XLIV convegno internazionale della ceramica (Savona, – maggio), Firenze , –.
T c = M. T, Produzione e circolazione della ceramica invetriata policroma in Terrad’Otranto. Nuovi dati dal Salento, in G , –.
T = V. T, La population illyrienne de Dyrrhachion à la lumière des données historiques etarchéologiques, in Iliria , , –.
T = E. T, The Medieval Amphorae (Ninth to Fourteenth Centuries AD) fromexcavations at Silistra in (Preliminary Report), in T, S, B , –.
T = A. T, Anfore dall’area lagunare, in G, N , –.
T, L = G. T, P. L, L’Albanie méridionale et le monde égéen à l’âge du bronze.Problèmes chronologiques et rapports culturels, in G et alii , –.
T = A. T, Inventario dei rinvenimenti monetali del Salento. Problemi di circolazione,Roma .
T = A. T, Le monete, in D’A, W , –.
T, C = A. T, V. G. C, Aspetti della circolazione monetaria inarea basso adriatica, in Proceedings of the XIV international numismatic congress (Glasgow, August–September ), Glasgow , –.
T = W. T, The Byzantine revival, –, Stanford .
T = J. T, Sur la réalité historique des offrandes hyperboreennes, in Studies presented toD.M. Robinson, II, Saint Louis , –.
T = A. T, s. v. Apollonia, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, II, Roma, –.
T = A. T, s. v. Berat, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, III, Roma ,–.
T = K. T, Glazed bowls in Late Byzantine churches of North–Western Greece, in AMediev, , –.
T = C. T, Archaic amphora import from Thracian sites around the Bay of Bourgas, inT, S, B , –.
Abbreviazioni bibliografiche
T, S, B = PATABS II. Production and trade of amphorae in the Black Sea,Acts of the international round–table (Kiten–Nessebar–Sredetz, September – ), ed. C.T, T. S, A. B, Sofia .
U = L. M. U, , La Panighina. Fonte sacra preistorica, in MonAnt , , –.
U = L. M. U, Recensione a Radu Vulpe, Gli Illiri dell’Italia imperiale romana. – InEphemeris Dacoromana, Annuario della Scuola Romena di Roma, a. III, pag. –, in BCom , ,–.
U a = U = L. M. U, Albania antica, I. Ricerche archeologiche, Roma–Milano.
U b = L. M. U, Italia, Albania e civiltà adriatica nelle più recenti scoperte archeologiche,in Il Giornale d’Italia, ...
U c = L. M. U, Le antichità primitive dell’Albania (Lavori della Missione Italiana), inBPI , , –.
U a = L. M. U, L’Antica Albania nelle ricerche archeologiche italiane, Roma .
U b = L. M. U, Missione archeologica italiana in Albania, in BollRealeIstArchStoriaArte, , –.
U = L. M. U, L’archeologia dell’altra sponda adriatica nelle ricerche della MissioneArcheologica Italiana in Albania, in Japigia . , –.
U = L. M. U, Albania antica, II. L’acropoli di Fenice, Roma–Milano .
U = L. M. U, Malta. Origini della civiltà mediterranea, Roma .
U = L. M. U, Butrinto. Il mito d’Enea. Gli scavi, Roma .
UNESCO = http://whc.unesco.org/en/news/
V = D. Vaglieri, Nell’alta Albania, in Rivd’Italia , , –.
V = G. V, Castriota Scanderbeg und Granai Castriota in Italien, in The living Skan-derbeg. The Albanian hero between Myth and History, Proceedings of the international conference(Lecce, March – ), ed. M. G, J. M, G. V, Hamburg , –.
A et alii = Via Egnatia revisited. Common Past, Common Future, Proceedings of theVEF conference (Bitola, February ), ed. M. A et alii, Driebergen .
C et alii = R. C et alii, Leuca, Galatina .
M = C. M, Vins et ampores de Grande Gréce et de Sicile, Naples .
D = F. H. J. D, Byzantine shipwrecks, in L , –.
V = R. V Gli Autariati, la tribù illirica più grande e più forte, nella storia e nell’archeologia, inIlliri , –.
V = S. V, Trasformazioni negli insediamenti della Sicilia centro–settentrionale, in Kriseund Wandel, Akten des kolloquium (Rom, .–. Juni ), hrsg. R. N (Palilia, ),Wiesbaden , –.
V = R. V, Teopompo e l’Adriatico. Ricerche sui frammenti del libro XXI delle Filippiche(FF – Jacoby), in Hesperìa, , Roma , –.
V, G = N. C. V, O. G, The lure of the Antique: Nationalism, politics andarchaeology in British Malta (–), in BSR , , –.
V = T. V, La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge, Paris .
V, V = A. M. V, C. V, Le mariage grec du VIe siècle av. J.–C. à l’époqued’Auguste (BCH Suppl., ), Athènes .
Abbreviazioni bibliografiche
V = P. V, La distruzione dei palazzi imperiali di Roma e di Ravenna e la ristrutturazionedel palazzo lateranense nel IX secolo nei rapporti con quello di Costantinopoli, in Roma e l’età carolingia,Atti delle giornate di studio (Roma, – maggio ), Roma , –.
V = S. V, Archaeology, nationalism and the construction of national identity in Albania, inB, H , –.
Villes = Villes et peuplement dans l’Illyricum protobyzantin, Actes du colloque (Rome, – mai) (Coll. École française de Rome, ), Rome .
V = G. V, Archeologia subacquea e ‘archeologia globale dei paesaggi’ tra formazione, ricerca etutela, in ASub ., , .
V = G. V, Per una ‘archeologia globale dei paesaggi’ della Daunia. Tra archeologia, metodolo-gia e politica dei beni culturali, in Storia e archeologia della Daunia, in ricordo di Marina Mazzei, Attidelle giornate di studio (Foggia, – maggio ), a cura di G. V, M. J. S, D.L, Bari , –.
V, A = G. V, R. A, Rotte, itinerari e commerci, in Andar per mare. Pugliae Mediterraneo tra mito e storia, a cura di R. C, R. L R, M. M, Bari ,–.
V et alii = G. V, A. A, G. D, D. L, M. M, M. T,Progetto Liburna. Archeologia subacquea in Albania, in ASub ., , .
V et alii = G. V, A. A, G. D, D. L, N. M. M, M.M, M. T, Progetto Liburna. Archeologia subacquea in Albania. Campagne /,in ASub, .–, , –.
V et alii = G. V, A. A, A. D S, G. D, D. L, M. M,M. T, Progetto Liburna. Archeologia subacquea in Albania (Campagna ). Parte I, in ASub., , –.
V, L, T a = G. V, D. L, M. T, Progetto Liburna. Archeologiasubacquea in Albania. Campagna , Parte I, in ASub ., , –.
V, L, T b = G. V, D. L, M. T, Il Progetto Liburna: ricerchearcheologiche subacquee in Albania (campagne –), in ASAtene , s. III, , , –.
F = V. F, La dominazione bizantina dell’Italia meridionale dalIX all’XI secolo, Bari .
F = V. F, I Bizantini in Italia, in I Bizantini in Italia, a cura diG. C et alii, Milano , –.
F = V. F, Tra Occidente e Oriente: Otranto in epoca bizantina,in H , –.
H = H. H, Ein Figuralkapitell aus Apollonia, in Zbornik u cast Emilija Marinaza . rodendan / Miscellanea Emilio Marin sexagenario dicata, Split , –.
H, E = H. H , W. E, Reliefs, Skulpturen und Inschriften aus dem Theatervon Apollonia (Albanien), in RM , , –.
H, E = H. H, W. E, Die Transformation des politischen Raumes. DasBouleuterion in Apollonia (Albanien), in RM , , –.
S = R. S, Umrisse der älteren Geschichte Europas, Innsbruck .
S = R. S, Die Anfänge geschichtlichen Lebens in Italien, in HZ ., , –.
W–M = U. W–M, Der Glaube derHellenen, I, Basel .
Abbreviazioni bibliografiche
V = J. V, The medieval and post–medieval fine wares and cooking wares from the TriconchPalace and the Baptistery, in H, B, L , –.
V = J. V, ‘Corfu’s right eye: Venetian pottery in Butrint (Albania)’, in The Heritageof the Serenissima. The presentation of the architectural and archaeological remains of the VenetianRepublic, Proceedings of the international conference (Izola–Venezia, –..), ed. M. G,S. G, K. S, Koper , –.
V = J. V, Pottery finds from a ‘cess–pit’ at the southern wall in Durrës, central Albania, inB–A, U, W–O , –.
V a = J. V, Early Medieval pottery finds from recent excavations at Butrint, Albania, inG , –.
V b = J. V, From one coast to another: Early Medieval ceramics in the Southern Adriaticregion, in G, H , –.
W = F. O. W, Preliminary report on the medieval pottery from Corinth: I. The prototype ofthe archaic Italian majolica, in Hesperia , , –.
W = K. A. W, The Greek Bronze Age west of the Pindus: A study of the period ca. BC – BC in the Epirus, Aetolo–Akarnania, the Ionian Islands and Albania with reference to the Aegean,Adriatic and Balkan regions, PhD diss., University of London, .
W = J. J. W, Dalmatia, London .
W = J. J. W, Gli Illiri: tra identità e integrazione, Genova .
W, F–H = J. J. W, T. F–H, The Adriatic, in H, N, –.
W = B. W, Die byzantinische Keramik aus einem Ziegelschacht in Ägina Kolonna, inB–A, U, W–O, Istanbul , –.
W = C. K. W II, Frankish Corinth: An overview, in W, B , –.
W, B = Corinth. The Centenary: –, ed. C. K. W II, N. B(Corinth, ), Princeton .
W = John Skylitzes: A synopsis of Byzantine history, –, ed. J. W, Cambridge.
Y = J. J. Y, The Paleologan refectory of Apollonia, in The Twilight of Byzantium, ed. S.C, D. M, Princeton , –.
Y = D. G. Y, The Matt–painted pottery of Southern Italy: A general survey of theMatt–painted pottery styles of Southern Italy during the Final Bronze Age and the Iron Age, Galatina.
Z = Strutture portuali e rotte marittime nell’Adriatico di età romana, Atti della XIX settimanadi studi aquileiesi, a cura di C. Z (Antichità Altoadriatiche, XLVI / Coll. École Françaisede Rome, ), Trieste–Roma .
Z = A. Z, Storage jars in ancient sea trade, Haifa .
Z = D. Z, Carta di Valona e del territorio circostante, in Ciuitatum aliquot insigniorum [!],et locorum magis munitorum exacta delineatio: cum additione aliquot insularum principalium. / Disegnidi alcune più illustri città et fortezze del mondo, con aggiunta di alcune isole principali, Venetiis .
Z = M. Z, Rezultate të kërkimeve arkeologjike në Karaburun e në Rrëzën e Kanalit, inMonumentet , , – (riass. in franc., Resultats obtenus par les recherches effectuees dans lapeninsule de Karaburun et dans Rrëza e Kanalit, –).
Z = F. Z, L’archeologia italiana in Albania, in L R , –.
Abbreviazioni bibliografiche
Z = K. Z, Monumenti i Agonotetëve. (Rikonstruksioni i pamjes kryesore), in Monumentet, , – (riass. in franc., Le monument des Agonothètes. Reconstruction hypothétique de sa vueprincipale, –).
Z = K. Z, Rishtyllëzimi i pamjes kryesore të Monumentit të Agonoteteve në Apoloni, inMonumentet , , – (riass. in franc., L’anastylose de l’aspect principal du monument desAgonothètes à Apollonie, –).
Z = V. Z, Bizantski srednjovyekovni brodolomi u podmorju istocnog jadrana, in HistriaAnt, , –.
Z, M = V. Z, I. M, Medieval Byzantine shipwrecks in the Eastern Adriatic,in Skyllis .., , –.
–
– Scienze matematiche e informatiche
– Scienze fisiche
– Scienze chimiche
– Scienze della terra
– Scienze biologiche
– Scienze mediche
– Scienze agrarie e veterinarie
– Ingegneria civile e architettura
– Ingegneria industriale e dell’informazione
AREA – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche
– Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
– Scienze giuridiche
– Scienze economiche e statistiche
– Scienze politiche e sociali
Il catalogo delle pubblicazioni di Aracne editrice è su
www.aracneeditrice.it