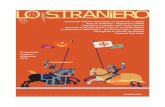Regole e implicazioni giuridiche della produzione e del consumo di cibo locale
Il bibliotecario "locale": ieri e domani.
Transcript of Il bibliotecario "locale": ieri e domani.
Amministrazione provinciale di Pescara Biblioteca provinciale "G. D'Annunzio"
Biblioteche provinciali e biblioteche pubbliche di capoluogo:
servizio sul territorio
V Convegno nazionale | Pescara, 27-28 settembre 2001Ì
a cura di Dario D'Alessandro
A S S O C I A Z10 N K 1 r A I, I A N A
B I B L I O T E C H E
Amministrazione provinciale di Pescara Biblioteca provinciale "G. D'Annunzio"
Biblioteche provinciali e bibhoteche pubbliche di capoluogo:
servizio sul territorio
V Convegno nazionale Pescara, 27-28 settembre 2001
Atti a cura di Dario D'Alessandro
Roma Associazione italiana biblioteche
2002
Redazione: Maria Teresa Natale M:̂ . . '
Stampa: Veant s.r.l.
Copyright © 2002 Associazione italiana biblioteche
Produzione e diffusione: Associazione italiana biblioteche C.P. 2461 - Roma A.D.
Tel. 064463532, fax 064441139 e-mail [email protected], http://www.aib.it
ISBN 88-7812-101-0
INDICE
Preme^.sa (DarioD'Alessandro) ..':'r\-\ì:^:.'^'i:,.^: /^•.:yxl ,
Giuseppe De Dominicis, Saluto e apertura dei lavori 9
Igino Poggiali, La biblioteca provinciale nella rete - ; dei servizi d'informazione sul territorio 11
Alois Schacher, Le biblioteche cantonali svizzere 17
Giovanni Solimine, A/ifl/w/e vfl/wtoz/one delle biblioteche pubbliche di capoluogo 24
Alberto Petrucciani,//ò/Wio/É^can'o "/ocfl/e".' ieri e domani 34
Dario D'A\essandvo, Le biblioteche provinciali 1991-200L Rinnovamento o aggiornamento? ^ 41
Daniele Danesi,/5//mz/one.-cui prodest 49
TAVOLA ROTONDA Biblioteche provinciali, consorziali e civiche di capoluogo dentro il cambiamento: esperienze a confronto
Enrichetta Fatigato, IlDock nella Biblioteca provinciale di Foggia 59
Moreno Gagnoli, La Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia 64
Emanuela Impiccinì, La Biblioteca comunale "G. Gabrielli" di Ascoli Piceno 73
Vincenzo Lombardi, L'esperienza della Biblioteca provinciale "P. Albino di Campobasso 80
Franco Neri, La Biblioteca "A. Lazzerìni nel sistema provinciale pratese 84
Lorena Pesaresi, La Biblioteca-Centro di documentazione della Provincia di Perugia 102
TAVOLA ROTONDA Biblioteche provinciali e consorziali: servizio bibliotecario sul territorio <
Anita Bogstti, Le attività di promozione della lettura: l'esempio della Biblioteca ' ' consorziale "Astense" 109
Miranda Sacchi, La Provincia di Milano e le biblioteche comunali: un servizio per il territorio 112
Giovanni Battista Sguardo,//5i5?ema WW/ofecfln'o della Provincia di Viterbo 116
TAVOLA ROTONDA La gestione istituzionale: tradizione e innovazione
Giorgio Lotto, Istituzione e biblioteca pubblica: ' una riflessione critica 123
Francesco'Lullo, L'istituzione: l'esempio della Biblioteca provinciale di Chieti , 128
Lapo Mslani, La Biblioteca Città di Arezzo: dal consorzio all'istituzione 133
6
Alberto Petrucciani ' -
Il bibliotecario "locale": ieri e domani
A quanto si dice, almeno nel mondo della scuola e dell'università, la storia è in ribasso. Eppure è uno strumento molto potente di analisi e comprensione della realtà, e duttile per la capacità di far proprie le acquisizioni delle più diverse discipline, a partire ovviamente dalle scienze sociali, e di utilizzarle.
Non voglio far della retorica sulla storia "maestra di vita", ma r i chiamare due ragioni precise. La prima, la più ovvia, è i l cambiamento: abbiamo l'esigenza di imparare a discernere quanto muta da quanto resta, le opportunità e i rischi del "nuovo", sempre più sottili e complessi, più "intelligenti", di quanto non appaia a prima vista, sia agli apocalittici che agli entusiasti. Non abbiamo e non possiamo avere delle società-laboratorio, in cui sperimentare l'innovazione e le sue conseguenze anche a lungo termine: la conoscenza del cambiamento dobbiamo quindi trarla dalla storia. La seconda ragione, parallela, è la durata. Oggi apparentemente, a leggere i giornali o a vedere la TV, viviamo in un mondo in cui la durata sembra tendere a zero: la geniale mossa di ieri, letta sul giornale di oggi, è liquidata dopo pochi giorni come vecchiume già archiviato, la settimana scorsa è preistoria, dimenticata o da dimenticare. D'altra parte, cinici e saggi non possono fare a meno di ripetersi spesso che plus ga change, plus c'est la mème chose.
Se guardiamo la storia per porci domande, non per recitare litanie o spacciare risposte preconfezionate, la dimensione della durata spesso ci sorprende. Prendiamo per esempio proprio la provincia, come ambito di riferimento territoriale e istituzionale, sia in generale sia più particolarmente in campo bibliotecario. Nei rialzi e ribassi dei valori e delle proposte all'ordine del giorno, a confronto con altri ambiti di riferimento forti come la regione e la città (il comune), la provincia ha subito lunghe eclissi. Almeno nel nostro campo, però, si è ripresentata molte volte in primo piano.
* Università di Pisa.
34
IL BIBLIOTECARIO "LOCALE": IERI E DOMANI
A l principio del secolo scorso Desiderio Chilovi, in un saggio sulla «Nuova antologia»', notava che le biblioteche municipali - a suo avviso - erano «rette con gli intendimenti del secolo passato», e non e-rano in grado di assecondare efficacemente i l movimento di diffusione della cultura e del sapere che riteneva necessario per lo sviluppo sociale e culturale della nuova Italia. Lanciava quindi l'ipotesi, rimasta poi solo sulla carta, di un sistema di biblioteche provinciali. «Si capisce benissimo - scriveva - che, dicendo così, non parlo delle presenti biblioteche provinciali, perchè, in bella unione alle altre biblioteche, anch'esse menano vita incerta, stentata e di rado proficua; tanto più che in un ordinamento razionale delle nostre biblioteche, quello che di utile e di buono si potrebbe ora pretendere dalla biblioteca di una provincia, di estensione territoriale limitata, si confonde sempre con quello che ragionevolmente si può chiedere ad una biblioteca municipale». Chilovi intendeva invece biblioteche di tipo nuovo, non rivolte direttamente al servizio del pubblico, in sede, ma piuttosto organizzate come centrali di sostegno e supporto - in maniera analoga alle biblioteche dipartimentali di prestito create più tardi in Francia - a un servizio bibliotecario di base diffuso capillarmente nel territorio rurale.
Se questa ipotesi non fu mai concretamente sviluppata, troviamo un riferimento molto significativo all'ambito provinciale nella legge del 1941 sulle biblioteche dei capoluoghi, legge tanto e lungamente caldeggiata dai bibliotecari, con aspetti fortemente innovativi (per e-sempio nel mettere in secondo piano la titolarità della biblioteca r i spetto al suo servizio e al suo finanziamento), ma che come si sa non ebbe grandi effetti concreti.
L'ambito provinciale è poi tornato in evidenza nell'esperienza del Servizio nazionale di lettura, nei primi anni Sessanta, esperienza che a mio avviso - come già notarono alcuni dei protagonisti di allora - ha costituito la radice forte, poi spesso dimenticata se non occultata, del diffondersi di una pratica di programmazione dei servizi e di cooperazione sul territorio che si dispiega soprattutto negli anni Settanta, e quindi sotto l'egida di un nuovo soggetto, la Regione.
I l regionalismo, da allora in poi, ha per certi versi corso i l rischio di un appiattimento della visione complessiva di un sistema bibliotecario, spesso concepito sulla falsariga mentale dell'egualitarismo a-
' Desiderio Chilovi, IM scuola rurale e la sua biblioteca, «Nuova antologia di lettere, scienze ed arti», n. 710(16 lug. 1901), p. 200-228 (poi IM scuola rurale e la sua biblioteca e le biblioteche provinciali, 2" ed. con aggiunte, Firenze, 1902).
Legge 24 aprile 194J, n. 393: Disposizioni concernenti le biblioteche dei Comuni capoluoghi di provincia.
35
ALBERTO PETRUCCIANI
Stratto, che vede sullo stesso piano tutti i comuni - che m Italia possono essere grandissimi o piccolissimi - e punta alla cooperazione fra uguali, e quindi in concreto, in molti casi, a piccoli sistemi costituiti da piccoli comuni che non hanno possibilità realistiche di decollo del servizio. I l sistema bibliotecario invece per sua natura non può essere piatto, ma richiede una notevole differenziazione ed articolazione su più Hvelli, da quello cittadino a quello provinciale e poi regionale, fino a quello nazionale e infine a quello intemazionale.
Ma veniamo dalla biblioteca al bibliotecario. La prima cosa che salta agli occhi, confrontando storicamente i l bibliotecario "statale" e i l bibliotecario "locale", è che mentre i l primo sta saldamente collocato dentro l'alveo (e i ruoli di anzianità) di una "grande madre", protettiva e magari un po' oppressiva, che è l'amministrazione centrale dello Stato, che scendendo per l i rami si precisa in Direzione generale delle accademie e biblioteche o Ufficio centrale per i beni librari, i l secondo è invece per sua natura un bibliotecario in partibus infide-lium, un ambasciatore fra i selvaggi (senza offesa, naturalmente, per i non bibliotecari). Bibliotecario unico, nei casi migliori con qualche collaboratore, e non bibliotecario tra bibliotecari.
I l bibliotecario locale, sia inserito in una comunità attenta oppure sorda, è un bibliotecario fra non bibliotecari, chierico fra i laici (e magari laico fra i chierici, se visto dalla prospettiva dei suoi colleghi e interlocutori nell'ente locale, funzionari amministrativi, che non lo r i conoscono fino in fondo come uno di loro). Comunque diverso, condannato a spiegare le sue ragioni e a spiegarsi a persone diverse (amministratori e politici, funzionari, esponenti di istituzioni e forze social i , cittadini), condizione che non muta a seconda della sensibilità o insensibilità degli interiocutori e forse nemmeno della loro cultura.
Per inciso, questa è una delle tante prove che quella del bibliotecario è una professione. Lo è di fatto, per come si sente chi ne fa parte e per come la percepiscono gh altri. Una professione spesso incerta o insicura, talvolta bistrattata, attraversata da forti correnti d'aria e soggetta a scorrerie, quasi sempre in dubbio su se stessa e spesso tentata di evadere verso altri l idi. Ma non si evade da un luogo che non esiste o è indefinito. I l bibliotecario si riconosce nel bibliotecario (non sempre si piace, ma questa è altra questione) e diverso da chi bibliotecario non è. Trasferito o anche promosso ad altri incarichi, magari di alta responsabilità e più remunerativi, non mancherà di dirci, anche quando ne è contento, che «però non faccio più i l bibliotecario».
I l bibliotecario locale, perciò, come la biblioteca locale o cittadina, vive e si muove necessariamente su due binari, interagendo da una
36
IL BIBLIOTECARIO "LOCALE": IERI E DOMANI
parte con la sua comunità locale, sul territorio, dall'altra con gli altri liibliotecari, che restano un punto di riferimento imprescindibile. Non mi soffermo su questo secondo versante, che dovrebbe essere ovvio, se non per ricordare che, come ogni cosa può essere classificata secondo più aspetti, così numerose sono le affinità e di conseguenza le relazioni che sarà utile tenere, non solo con i colleghi più vicini, non solo con quelli di istituti analoghi al proprio.
Torniamo al rapporto con la comunità, con le sue istituzioni, con i suoi fenomeni rappresentativi, e quindi in primo luogo alle relazioni con gli altri istituti culturali, che svolgono funzioni diverse ma in vario modo collegate, o collegabili, a quelle della biblioteca.
Vorrei riprendere qui un vecchio ma interessante intervento dedicato proprio a questo tema da un bibliotecario oggi quasi sconosciuto, Virginio Mazzelli. Mazzelli diresse per quasi trent'anni, fino alla morte (1931), la Biblioteca municipale di Reggio Emilia, di cui era stato prima vicedirettore. Come tanti bibliotecari veniva da una prima esperienza di insegnamento, nella scuola di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia, e cominciò la sua carriera nelle biblioteche dello Stato, come alunno (oggi diremmo tirocinante) alla Braidense di Milano, allora diretta da Giuseppe Fumagalli.
A Mazzelli fu chiesto di svolgere, nel primo Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia tenuto a Roma e Venezia nel 1929, un tema che gli era caro, e che aveva già affrontato nel 1925 al primo Congresso dei bibliotecari, archivisti e direttori dei musei comunali e provinciali^.
«Il tema che mi è stato proposto di svolgere - inizia la sua relazione - : "Utilità che siano accentrati e posti sotto un'unica direzione tutti gli Istituti bibliografici, artistici, archivistici, archeologici delle piccole città sedi di biblioteche comunali" è, come ognun vede, di una semplicità e di una evidenza tale che si direbbe essere assunto affatto inutile il dimostrarlo.
Gli è come dire: Utilità che per un pianista non sia i l do diesis in soffitta e i l do naturale in cucina e i l do bemolle in cantina, ma che tutti i tasti di tutte le note sieno graduati e pronti sotto le sue dita.
Virginio Mazzelli, Distribuzione razionale del materiale manoscritto e stampato tra biblioteche e istituii scientifici, in: 1° Congresso Ira funzionari di biblioteche musei ed archivi comunali provinciali e di enti locali, Padova XVI-XVIII giugno MCMXXV, in: Nel 1° centenario del Museo civico di Padova MDCCCXXV-MCMXXV: atti ufficiali della Celebrazione del centenario e del Congresso Ira funzionari di musei, biblioteche e archivi di enti locali, «Bollettino del Museo civico di Padova», n.s., 2 (1926), n. 1/4, p. 149-152.
37
ALBERTO PETRUCCIANI
Per un accentramento non si deve intendere trasporto in un solo luogo di tutto quanto sia attualmente sparso. Accentrare in questo senso equivale a distruggere [. . .] .
Non quindi le opere materiali: l ibri , quadri, statue, manoscritti, pergamene e via dicendo; ma la loro storia, ma la loro scheda, ma i l loro catalogo e soprattutto la loro conoscenza ed i l loro culto deve essere accentrato: vale a dire che la biblioteca di provincia, unico e massimo Istituto culturale, deve avere uno schedario completo, aggiornato, sempre alimentato di tutto ciò che nella provincia esiste e si acquista, o man mano si scopre, nonché un cervello, un'anima, un cuore che tutte queste cose abbracci, che le studi, che le conosca, che le illustri e che le indichi, quando occorra a chi che sia. [...]
Conoscere, approfondire, valutare i proprii tesori, ecco i l vero e v i tale accentramento; i l poterne disporre e i l poter dire con sicurezza: i l patrimonio culturale, artistico, storico ha questi confini: la provincia ha queste ricchezze: questo ne è l'elenco, questa ne è la precisa indicazione, queste sono le norme per la relativa visione e consultazione: eccone la palpitante utilità)/.
: La biblioteca locale, quindi, come sede in cui si realizza l'interesse comune a trattare tutta l'informazione che riguarda i l patrimonio culturale, le tradizioni, le attività della provincia, del capoluogo e dei comuni che lo circondano.
Già quattro anni prima, come si è detto, Mazzelli aveva discusso un problema interessante e tipico della realtà italiana, cioè la proliferazione nei centri cittadini anche medi e piccoli di altri istituti culturali oltre alla biblioteca: accademie, società storiche, circoli culturali, o-gnuno dei quali tendeva a creare una propria raccolta di libri e riviste (per donazioni, scambio con le proprie pubblicazioni ecc.). Ogni istituto, notava Mazzelli, aveva i l diritto e i l dovere di creare ed accrescere la propria strumentazione scientifica, ma poi di fatto questo materiale era spesso irraggiungibile dagli studiosi, raramente ordinato, quasi mai oggetto di un vero servizio pubblico, che solo la biblioteca locale poteva garantire.
A questo proposito segnalerei, come esempio, la recente esperienza della Spezia, dove è stata costituita dal Comune una istituzione per i servizi culturali che abbraccia biblioteche, archivi e musei; all'interno
Virginio Mazzelli, Utilità che siano accentrali e posti sotto un'unica direzione tutti gli istituti bibliografici, artistici, archivistici, archeologici delle piccole città sedi di biblioteche comunali, in: Primo Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia, Roma-Venezia, 15-30 giugno MCMXXIX-a. VII atti, Roma: Libreria dello Stato, 1931-1933, voi. 3, p. 291-292.
38
* IL BIBLIOTECARIO "LOCALE": IERI E DOMANI
di una delle due biblioteche, quella moderna, hanno potuto trovare sede anche i due principali istituti storici della città, con le loro attività e le loro importanti raccolte bibhografiche.
Come è tipico del cambiamento storico, insomma, molte cose sono rimaste, continuano a costituire gli elementi del nostro paesaggio, ma altre se ne sono aggiunte. Oggi non possiamo piti vedere le biblioteche locali solo nel contesto delle istituzioni culturali, ma dobbiamo legarle anche ad altri campi, all'informazione, ai servizi sociali ecc. I legami con altri campi e attività sono piii numerosi, ma rimangono valide le esigenze di collegamento della biblioteca con altri istituti e l'individuazione del contributo che essa può dare nel suo campo proprio, quello dell'informazione. Virginio Mazzelli lo diceva in una lingua un po' diversa dalla nostra, ma la sostanza è la stessa. Oggi lo diciamo con parole diverse: la biblioteca pubblica è la «via di accesso locale alla conoscenza», «è i l centro informativo locale, che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione»^.
La biblioteca locale, anzi, si propone sempre più come "centrale" per raccogliere o creare e per organizzare le informazioni su tutta la varietà di oggetti e di possibili interessi della comunità locale, per e-sempio nell'ambito delle reti civiche, in cui la biblioteca può dare un contributo fondamentale come "architetto" del complesso delle informazioni di interesse per la comunità''.
C 'è però un ultimo punto che vorrei toccare, un interrogativo che vorrei che ci ponessimo. Abbiamo visto come molti tratti della biblioteca locale appartengano alla dimensione della lunga durata, cosa è i l proprio della biblioteca rispetto ad altri istituti locali con cui deve necessariamente collegarsi, quale è i l suo ruolo per l'informazione. Rimane però da interrogarsi su quale sia i l rapporto tra questa centralità dell'informazione e i l ruolo del libro e della lettura.
Oggi siamo abituati a considerare l'informazione come qualcosa che si valuta soprattutto sotto i l profilo della tempestività e dell'efficacia, l'informazione che serve al momento in cui serve, quindi per sua natura anche estremamente effimera.
Siamo anche abituati a porci i l problema della multimedialità, a riconoscere che oltre al libro ci sono tanti altri mezzi di comunicazione e di espressione, e a sentirci in qualche modo in difetto, perché sap-
^ // Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche, «AIB notizie», 7 (1995), n. 5, p. 1-2.
Cfr. Claudio Leombroni - Igino Poggiali, Biblioteclie e reti civiche: un'alleanza perla libertà, «Bollett ino AIB», 36 (1996), n. 3, p. 291-306.
39
ALBERTO PETRUCCIANI
piamo ciie le nostre biblioteche non sono affatto eque nell'offerta dei diversi materiali, sono generalmente molto povere, o prive di tutto, appena si esce fuori dall'ambito del libro, o del periodico. Non voglio dire che non dobbiamo sentirci in difetto, che non dobbiamo porci questo problema.
Ma dovremmo anche provare a riflettere su quanto nella biblioteca si debba anche tenere conto di una duplicità di prospettìve: sicuramente dobbiamo lavorare sull'informazione, e in particolare sull'informazione contemporanea, dobbiamo lavorare su tutti i mezzi di comunicazione, ma dobbiamo anche tenere conto del fatto che ci sono mezzi di comunicazione e scopi di diversa durata, tra i quali abbiamo noi la responsabilità di definire un equilibrio. Ci sono cose che servono oggi, che è opportuno che funzionino subito, ma come biblioteche e come bibliotecari abbiamo anche una grossa responsabilità per la lunga durata.
Non penso semplicemente al problema della conservazione, all'esigenza, sacrosanta, di garantire che i documenti della cultura di ieri e di oggi non decadano e non si distruggano.
La durata è qualcosa di piti profondo della conservazione, forse difficile da spiegare senza fare della retorica. Come bibliotecari abbiamo i l problema di prenderci cura, di diffondere dei valori, dei messaggi di lunga durata. Questo è forse i l senso del riferimento al " l i bro". Cercare di dedicare sempre una particolare attenzione non tanto a un singolo mezzo rispetto ad altri, al prodotto di una particolare tecnologia o di uno specifico circuito editoriale, ma ai valori e ai messaggi che durano di più, e che poi sono spesso quelli di cui meno si prende carico l'industria culturale.
Quando pensiamo al libro, pensiamo non solo alla conservazione, ma a come la biblioteca possa e debba proporsi quale luogo in cui non si danno semplicemente delle informazioni, ma si è sempre attenti a far circolare i messaggi che conteranno di piii , che avranno i l maggiore impatto, i l maggiore significato per i propri utenti. I messaggi che l i aiuteranno non solo a fare oggi una cosa, domani un'altra, ma a diventare quello che sono.
40