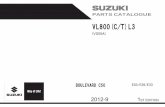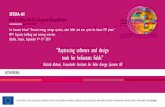Igor Baglioni, Prolegomeni allo studio della sfera del post mortem. Brevi osservazioni di metodo, in...
Transcript of Igor Baglioni, Prolegomeni allo studio della sfera del post mortem. Brevi osservazioni di metodo, in...
ReligioCollana di Studi del Museo delle Religioni
“Raffaele Pettazzoni”Diretta da Igor Baglioni
Comitato Scientifico:Maria Giovanna Biga, Sergio Botta, Ileana Chirassi Colombo,
Sabina Crippa, Emanuela Prinzivalli
estratto
© Roma 2014, Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.via Ajaccio 41-43, 00198 Romatel. 0685358444, fax 0685833591email: [email protected]
ISBN 978-88-7140-570-4
Finito di stampare nel mese di Novembre 2014presso Global Print - Gorgonzola (MI)
ReligioCollana di Studi del Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”Diretta da Igor Baglioni
Volumi pubblicati:2013 - I. Baglioni (a cura di)Monstra. Costruzione e percezione delle entità ibride e mostruose nel Mediterraneo antico
Vol. 1 - Egitto, Vicino Oriente Antico, Area Storico-ComparativaVol. 2 - L’Antichità Classica
2014 - I. Baglioni (a cura di)Sulle Rive dell’Acheronte. Costruzione e Percezione della Sfera del Post Mortem nel Mediterraneo
AnticoVol. 1 - Egitto, Vicino Oriente Antico, Area Storico-ComparativaVol. 2 - L’Antichità Classica e Cristiana
Volumi in programmazione:2015 - I. Baglioni (a cura di)Ascoltare gli Dèi / Divos Audire. Costruzione e Percezione della Dimensione Sonora nelle
Religioni del Mediterraneo Antico .Vol. 1 - Egitto, Vicino Oriente Antico, Area Storico-ComparativaVol. 2 - L’Antichità Classica e Cristiana
estratto
Sulle Rive dell’AcheronteCostruzione e Percezione della Sfera
del Post Mortem nel Mediterraneo Antico
a cura di Igor Baglioni
Primo volume(Egitto, Vicino Oriente Antico,
Area Storico-Comparativa)
estratto
Indice
Primo volume(Egitto, Vicino Oriente Antico, Area Storico-Comparativa)
IntroduzioneIgor Baglioni, Prolegomeni allo studio della sfera del post mortem. Brevi osservazio-
ni di metodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
La sfera del post mortem in Egitto e nel Vicino Oriente AnticoBenedetta Bellucci - Matteo Vigo, Note sulla concezione del post mortem presso gli
Ittiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Alessandra Colazilli, La Morte per annegamento nell’antico Egitto. Privilegio e dan-
nazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Ilaria Davino, Da un mondo all’altro. L’“apertura della bocca” e il legame tra il de-
funto e il vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Francesca Iannarilli, Culto degli antenati o damnatio memoriae? I defunti “speciali”
del complesso funerario di Umm el-Marra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Valentina Melchiorri, Defunti bambini e dinamiche rituali nel mondo fenicio d’Oc-
cidente. Il contributo dell’archeologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Michela Piccin, Escamotages di immortalità? Morte e retorica nel mondo accadico . . 89Simonetta Ponchia, Le divinità infere nella letteratura neo-assira tra canonizzazione
e ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Lucio Sembrano, L’evocazione del mondo infero nel salterio e nei libri sapienziali a
confronto con i Canti degli arpisti egiziani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Valeria Turriziani, La rappresentazione “parziale” del defunto: funzione e significato
dei busti nelle tombe private dell’Antico Regno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Irene Vezzani, A ciascuno il proprio destino nella Duat: il papiro SAT 3663 della
cantante di Amon Cesmehed-Khonsu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
La sfera del post mortem in una prospettiva storico-comparativaParide Bollettin, Il morto non sono io. Vivi e morti tra i Mebengokré del Brasile cen-
trale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Jorge García Cardiel, A lomos de la esfinge, guiados por la diosa: El tránsito al más
allá en el imaginario ibérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Marco Menicocci, Praterie senza “Aldilà”. Morte e sorte “oltremondana” tra gli in-
diani Crow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
estratto
Marco Nocca, “Una ex illis ultima”. Immagine e rappresentazione della morte dalla fine del Medioevo al Rinascimento. Danza macabra, Trionfo della Morte, Giudi-zio Universale in alcuni cicli pittorici italiani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Secondo volume(L’Antichità Classica e Cristiana)
IntroduzioneIgor Baglioni, Prolegomeni allo studio della sfera del post mortem. Brevi osservazio-
ni di metodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
La sfera del post mortem nell’Antichità ClassicaIgor Baglioni, Kerberos. Il cane guardiano degli Inferi nella Teogonia esiodea. . . . . . 21Tommaso Braccini, Pescare nell’“Aldilà”. La katabasis di PFayum 2 . . . . . . . . . . . . . 29Romina Carboni, Ecate e il mondo infero. Analisi di una divinità liminare . . . . . . . . 39Doralice Fabiano, Tra Ade e Olimpo. I castighi di Tantalo e Issione . . . . . . . . . . . . . . 53Paolo Garofalo, Non solo funerali: qualche considerazione sulle funzioni del collegio
salutare di Lanuvio (CIL XIV 2112) e sulle ragioni della sua dedica a Diana e Antinoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Marco Giuman, ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΙΩΝ ΜΕΛΙ ΑΝΕΣΤΗ. Ritualità e simbologia del mie-le nel mito di Glauco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ezio Pellizer, Figure dell’“anima” e del regno dei morti nella Grecia arcaica . . . . . . . . 89Carmine Pisano, Riformulare la tradizione: un’antropologia “oltremondana” orfica . . 99Diana Segarro Crespo, Orbona: il rischio di divenire un morto in vita nell’antica Roma . . . 109Ilaria Sforza, Il Peso delle Chere. La Kerostasia in Il. VIII 70 e XXII 210 . . . . . . . . . . 125
La sfera del post mortem nell’Antichità CristianaRossana Barcellona, Fuoco nemico. L’uso polemico delle fiamme infernali tra Salvia-
no di Marsiglia e Fausto di Riez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Luigi Maria Caliò, Escatologia ed esperienze sapienziali nella Necropoli Vaticana . . 155Michele Ciccarelli, Anime fuori dell’Ade. Carattere e funzione delle anime dei mar-
tiri nell’Apocalisse di Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Giovanni Frulla, “Due strade nell’Ade” (Ps. Iust. De Monarchia 3): riferimenti esca-
tologici nei frammenti della letteratura giudaico-ellenistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Elio Jucci, Vita e morte a Qumran. Sepolture, risurrezione, ascesa al cielo, e vita
comunitaria. Tra il clamore delle tombe, e l’ambiguità dei testi . . . . . . . . . . . . . . . 197Paola Marone, Agostino e la questione delle apparizioni dei defunti . . . . . . . . . . . . . . 211Ilaria Ramelli, La dottrina escatologica cristiana dell’apocatastasi tra mondo siriaco,
greco, latino e copto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Teresa Sardella, Dalla scomunica all’Inferno. L’Aldilà come strumento di potere nelle
prime decretali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Luigi Silvano, Per una fenomenologia dell’Inferno bizantino: la geografia morale del-
le visioni dell’Aldilà (IV-XI sec.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
estratto
Questo libro raccoglie gli Atti del II Incontro sulle Religioni del Mediterraneo Antico promosso dal Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni” e dedicato al tema del post mor-tem. L’iniziativa, denominata Sulle Rive dell’Acheronte. Costruzione e Percezione della Sfera del Post Mortem nel Mediterraneo Antico, si è svolta da martedì 12 a sabato 16 giugno a Velletri (Roma), nel 2012. Nel primo volume, sono riportati gli interventi inerenti all’Egitto e al Vi-cino Oriente antico, così come i contributi che indagano il tema da un punto di vista storico-comparativo. Nel secondo volume, sono riportati gli interventi inerenti all’antichità classica e cristiana. L’incontro si è reso possibile grazie al contributo e alla collaborazione dell’unità di ricerca della Sapienza Università di Roma, diretta da Tessa Canella, del progetto di ricer-ca nazionale FIRB “Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda Antichità e Medioevo”. L’unità di ricerca ha curato, nello specifico, l’organizzazione di una sessione dedicata ai temi e alle problematiche storico-religiose legate alla “Geografia Infera” i cui Atti sono stati pubblicati, separatamente, sul numero 80 (primo fascicolo) della rivista “Studi e Materiali di Storia delle Religioni”, ospi-tati, insieme ad altri contributi che contribuiscono ad approfondire questo tema di ricerca, nella theme section “Geografie del mondo altro. Prospettive comparative sugli spazi sacri e l’aldilà”. Sempre in una theme section su rivista – in questo caso si tratta del “Mediterranean Journal of Social Sciences” – sono in corso di pubblicazione gli interventi presentati al conve-gno di taglio più spiccatamente archeologico, legati alla cosiddetta “Archeologia della Morte”.
Oggetto e fine del convegno è stato l’approfondimento, da un punto di vista interdisci-plinare, delle metodologie di indagine atte ad analizzare i meccanismi di costruzione culturale di quanto attiene alla sfera del post mortem. Per questo, gli interventi si sono soffermati sulle tematiche connesse a quanto possiamo definire convenzionalmente come “anima” e “Aldilà”, sulle caratteristiche degli esseri extra-umani e delle divinità collegate a questa sfera, così come sui rituali funebri, ponendo in evidenza, tramite l’analisi di singoli casi di studio, l’approccio euristico e i metodi di analisi, usuali o di carattere innovativo, verificandone criticamente l’efficacia in un confronto diretto con il materiale documentario.
Non si è quindi ritenuto opportuno indirizzare l’incontro di studi verso una ricostruzio-ne critica del “sistema” tanatologico relativo alle singole aree culturali prese in esame. Questo perché, da un punto di vista generale, le religioni dei popoli gravitanti nell’antichità intorno al bacino del Mediterraneo, pur con le differenze e le peculiarità che a volte le rendono estrema-mente divergenti le une dalle altre, sono nell’insieme storicamente assai “fluide”, presentano cioè un panorama in continuo fermento e mutamento, dovuto alla mancanza di autorità o
IntroduzioneProlegomeni allo studio della sfera del post mortem Brevi osservazioni di metodo
Igor Baglioni
estratto
10 I. Baglioni
di testi sacri di carattere “canonico”1, che, allo stesso tempo, siano in grado di cristallizza-re, garantire e fissare determinate credenze come “ortodosse” ed esclusive rispetto alle altre per la comunità nel suo complesso. Ciò comporta non solo un quadro in continuo divenire, ma soprattutto la presenza nello stesso contesto culturale e nella stessa fase storica di conce-zioni della morte alternative, se non addirittura in contraddizione tra loro2. Come nota, ad esempio, Jean Bottéro in relazione alle credenze relative alla sfera del post mortem nell’antica Mesopotamia, si possono rilevare nelle fonti riguardanti la “Terra tra i due fiumi” la presenza di visioni antinomiche quali «l’entrata del Regno dei morti, moltiplicata da una parte dalle tombe individuali, e dall’altra unica e posta al termine di un lungo viaggio verso l’Occidente; i defunti, da un lato torpidi e come paralizzati, dall’altro aggressivi ed attivi; il Paese-senza-ritorno, che non cessa di lasciar “ritornare” i propri abitatori; da una parte, l’uguaglianza di tutti in una condizione fondamentalmente negativa e, dall’altra, la gerarchia perpetuata dei grandi e dei piccoli, dei ricchi e dei poveri…»3. Inoltre, come sottolinea Paolo Xella, «non è da credere che esista ovunque una tanatologia sistematica, o che ci si ponga di fronte al decesso umano necessariamente con gli schemi mentali da noi elaborati. Chi penserebbe, ad esempio, che la sterminata letteratura egiziana di carattere funerario, denotante un interesse quasi morboso per il destino ultraterreno dell’uomo, non abbia lasciato trasparire una chiara concezione circa le origini, le cause, la “natura” della morte? Sarà banale notare che ciò non si deve ad un’incapacità egiziana di “teorizzare” al riguardo, ma solo ad una mancanza di inte-resse di tale cultura per la domanda: che cos’è la morte?»4.
Pertanto, stante quanto qui abbiamo delineato, si è ritenuto che un maggior contributo all’avanzamento degli studi sul tema potesse venire da un momento di confronto su quelle che sono le nostre “bussole” per orientarci in un quadro così complesso e spesso apparentemente caotico (almeno per noi moderni), ovvero i nostri metodi di analisi e il nostro approccio cri-tico alla realtà indagata.
L’affinamento metodologico è importante perché lo studio dei rituali funebri, così come della strutturazione culturale della “realtà” che si celerebbe oltre il post mortem, ci consentono di avere una via ulteriore alla ricostruzione delle caratteristiche di una data società nel suo complesso, così come del quadro ideologico che ne garantisce e sostiene i meccanismi di funzionamento e la coesione sociale. Ad esempio, si possono presentare casi in cui l’organiz-zazione di una società può essere pensata perpetuarsi nell’“Aldilà” esattamente così come si strutturava nella realtà “terrena”; oppure si possono presentare casi in cui l’organizzazione e le gerarchie sociali nell’“Aldilà” siano completamente invertite rispetto alla condizione che si aveva quando si era in vita, magari per motivazioni di carattere etico che, comunque, se pur indirettamente, ci documentano il mondo di cui sono proiezione ideale e quelle che veniva-no percepite come le sue “ingiustizie”. In sintesi, si deve rilevare come «struttura e funzioni dell’aldilà, ben lungi dal vivere di vita propria in un mondo delle idee, siano una via d’accesso
1 Sui concetti di “autorità” e “canone” come strumenti tipologici di analisi, si vedano i contributi presenti sul n. 78 (1) di SMSR del 2012, pubblicati nella theme section “Canome, norma e autorità”, con l’editoriale di presentazione.2 Su questo aspetto, si vedano i contributi presenti in Xella 1987a.3 Bottéro 1987: 93.4 Xella 1987b: 9.
estratto
Prolegomeni allo studio della sfera del post mortem. Brevi osservazioni di metodo 11
privilegiata per una piena comprensione storica di una civiltà, mai astraibili dal complesso delle sue manifestazioni»5.
Ciò comporta, ovviamente, la particolare attenzione che deve essere data all’esame delle fonti, sia letterarie che iconografiche, come a quelle di carattere più genericamente archeolo-gico legate al contesto di scavo. Di un documento bisogna chiedersi a che tipologia appartiene secondo le categorie della cultura che lo ha prodotto e/o nella quale viene fruito, soffermarsi sulle sue caratteristiche redazionali o realizzative, su chi ha prodotto questo documento, se individuabile, e con quali finalità, chi erano i suoi destinatari in caso avesse lo scopo di tra-smettere esplicitamente un messaggio. Utile, in una fase successiva, è analizzare il documento e/o il messaggio che esso trasmette da un punto di vista storico-comparativo, ponendolo in confronto con la documentazione prodotta in altre aree culturali che per caratteristiche e finalità si presenta “analoga” o “somigliante” a quanto è oggetto della nostra analisi. Compito di questa fase è mettere in luce le differenze presenti tra i due o più elementi presi in consi-derazione e, soprattutto, le motivazioni storiche che soggiacciono a tali differenze e che sono riconducibili alle peculiarità ideologiche e socio-economiche di appartenenza6.
Procedere secondo queste modalità, potrebbe essere d’aiuto per orientarsi nella plura-lità di concezioni del post mortem che, come abbiamo rilevato in precedenza, possono essere attestate nel medesimo contesto storico-culturale, in quanto non si tratta, come è anche stato proposto più o meno esplicitamente, di un fenomeno che rappresenterebbe la peculiarità di un astratto “pensiero mitologico”, di un “pensiero selvaggio”, se ci si può far passare questa citazione impropria di Lèvi-Strauss7, connaturato ai popoli “arcaici” e alle loro modalità di pensare e recepire il mondo, in opposizione alla “logica” di un astratto “uomo moderno”, teso “per sua natura” a ordinare ciò che lo circonda in sistemi ideali coerenti e bene delineati. Si tratta, semplicemente, del risultato dato in società che, come abbiamo sottolineato nelle pa-gine precedenti, non conoscono o conoscono in forma molto attenuata autorità in grado di stabilire “ortodossie” vincolanti per l’intera comunità e che, pertanto, producono, secondo le loro caratteristiche ed esigenze storiche determinate, una molteplicità di tradizioni fondanti e orientative. L’analisi contestuale di quali fonti ci attestano queste tradizioni e la verifica di chi le ha formulate e/o impiegate, ci aiuta a comprendere le motivazioni della loro esistenza, e questo in rapporto al loro quadro storico di appartenenza ed utilizzo, e non in rapporto a una astratta mentalità genericamente umana o a una fase di una sua ipotetica “evoluzione”8.
Ad esempio, l’importanza di un confronto diretto con la documentazione per la rico-struzione di come possa esplicarsi l’atteggiamento dell’uomo nei confronti della morte e di come esso presenti potenzialità che vadano ben oltre a quanto si ritiene aprioristicamente sia l’atteggiamento “dato” e “naturale” che l’uomo ha di fronte a essa, emerge sicuramente dalla
5 Xella 1987b: 10.6 Per un approfondimento della prassi metodologica di analisi, si rimanda ai contributi presenti in Rocchi - Xella 2006; Baglioni 2010; Nizzo 2011a; Nizzo - La Rocca 2012. Specificamente per quanto riguarda l’analisi delle fonti letterarie, si vedano anche le osservazioni presenti in Brelich 1970-1972.7 Il riferimento è al classico studio La pensée suavage, Paris 1962.8 Le possibilità e i limiti entro i quali si può parlare di una generica “evoluzione umana” e della sua “mentalità”, sono sottolineati in Brelich 1956 e 1985. Si veda anche Sabbatucci 1977.
estratto
12 I. Baglioni
lettura dei dati riguardanti un’area come Ras Shamra, l’antica Ugarit, che svolse un ruolo rilevante nella storia del Vicino Oriente antico. Normalmente, infatti, come si trova anche variamente attestato in diversi contesti culturali, si ritiene che l’uomo abbia una “naturale” e “spontanea” paura dei defunti. Bene. Così non sembrerebbe essere a Ras Shamra, almeno allo stadio delle fonti cui rimanda lo studio che qui citiamo, e questo per precise ragioni dovute alla “strutturazione religiosa” che quella cultura si era data nell’arco della sua storia e al rap-porto cultuale con i defunti stabilito in essa. Infatti, Paola Xella nota, al riguardo, come «i dati archeologici testimoniano da un lato una diffusa familiarità con i morti, la radicata consue-tudine a vivere accanto ai propri defunti, per meglio onorarli e di conseguenza assicurarsene il prezioso aiuto. L’architettura funeraria di Ras Shamra mostra … che quasi ogni casa era stata pianificata per ospitare le famiglie dei vivi ed insieme per fornire adeguata collocazione alle generazioni dei loro morti»9. Si riscontra, sostanzialmente, «una familiarità “positiva” con i defunti, che, a differenza di altre documentazioni, non ci appaiono qui in quei ruoli terrorizzanti e negativi, che hanno altrove prodotto abbondantissime letterature esorcistiche e apotropaiche»10. In sintesi, dal materiale documentario sembrerebbe emergere un quadro per il quale «il desiderio di “reintegrazione” dei defunti, il riguadagno delle loro positive poten-zialità per il bene del singolo come della collettività, paiono prevalere sull’istanza spontanea di terrore. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che, dei testi finora noti, non uno sia volto a neutralizzare gli interventi malefici degli spettri»11.
Inoltre, il confronto con i realia relativi al post mortem, non solo ci è utile, come ab-biamo poc’anzi esemplificato, per porci criticamente verso qualsiasi tipo di comportamento che venga usualmente ritenuto come “dato”, “spontaneo” e “naturale” per l’uomo, spesso di fatto proiettando inconsapevolmente sul “genericamente umano” quelli che sono i nostri usi e costumi attuali, ma anche, come già detto, per la ricostruzione delle pratiche sociali di una determinata cultura, particolarmente quando, in essenza di fonti scritte, la documentazione archeologica di ambito funebre ci consente di supplire con cautela a tale mancanza.
Un caso emblematico in tal senso è quello costituito dalla tomba 12 della necropoli protostorica di Caracupa (una località del Lazio meridionale, non lontana da Sermoneta e Norba) dove si sono rinvenuti i resti del corpo di una donna, di età stimabile tra i 25 e i 27 anni. Le analisi di carattere antropologico hanno rivelato che la giovane doveva essere afflitta fin dalla nascita da una grave patologia. Il male le aveva pregiudicato le capacità motorie in maniera probabilmente molto grave e, verosimilmente, le aveva provocato anche gravi pro-blemi a livello celebrale che dovevano limitarne fortemente le capacità mentali. In sintesi, si trattava sicuramente di una donna non autosufficiente, sia per motivi fisici che mentali, che, però, come le analisi hanno messo in luce, aveva completato il suo sviluppo e doveva avere la possibilità di ricevere un’alimentazione corretta e variegata. Da questo dato, possiamo inferi-re l’esistenza in quell’area, intorno al terzo quarto dell’VIII sec. a. C., di una comunità in cui, almeno in determinati ambienti sufficientemente ricchi, le strutture parentali dovevano essere
9 Xella 1987c: 121-122.10 Xella 1987c: 124.11 Xella 1987c: 132-133.
estratto
Prolegomeni allo studio della sfera del post mortem. Brevi osservazioni di metodo 13
organizzate, assistenzialmente attente e in grado di garantire la sopravvivenza di un individuo che difficilmente godeva di autonomia fisica e mentale12. In aggiunta, da un punto di vista storico-comparativo, possiamo rilevare che, contrariamente a quanto spesso si crede sulla scia delle leggi spartane che prevedevano che i bambini nati deformi o con handicap venissero gettati dall’alto del monte Taigeto, non necessariamente in tutte le società del Mediterraneo antico i bambini destinati a non divenire adulti “normali”, secondo gli “standard” fisici della comunità, venivano abbandonati e/o lasciati morire. Altro esempio, quindi, di come il con-fronto corretto con la documentazione possa non avallare quelli che possiamo considerare dei “luoghi comuni” condivisi, in questo caso non riconducibili a una presunta “psicologia umana universale”, ma di altro ordine.
Ora, dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale che le fonti rivestono per qualsiasi approccio euristico che intenda ancorare la propria analisi al dato storico, è utile soffermarsi, per approfondire queste osservazioni di carattere metodologico, anche su alcune domande che possiamo orientativamente porci per studiare la costruzione culturale della sfera relativa al post mortem. Di fronte a quanto attiene a questa sfera in un determinato contesto storico-culturale, possiamo procedere nella nostra indagine, dopo aver chiarito la natura delle fonti che abbiamo a disposizione e il messaggio che queste trasmettono, chiedendoci e chiedendo al materiale documentario, ad esempio, chi è che in quel dato contesto deve morire e per-ché, se la sua sorte è differenziata rispetto a quella di altre persone, se uomo, o di altri esseri extra-umani, se dio o appartenente ad altra tipologia di entità, quali siano le modalità della morte e come essa venga concepita, cosa si riteneva avvenisse dopo di essa, quali siano gli atteggiamenti corretti da adottare verso il defunto e in generale verso i morti nel loro insieme. Anche le risposte a queste domande possono essere inserite con esiti proficui in un raffronto di carattere storico-comparativo, teso a sottolineare le differenze e le motivazioni soggiacenti a tali differenze in relazione alle caratteristiche di altre aree culturali in una specifica fase della loro storia.
Va precisato, comunque, che si tratta di domande che possiamo porci a titolo puramente orientativo, per avere, come detto, una “bussola” a guidarci, e quindi non vanno prese come delle domande valide universalmente ed esegeticamente utili per qualsiasi contesto storico-culturale. I nostri strumenti interpretativi, così come il nostro percorso di ricerca, devono essere calibrati in relazione all’oggetto e all’area di interesse in questione, che ha le sue proprie caratteristiche, il suo particolare modo di articolare culturalmente il mondo e di rapportarsi ad esso. Pertanto, durante la ricerca, può presentarsi la necessità di rivedere e, appunto, ricali-brare i propri interrogativi, scopi e modalità di approccio euristico per poter meglio compren-dere la costruzione culturale del mondo che una determinata società ha elaborato in relazione a specifiche esigenze storiche, e le domande come le soluzioni che essa si è posta in rapporto al contesto che ha strutturato.
Questo, ci conduce adesso a un altro aspetto del quale dobbiamo essere ben consci al momento di “interrogare” il materiale documentario in maniera opportuna, ovvero il carattere convenzionale di molti dei termini, concetti e tipologie con i quali andiamo ad
12 Nizzo 2011b: 30-33.
estratto
14 I. Baglioni
operare e che possono non trovare un esatto riscontro nel contesto storico-culturale ogget-to di indagine. Cosa normale, in quanto non si tratta di categorie umane universali, ma di “strumenti” conoscitivi e di ordinamento del reale che sono il frutto del percorso storico della nostra civiltà.
Nell’ambito dello studio degli aspetti relativi alla sfera del post mortem, ciò emerge in maniera paradigmatica per quanto riguarda i concetti di “anima” e di “Aldilà”.
L’idea di “anima”, infatti, intesa quale principio spirituale dell’uomo contrapposto alla sua parte corporea ed esistente a prescindere dalla vita o dalla morte di essa, è il frutto di un percorso storico che inizia in ambito greco antico, a partire da quelle correnti religiose che vengono normalmente comprese nella categoria dell’“Orfismo”, per poi svilupparsi e “si-stematizzarsi”, dapprima nel pensiero di Platone e della filosofia a lui successiva, e poi nella speculazione cristiana relativa alla Salvezza13. Quest’idea non è di fatto riscontrabile in tutte le culture, come peraltro non è riscontrabile in quel mondo greco arcaico rappresentato dai po-emi omerici dove il termine psyché, che è quello che noi traduciamo con “anima”, ha valenze ben diverse, apparendo sostanzialmente come il “soffio vitale” che mantiene in vita l’indivi-duo, ma non come il suo vero “io” o la sua vera “essenza” e “identità” in senso platonico, così come non è riscontrabile la distinzione/opposizione “corpo/anima” così come viene concet-tualizzata nel pensiero del filosofo ateniese. Come nota Giulio Guidorizzi, «la psiche omerica non indica l’anima nel senso platonico del termine, e tanto meno ha relazione con fenomeni mentali: è il soffio vitale che abbandona un uomo, lasciandolo immoto tra le braccia della morte. … Nei nobili versi dell’epica omerica la psyché designa l’energia che anima un uomo e che si rende percepibile solo quando le manifestazioni della vita cessano o vengono sospese: l’unica sua funzione sembra essere quella di abbandonare un uomo quando questi esala l’ul-timo respiro, mentre nulla si dice del modo cui essa operi nel vivente. La psyché è un’entità materiale, un alito di vapore che si disperde nell’aria oppure un fiotto di sangue che sgorga da una ferita»14. Inoltre, la psyché omerica è collegata con una concezione “oltremondana”, umbratile e desolata, nella quale risulta essere per certi aspetti una copia “sbiadita” e “spenta” dell’essere vivente, piuttosto che la sua vera “essenza”15. Una visione esattamente all’opposto di quella presente nelle cosiddette correnti “orfiche”, tanto che, in una fase degli studi, un fenomeno religioso come quello che va sotto l’etichetta di “Orfismo”, che oggi sappiamo es-sersi formato nel mondo greco16, poteva essere ritenuto come il frutto di un’“importazione” di credenze dei popoli traci confinanti con l’Ellade, che avrebbero appunto trasmesso nella terra di Omero le loro idee relative all’“anima” e all’“Oltretomba”17. Un’interpretazione questa che ben esemplifica i possibili esiti nel campo degli studi di quell’“imbarazzante” pluralità di concezioni divergenti del post mortem, presenti nello stesso contesto storico-culturale, di cui abbiamo parlato in precedenza.
13 Segal 2004: 230 sgg.; Mirto 2007: 51-55.14 Guidorizzi 2010: 114.15 Bremmer 1983; Guidorizzi 2010: 118.16 Sabbatucci 2006. Specificamente sull’Orfismo si veda Scarpi 2004: 347-355.17 Si pensi al classico studio di E. Rohde, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, Greiburg im Breisgau-Leipzig 1890-1894.
estratto
Prolegomeni allo studio della sfera del post mortem. Brevi osservazioni di metodo 15
Presa quindi coscienza che la nostra concezione di “anima” è l’esito di un percorso sto-rico e non un dato assoluto, è necessario procedere, in questo come in altri campi, rapportan-dosi e partendo per le proprie analisi ai concetti emici della cultura oggetto della ricerca. Dob-biamo chiederci come in un determinato contesto e secondo le categorie ivi elaborate, è stato costruito culturalmente l’individuo come persona, di quali elementi esso risulta composto.
Ad esempio, «secondo gli Egiziani ogni individuo era formato da cinque elementi: l’om-bra, doppio immateriale di ogni forma che l’uomo assumeva nel corso della vita, l’akh, il ka, il ba e il nome. L’akh è un principio solare, è l’elemento luminoso che consente al defunto l’accesso alle stelle al momento del passaggio nell’Aldilà: è la forma in cui si manifesta la potenza degli dèi e dei morti, il loro spirito. Il ka è la forza vitale che ogni essere possiede; si moltiplica a se-conda della potenza di colui che ne è il possessore – Ra, ad esempio, ha ben quattordici kau – e deve essere alimentata, per conservare la propria efficacia. È questa forza che consente al corpo, convenientemente preparato per trionfare sulla morte, di riprendere una vita simile a quella che conduceva sulla terra. Il ka, per esistere, necessita di un supporto materiale e di nutrimento: per-ciò ben presto si cominciò a costruire dei sostituti per il corpo umano, purtroppo soggetto alla degradazione, i quali sono le effigi del defunto. … Il ba è anch’esso un principio immateriale, portatore della potenza di chi lo possiede, sia esso dio, defunto o vivente. È una sorta di doppio dell’individuo, indipendente dal corpo – viene rappresentato come un uccello a testa umana che abbandonava la spoglia mortale al momento del trapasso, per poi ricongiungervisi dopo la mummificazione –, un alter ego con cui l’uomo può dialogare … Il nome, infine, è per l’Egiziano una seconda creazione dell’individuo, innanzitutto al momento della nascita, quando dalla ma-dre viene imposto al neonato un appellativo che ne esprime sia la natura, sia il destino che ella gli augura, ma anche ogni volta che viene pronunciato»18. In un contesto simile, quale utilità per la ricerca presenterebbe il nostro concetto di “anima” quale strumento euristico?
Medesime problematicità sono presenti nell’impiego di termini come “Aldilà”, “Oltre-mondano”, “Oltretomba”, ecc., a indicare la “realtà” che si troverebbe oltre la morte. Come nota Angelo Brelich nella sua Introduzione alla storia delle Religioni, «non bisogna confon-dere tutto ciò che i vari popoli – sia “primitivi” sia di civiltà “superiori” (come i babilonesi, ebrei, greci) – dicono di questa dimora definitiva con una fede nell’immortalità; anziché una fede positiva (come in certe religioni, quale il cristianesimo, ma anche religioni antiche come l’egiziana), l’idea dell’al di là può essere un semplice riflesso semi-cosciente dell’esperienza secondo cui il morto non è più tra i vivi: allora, infatti, “dev’essere” altrove: in un posto lonta-no, p. es. in cielo, sotto terra, in un’isola, in occidente dove anche il sole muore, ecc.; là, la sua vita è come la nostra, o addirittura migliore, o peggiore, o esattamente il rovescio della vita terrena come la morte è il rovescio della vita. Proprio questo carattere di riflesso secondario e marginale di molte idee dell’oltretomba spiega che mentre il cadavere – sia prima della sepol-tura, sia nella tomba – e gli spettri provocano qualche trattamento rituale, i morti immaginati già definitivamente sistemati nell’al di là diventano religiosamente indifferenti (al contrario di quanto avviene nel caso in cui l’al di là costituisce oggetto di una fede positiva)»19.
18 Grimal 1999: 138-139.19 Brelich 1965: 22-23.
estratto
16 I. Baglioni
Emerge molto bene in questo passo di Brelich come, quando noi utilizziamo convenzio-nalmente termini come “Aldilà” a indicare la “realtà” che si celerebbe oltre la morte, così come concepita in diversi contesti storico-culturali, sottintendiamo e rischiamo inavvertitamente di rimuovere, di fatto, le differenze presenti tra l’uno e l’altro contesto riguardo alla concezione “spaziale” ed “escatologica” relativa a questa “realtà”, così come peraltro le differenti pratiche rituali connesse ai defunti, non interrogandoci di conseguenza sulle motivazioni che sono alla base di tali diverse “costruzioni”20.
È necessario, pertanto, procedere sempre con estrema cautela e attenzione, partendo anche in questo caso da concezioni emiche, in quanto le casistiche, come detto, possono esse-re svariate ed estremamente divergenti, fino a prevedere persino la negazione di una “Aldilà” inteso in senso spaziale. Ad esempio, in ambito fenicio «i dati archeologici e quelli epigrafici lasciano … supporre si pensasse alla tomba come il luogo di residenza permanente dei defun-ti, che dunque non “andavano” con la morte in una diversa dimora oltremondana»21. Oppure in ambito ebraico, come sottolinea Thomas Podella, l’Antico Testamento non sa né di un altro mondo concepito in senso spaziale, né di forze “numinose” o di divinità che vi dimorino e vi regnino22. Nel testo sacro sono recepite e interpretate «le concezioni vicino-orientali antiche sull’Aldilà col proposito primario di escludere i morti e la loro dimora dalla sfera spazio-tem-porale di influenza di Yahwè. Fino al sorgere dell’Apocalittica una dimensione ultraterrena intesa come parte del cosmo resterà un corpo estraneo nella religione vetero-testamentaria. … Un regno dei morti posto all’interno del cosmo, situato al di là dell’esperienza individuale della precarietà umana, sembra non esistere nella visione biblica»23.
Da ultimo, sono opportune anche alcune osservazioni di carattere generale in merito allo studio dei rituali attinenti alla sfera del post mortem. Un primo passo da muovere per l’analisi di un rito è quello di indagarne, da un punto di vista simbolico che di manifesta-zione esplicita del messaggio, la “grammatica” dei gesti ivi prescritti e delle fasi in cui la procedura nel suo insieme può essere divisa, tenendo attentamente presente il contesto spazio-temporale di realizzazione e stabilendo a chi il rituale si rivolgesse e per quale fine. Inoltre, bisogna cercare di ricostruire, naturalmente entro i limiti della documentazione, gli effetti e il coinvolgimento emotivo di coloro che celebrano e di coloro che assistono al rituale. È necessario cercare di stabilire, quando si studia specificamente un caso concreto, se nell’esecuzione del rito si possono rilevare varianti rispetto alla “norma” (che questa sia esplicitamente attestata dalla tradizione o ricostruita in base all’insieme della documenta-zione) e se la reazione e/o la partecipazione di chi assiste ad esso si sia manifestata secondo gli schemi previsti o se sia stata avvertita come insolita o non corretta. Ovviamente anche i riti possono essere utilmente oggetto di un confronto a carattere storico-comparativo, se-condo le medesime modalità menzionate in precedenza. Anche in questo caso si deve con-
20 Proprio per rimarcare tali differenze, nei contributi presenti negli Atti, i termini “anima” e “Aldilà”, come quelli ad essi affini per significato, sono sempre utilizzati tra virgolette quando impiegati in relazione alle credenze delle culture antiche, prima dell’affermarsi del cristianesimo, o dei popoli di interesse etnologico.21 Ribichini 1987: 158.22 Podella 1987: 163.23 Podella 1987: 189.
estratto
Prolegomeni allo studio della sfera del post mortem. Brevi osservazioni di metodo 17
siderare il modello proposto come orientativo e potenzialmente da “ricalibrare” a seconda delle caratteristiche dell’oggetto di studio.
Per concludere, desidero ringraziare Sergio Botta, Ileana Chirassi Colombo, Marcello Del Verme e Lorenzo Verderame per aver accettato di far parte del Comitato Scientifico del Convegno che insieme a me ne ha curato l’organizzazione. Un ringraziamento particolare va a Tessa Canella e Alessandro Saggioro per la preparazione della sessione di studi sulla “Geo-grafia Infera”.
Bibliografia
Baglioni 2010: I. Baglioni (a cura di), Storia delle religioni e archeologia. Discipline a confronto, Roma 2010.
Bottéro 1987: J. Bottéro, La mitologia della morte nell’antica Mesopotamia, in P. Xella (a cura di), Arche-ologia dell’Inferno. L’Aldilà nel mondo antico vicino-orientale e classico, Verona 1987, pp. 49-93.
Brelich 1956: A. Brelich, Appunti su una metodologia, SMSR 27, 1956, pp. 1-30. Riedito in K. Kerényi - A. Brelich, Tra gli asfodeli dell’Elisio. Carteggio 1935-1959, a cura di A. Alessandri, Roma 2011, pp. 319-348.
Brelich 1965: A. Brelich, Introduzione alla storia delle religioni, Roma 1965.Brelich 1970-1972: A. Brelich, Ad philologos, “Religioni e civiltà” 1 (SMSR 41, N.S: 1), 1970-1972, pp.
621-629. Riedito in A. Brelich, Mitologia, politeismo, magia e altri studi di storia delle religioni (1956-1977), a cura di P. Xella, Napoli 2002, pp. 119-127.
Brelich 1985: A. Brelich, Il cammino dell’umanità, Roma 1985.Bremmer 1983: J. Bremmer, The early greek concept of the soul, Princeton 1983.Grimal 1999: N. Grimal, Storia dell’antico Egitto, tr. it. Roma-Bari 1999.Guidorizzi 2010: G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima. I Greci e la follia, Milano 2010.Mirto 2007: M. S. Mirto, La morte nel mondo greco: da Omero all’età classica, Roma 2007.Nizzo 2011a: V. Nizzo (a cura di), Dalla nascita alla morte. Antropologia e archeologia a confronto, Roma
2011.Nizzo 2011b: V. Nizzo, Introduzione, in V. Nizzo (a cura di), Dalla nascita alla morte. Antropologia e
archeologia a confronto, Roma 2011, pp. 27-39.Nizzo - La Rocca 2012: V. Nizzo - L. La Rocca (a cura di), Antropologia e archeologia a confronto: rappre-
sentazioni e pratiche del sacro, Roma 2012.Podella 1987: Th. Podella, L’aldilà nelle concezioni vetero-testamentarie: Sheol, in P. Xella (a cura di),
Archeologia dell’Inferno. L’Aldilà nel mondo antico vicino-orientale e classico, Verona 1987, pp. 163-207.
Ribichini 1987: S. Ribichini, Concezioni dell’oltretomba nel mondo fenicio e punico, in P. Xella (a cura di), Archeologia dell’Inferno. L’Aldilà nel mondo antico vicino-orientale e classico, Verona 1987, pp. 147-161
Rocchi - Xella 2006: M. Rocchi - P. Xella (a cura di), Archeologia e religione. Atti del I Colloquio del “Gruppo di contatto per lo studio delle religioni mediterranee” Roma - CNR 15 dicembre 2003, Verona 2006.
Sabbatucci 1977: D. Sabbatucci, O psiche o cultura, “Culture” 2, 1977, pp. 51-72. Riedito in D. Sabbatucci, Giuoco d’azzardo rituale e altri scritti, a cura di G. Mazzoleni, Roma 2003, pp. 119-153.
Sabbatucci 2006: D. Sabbatucci, Il misticismo greco, Torino 2006.Scarpi 2004: P. Scarpi, Orfismo, in P. Scarpi (a cura di), Le religioni dei Misteri, vol. 1, Milano 2004, pp.
347-437.
estratto
18 I. Baglioni
Segal 2004: A. F. Segal, Life after death. A History of the Afterlife in the Religions of the West, New York 2004.
Xella 1987a: P. Xella (a cura di), Archeologia dell’Inferno. L’Aldilà nel mondo antico vicino-orientale e classico, Verona 1987.
Xella 1987b: P. Xella, Prefazione, in P. Xella (a cura di), Archeologia dell’Inferno. L’Aldilà nel mondo anti-co vicino-orientale e classico, Verona 1987, pp. 7-10.
Xella 1987c: P. Xella, Imago mortis nella Siria antica, in P. Xella (a cura di), Archeologia dell’Inferno. L’Aldilà nel mondo antico vicino-orientale e classico, Verona 1987, pp. 117-145.
estratto