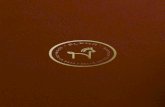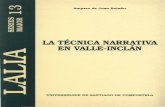Francisco Valle, um precursor do nacionalismo musical brasileiro?
I Trissino nel '400, tra la valle e la città, in "Quaderni del Gruppo Storico Valle dell'Agno", n....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of I Trissino nel '400, tra la valle e la città, in "Quaderni del Gruppo Storico Valle dell'Agno", n....
febbraio 2006
q u a d e r n i d e lG r u p p o S t o r i c oV a l l e d e l l ’ A g n o
31
anno 11
Ceramica domestica di età medievale nella Valle dell'Agno
L'origine del nome e del comune di Valdagno
I Trissino nel '400, tra la valle e la città
3
19
43
Mara Migliavacca
Luciano Chilese
Silvano Fornasa
Consiglio direttivo delGruppo Storico Valle dell’Agno:Alessandro Massignani (presidente)Gianni A. Cisotto, Giorgio Trivelli (vicepresidenti)Silvano Fornasa (segretario)Mara Migliavacca, Alessia Montagna,Gianpietro Santagiuliana, Antonio Fabris
Collaborazioni:Paolo Preto (coordinatore)Gaspare Pozza (grafica)Martino e Silvano Fornasa (impaginazione)
I testi degli articoli sono di proprietà dei singoli autoriStampato nel mese di febbraio 2006
42 43
I Trissino nei primi anni dell’età veneziana
Sono necessarie tre rapide premesse in merito al titolo di questo intervento, ai tempi ed ai luoghi in esso
riportati.Si dice «I Tissino nel ‘400, tra la valle e la città»: in
realtà ciò che qui viene riportato è fortemente sbilanciato verso la valle, la Valle dell’Agno nella fattispecie, fino al XIX secolo meglio nota – certamente non a caso – come Valle di Trissino o Valtrissino, poiché ho avuto modo di affrontare in più occasioni questa ricerca e poiché la presenza e l’attività dei Trissino nel loro antico feudo sono senz’altro meno note del ruolo che questa famiglia ebbe nell’ambito cittadino.
In secondo luogo l’analisi si è spinta fino ai primi de-cenni del ‘500, per poter elaborare più compiutamente alcuni aspetti specifici.
Va infine rilevato che questo lavoro segue cronologica-mente due saggi sui Trissino: quello di Rosa Gregoletto, prodotto in un convegno trevigiano del 1988, e quello di Sante Bortolami, pubblicato nell’opera miscellanea Storia della Valle dell’Agno, ambedue riferiti ai secoli XIII e XIV1. E proprio il lavoro di Bortolami ci consegna i Trissino, benché riciclati come aristocrazia cittadina nel corso della dominazione scaligera, ancora ben coscienti delle loro antiche prerogative in questo angolo del ter-ritorio vicentino.
Con i Della Scala, in effetti, i Trissino mantennero inalterati beni e giurisdizioni nella Valle dell’Agno: nella documentazione è evidente la persistenza, almeno par-
I Trissino nel '400, tra la valle e la città
di Silvano Fornasa
Con l’avvento della domina-zione veneziana, i Trissino avevano ormai perduto le loro antiche prerogative feu-dali: mantennero però un ruolo di primissimo piano nel governo della città, e soprat-tutto estesis-sime proprietà e privilegi nel loro antico feudo, la Valle dell’Agno.
Esercitavano questa preminen-za controllando la carica di vicario e con la loro influenza negli organi amminis-trativi e giudiziari cittadini.
I segni più evidenti del loro potere e prestigio furono le numerose ville erette in val-lata, nel corso dei secoli XV e XVI.
ETÀ DELLAREPUBBLICADI VENEZIA
44 45
ziale, di prerogative signorili in questo che era il loro feudo. Nei rinnovi delle investiture si dichiarano sempre «fideles vasalli» del vescovo e non si tralascia mai di elencare tutti i diritti feudali, compreso il «comitatus», anche se oramai il comune cittadino aveva definitivamente avocato a sé le maggiori prerogative giurisdizionali.
Incontrarono difficoltà nel corso della parentesi viscontea: in questo lasso di tempo continuarono a rinnovare formalmente le investiture vescovili, ma per alcuni anni le giurisdizioni furono revocate e molti beni incamerati dalla nuova signoria: lo testimoniano gli acquisti degli stessi, successivi al 1404, e la formula «… per molto tempo possedute dalla fattoria di Vicenza», ricorrente nelle investiture del primissimo periodo veneziano.
Anche se a caro prezzo, con la dedizione di Vicenza alla repubblica di Vene-zia del 1404, i consorti Trissino tornarono quindi in possesso di beni e diritti. Per quanto concerne questa vicenda storica, il vicariato della Valle dell’Agno è il meno assistito dalla documentazione conservata: non abbiamo patti di dedizione, come per Lonigo, Marostica e il vicino Montecchio Maggiore. Ma conosciamo meglio la vicenda dei Trissino e della loro valle: tra settembre 1406 e marzo 1407 i Trissino, che avevano ormai frammentato le antiche giurisdizioni in ventiquattro parti, dovettero riacquistare uno ad uno da Venezia feudi reali, feudi decimali e giurisdizioni dei vari paesi della media e alta Valle dell’Agno, per cifre non proprio simboliche: moltiplicando per tutte le quote le cifre rese note dalla documentazione superstite si arriva a 14-15.000 ducati.
Da domini loci a patrizi e grandi proprietari terrieri
I Trissino, quindi, nel complesso passaggio dalla signoria territoriale che essi esercitarono nella Valle dell’Agno alla supremazia del comune cittadino sul contado, mantennero un ruolo di primissimo piano nel governo della città, estesissimi beni e prestigio nel territorio. Con i cambiamenti di regime politico avevano inevitabilmente perduto le antiche prerogative feudali, ma conserva-rono senza dubbio il ruolo di protagonisti nella vita della Valle dell’Agno e nelle altre località del Vicentino dove possedevano beni.
Anche se è difficile definire il ceto dirigente vicentino del ‘400 e valutare il peso politico delle famiglie della vecchia e nuova nobiltà, sono noti a tutti il ruolo e la rilevanza che i Trissino rivestirono anche dopo il 1404. Più precisa-mente, fin dai primi decenni del ‘400 essi ebbero un ruolo primario nella vita cittadina: sono tra le 14 famiglie a ricevere nel ‘400 riconferma imperiale del
44 45
titolo di conti palatini, occupano un elevato e costante numero di seggi nel Consiglio cittadino, c’è una loro costante presenza nel collegio dei giudici, sono protagonisti nella vita amministrativa, culturale; contestualmente esercitano una presenza - preminenza in tutte le comunità della Valle dell’Agno, con una distinzione fondamentale, che forse non è sempre stata messa debitamente in risalto e che uno spoglio accurato anche della documentazione meno indagata rende evidente, una distinzione cioè tra i rami familiari maggiori ed i minori della prolificissima schiatta nobiliare.
I primi vivono prevalentemente in città e soggiornano per periodi comunque non irrilevanti nelle loro domus dominicales della valle, non sempre e non anco-ra dotate delle comodità delle residenze cittadine: qui curano i rilevantissimi interessi economici e si apprestano a segnare il territorio con le loro ville di campagna, accanto o in esatta corrispondenza dei loro antichi castelli.
I rami minori, invece, si radicano definitivamente nei paesi, e precisamente in due: a Trissino, il centro primigenio, ed a Valdagno, divenuto il centro prin-cipale della valle dal secolo XIV in poi. Un paio di esempi possono illustrare adeguatamente questa differenza: il regesto di un rarissimo estimo trissinese del 1460 riporta esponenti minori dei Trissino estimati nel paese, con aliquote medie, non di rado inferiori a quelle di alcuni popolari locali; nelle buste quat-trocentesche dell’Estimo cittadino, tra i passipaga che esercitavano lavori arti-gianali o curavano direttamente le loro proprietà terriere nella Valle dell’Agno, compaiono esponenti dei rami collaterali minori dei Trissino, «cittadini rustici» - come sono stati definiti - contrapposti ai «cittadini ottimi» loro parenti2.
Ritengo non del tutto inutile ricordare in rapida sintesi la vicenda genealogica dei Trissino. Tra i colonnelli più antichi della famiglia, i Castel maggiore e i Castel antico si estinsero nel XIV secolo, e i Della Pietra nei primi decenni del ‘400; ai colonnelli storici dei Miglioranza e dei Paninsacco si aggiunse nel ‘500 il Vello d’oro (il cui esponente senz’altro più illustre fu Giangiorgio Trissino). I Miglioranza si estinsero nel 1851 e i Vello d’oro nel corso del XX secolo. L’ultima discendente dei Paninsacco, e unica di tutta la schiatta, è la prof.ssa Mariangela Trissino.
Privilegi nel rapporto con le istituzioni
Le leve principali sulle quali i consorti Trissino agivano per salvaguardare e accrescere prerogative, proprietà ed altri interessi economici nella valle erano sostanzialmente tre: difesa ad oltranza delle antiche prerogative, soprattutto
46 47
del diritto di decima; la carica di vicario; l’influenza negli organi amministrativi e giudiziari cittadini.
Della prima si dirà in seguito.Per quanto concerne il vicariato, occorre premettere che nella genesi dei
capitanati e dei vicariati del territorio vicentino, seconda metà del ‘300, quel-lo della Valle dell’Agno è forse il meno documentato. Alle notizie sull’unico capitano scaligero insediato a Valdagno finora noto (Alvise Grifalconi) vanno ora aggiunte le informazioni fornite da un fascicoletto notarile conservato nell’Archivio di stato di Treviso: in esso si parla di Guglielmo de Piepoli, «ca-pitaneus Valtrissini» dall’ottobre 1381 al giugno 13833. In questo frammento di registro sono annotati gli interventi del capitano in cause civili di abitanti della valle. In un documento, purtroppo mutilo, si accenna alle modalità con cui le comunità della valle versavano le decime alla fattoria scaligera. I funzio-nari erano il cancelliere, il comestabile ed alcuni «stipendiarii et socii». Troviamo esponenti delle famiglie Trissino di frequente presenti all’attività del capitano. Quindi era lui il «capetano de la vale de Tresseno» della nota petizione inoltrata ad Antonio della Scala dalla comunità di Castelgomberto nell’estate del 1382: in quell’occasione constatò di persona le conseguenze delle distruzioni operate dalle truppe di Bernabò Visconti nella Valle dell’Agno (1379)4.
Di un terzo capitano o vicario è riportata notizia, non confermata per ora da altra documentazione, dal Crescenzi: si tratta di Alvise de Surdis, fratello di Giovanni, vescovo di Vicenza dal 1362 al 1386. Questo esponente della famiglia piacentina, legata agli Anguissola, potrebbe aver svolto le sue funzioni a Valdagno tra gli anni ’70 ed ’80 del secolo; di lui dice il Crescenzi: «Aluigi Sordi Piacentino fratello del vescovo di Vicenza servì a gli Scaligeri Prencipi di Verona da i quali fu dichiarato generale Commissario della Valdagni e castella de Tressini con l’assoluto governo di venti grosse ville, e altri luoghi»5.
Va aggiunto che la casa dove alloggiava il vicario della Valle dell’Agno è sempre stata di proprietà dei Trissino e tutti i paesi del vicariato dovevano versare un canone annuo, in corrispondenza della loro capacità contributiva.
Arrivando al secolo successivo, ci sono esempi, anche precoci, di come fosse importante per i Trissino esercitare o comunque controllare il vicariato a Valdagno: il più interessante si riferisce agli anni 1429-306.
Bongiacomo di Galvano Trissino viveva tra Vicenza e la casa padronale di Cornedo; il 1 febbraio 1429 assunse la carica di vicario di Valdagno e si trasferì nella «domus vicarii» valdagnese. A due giorni dalla scadenza del suo mandato (29.1.1430), per sfruttare adeguatamente il vantaggio che la carica gli offriva,
46 47
convocò congiuntamente in vicinia le comunità di Recoaro e Rovegliana per mettere ordine nella massa di livelli, che, a suo dire, erano stati alterati o oc-cultati dai contadini, «in danum et preiudicium» dei consorti Trissino. Ordinò quindi, a nome di tutti i familiari, di regolarizzare la propria posizione pena la rescissione dei contratti. Vengono poi riportati una sessantina di livelli, da lui stipulati durante il suo mandato: interessano 1200 campi, la gran parte della terra coltivabile delle due comunità.
Se pensiamo poi che il vicario di Valdagno presenziava alla ratifica degli statuti comunali delle comunità della valle e che il suo parere era determinante per l’inoltro alle autorità cittadine (è documentato l’esempio di Cereda, del 1427, due anni prima dei fatti testè riportati) comprendiamo quanto fosse impor-tante il controllo di questa carica e ancor più la sua gestione diretta. Non è un caso, a questo proposito, se i più antichi Statuti comunali della Valle dell’Agno, (Brogliano 1364 e Trissino 1409) vennero registrati in sede cittadina dal notaio Pace Trissino il primo e da suo figlio Bartolomeo il secondo.
Ma il vantaggio maggiore era quello di disporre di appoggi sicuri nei consigli cittadini e nei tribunali. Valga un esempio, conservato tra le carte veneziane del Consiglio dei X, e riportato da Sergio Zamperetti7. Nel 1463, due fratelli Trissino, che abitavano nella villa di famiglia a Castelgomberto, penetrarono armati nella casa del comune e sottrassero la documentazione relativa al pensionatico (già da tempo diritto acquisito dal comune) e alla decima selvatica (soppressa da Venezia nel 1407 su petizione del comune, ma di cui i Trissino nei decenni successivi chiedevano e ottenevano ancora l’investitura dal vescovo). Il Consiglio dei X ac-colse la protesta degli uomini di Castelgomberto e ordinò ai rettori cittadini di procedere contro i due fratelli Trissino. Costoro attivarono immediatamente la parentela presso gli organi amministrativi e giudiziari cittadini, come di consueto, ma Venezia, in questo caso, favorì la comunità, e ingiunse ai consorti Trissino di restituire la documentazione e di pagare le spese processuali.
Proprietà della terra ed altre attività economiche
L’aspetto che connotava con maggiore evidenza la presenza dei Trissino, in relazione agli abitanti delle comunità, era indubbiamente quello economico.
La documentazione illustra con chiarezza che la relativa tranquillità che ca-ratterizzò la prima età veneziana favorì un allargamento ed una differenziazione delle attività economiche dei Trissino nella Valle dell’Agno. Il giudizio espresso dal Mantese, nella sua datata ma importante Storia di Valdagno, che individuò i
48 49
consorti di questa famiglia unicamente interessati alla rendita e alle investiture, è forse troppo affrettato. E’ vero che l’accumulazione fondiaria nobiliare del ‘400 fu un po’ dappertutto convulsa, poco razionale e non portò subito ad un miglioramento delle tecniche e delle rese. Anche per i Trissino è documentata, nel corso del ‘400 e del secolo successivo, un’intensa attività di accumulo di-sordinato di terre mediante un frequentissimo ricorso allo strumento creditizio dei fitti o livelli fiancabili: il Balanzon, il primo grande estimo del territorio di metà ‘500, ne registra oltre 1200 lungo tutto il corso della valle.
Ma la grande disponibilità di terre li spinse a rinnovare e diversificare la pro-duzione agraria. Furono loro, infatti, che intensificarono nella Valle dell’Agno, fin dalla metà del ‘400, il prato irriguo e l’allevamento: sono documentate già in questo periodo, nella fertile piana alluvionale fra Castelgomberto e Trissino, stalle con parecchie decine di capi di bestiame.
Per conoscere con una certa esattezza la tipologia delle colture occorre rifarsi al già citato Balanzon, che offre peraltro indicazioni molto interessanti: laddove i piccoli proprietari e i contadini in genere erano legati a doppio filo alla necessità di coltivare cereali, nelle medie e grandi possessioni dei Trissino quasi la metà della terra veniva destinata al prato (sono alcune centinaia di ettari), servito da una notevole ed efficace rete idrica.
Tra la fine del ‘400 e la prima metà del secolo successivo sorsero parecchie fattorie di cospicue dimensioni, dotate di ampi granai, cantine, e ognuna con 8, 10, 15, anche 20 cassi di tezza. Tre grandi casare (a Cornedo, Castelgomberto e Trissino) per la produzione del formaggio erano l’ultimo anello della catena.
I Trissino investirono molto anche nell’allevamento ovino e nell’alpeggio. L’infinita lotta per il pensionatico tra la famiglia e le comunità ne è la dimostrazione più efficace. Il pensionatico era una prerogativa che rivestiva a mio parere una notevole importanza, insieme al possesso dei pascoli montani sopra Valdagno e Recoaro, dal momento che una più attenta analisi del fondo notarile ha di-mostrato una forte presenza dell’allevamento ovino in tutta la valle. Fino agli anni ’20 del ‘400 il pensionatico era ancora dei Trissino, che lo rivendicavano con forza: sono note le vertenze con Recoaro, Rovegliana e Valdagno degli anni 1420-21. Ma nei documenti redatti intorno alla metà del secolo, tale prerogativa appare quasi ovunque in possesso delle comunità.
I Trissino infine cominciarono, nella seconda metà del ‘400, a costituire possessioni di una notevole consistenza (anche di un centinaio di ettari) e introdussero con una certa regolarità contratti di mezzadria.
Ma l’attività economica dei Trissino non si limitava alla sia pur preminente agricoltura. Tra Recoaro e Valdagno, dove la disponibilità di acqua era maggiore,
48 49
i consorti Trissino erano proprietari di segherie e di fucine per la fusione del ferro, documentate fin dagli anni ’20 del ‘400.
E’ documentata la lavorazione della lana ed il commercio della lana grezza da parte dei Trissino dei rami collaterali nella seconda metà del ‘400 e l’attività serica nei primi decenni del ‘500, anche nella grande villa trissinese della Co-lombara8. Parecchi contratti notarili dei primi decenni del ‘500 documentano la concessioni agli artigiani locali da parte dei Trissino proprietari di mulini, di costruire folli per la lavorazione della lana.
I segni della loro presenza nella valle
Non erano però solamente questi i segni della presenza dei Trissino nella Valle dell’Agno, anche se il fattore economico rivestiva un’importanza primaria.
Per cercare di capire quale fosse, in termini qualitativi e quantitativi, la pre-senza dei nobili Trissino nelle comunità della valle occorre, come s’è detto, tener presente la diversa posizione tra i rami collaterali, in parte impoveriti, e le famiglie maggiori.
I primi erano a tutti gli effetti inseriti nella vita economica delle comunità: erano spesso i notai del paese (sono conservate le buste di una decina di loro, che rogarono nelle comunità della Valle dell’Agno nel corso del secolo XV); possedevano quantità non elevate di terreno che amministravano direttamente; esercitavano, come s’è visto, l’arte della lana e ella seta.
Ma per tutti, anche per le famiglie maggiori, ancorate alla città per la maggior parte dell’anno, il legame con le comunità della valle era forte e parecchi fattori confortano questa affermazione.
In primo luogo l’ostinata difesa di alcune antiche prerogative signorili, ormai solo simboliche, ma che comunque alimentavano il prestigio.
Poi il protagonismo dei Trissino nei costituti di pace paesani: si potrebbe rav-visare un’eco dell’antico comitato, quando, a Trissino, due di loro - siamo nel 1476 in occasione di una lite tra paesani - sentenziano solennemente dall’alto del poggiolo della casa padronale9.
Ci fu sempre una loro presenza molto attiva in campo religioso. Eressero due oratori privati a Valdagno (San Cristoforo, primissimi anni del secolo) e a Trissino (è del 1430 la prima traccia documentaria dell’oratorio privato di Sant’Antonio abate, annesso alla villa Trissino-Marzotto ed oramai, purtroppo, in condizioni molto critiche), ed eressero cappelle di famiglia nelle parrocchiali degli altri paesi.
Nel 1380 avevano ricostruito la parrocchiale di San Clemente e intorno al
50 51
1450 contribuirono alla radicale ristrutturazione della parrocchiale di Castel-gomberto.
Nelle altre parrocchiali della valle possedevano comunque quasi sempre un altare e nel corso del ‘400 molti Trissino disposero nei loro testamenti di essere sepolti nelle comunità della Valle; lo stesso Gian Giorgio Trissino - nel suo primo testamento - ordinava di essere seppellito nell’oratorio di San Sebastiano di Cornedo.
Nel corso del ‘400 non raramente alcuni esponenti delle famiglie Trissino furono rettori nelle comunità della valle. Un episodio molto significativo è l’istituzione di un piccolo ospedale da parte dei Trisino, avvenuta nel 1430 a Trissino. Numerose, infine, le caritates per i poveri delle varie comunità nei testamenti dei Trissino.
A confermare il legame tra i Trissino e la valle occorre poi dare il dovuto risalto all’episodio narrato, forse con un po’ di enfasi, da Giangiorgio Trissino nella sua nota Orazione10. La Valle dell’Agno era stata toccata duramente dalla guerra tra Venezia e il Ducato di Milano degli anni 1436-38: le comunità della valle si erano ribellate a Venezia, consegnandosi nelle mani di Niccolò Piccinino, condottiero dei Visconti e il castello di Valdagno era in mano ad Azzo da Sesso: in quell’occasione la valle venne riconquistata alla Repubblica di Venezia da un altro Gian Giorgio Trissino, nonno dell’illustre letterato.
Maggiore era la presenza, come s’è detto, degli esponenti dei rami collaterali e a questa considerazione concorre in modo tutt’altro che trascurabile la costante loro presenza nelle buste degli archivi giudiziari.
Qui si accennerà solamente ad una vicenda conservata nel fondo notari-le e nei registri delle Sentenze criminali della Bertoliana11. Due bande armate, composte da parecchie decine di elementi per parte, erano capeggiate ognuna da esponenti delle famiglie Trissino che vivevano a Valdagno e Cornedo, già banditi precedentemente per omicidio. Imperversarono a Valdagno e nell’alta valle tra il 1490 e il 1493: gli scontri armati e le risse condotte «more belico», che avvennero anche davanti alla porta del vicariato di Valdagno indicano suf-ficientemente la capacità di tenere in scacco le autorità locali di questi rampolli, eredi dei milites duecenteschi.
Ma i registri delle Sentenze, di cui s’è detto, conservano numerosi esempi - riferiti alla Valle dell’Agno fra gli ultimi decenni del ‘400 ed i primi due molto turbolenti del secolo successivo - di esponenti della famiglia Trissino o di loro servi, accusati di omicidio o di falsa testimonianza. Che costoro appartenessero ai rami minori della famiglia lo conferma lo stesso Gian Giorgio Trissino nella sua Orazione, quando li definisce «di vilissima fama», e benché portassero il suo
50 51
cognome nega di aver mai avuto a che fare con loro.Per il periodo immediatamente successivo, meglio documentato, ci sarebbe
solo l’imbarazzo della scelta: su queste vicende cinquecentesche riguardanti i Trissino ha scritto di recente Lucien Faggion12.
Ma anche la presenza in vallata dei Trissino maggiori non era affatto saltuaria: li troviamo assistere alla stesura dei contratti un po’ in tutti i mesi dell’anno. Senza dubbio, però, i segni più evidenti della presenza dei domini maggiori della famiglia sono indubbiamente le ville erette tra la fine del ‘400 ed i primi decenni del secolo successivo.
E’ un elemento, questo delle residenze nobiliari, fondamentale e attorno ad esso si è sviluppata la gran parte della ricerca. Ma anche in questo caso, a mio avviso, molto sarebbe ancora da fare. Conosciamo infatti - per quanto riguarda specificatamente i Trissino e la loro valle - gli esempi maggiori o comunque quelli indagati dagli storici dell’arte: valga come esempio i lavori di Cevese, ultimo in ordine di tempo il saggio contenuto nella già citata Storia della Valle dell’Agno del 200213.
La prima villa di campagna costruita dai Trissino e comunque la più antica della valle dell’Agno sembra essere quella di Castelgomberto, oggi nota come palazzo Barbaran. Il Cevese la colloca senz’altro nel secolo XV, segnalando gli elementi gotici ancora visibili. La conferma è in una iscrizione che il Faccioli vide nella villa, che riporta i fratelli Trissino protagonisti dell’effrazione violenta di carte dalla casa comunale, avvenuta - come s’è detto poc’anzi - nel 1463.
Sono riferibili alla seconda metà del ‘400 quattro ville dei Trissino, costruite proprio a Trissino: villa Trissino ora Marzotto, di cui si conoscono interventi degli anni 1484 / 1493; villa Trissino-Marzotto detta la Colombara (anche in questo caso alcuni elementi inducono il Cevese a collocare la prima costruzione intorno alla metà del secolo); villa Trissino-Centomo; villa Paninsacco, quella senz’altro meglio conservata. La loro costruzione va collocata nel passaggio di secolo.
Fra Castelgomberto e Cornedo venne eretta nello stesso arco di tempo villa Trissino, ora Carlotto-Albanese.
L’esempio senz’altro più noto, infine, è villa Trissino di Cornedo Vicentino, la cui costruzione Cevese colloca tra il 1485 ed il 1515, soggiorno estivo di Giangiorgio Trissino e scena dell’assassinio di suo figlio Ciro.
Ma dalle carte notarili quattrocentesche, dai testamenti e dai Catastici della famiglia, oltre a queste sette ville emergono non di rado altri esempi di domus dominicales e domus magnae a Valdagno, Cornedo, Trissino e Castelgomberto.
52 53
Non ho la competenza per capire quale possa essere il discrimine fra la grande casa colonica e la villa rustica quattro-cinquecentesca. Ma se nel più volte citato estimo Balanzon, redatto nel 1544 troviamo a Cornedo un’altra domus dominicalis dei Trissino con una loggia di oltre 20 metri, con 7 colonne e volti in pietra lavorata, sala sopra la loggia, camere tutte con camini in pietra lavorati, poggioli, scale in pietra, oltre 20 finestre in pietra, la casa del fattore, colombara, tezze e granai, una cantina con 50 botti, orto e brolo, tutto cinto da muro, una domus valutata 1650 ducati, più del doppio delle più nota villa di Giangiorgio Trissino, è chiaro che ci troviamo di fronte ad un’altra villa dei Trissino, non compresa nelle antologie di storia dell’arte. Ci sono poi altri esempi ancora a Cornedo ed a Castelgomberto, anche se non sempre di questo livello.
Appaiono evidenti quindi la massiccia presenza e la preminenza dei Trissino in quello che era stato il loro feudo, si potrebbe dire il monopolio, dal momento che non è documentata nella valle alcun’altra villa in questo periodo: occorrerà attendere la metà del XVII secolo, quando i Piovene innalzeranno la loro im-ponente dimora a Castelgomberto.
I conflitti con le comunità della valle
L’ultimo aspetto che vorrei mettere in evidenza, sempre in estrema sintesi, riguarda la inevitabile conflittualità che spesso contrapponeva i Trissino alle comunità della valle.
Le buste dei notai sono piene di processi per l’uso dell’acqua fin dai primi decenni del ‘400, segno della grande importanza che rivestiva la rete idrica locale per l’attività agraria dei Trissino.
È sintomatica poi la caparbietà con la quale i Trissino rivendicavano le anti-che prerogative signorili: durante tutto il ‘400, ma anche nella prima metà del secolo successivo, richiedevano costantemente l’investitura di mariganza, decanìa e pensionatico ed a Quargnenta ancora del comitato: è documentata nel 1537 una riunione di tutti i consorti Trissino delle famiglie maggiori, a Trissino, dove individuarono la necessità di far fronte comune, ognuno si tassò e stipularono un patto ventennale contro la comunità e gli uomini di Trissino «qui conspirare videntur contra ipsos consortes, dictas suas iurisditiones usurpando».
Ma la causa dominante di conflitto fu sempre quella per le decime. Durante il ‘400 ci furono episodi di controversie, come negli anni 1420-21, ma i Trissino riuscirono sempre a risolvere la questione a loro favore. I contrasti riemersero nei primissimi anni del secolo XVI, culminarono durante le vicende belliche della
52 53
lega di Cambrai e si trascinarono per tutta la prima metà del ‘500.La posizione filoimperiale dei Trissino durante la guerra spinse le comunità a
tentare la spallata definitiva contro l’onere della decima. I comuni dove detene-vano tale diritto i Trissino del ramo Miglioranza (Rovegliana, Recoaro, Valdagno, Cornedo e Quargnenta) deliberarono di esimersi da tale obbligo. In particolare, il primo febbraio 1512 gli uomini di Recoaro e Valdagno si presentarono a Venezia con la supplica di essere esentati dalla decima, soprattutto nelle terre che in quel frangente di forte crescita demografica avevano, «con somma fatica», strappato «dalla sterilità alla coltura». Sempre in quell’anno la popolazione di Valdagno si sollevò – narra il Castellini – contro tre fratelli Trissino arrivati a riscuotere le loro entrate e uccisero uno di loro14.
Non tutti i Trissino, per la verità, si schierarono contro Venezia: ricorda Marin Sanudo che Nicolino Trissino, titolare di grosse proprietà a Valdagno, Cornedo e Castelgomberto, il 21 giugno 1510 si presentò ai governatori veneziani, pro-fessò la sua devozione alla Repubblica Veneta (contrariamente - disse - ai «suoi parenti che erano ribelli»), raccontò di aver subito devastazioni nella famiglia e nella proprietà e chiese per sé la «villa e vicaria di Valdagno», offrendo 600 ducati annui. Venezia, dimostrando ancora una volta il suo realismo politico, declinò l’offerta, «per rispetto de li vicentini»15. Nemmeno un anno dopo, Nicolino Trissino fu catturato e messo a morte dagli imperiali, come risulta dagli Annali inediti dello Zugliano16.
E’ interessante notare come non di rado i Trissino si siano schierati su ambe-due i fronti di un conflitto, dimostrando una spiccata tendenza a tenere il piede su due staffe: ghibellini e guelfi nel XIII secolo e oltre, filoimperiali e fedeli a Venezia in questo frangente.
Questi fatti innescarono un periodo molto turbolento per la Valle dell’Agno, che si protrasse fino al 1514, ma che ebbe ripercussioni per molto tempo sulle vicende della valle. Sembrava proprio che per gli abitanti della Valle dell’Agno – come appare nella interessata ricostruzione dei fatti, operata da Gian Giorgio Trissino una quindicina d’anni dopo nella sua Orazione – «tutto il mondo» stesse andando «sotto et sopra». Ma a rimettere le cose a posto ci pensò il governo veneziano, che, già nel dicembre 1512 e poi, passata la bufera, nel 1516, trovò conveniente sorvolare sull’attività e sui sentimenti antiveneziani dei Trissino, e sulla fedeltà dimostrata invece dai contadini, pronunciandosi a favore della consorteria aristocratica sulla questione delle decime.
Va detto, per la verità, che Venezia non dimenticò facilmente l’atteggiamento ostile dei Trissino nei suoi confronti: alcuni documenti contenuti nei Catasttici
54 55
della famiglia Trissino ci informano che tra maggio e giugno 1518 il Consiglio dei X deliberò di assegnare i beni dei «ribelli» Antonio e Nicolò Trissino, proprio i fratelli cacciati o uccisi dai contadini della Valle dell’Agno nel 1512, agli eredi del defunto Bartolomeo D’Alviano, «capitano generale» delle milizie veneziane durante la guerra, morto tre anni prima17.
La ducale veneziana del 1516 non aveva comunque convinto le comunità dell’alta valle, che ad ogni occasione alimentavano il tentativo di affrancamento dall’onere della decima.
La situazione turbolenta che caratterizzò la Valle dell’Agno nei decenni che seguirono suggeriscono l’ipotesi, non dimostrata ma plausibile, di una sensibile diffusione delle idee anabattiste tra la popolazione della valle, idee che avrebbero impresso una nuova e decisa spinta all’aperta ribellione dei contadini all’obbligo di versare la decima parte dei prodotti ai consorti della famiglia Trissino. Un importantissimo appoggio a questa ipotesi viene dal testo della già citata Ora-zione di Gian Giorgio Trissino sulle decime della Valle dell’Agno, letta davanti al Consiglio dei Quaranta nel 1532, e soprattutto da una lettera che lo stesso scrisse al figlio Giulio, il «papa dei Luterani», in realtà uomo di punta del calvinismo vicentino, per dissuaderlo dal professare le idee riformiste. In essa, dopo averlo blandamente rimproverato per il suo comportamento non ortodosso, arrivò al punto che più gli premeva: «I nostri antichi hanno habuto dalla Chiesa di Vicenza in feudo tutte le Decime, possessioni e fitti de la Val di Trissino; onde se le cose luterane si facessero grandi, i vilani ce le torriano tutte e le metteriano in comun, come fariano con tutti li altri beni de la Chiesa»18. E’ chiaro che la preoccupazione principale dell’illustre letterato vicentino era il timore di perdere i diritti di decima nella Valle dell’Agno e la convinzione che i contadini della vallata, una volta strappate ai Trissino anche le terre, «le metteriano in comun». Questa frase apre la strada alle suggestioni cui si faceva cenno poco sopra e ad un possibile collegamento che si sarebbe instaurato dopo il 1525 tra i villici della Valle dell’Agno (e dell’Alto Vicentino) ed i movimenti contadini in rivolta del Tirolo e della Baviera, movimenti che prefiguravano il possesso collettivo della terra e si fondavano su un radicale rifiuto del principio di autorità, nella prospettiva di realizzare una sorta di comunismo evangelico.
Il culmine della vertenza sulle decime, che investì la Valle dell’Agno più di quanto traspaia dalla documentazione superstite, fu raggiunto intorno alla metà del secolo e vide opposti sempre i comuni dell’alta valle e Ciro, figlio ed erede di Gian Giorgio Trissino. Nel luglio del 1550, quando i suoi uomini si presentarono a prelevare la quota di decima direttamente sui campi, parecchi contadini per-
54 55
sistevano nel loro rifiuto: ormai molti avevano ceduto, ma gli irriducibili erano comunque sostenuti, moralmente e legalmente, dai rappresentanti dei comuni. Ciro allora, spalleggiato indebitamente dal viceconnestabile cittadino, passò alle vie di fatto: «In persona, con molti homeni over bravi, al numero di cinque in sei – dichiarò un proprietario di Novale – vene ive in contrà di Megliara pertinentie de Valdagno» e si prese il numero di faglie di frumento che credette opportuno. Così fecero anche a San Quirico, nella campagna di Valdagno, al Castello, ecc. Spade e bastoni erano i mezzi per convincere i più restii, e ripetutamente si sfiorò il fatto di sangue19. Alla fine i contadini ottennero la formale condanna di Ciro Trissino per l’estorsione violenta della decima, ma erano gli ultimi fuochi: subito dopo, le autorità veneziane confermarono il diritto signorile ed i comuni dell’alta valle si ritroveranno a dover pagare, per due secoli almeno, gli interessi sugli arretrati di decima, accumulati in quasi cinquant’anni di resistenze.
L’obiettivo di ostacolare le pretese signorili spingeva le comunità a porre in essere meccanismi di autodifesa comuni. Questi fermenti indispettivano Ciro Trissino, che indirizzò, intorno alla metà del secolo, una protesta ai rettori di Vicenza. Egli lamentò soprattutto la strategia solidaristica messa in atto dai co-muni della valle, con in testa Valdagno: sono talmente audaci – dichiarava – «che non solamente ardiscono sonar campana a martelo et correr a furore alla ruina et pernicia de’ cittadini, ma etiandio fanno conniurationi segrete et conventicule […]. Et specialiter fanno certe convicinie nelle quali mettono capituli che, se sarà alcuno che sii offeso o nelle facultà o ne la roba, sia reffatto over reintegrato dal comun, sì come al presente ha fatto il potentissimo comun de Valdagno»20.
1 R. GREGOLETTO, Una famiglia signorile vicentina nei secoli XIII e XIV: i Trissino, in Istituzioni, società e potere nella marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII e XIV). Sulle tracce di G.B.Verci, Roma 1988 (Istituto storico italiano per il Medioevo. Studi storici, 199-200), pp. 179-192; S. BORTOLAMI, I Trissino e la Valle dell’Agno nel Medioevo: l’avvio di un rapporto di lunga durata, in Storia della Valle dell’Agno. L’ambiente, gli uomini, l’economia, a c. di G.A. Cisotto, Valdagno (VI) 2002, pp. 209-250.
2 Archivio di Stato di Vicenza (d’ora in avanti ASVi), Archivio della famiglia Trissino, Catastici, b. 5 (2 marzo 460); ASVi, Estimo, b. 1; N. CARLOTTO, I passipaga. Profilo dei cittadini del contado vicentino nel XV secolo, in Storia di Vicenza, III/1, L’età della Repubblica di Venezia (1404-1797), a cura di Franco Barbieri e Paolo Preto, Vicenza 1989, p. 327.
3 Archivio di Stato di Treviso, Atti dei notai, b. 35, not. Rigo de Santo Zenone (ringrazio il sig. Renato Nardon per la segnalazione).
56 57
4 S. FORNASA, La chiesa campestre di S. Fermo nella storia di Castelgomberto, Castelgom-berto (VI) 1994, p. 107 sgg.
5 G.B. DE CRESCENZI, Corona della nobiltà d’Italia, overo compendiodell’istorie delle famiglie illustri, Bologna 1639, p. 295.
6 ASVi, Ufficio del registro, 1430/1°, c. 14v. sgg.7 S. ZAMPERETTI, I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello stato regionale
veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del ‘600, Venezia 1991, pp. 102-103.8 ASVi, not. G. Zucchetti, b. 4698, 10 giugno 1476 e Estimo, b. 32, f. 222r.9 ASVi, not. G. Zucchetti, b. 4698, 13 ottobre 1476.10 Orazione di Giangiorgio Trissino in difesa de’ diritti di decima ne’ comuni della Valle Dell’Agno,
Vicenza 1881.11 Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, Archivio Torre, b. 1141, f. 97v.12 L. FAGGION, Disordini in una famiglia dell’aristocrazia vicentina: i Trissino nella seconda
metà del ‘500, in Acta Histriae, 10, 2002, 2 (XIV), Koper 2002, pp. 285-301.13 R. CEVESE, Tre ville nella Valle dell’Agno, in Storia della Valle dell’Agno. L’ambiente, gli
uomini, l’economia, a c. di G.A. Cisotto, Valdagno (VI) 2002, pp. 451-462.14 ASVi, Archivio della famiglia Trissino, Catastici, b. 5, n. 806; SILVESTRO CASTELLINI,
Storia della città di Vicenza, Vicenza 1783-1822, XVII, p. 166.15 MARIN SANUDO, I diarii, X, Venezia 1883, coll. 601-2; CASTELLINI, cit., p.
167.16 G. MANTESE, Storia di Valdagno, Valdagno (VI) 1966, p. 176.17 ASVi, Archivio della famiglia Trissino, Catastici, b. 5, n. 825 (31 maggio 1518).18 MORSOLIN, Giangiorgio Trissino, o monografia di un letterato del secolo XVI, Vicenza
1878, pp. 502-506.19 S. FORNASA, La Valle dell’Agno in età moderna, in Storia della Valle dell’Agno. L’ambiente,
gli uomini, l’economia, a c. di G.A. Cisotto, Valdagno (VI) 2002, pp. 257.20 Ibid., p. 258.