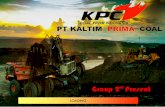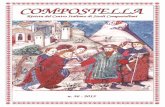I traduttori di Perec : inchiesta su una specie in via di moltiplicazione (Prima parte : Italia)
-
Upload
univ-paris13 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of I traduttori di Perec : inchiesta su una specie in via di moltiplicazione (Prima parte : Italia)
La mia relazione si iscrive nell’àmbito più ampio di unaricerca in córso sui traduttori di Perec nel mondo, per unnumero dei Cahiers Georges Perec che sarà dedicato allatraduzione. Si iscrive anche, più generalmente, nell’àmbitodella ricerca in sociologia del campo letterario di Bourdieue con Gisèle Sapiro, della ricerca in sociologia delle tradu-zioni (cf. Translatio, le marché de la traduction, CNRS édi-tions, 2008). Questo tipo di sociologia analizza lecondizioni di circolazione dei beni culturali, allontanandosidall’approccio interpretativo del testo letterario e dalla pro-blematica intertestuale in cui la traduzione è generalmentestudiata. Non è neanche un’analisi economica degli scambimondiali dei beni culturali: ci si interessa piuttosto alla ri-cezione dei testi e ai mezzi sociali di produzione del librotradotto. Ci si interessa anche alla costituzione di reti e alloro funzionamento. In questo quadro, la traduzione apparecome un buon indicatore della ricezione di un autore.
Chi sono i “passatori” di questi libri? Che ruolo giocanoesattamente? Come, concretamente, un testo passa da unpaese all’altro, da una lingua a un’altra? Ecco alcune delledomande che questa ricerca pone.
Consideriamo anche il fatto che in un certo senso i tra-duttori possono essere percepiti come “super-lettori”, ar-chetipi del lettore perecchiano: studiarli è anche un mododi studiare il lettore perecchiano.
I traduttori di Perec formano una specie di “rete astratta”,di “comunità invisibile” la cui presenza, però, nel campoletterario italiano è forte. Facendone un oggetto di studio,
33
Camille BloomfieldI traduttori di Perec in Italia:
inchiesta su una specie in via di moltiplicazione
“oggettivando” questa rete, si tratta per me di darle unasorta di consistenza, di realtà sociologica che ci aiuti a ca-pirne il ruolo esatto nella ricezione di Perec in Italia e, piùgeneralmente, all’estero. Perec è un autore molto studiatoe molto tradotto, come mostra il fondo di libri tradottidell’Association Georges Perec a Parigi, che fornisce unarassegna impressionante di una collezione di traduzioni datutto il mondo. Per esempio, un libro come La Vita istru-zioni per l’uso è stato tradotto in 22 lingue (tra queste, cisono anche lingue dette “minori” o “rare” nel mercato mon-diale della traduzione, come il coreano, il ceco, lo sloveno,o il brasiliano – diverso dal portoghese), e La Disparitionè stata tradotta in 14 lingue, fra poco 15. Le 3 lingue in cuiPerec è stato più tradotto sono l’inglese, il tedesco, e vicinoo allo stesso livello, l’italiano (questi dati devono ancoraessere precisati nel futuro della ricerca, con il completa-mento della base di dati bibliografici delle traduzioni diPerec nel mondo). Intanto, si sa che l’opera di quest’autoreha avuto una fortuna eccezionale in Italia, grazie, tra l’altro,al lavoro di “passatori” come Calvino o gli oplepiani. Per-ciò cominciare una tale ricerca col caso particolare dell’Ita-lia sembra pertinente, in quanto l’Italia costituisce uncampione ricco di esempi e quindi di potenziali risultati.
Si tenga presente che questo contributo mostra i primirisultati di un lavoro che è ancora in córso, e devono perciòperdonarsi alcune imprecisioni che ancora lo caratteriz-zano. Prima di cominciare, vorrei ringraziare il “passatoretra i passatori”, Raffaele Aragona, che mi ha messo in con-tatto con i traduttori di cui parlerò oggi, e senza il qualenon avrei mai potuto realizzare questo studio. Sono moltograta anche a tutti i traduttori che hanno accettato di rispon-dere al mio questionario. Per alcuni di loro, il lavoro suPerec risale ad anni addietro e so che non è stato facile ri-spondere, mentre per altri sono gli attuali impegni profes-sionali che lasciano loro poco tempo per parlare diletteratura e di traduzione. Hanno però risposto tutti conmolto entusiasmo e molta precisione, e li ringrazio di cuoredella collaborazione.
34
1/ Perec in Italia: chi, dove, cosa? (traduttori, caseeditrici, testi)
Chi? Ritratto di gruppoIl primo lavoro è consistito nello stabilire la lista e i nomi
dei traduttori di Perec in italiano. Ne ho contati, con l’aiutodi Raffaele Aragona e con le mie ricerche, 16. Forse ce nesono altri, che non conosco e che per esempio hanno tra-dotto brevi testi o articoli di Perec per delle riviste, ma que-sto numero tiene conto solo di quelli che hanno tradotto unlibro “pubblicato e firmato da Perec”. Potrei dire anche17, se contassi il misterioso traduttore della seconda ver-sione di W o il ricordo d’infanzia (la prima è stata fatta daDianella Selvatico Estense per Rizzoli nel 1991), pubbli-cata da Einaudi nel 2005 e firmata da un pseudonimo chericorda il nome di un personaggio di La Vita, istruzioni perl’uso: Henri Cinoc. Considerando che quel misteriosoCinoc potrebbe essere tranquillamente uno dei 16 già men-zionati, preferisco non decidere finché non trovo il veronome di questo traduttore. Per oggi, diciamo quindi chesono in 16. Di questi, ce ne sono due che non sono più vivi(Dianella Selvatico Estense, Sergio Pautasso), e tre che nonsono riuscita a contattare (Maria Tosti Croce, Laura FrausinGuarino, Eileen Romano). Ne rimangono 11, che hanno ri-sposto alle mie domande: Ferdinando Amigoni, EmanuelleCaillat, Roberta Delbono, Piero Falchetta, Ernesto Ferrero,Leonella Prato Caruso, Alberto Lecaldano, Maria Segre-bondi, Jean Talon, Laura Vettori Gallo, Eliana VicariFabris.
La prima constatazione è quella della ripartizione spar-pagliata della “voce” di Perec in Italia. Infatti, al contrariodi certi autori che hanno un traduttore regolare, al contrariocioè delle coppie traduttore/autore che permettono un’iden-tificazione chiara dello stile di un autore da parte del pub-blico (per esempio, in Francia, una coppia famosa è quelladi Umberto Eco e Jean-Noël Schifano, che traduce tutti iromanzi di Eco sin dal Nome della rosa) – Perec è
35
conosciuto attraverso più voci. Tra queste voci, alcune sidistinguono. Per la scelta delle opere ma anche per la cro-nologia delle traduzioni, la prima di queste è la voce dellatraduttrice di 3 opere maggiori (La Vita, istruzioni per l’uso- 1984, Mi ricordo - 1988, e W o il ricordo d’infanzia -1991, tutte e tre da Rizzoli): Dianella Selvatico Estense. Sipuò citare anche Roberta Delbono che è spesso associata aPerec, perché ha tradotto 4 suoi libri: Specie di spazi (Bol-lati Boringhieri, 1989); Sono nato (Bollati Boringhieri,1992); L’infraordinario (Bollati Boringhieri, 1994); Can-tatrix sopranica L. (Bollati Boringhieri, 1996). Sergio Pau-tasso ne ha tradotto 3 (Pensare/Classificare (Rizzoli, 1989)// Storia di un quadro (Rizzoli, 1990 e Skira, 2011) // 53giorni (Rizzoli, 1996). Poi, Laura Vettori e Emanuelle Cail-lat ne hanno tradotto due, e gli altri 11 hanno ciascuno tra-dotto un solo testo!
Una grande maggioranza di traduttori perecchiani, dun-que, sono stati “traduttori perecchiani” soltanto una volta.Questo “sparpagliamento” non è necessariamente un male,riflette solo lo “sparpagliamento” editoriale dell’opera diPerec in Italia (ne riparleremo). Anzi, in una prospettivapiù letteraria, non è tanto sorprendente, se si pensa alla di-versità delle opere di Perec, se non dal punto di vista dellostile, comunque da quello dei generi (romanzo, saggio, poe-sia, teatro...).
Un’altra spiegazione potrebbe essere anche la condi-zione dei traduttori in Italia, che non permette a molti diloro di esercitare la professione di traduttore a tempo pieno.Appare infatti dalle interviste e dagli scambi via e.mail cheuna buona parte dei traduttori di Perec ha un altromestiere.
La prima domanda del questionario che ho inviato loroera: “Qual è il Suo percorso di traduttore (quali testi ha tra-dotto) e quali sono i libri di Perec che ha tradotto?”. 6 dicoloro che hanno risposto sono traduttori confermati, nelsenso che hanno tradotto parecchi autori francesi, tra i piùgrandi:
36
- Caillat (Patrick Modiano, Muriel Barbery, Anna Moï,Françoise Chandernagor…)
- Ferrero (Céline, Flaubert…)- Prato Caruso (Sagan, Toussaint, Annie Ernaux, Roland
Barthes, Pierre Loti, Stendhal, Duras, Modiano,Delerm…)
- Sebregondi (Queneau, Duras, Bonnefoy e dall’ingleseNabokov, Coleridge…)
- Vettori (Hervé Guibert, Jacques Roubaud…)- Vicari Fabris (Maryse Condé, Georges Simenon, Agnès
Desarthe, Sylvie Germain…) Una è stata traduttrice solo di Perec – Roberta Delbono –
e si può dire che è arrivata alla traduzione grazie a Perec,per Perec.
4 di loro si sono presentati come traduttori “nonprofessionisti”: - Piero Falchetta : saggista, letterato, e storico della car-
tografia, dei viaggi e della navigazione, che lavora allaBiblioteca Marciana a Venezia, scrive : «Sono stato tra-duttore vero e proprio una sola volta»
- Alberto Lecaldano si è presentato come grafico, attrattodai testi di Perec più che dalla traduzione in sé.
- Jean Talon Sampieri ha anch’egli risposto: «Io non sonoun traduttore professionista», ma ha tradotto anche HenriMichaux. È curatore di una collana di narrativa per lacasa editrice Quodlibet assieme a Ermanno Cavazzoni.
- Ferdinando Amigoni, professore nel Dipartimento diFilologia Classica e Italianistica dell’Università di Bo-logna dove insegna Letterature comparate, ha affermato:«Le mie uniche esperienze di traduttore riguardano al-cuni saggi sull’interpretazione dei sogni tratti dalla“Nouvelle Revue de Psychanalyse”».
Perec ha attratto sia persone appassionate dalla sua let-teratura che traduttori “professionisti”. Il potere di sfida,d’invito alla creazione della sua letteratura è stato tale cheha trasformato alcuni suoi lettori in traduttori. L’ho detto:
37
il fatto che molti abbiano un altro mestiere non è sorpren-dente, è generalmente il caso nella comunità dei traduttoriletterari, che sono pagati poco, in Italia come in Francia.Ma si deve capire che nel caso di Perec, autore difficile, esi-gente, le realtà del mercato abbiano un’influenza stringentesul traduttore, come dice Roberta Delbono: «questo tipo didifficoltà si supera con ore e ore di lavoro e un traduttoreprofessionista non può probabilmente permetterselo!».
Le conseguenze di questa pluralità di mestieri non sonoper niente negative, anzi: permettono scambi tra il lavorodi traduzione e l’altro lavoro – si arricchiscono l’uno conl’altro. Una traduttrice (Delbono) parla così dell’influenzache il suo lavoro su Perec ha avuto nel suo insegnamento.Un altro, Alberto Lecaldano, ha utilizzato la sua sensibilitàdi grafico per la sua traduzione di Perec: «Ho fatto atten-zione anche a molte questioni compositive. Ho potuto con-sultare e confrontare il manoscritto di Perec e la suatrascrizione dattiloscritta alla Bibliothèque de l’Arsenal diParigi. Così, pensando che avessero un senso, ho riportatonella traduzione anche gli allineamenti, i rientri, gli spazi,la punteggiatura tentando di riprodurre l’originale anche secon limiti evidenti».
Un altro risultato che è apparso dalle risposte a questaprima domanda è l’importanza dell’effetto di gruppo, o direte, come se un certo mimetismo si fosse prodotto attornoall’Oulipo, incitando i traduttori a ricostituire il propriogruppo, “specializzandosi” nel campo della traduzione “àcontrainte”, e traducendo altri membri del gruppo : infatti4/11 hanno tradotto almeno un altro autore dell’Oulipo(Caillat e Segrebondi: Queneau, Vettori e Vicari: Roubaud),e si può indovinare che se guardiamo i traduttori di JacquesRoubaud o di Marcel Bénabou, per esempio, troveremo lostesso tipo di risultato.
Dove? Panorama editorialeIn Italia, Perec è stato pubblicato da 12 case editrici. Una
cifra enorme, che si spiega forse, da una lato, dal fatto che
38
per gli autori stranieri, il continuo seguire di un autore èpiù raro che per un autore del paese, perché l’autore stra-niero viene scoperto a poco a poco dal pubblico, con un po’di ritardo rispetto al paese di origine. Gli editori aspettanogeneralmente che l’autore sia consacrato da un best-sellerper far tradurre le sue opere meno famose, anche se sonostate pubblicate prima.1
Dall’altro lato, se si osserva la tipologia di queste caseeditrici, vediamo che essa riproduce in una certa misura lavarietà degli editori di Perec in Francia: se la maggior partedella sua opera è stata pubblicata da Maurice Nadeau perDenoël, La Vie mode d’emploi al contrario è stata pubbli-cata da Hachette, e alcuni testi più confidenziali sonoapparsi in piccole case editrici (Galilée, Christian Bour-gois). Se Perec è così famoso oggi, è anche perché è un au-tore che ha raggiunto sia un pubblico ampio che unpubblico di letterati più esigenti e più pronti a leggere i suoitesti difficili. Così in Italia, alcuni romanzi suscettibili diincontrare il successo da parte di un pubblico vasto sonostati pubblicati dalle più grandi case editrici (Mondadori,per Le Cose, Einaudi, per il suo teatro che dopo le messein scena a Parigi ha incontrato un bel successo e per la rie-dizione di Le Cose, ma soprattutto Rizzoli, che aveva com-prato, sembra, una gran parte dei diritti di traduzione e cheha pubblicato 3 libri di Perec). Ma poi Perec ha anche in-teressato delle case di dimensione media o veramente pic-cola: Bollati Boringhieri, che arriva in primo posto nellaclassifica per aver pubblicato 5 opere di Perec, e/o, Ar-chinto, Robin Edizioni-Biblioteca del Vascello, Quodlibete Baskerville, per esempio. Menzione particolare per altredue, Voland e Henri Beyle: Voland per il lavoro bellissimoche ha fatto sul Tentativo d’esaurimento di un luogo
39
1 Sarebbe interessante qui comparare con altri scrittori importanti del ven-tesimo secolo, come Céline, Sartre, o Duras, e di vedere se alcuni di essisono stati pubblicati dalla stessa casa editrice: apro la discussione perdopo rifacendomi alla vostra esperienza del campo editoriale italiano perle opere straniere.
parigino (trad. A. Lecaldano), in cui per la prima volta sonostate pubblicate insieme al testo anche le foto di Perec men-tre scriveva il suo testo Place Saint Sulpice, fatte dal suoamico Pierre Getzler; e Henri Beyle che si presenta sul suosito come “libri editoria grafica” e che fa delle edizioniquasi da bibliofili (poche copie, molto belle) – interessanteil fatto che Perec abbia interessato anche questo tipo di edi-tori, come più generalmente ha interessato molto i graficiin Francia, che spesso propongono edizioni originali deisuoi testi.
Il luogo geografico di queste case editrici è fedele allaripartizione dell’edizione in Italia: maggioranza nel Nord(4 a Milano, 2 a Torino, una a Bologna), alcune a Roma(2), una tra Macerata e Roma (Quodlibet)… Si nota inoltrela presenza di una casa editrice napoletana (Guida editore)– traccia dell’intensa attività pro-oulipiana a Napoli (èanche lì che sono pubblicati molti testi oplepiani).
Si può concludere da questo (troppo) breve panoramadell’impianto di Perec nell’edizione italiana che:
la collocazione delle sue traduzioni è, al contrario dellasituazione negli Stati Uniti per esempio (dove Perec è solopubblicato da piccole “non profit press”), piuttosto positiva,nel senso che ha beneficiato di una diffusione larga per al-cuni suoi testi,
l’opera, però, è talmente sparpagliata che può essere dif-ficile al lettore italiano farsi un’idea globale dell’autore. Sipuò immaginare che ci siano due percezioni parallele diPerec da parte del lettorato italiano: l’autore dei romanzidi successo, la cui reputazione va al di là di un circolo diletterati, e il Perec più confidenziale, noto e apprezzato solodai letterati. Questa situazione ci rimanda alla situazione diPerec in Francia qualche anno fa, oggi attenuata da moltistudi, articoli, riedizioni, che tendono a dare un’immaginepiù complessa e completa al pubblico francese.
40
Cosa? Bilancio nel 2012L’altra domanda che mi sono posta è: quali sono le opere
che sono state tradotte ? Qual è il Perec che conoscete qui?E: qual è la proporzione della sua opera che è stata tradotta?
Opere in vitaLa prima constatazione è che sulle opere pubblicate du-
rante la vita di Perec, 16 su 21 sono state tradotte in italiano,cioè il 76 %: quasi tutta l’opera. Tra quelle che non sonotradotte, ci si trova:
Die Maschine, un pezzo radiofonico di Perec con EugenHelmlé, scritto per la radio tedesca
E gli altri sono testi detti “intraducibili” perché basatisulla combinatoria di lettere o su altre contraintes diffici-lissime, tra questi la poesia di Perec:
Alphabets (la contrainte è quella di non riutilizzare laconsonante di un insieme prima di aver usato tutte le altreconsonanti dello stesso insieme)
una bella sfida per il traduttore: Les Revenentes: il pezzo“monovocalico” in e scritto dopo La Disparition, e fino aoggi tradotto solo in inglese (invito gli amici oplepiani aprovarci!)
e, realmente intraducibili, le “parole incrociate” di Perec(Mots croisés).
Nb: Le Petit traité sur l’art subtil du go, scritto con Jac-ques Roubaud et Pierre Lusson, sta per essere pubblicatoda Quodlibet nel 2014 (tradotto da Martina Cardelli).
Mi fermo per un momento sul caso limite dell’opera in-titolata Ulcérations, primo volume della “Bibliothèque Ou-lipienne”: in questo testo, Perec utilizza le undici lettere piùfrequenti nella lingua francese, contenute nel titolo, perfarne trecento novantanove permutazioni. Ho contato que-st’opera tra le opere tradotte perché c’è stato, nel primo vo-lume della Biblioteca Oplepiana, una versione proposta daRuggero Campagnoli e chiamata Edulcoranti, in cui Cam-pagnoli ha fatto la stessa operazione di Perec, ma con lelettere più frequenti della lingua italiana. Si potrebbe dire
41
che il testo non è una traduzione, nel senso che non ripro-duce niente del contenuto dell’opera perecchiana (il risul-tato essendo invece molto diverso, si parlerebbe piuttostodi adattamento); ma dall’altra parte è un esempio bellissimodi traduzione “fedele” nel senso che Campagnoli hariprodotto con esattezza il sistema perecchiano, ha giocatocon l’alfabeto della propria lingua come e nello stesso spi-rito di Perec.
Si potrebbe anche parlare qui delle ritraduzioni, che sonoun altro segno del grande successo di Perec in Italia : W oil ricordo d’infanzia, Un uomo che dorme, L’Aumento(chiamato nella sua seconda traduzione L’arte e la manieradi affrontare il proprio capo per chiedergli un aumento)hanno conosciuto due traduzioni diverse. E se contiamoanche le riedizioni, come quelle di Le Cose – prima pub-blicata da Mondadori, poi da Rizzoli, e infine da Einaudinel 2010, si può dire che quasi tutti i libri pubblicati daPerec quando era in vita non solo sono stati tradotti in ita-liano, ma hanno anche avuto una accoglienza eccezionale.
Opere postumePerò l’opera intera di Perec è fatta in due parti: quella
antuma, ma anche quella postuma, molto importante, cherappresenta 25 pubblicazioni al totale. Su questi testi più omeno importanti, più o meno lunghi, solo 6 sono stati tra-dotti: Pensare/Classificare; 53 giorni, Sono nato, CantatrixSopranica, Il Viaggio d’inverno e Il Condottiero. Riman-gono, come per l’opera antuma, le opere di poesie (La Clô-ture, di cui Alberto Lecaldano ha tradotto qualche poemama non sono pubblicati), alcuni testi di circostanza (gli Epi-thalames, Voeux), e testi proprio intraducibili (es: altre pa-role incrociate). Invito i traduttori presenti oggi a osservarein particolare la poesia di Perec per progetti futuri, cosa checostituisce una bella sfida di traduzione.
42
2/ Tradurre Perec: un’attività collettiva e militanteLa seconda e la terza domanda del questionario mandato
hanno fatto sorgere un altro aspetto importante dell’attivitàtraduttiva attorno a Perec, dal punto di vista dell’analisidella rete: il funzionamento di una “rete perecchiana” moltoefficiente, in quanto insieme di rapporti stretti, intrecciati,che in un certo modo invalidano il discorso abituale dellasolitudine del traduttore. Anche qui, sembra che l’attrazionedi Perec verso l’attività collettiva si sia riprodotta al livellodei suoi traduttori. Le due domande erano:2. Quando e come ha scoperto Perec per la prima volta?3. Chi ha preso l’iniziativa di tradurre Perec: un editore,
Lei, o qualcun’altro?Tre traduttori evocano la loro scoperta di Perec poco
dopo pubblicazione di La Vie mode d’emploi, negli anni ot-tanta, che senza sorpresa appare per molti come il primolibro che ha scattato la “passione Perec”. Tre hanno rispostoevocando il loro contatto stretto con la Francia, grazie alquale conoscevano già Perec quando hanno cominciato atradurlo – lo hanno scoperto attraverso articolo suoi (PratoCaruso), articoli del giornale su di lui (Delbono), o il nu-mero speciale del Magazine Littéraire su di lui. È menzio-nata una volta su 11 solo la formazione universitaria(Caillat) come modo di scoprire l’autore, ma ci si può im-maginare che questo numero si spiega in parte per una que-stione di generazione: ci vuole un po’ di tempo per qualsiasiautore per entrare nell’ “accademia”. Ora che Perec vieneinsegnato assai spesso all’università, ci si può immaginareche l’accademia/l’università sarà un media sempre più im-portante per la diffusione dell’opera (è importantissima inFrancia, per esempio).
La risposta più frequente che ho ricevuto alla domanda2 è, però, tutt’altra: 4 traduttori su 11 evocano infatti ilruolo di Italo Calvino nella loro scoperta di Perec. Non soloquesto rafforza una volta ancora, in modo molto concreto,l’immagine di Calvino come “mediatore”, “passatore” diPerec – un’immagine ben conosciuta qui, ma mette anchein valore il ruolo più generale dell’Oulipo, cioè della “rete
43
primaria” di Perec nella diffusione dell’opera. Ernesto Fer-rero, per esempio, racconta: «Avevo scoperto Perec aitempi di La vie, perché Italo Calvino, che era suo amico,me ne aveva parlato con entusiasmo, caldeggiandone la tra-duzione presso Einaudi». Per Maria Segrebondi, è stato“grazie al suo interesse per Calvino e gli esperimenti ouli-piani”, e due altri citano dei testi di Calvino che hanno su-scitato da loro il desiderio di leggere Perec (la recensionedi La Vita, istruzioni per l’uso su “la Repubblica”, e l’elo-gio che ne è fatto nelle Lezioni americane).
Oltre al ruolo di Calvino, altri personaggi sono citatinelle risposte come “passatori” che hanno fatto scoprirePerec o che hanno aiutato con la traduzione: una rispostamenziona Jacques Roubaud (ma senza esserne sicura),un’altra racconta il lavoro con Eugen Helmlé, eminente tra-duttore tedesco che è un riferimento frequente per la “co-munità invisibile” dei traduttori perecchiani : «E. Helmlé(…) mi aveva fornito utili consigli per ritrovare le figuredi stile (lui aveva infatti avuto la fortuna di poter collabo-rare direttamente con Perec !)» (Delbono). Una traduttriceparla della frequentazione dei perecchiani a Parigi attornoall’Association Georges Perec, e in particolare dell’aiutodi Bernard Magné, «profondo, straordinario ricercatore econoscitore di Perec» (Vettori). Ma non solo a Parigi o inFrancia ha funzionato la rete: un altro traduttore, Ferdi-nando Amigoni, evoca «un’attivissima collaborazione edi-toriale e amichevole da parte di Ermanno Cavazzoni, JeanTalon e Martina Cardelli». Questo effetto di rete ha funzio-nato anche al livello della pubblicazione della traduzione:in uno dei casi, è stato un traduttore di Perec a proporre ilnome di un altro alla casa editrice, che ha accettato (Lecal-dano ha proposto Ferrero a Voland per Il condottiero). Sipuò dire così che come l’autore, e contrariamente a un’im-magine comune, il traduttore di Perec lavora spesso nelquadro di una rete molto attiva e pronta alla collaborazione.L’estetica della complicità rilevata da Hervé Le Tellier aproposito dell’Oulipo esiste anche per i traduttori oulipiani.
44
Un’altra dimensione importante di questa rete di tradut-tori è il suo aspetto attivo, anzi, proattivo, talvolta militante.Il sapere non è andato in una direzione sola, e i traduttoriperecchiani hanno anche loro contribuito a far conoscerePerec in profondità, al di là delle loro traduzioni. Infatti,due di coloro che mi hanno risposto hanno fatto un lavorocritico su di lui (Caillat e Delbono per la loro tesi di laureasu Perec), e un altro, Piero Falchetta, racconta anche come«numerose tesi di laurea hanno preso in considerazione inmodo più o meno approfondito il mio lavoro» – e questo èvero anche in Francia: il suo lavoro ha alimentato molto laricerca sulla traduzione, per esempio.
Poi, sono stati spesso essi stessi a proporre la propria tra-duzione agli editori, e non l’inverso: 5 hanno risposto que-sto alla terza domanda, tra i quali uno ha potuto anchepubblicare la sua traduzione nella sua collana. Un’altro rac-conta come ha dovuto insistere un po’ prima di trovare uneditore: «Molte case editrici importanti come Rizzoli, Bol-lati Boringhieri, Einaudi e Adelphi contattate da me nonhanno accettato la proposta. Ho allora interpellato les Edi-tions Denoël che detengono i diritti d’autore (…), e pocodopo Madame Françoise Bothorel mi ha messo in contattocon l’editore italiano che aveva comprato i diritti. A quelpunto ho spedito loro un saggio della traduzione che giàavevo quasi completato e che è stata positivamente ac-colta». Un altro traduttore cita il caso in cui la casa editriceche deteneva i diritti di traduzione si è dichiarata non inte-ressata dalla pubblicazione dell’opera, e l’altra casa edi-trice, più piccola, dovette ricomprare i diritti per poterpubblicare la sua traduzione.
3/ Una sfida alla traduzioneLa quarta domanda del mio questionario verteva sul
modo in cui questi traduttori hanno vissuto il fatto di tra-durre Perec. Il campo lessicale usato nelle risposte è statoquello della difficoltà e della sfida, quasi di un combatti-mento con l’autore, sempre associato però al campo lessi-
45
cale della soddisfazione e del piacere: si trova la parola “in-traducibile” più volte, “sfida linguistica e ludica” ma anche“trappole”, “fatica”… sono associate a parole come “sod-disfazione”, “motivazione”, “enorme piacere”.
Le difficoltà incontrate sono tanto varie quanto sonovari i libri di Perec: uno parla del fatto che «in Perec tuttoè importante, anche il minimo e più ordinario oggetto no-minato», un’altra evoca la «struttura rigorosa, (i) richiamiletterari – alcuni chiaramente identificabili (il ritmo terna-rio, gli imperfetti di Flaubert) altri che suonavano comequalcosa di familiare ma che non riuscivo a identificare».Per un’opera come Ellis Island, la difficoltà fu per la tra-duttrice di «cercare la giusta tonalità», per riprodurre il cre-scendo dello stile «in cui via via la prosa cede alla poesia».Per La Poche Parmentier, e sicuramente per tante altreopere di Perec, si è trattato sopratutto di «risolvere i giochilinguistici» - risposta data anche da Eliana Vicari: «trapian-tare i giochi di parole semantici o sonori, i neologismi e gliscarti di registro». Invece per un’opera come La bottegaoscura, il traduttore è stato attento «a riprodurre la trascri-zione onirica (da intendere tra virgolette) il più diretta e ilmeno letteraria possibile».
Il piacere proviene anche dal fatto che spesso, mentre la-vora, il traduttore legge in modo molto attento e scopredelle cose nel testo che non sono state scoperte prima, siadelle contraintes, sia, al contrario, delle sorprese, pezzi chesono “fuori contrainte”. Alberto Lecaldano racconta, peresempio:
«Ma soprattutto nella sua precisa descrizione degli av-venimenti a place Saint Sulpice cosa ha mai voluto direPerec con “Précédé de 92 motards, le mikado passe dansune rolls-royce vert pomme”. Alla fine ho pensato chedopo pranzo il 19 ottobre 1974 (in questi giorni 38 annifa) Perec forse mentre prendeva i suoi minuziosi appuntiun po’ si annoiava e così una fuga fantastica in compa-gnia dell’imperatore del Giappone (mikado) e di 92 mo-tociclisti si rendeva indispensabile: meraviglioso Perec».
46
Il piacere della traduzione è qui un piacere di lettura mi-nuziosa, un tipo di lettura che è particolarmente adatto aitesti di Perec.
Mi fermo qui, ma ci sarebbero molte altre cose da diresulle risposte a questo questionario, tra l’altro sulla rice-zione delle traduzioni (i numerosi premi ricevuti, le recen-sioni positive, ecc.). Per rendere omaggio a tutti questitraduttori e all’intensità che traspariva in tutte le risposte,e che forse non ho resa in questo lavoro, vorrei concluderecon un paragone molto bello proposto da Maria Sebregondiper descrivere la traduzione letteraria, che rifletta l’intensitàdel rapporto sentimentale/affettivo che ha unito questi tra-duttori a Perec:
«Tradurre (parlo di traduzioni letterarie, di testi poeticie/o à contrainte) è come nuotare sott’acqua attaccati allapancia del proprio autore, respirando attraverso i suoirespiri, partecipando di ogni minima vibrazione».
47