Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da...
Transcript of Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da...
Una nota sul bartolismo
Adolfo Giuliani1
Abstract
That the word ‘bartolism’ first appeared in 19th century France might sound like a purely erudite detail, but if we consider the context in which this word was used, this fact has important implications. As this paper tries to show, references to ‘bartolism’ only began to appear in legal history manuals published in the first decades of 19th century France and starteda new writing style which left behind a tradition which until the18th century was shaped on commentaries on Pomponius’ text De origine juris (D. 1.2.2). Closely connected to the ideology of the Civil Code (1804) and to the vision of legislation without interpretation, they offered a simplified narrative: a medieval age to be condemned and a new beginning begun by Cujacius. In their devastating criticism of ‘bartolism’ their real target was not their clumsy Latin, their ignorance of history, or their scholasticism, but the very possibility of a model of jurisdiction functionally based on the existence of a jurist-interpreter. This matter brings to the fore the complicated relation between legal theory and legal history and shows that the latter cannot be a priori exempted from more or less explicit premises about a definition of law and a vision of its sources.
1 Questa relazione è stata presentata al convegno Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società, Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013.
- 1 -
I.
Sono passati appena più di 50 anni da quando nel 1959 si svolse
qui a Todi un’altra grande celebrazione dedicata a Bartolo. I
lavori furono aperti da Francesco Calasso che in una nota
prolusione toccò il punto centrale del grande giurista che oggi
celebriamo: L’eredità di Bartolo2. È appunto quell’eredità che si lega
al nome di Bartolo la fonte del vero problema storiografico del
grande giurista di Sassoferrato. È un difficile connubio quello
tra Bartolo e la sua eredità: da una parte si pone Bartolo, fonte
di un mito agiografico durato secoli, dall’altra il bartolismo, e
quindi il discredito ed addirittura il vilipendio. È un problema
difficile da risolvere, notava Calasso, da una parte per
l’immensità della mole dell’opera Bartoliana che impedisce una
visione completa del giurista; dall'altra per le ambiguità del
bartolismo, con tutte le ombre evocate da questo termine: a causa
dello ‘scontro’, l’ ‘antagonismo’ e la sua conseguente ‘condanna’
decretata dall’Umanesimo. Questi due ostacoli, concludeva
Calasso, determinano «quel mancato giudizio storico sull’opera di
2 F. CALASSO, L’eredità di Bartolo, ora in Storicità del diritto, Milano, 1966, pp. 317-337,e, dello stesso, Bartolismo, in Enciclopedia del diritto, V, Milano, 1959, pp. 71-74.
- 2 -
Bartolo da Sassoferrato, che lamentiamo»3.
Rileggere oggi questa famosa prolusione fa pensare che il
primo ostacolo notato da Calasso sia ancora da superare:
l'immensità della produzione Bartoliana, con i tanti dubbi di
attribuzione, sono un ostacolo insormontabile per lo storico ed
impediscono una visione completa della sua opera. Sul versante
del bartolismo qualcosa è invece cambiato. Nella storiografia
giuridica dell’ultimo cinquantennio sono emerse nuove sensibilità
e nuovi approcci che hanno portato a ripensare alcuni aspetti
dello scrivere la storia del diritto; non senza un motivo, perché
prima di tutto è mutato l'oggetto stesso della storiografia
giuridica: è mutato il diritto.
Nella vivace e vasta discussione che si è aperta in questo
ambito si possono isolare due elementi che hanno contribuito in
modo particolare a questa evoluzione. Il primo è il prendere
corpo di quello che Nicola Picardi ha efficacemente sintetizzato
come la vocazione del nostro tempo per la giurisdizione e la
dottrina4. Alla fonte c’è lo spezzarsi di un consenso cha ha
3 Calasso, L’eredità di Bartolo cit., (n. 2), p. 329-330.4 NICOLA PICARDI, La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione, in M.G. DI RENZO VILLATA,Il diritto fra scoperta e creazione, Napoli, 2003, pp. 467-501.
- 3 -
regnato sulla definizione di diritto ed il primo suo frutto si
manifesta nell’erosione di una concezione statualista che vedeva
nella legge il prototipo di norma giuridica — il c.d.
‘assolutismo giuridico’ di cui parla Paolo Grossi5. Come
conseguenza la legge scende dal piedistallo. È così uno stato
d’animo diffuso il pensare che il diritto non si rifletta
esclusivamente nella legge, così come il dubitare che la
creazione di nuovo diritto possa essere compendiata da un fiat
legislativo, o che la metafora delle fonti del diritto possa
cristallizzare la fluidità dei fenomeni normativi. Tale
inquietudine riguardo il modello legislativo contribuisce a
spostare l’attenzione verso la giurisprudenza. Questo spostamento
porta con sé una radicale mutamento di paradigmi: sulla sommità
degli apices juris porta a far volgere l’attenzione dalla giustizia
distributiva alla giustizia correttiva6; sulla scena concreta del
farsi del diritto, dal legislatore al giudice, personificazione
del ‘diritto vivente’. Innumerevoli segni di questo cambio di
direzione si colgono nella storiografia giuridica, a cominciare
5 P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998. 6 Basterebbe considerare l’evoluzione tra due delle maggiori opere pubblicate su questo tema negli ultimi decenni, da JOHN RAWLS, A Theory of Justice, 1972 ad AMARTYA SEN, The idea of Justice, 2009.
- 4 -
dalla tendenza attuale a leggere nello ius commune una forma
storica di organizzazione giuridica che al suo centro poneva un
diritto a formazione giurisprudenziale piuttosto che un sistema
legislativo7.
Il secondo aspetto riguarda più da vicino la storia del
diritto. L’erosione dell’ ‘assolutismo giuridico’ significa anche
rendere più incerta la linea di confine che divide il giuridico
dal non-giuridico. Questa incertezza porta lo storico ad
allargare il proprio ambito di ricerca per cogliere la
molteplicità di elementi che hanno contribuito al suo farsi8.
Nulla di veramente nuovo per chi tiene presente l’esortazione di
Riccardo Orestano a volgersi allo studio di quella cerchia di
fatti normativi che egli comprendeva nell’espressione di
esperienza giuridica9. Importanti corollari discendono da simili
7 Sullo spostamento da una lettura legislativa ad una lettura giurisprudenziale dello ius commune v. E. CORTESE, Immagini di diritto comune medievale, in Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Roma, 2006, pp. 3-16.8 In questa chiave possono leggersi varie ricerche tese a ricostruire i legamitra diritto e religione (Harold Berman), diritto ed etica (James Gordley e WimDecock), diritto e logica (Jan Schroeder).9 Riccardo Orestano esortava lo storico a «considerare qualunque manifestzionedell’esperienza giuridica nella totalità delle sue connessioni col reale storico (...), a ricercare le reciproche implicazioni fra i fenomeni ‘giuridici’ e la struttura delle società in cui essi si manifestano: strutturaeconomico-sociale ma (anche) modo di essere in tutti i suoi aspetti della singola società presa in esame», RICCARDO ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto
- 5 -
premesse. Il primo è di considerare i fenomeni normativi come il
prodotto degli attori che si muovono nel mondo del diritto, e,
strettamente collegato, il vedere le parole che ne designano i
fenomeni come il risultato di un «fare cose con parole»10. Tali
posizioni attribuiscono un ruolo decisivo allo storico. Suo è il
compito di chiarire le ambiguità ed oscurità del linguaggio
giuridico che lo studioso di diritto positivo, lavorando ad un
puro livello concettuale, non coglierebbe. In definitiva, nuovi
compiti e nuovi metodi si propongono oggi allo storico del
diritto.
Torniamo al bartolismo. I due elementi menzionati sopra —
una maggiore sensibilità per il momento giurisprudenziale nel
diritto e per la formazione storica dell’apparato concettuale del
giurista — sono un equipaggiamento utile per tornare oggi a
ragionare di bartolismo.
romano, Bologna, 1987, p. 343.10 J. L. AUSTIN, How to do things with words, Cambridge, 1978. È appena il caso di ricordare come da queste premesse ha preso l’avvio un radicale ripensamento della storia del pensiero politico ed in generale della storia intellettuale, su cui v. Q. SKINNER, Meaning and understanding in the History of Ideas, in History and theory, VIII, 1 (1969), pp. 3–53, ora in Q. SKINNER, Visions of politics, I. Regarding method, Cambridge, 2002, pp. 57-89; e per la storia del diritto P. COSTA, In search of legal texts: Which texts for which historians? in Reading past legal texts, a cura di D. MICHALSEN, Oslo, 2006, pp. 158-181, e sullo sfondo intellettuale, A. GIULIANI, L'altro Aristotele, in Sociologia, III (2010), pp. 125-33.
- 6 -
II. 1
Che il ‘bartolismo’ avesse una storia fu notato da Biagio Brugi,
che nei suoi Fasti aurei del diritto romano (1879) riassunse
l’armamentario dialettico usato dal giurista di mos italicus con un
unico termine comprensivo, il ‘bartolismo’, ma subito aggiungendo
un’importante dettaglio: «come direbbe un moderno con parola
nuova ma espressiva»11. Un’osservazione interessante. La presenza
familiare di questo termine nel linguaggio corrente del giurista
potrebbe far pensare ad una entità collocata fuori dal tempo ma,
come vedremo, si inizia effettivamente a parlare di ‘bartolismo’
nei primi decenni del XIX secolo all’interno di una manualistica
di storia del diritto pubblicata in Francia. Questa letteratura
determina l’inizio di un nuovo corso della storiografia giuridica
che ispirandosi al mito codicistico di una legislazione senza
11 BIAGIO BRUGI, Fasti aurei del diritto romano, Pisa, 1879, p. 91: «Il metodo s'infiltrò nelle scuole, vi fu adorato e i rimase a lungo; gli scolari d'Italia per lungo tempo furono avversi ad abbandonare la distinzione, la casistica, il bartolismo, come direbbe un moderno con parola nuova ed espressiva».
- 7 -
interpretazione, eleva questo termine a protagonista, screditato
e soccombente, della storia giuridica12.
II. 2
Prima di esaminare questa letteratura è necessaria una premessa.
Il sapere che la parola ‘bartolismo’ ha un’origine ottocentesca
secolo potrebbbe essere presa per un mero dettaglio erudito che
lascia il tempo che trova. In realtà quest’osservazione rivela un
risvolto importante non appena viene posta nel contesto in cui ha
preso origine.
Che il passaggio tra XVIII e XIX secolo abbia registrato una
profonda cesura nel tessuto del diritto è un’opinione radicata
nella storiografia, che concordemente vede in quei decenni il
determinarsi di una svolta radicale nel diritto, in tutti i suoi
rami. Ma tale cesura non ha inciso solo nel tessuto del diritto:
12 Non è una coincidenza che questa osservazione venisse proprio da Biagio Brugi, uno studioso sensibile al delicato equilibrio tra legislazione e giurisprudenza in una atmosfera che puntava al primato del diritto legislativoed al corrispondente degrado dell’interprete al ruolo di un passivo ricevitoredi norme, su cui v. M. MECCARELLI, Un senso moderno di legalità. Il diritto e la sua evoluzione nel pensiero di B. Brugi, in Quaderni Fiorentini, XXX (2001), pp. 361-476.
- 8 -
ha toccato anche il modo di scriverne la storia13. Una
manualistica pubblicata in Francia in quei decenni determina un
nuovo inizio: essa riformula i modi di intendere la evoluzione
del diritto, i suoi modi di produzione e gli attori che ne
determinano le trasformazioni. Non per ultimo essa eleva il
bartolismo e lo personifica attribuendogli un ruolo di attore nel
palcoscenico di una storia semplificata. Questo, come altri ‘-
ismi’, appartengono ad una storiografia che pone come
protagonisti idee astratte che si muovono nel tempo e si
fronteggiano eroicamente in contrasti da cui esce un vincitore ed
un vinto14. A questo stile storiografico appartiene il
bartolismo, come l’antagonista sconfitto e soccombente alla
vittoria dell’umanesimo15. La sua sconfitta, fissata nell’apparire
di Cujas, costituisce il punto di inizio della storia del diritto
13 Negli stessi decenni si registra un simile cambio di direzione nella storiografia della filosofia in seguito all’influsso delle categorie Kantiane,su cui v. R. TUCK, The ‘modern’ theory of natural law, in The language of political theory in early-modern Europe, a cura di A. PAGDEN, Cambridge, 1987, pp. 99-119.14 Cosi la storia del diritto privato è stata talvolta riassunta in una lotta tra formalismo e consensualismo, e la storia del pensiero politico come una marcia verso il liberalismo ottocentesco. Altri esempi in R. V. CAENEGEM, I signori del diritto, Milano, 1991, p. 61-3.15 Per esempio, ALEXANDRE LABROQUÈRE, Guy du Faur de Pibrac, Toulouse, 1877, p. 7: «etle bartholisme vaincu ne savait plus se venger de ses défaites que par de misérables persécutions contre ses adversaires».
- 9 -
moderno. Questa parola segnala qualcosa di ulteriore rispetto
alle note invettive anti-bartoliane che fanno capolino nelle
opere dell’umanesimo giuridico. Se da una parte è innegabile che
si alimenti dello stesso humus culturale — si potrebbe sostenere
che la polemica contro i legisti attraversa i secoli — ne
costituisce un atteggiamento più radicale e profondo. Il
‘bartolismo’ appartiene allo stile di una storiografia giuridica
che si impone all’inizio del XIX secolo.
Il sapere chi usò questo termine per la prima volta è meno
importante di mettere a fuoco il percorso che lo porta ad entrare
nel lessico della storiografia giuridica. Il vero problema da
porsi è come tale termine possa acquisire una carica persuasiva e
denotativa all’interno di un lessico particolare attraverso un
processo collettivo che risponde alle necessità di attribuire
nomi a cose e mantenere il difficile equilibrio tra res e verba.
Si attribuisce, per esempio, la creazione della parola
‘umanesimo’ (Humanismus) ad un oscuro didatta tedesco, che usò
nel titolo di una sua opera pubblicata nel 1808, ma tale vicenda
non avrebbe che un peso trascurabile di fronte al suo immettersi
nell’uso storiografico in seguito alla classica opera di Jacob
- 10 -
Burckhardt La Civiltà del Rinascimento in Italia (1860) in cui l’ Humanismus
diviene l’asse portante di una influente visione del Rinascimento
su cui regnò il generale consenso sino alla metà del XX secolo16.
Come diceva Aristotele, una rondine non fa primavera17.
II. 3
L’origine ottocentesca del bartolismo nel seno di questa
particolare scuola storiografica è carica di implicazioni. La
principale è che la storia del diritto non è separabile da una
tacita premessa riguardo ad una generale definizione del diritto
e ad una visione delle sue fonti. La storia del diritto
continentale non è una libera narrazione svincolata da parametri,
in quanto esiste un criterio che determina l’ordine di
esposizione e la struttura della narrazione. La storia del
16 Si tratta di F.J. NIETHAMMER, Der Streit des Philanthropinismus und des Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts unsrer Zeit, 1808. Su questa vicenda v. W. RUEGG e H. DE RIDDER-SYMOENS, A History of the University in Europe, I. Universities in the middle-ages, Cambridge, 1992, p. 443. Come è noto, la visione dell’umanesimo offerta da JACOB BURCKHARDT nella sua classica opera La Civiltà del Rinascimento in Italia (1860) subìuna radicale revisione ad opera di Paul O. Kristeller a partire dal 1950, su cui v. una efficace sintesi in C.G. NAUERT, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, Cambridge, 2006, pp. 1-8.17 ARISTOTELE, Etica a Nicomaco, I.1098a18.
- 11 -
diritto prende infatti forma nel XVII secolo con il precisarsi di
una struttura che detta un ordine di esposizione dato dalla
distinzione tra historia iuris interna e historia iuris externa18. Il confine
che le divide è incerto e mobile nel tempo. Esso intende
rispondere alla necessità di creare un nesso tra storia e
definizione del diritto, tra un diritto che reclama la propria
purezza ed i fatti che determinano il farsi delle norme: il che
equivale, in ultima analisi, ad una quadratura del cerchio. Ogni
scuola storiografica ha tracciato il proprio confine. Ma nel
momento in cui accetta una visione delle fonti — in quanto la
fonte intende rispondere ad una domanda riguardo le origini ed il
processo creativo del diritto — essa pone una premessa riguardo
la natura del diritto che intende studiare. Per lo storico del
diritto il compito si pone di prendere posizione sull’identità
degli attori che determinano la creazione, modificazione ed
estinzione delle norme, e rispondere ad una domanda che
18 La fonte di questa distinzione è normalmente attribuita a G.F. Leibniz, Novamethodus discendae docendaeque jurisprudentiae (1667), II, § 1 a 2: «Jurisprudentia historica est vel interna vel esterna: illa ipsam Jurisprudentiae substantiam ingreditur, haec adminiculum est, et requisitum», su cui v. LUIGI RAGGI, Storia esterna e storia interna del diritto nella letteratura romanistica, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano ‘Vittorio Scialoja’, I, (1959), pp. 199-222 e E. CONTE, Diritto Comune (2009), pp. 29-32, e A. GIULIANI, Legal history and comparative legal history, in Comparative legal history, a cura di A. MASFERRER e O. MORÉTAU, Londra, 2014.
- 12 -
semplificando potrebbe essere formulata come: chi dà il
contributo decisivo, il giudice, il legislatore o il
professore?19
In questo contesto il ruolo dato all’interpretazione è
decisivo. Esso è il topos su cui si scontrano visioni alternative
di storia del diritto. Si possono fare tre esempi. Il progetto
esposto da Savigny nel Beruf contemplava una evoluzione giuridica
guidata dai giuristi, interpreti del Volksgeist della nazione
Tedesca; il particolare peso dato ai giuristi (pur se entità
fungibili di fronte al fine superiore di creare un corpus
scientifico coerente) configurava una nuova e specifica visione
delle fonti del diritto che egli oppose a Thibaut. In un
differente contesto, dominato dal fervore intellettuale per un
passato che si voleva vedere cristallizzato nella compilazione
Giustinianea, Francesco Calasso oppose la visione di un ‘medioevo
del diritto’ implicante il riconoscimento del valore creativo dei
giuristi, artefici della coerenza di un sistema di ius commune20.
19 P. ROUBIER, L’ordre juridique et la théorie des sources du droit, in Mélanges Ripert, 1950, I, p. 24: «dans diverses sociétés se manifestent, avec une force inégale selon les temps et selon les lieux, deux sources formelles … qui sont la jurisprudence et l’autre la législation».20 Osservazioni puntuali in P. COSTA, "Ius commune", "ius proprium", "interpretatio doctorum": ipotesi per una discussione, in El dret comú i Catalunya, a cura di A. IGLESIA
- 13 -
Per finire, la tesi di Emilio Bussi, su cui ruota (a volte
inconsapevolmente) gran parte della discussione attuale, nel suo
riscoprire il valore del diritto giurisprudenziale portava
l’attenzione sull’ineludibile presenza del giurista nel momento
applicativo del diritto21. È significativo che intorno alla
nozione di fonti del diritto si sia oggi acceso un vivace
dibattito, come se si fosse rotto un consenso che ha regnato per
decenni.
Nella condanna ottocentesca del bartolismo si manifesta una
particolare visione del diritto. Il bartolismo richiama
immediatamente il tema dell’interpretazione. Designando l’insieme
dei procedimenti logico-argomentativi con cui l’interprete
produceva norme a partire dal testo Romano, esso costituisce una
delle forme in cui il generale problema dell’applicazione della
legge si è storicamente manifestato: una interpretatio intesa come
attività produttiva di norme22. Essa era funzionale ad un
FERREIRÓS, Barcelona, 1995, pp. 29-42.21 E. BUSSI, Intorno al concetto di diritto comune, Milano 1935.22 Su cui v. S. CAPRIOLI, Interpretazione nel diritto medievale e moderno, in Digesto IV edizione, X Civile, Torino, 1993, pp. 13-25. Ho cercato di dare una base testuale alla tesi di un’evoluzione dell’idea di interpretazione riconducendola ad una quaestio discussa da JACOPO MENOCHIO nel suo trattato De praesumptionibus (1587) in A. GIULIANI, From presumption to interpretation, in Per Saturam. Studi per Severino Caprioli, a cura di G. DIURNI, P. MARI e F. TREGGIARI, Spoleto, 2008, pp. 447-474.
- 14 -
contesto istituzionale i cui i caratteri principali erano ben
diversi dalla realtà che si profila a partire dall’inizio del XIX
secolo: un contesto il giudice non era la bouche de la loi e la
applicazione della legge non aveva nulla dell’automatismo
meccanico dei regimi codificati. In tale contesto l’applicazione
della legge richiedeva un giurista interprete: egli era un attore
protagonista nel farsi del diritto.
III. 1
Volgiamoci alle fonti della nostra parola. Si parla di bartolismo
(bartolisme, bartholisme) in vari manuali di storia del diritto
pubblicati in Francia nei primi decenni del XIX secolo. Il più
risalente, e sicuramente il più influente, è l’ Histoire du droit
romain: suivie de l'histoire de Cujas di Jacques Berriat-Saint-Prix (1769-
1845)23. Questo manuale ebbe una diffusione europea:
successivamente alla pubblicazione a Parigi nel 1821 fu tradotto
in italiano da Giuseppe Del Re (1823) ed in tedesco da Ernst
Spangenberg (1823). Il suo autore fu una figura di spicco 23 JACQUES BERRIAT-SAINT-PRIX, Histoire du droit romain: suivie de l'histoire de Cujas, Paris, 1821,p. 582.
- 15 -
dell’Università (École de droit) di Parigi, della quale fu doyen
(marzo-ottobre 1845) e contribuì alla costruzione di quel
curriculum di studi giuridici che diede l’avvio al nuovo corso
dell’educazione giuridica che seguì alla codificazione del 1804.
La sua produzione toccò la procedura civile ed il diritto penale,
e fu particolarmente ampia nella storia del diritto che insegnò a
partire dal 182124. La sua Histoire mostra come la codificazione del
1804 spezzò una linea di continuità anche nella tradizione della
storiografia giuridica.
III. 2
Cerchiamo di comprendere il contesto in cui il manuale di
Berriat-Saint-Prix venne pubblicato. È fin troppo noto che la
promulgazione del Code Civil (1804) portò con sé una costellazione
di nuovi principi e metodi di interpretazione25. La premessa
fondamentale è che tutto il diritto si trova nella legge. Il
24 Un profilo biografico in M.A. TAILLANDIER, Notice sur la vie et les travaux de M. Berriat Saint-Prix, Paris, 1846.25 E. GAUDEMET, L’interprétation du code civil, Parigi, 2002, p. 58.
- 16 -
codice è il prototipo di una lex clara, tanto semplice e completa
da escludere ogni arbitrio giudiziale. Di fronte ad essa il
giudice è un interprete passivo. Egli deve ricercare la volontà
legislativa, ed il suo argomentare procede linearmente e
meccanicamente per sillogismi che connettono i fatti a norme
generali ed astratte, riaffermando ad ogni passo l’idea di una
legge che ha risposte per tutti i casi. Secondo la famosa
immagine di Montesquieu egli è la ‘bouche de la loi’26. Il mito
della lex clara elimina alla radice il problema
dell’interpretazione. Questo mondo parte da una ben definita
visione del fondamento del diritto e della sua elaborazione; come
tale esso espelle il giurista-interprete ed il suo armamentario
26 MONTESQUIEU, esprit des lois, p. I, l. XI, cap. 6: «Mais les juges de la nation nesont … que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui ne peuvent modérer ni la force, ni la rigueur». A ciò si accompagnano gli strumenti del sillogismo giudiziale: C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, §. IV: «In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev’essere la legge generale, la minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena» su cui recentemente v. D. MANTOVANI, Praetoris partes. La iurisdictio e i suoi vincoli nel processo formulare: un persorso di studi, inIl diritto fra scoperta e creazione, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Napoli, 2003, pp. 33-152. È forse il caso di notare che tale meccanismo decisionale apparteneva al bagaglio culturale del giurista cinquecentesco in riferimento all’applicazionedi una massima ad un caso concreto, risolto appunto per via sillogistica. Uno dei più diffusi manuali di insegnamento, la Introductio in dialecticam di Francisco Toledano, che insegnò al collegio Gesuita di Roma, riporta il seguente esempio: «omnis mater diligit filium, & haec est mater, ergo diligit filium», FRANCISCO TOLEDANO, Introductio in dialecticam, Roma, 1569, lib. 4, cap. 32, p. 162r.
- 17 -
dialettico27.
Questo complesso di principi trovò uno sbocco nel campo
dell’educazione giuridica. In perfetta sincronia con la
promulgazione del Code Civil (21 marzo 1804) un importante
intervento legislativo (l. 13 marzo 1804 = 22 ventôse anno XII)
introdusse una grande riforma dell’educazione giuridica28. Tale
legge riformò l'intero settore istituendo un nuovo sistema
educativo (gradualmente perfezionato) che creò Écoles de droit nelle
principali città della Francia. Esse erano ‘écoles
professionelles’ di stretta fedeltà monarchica e diretta
subordinazione al Ministero dell’Istruzione. Non si comprende
fino in fondo questo clima senza considerare che l’educazione
giuridica, indirizzata alla formazione dei funzionari dei quadri
burocratici, era costituita per una finalità ben precisa:
imparare il codice civile. Le Écoles de droit miravano ad uno studio
27 A. DUPIN, Manuel des étudiants en droit, Bruxelles, 1835, p. 65: «aujourd'hui elle [la glose] est tombée dans un discrédit total», ma gli esempi si potrebbero moltiplicare.28 Su questa evoluzione v. J.-L. HALPÉRIN, Un gouvernement de professeurs, réalité ou illusion? in Paris, capitale juridique (1804-1950), a cura di J.-L. HALPÉRIN, Paris, 2011, pp.45-88, PH. JESTAZ e CH. JAMIN, La doctrine, Paris, 2004, pp. 69-120, J. BONNECASE, Qu'est-ce que une faculté de droit? Paris, 1929, pp. 81-88, e J. IMBERT, L’enseignement du droit dans les Écoles centrales sous la Révolution, in Annales d’histoire des Facultés de droit, III (1986), pp. 37-56.
- 18 -
meccanico e contribuivano ad un’ideologia di legge ed ordine tale
da marginalizzare ogni originalità. In sostanza, esse erano la
cittadella dell’esegesi dei codici napoleonici.
Vale la pena di ripercorrere il tortuoso percorso che portò
la storia del diritto nel curriculum degli studi giuridici per
comprendere i compiti assegnati a questa disciplina29. Il
curriculum giuridico introdotto nel 1804 attribuì alla storia del
diritto un ruolo molto limitato e tale rimase per circa un
quindicennio. Voci di protesta si levarono per denunciare i
limiti di un approccio esclusivamente tecnico che suggeriva la
visione di un diritto libresco e retto da un meccanicismo
impersonale. Si manifestò un nuovo fervore storicista da cui
prese l’avvio la fondazione della rivista Thémis (pubblicata
negli anni 1819-1826) e vari lavori a sfondo storico e
filosofico30, i cui riflessi ultimi si colgono in una riforma
degli studi (24 marzo 1819) che introdusse cattedre di storia del
diritto, diritto amministrativo, diritto naturale ed economia
29 In particolare v. BERRIAT-SAINT-PRIX Discours sur l'enseignement du droit en France avant etdepuis la création des écoles actuelles, Paris, 1838, pp. 37-38.30 Tra cui A.J. LHERBETTE, Introduction a l'étude philosophique du droit, 1819, E. LERMINIER, Introduction générale a l'histoire du droit, 1829; H. KLIMRATH, Essai sur l’étude historique du droit et son utilité pour l’interprétation du code civil, 1833.
- 19 -
politica; a Parigi a Berriat-Saint-Prix e Blondeau venne affidato
un corso di storia del diritto nel 1821 (anno di pubblicazione
dell’Histoire di Berriat-Saint-Prix ). Pur se tale riforma ebbe
breve vita, a Parigi a partire dal 1829 l’insegnamento di storia
del diritto venne impartito senza interruzioni, ed ufficializzato
con l’istituzione di una cattedra di storia del diritto romano e
francese affidata a Eugène Lerminier31.
Quali furono i caratteri di fondo riscontrabili
nell’introduzione della storia del diritto? Se l’intera
educazione giuridica era funzionale al culto del Code Civil ed alle
sue concomitanti concezioni legaliste, a questo scopo non si
sottraeva la storia del diritto32. La introduzione di questa
disciplina era giustificata ai fini di una migliore conoscenza
del diritto moderno, ma in realtà si traduceva in una tecnica
ausiliaria per comprendere il codice: essa era finalizzata ad
affermarne l’autorità33. È importante sottolineare che le vicende
31 Sulle parallele vicende che portarono all’introduzione del diritto amministrativo, v. L. MANNORI e B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, Bari, 2001, pp. 277-291.32 J.-L. HALPÉRIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris 1996, p. 78 anche perla bibliografia, e J. –L. HALPÉRIN, L’histoire Du Droit Constituée En Discipline : Consécration Ou Repli Identitaire ? in Revue d’histoire des sciences humaines, IV, 1 (2001), pp. 9-32 a p. 16.33 HALPÉRIN, Histoire du droit privé cit. (n. 32), p. 72.
- 20 -
della storia del diritto in Francia, pur se sensibili alle
istanze storiciste di provenienza germanica, non furono legate da
un rapporto di diretta dipendenza con la scuola Savigniana. Il
compito che si poneva per lo storico francese era di persuadere
che il codice non fosse il frutto di un regime politico
particolare ma il prodotto storico della nazione34. Questo
carattere è riscontrabile nelle istanze di cui fu portavoce la
rivista Thémis. Se da una parte essa fu dedicata alla rinascita
degli studi romanistici in Francia, e come tale apparve un
importante canale di diffusione dello storicismo germanico, essa
non fu uno strumento passivo di tale fervore storicista: la
Thémis perseguiva un autonomo progetto intellettuale che non si
opponeva alla codificazione: essa esprimeva una scuola storica
francese35.
Al bagaglio culturale del giurista la storia non era
estranea, ma la sua presenza era condizionata da una visione che
la poneva come un progetto che si estende verso il futuro. In tal
modo la narrazione storica era inclinata ad assumere il carattere34 GAUDEMET, L’interprétation du code civil, cit, (n. 25), p 24-5)35 A questa conclusione giunge J. BONNECASE in La Thémis, Parigi,1914, v. anche PH.REMY, La Thémis et le droit naturel, in Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique,IV (1987), p. 145 e JESTAZ e JAMIN, La doctrine cit. (n. 28), pp. 96-101.
- 21 -
di una ottimistica evoluzione verso il moderno; esemplificata da
narrazioni storiche che disegnavano una evoluzione inarrestabile
che conduceva all’assolutismo monarchico oppure, come nel caso
che qui interessa, ad una successione di scuole di interpreti che
portano alla perfezione del diritto legislativo ottocentesco.
Come Berriat-Saint-Prix scrisse, nel medioevo si istruivano
processi anche contro i ratti36. Il punto di fondo è che
l’esistenza della storiografia non implica necessariamente una
coscienza della storicità del diritto.
III. 3
L’originalità dell’Histoire di Berriat-Saint-Prix si coglie dalla
distanza che la separa da opere precedenti37. Se lo scopo
didattico della historia juris non è un carattere distintivo
36 BERRIAT, Rapport et recherches sur les procès et jugements relatifs aux animaux, Paris, 1829. Di questa vicenda si occupa un noto lavoro di diritto comparato, teso a percorrere all’inverso l’argomento di Berriat per colmare il fossato metodologico scavato nel XIX secolo, William Ewald, Comparative jurisprudence (i): What was it like to try a rat? in University of Pennsylvania Law Review, 143, 6 (1995), p. 1889.37 Ho esaminato le seguenti opere: ANTOINE TERRASSON, Histoire de la jurisprudence romaine, Lyon, 1750, GIAN VINCENZO GRAVINA, De ortu et progressu iuris civilis, Napoli, 1701,JOHANN GOTTLIEB HEINECCIUS, Historia juris Romani, 1733; CLAUDE JOSEPH FERRIÈRE, Histoire du droit Romain, Parigi, 1783; JOHANNES SALOMON BRUNQUELL, Historia juris Romano-Germanici, Amsterdam, 1730, CHRISTIAN GOTTFRIED HOFFMANN, Historiae juris Romano-Justinianei, Lipsia, 1734.
- 22 -
dell’autore francese38, né l’affermazione di una conjunctio di jus ed
historia39, la sua specificità si coglie nel proporre una narrativa
che vede in Cuiacio e nella concomitante condanna del bartolismo
l’inizio di una nuova era del diritto.
È necessario sottolineare che sino al XVIII secolo ogni
historia juris conteneva una sezione dedicata alla descrizione delle
varie scuole giurisprudenziali, corrispondenti a differenti
approcci al testo romano, seguendo il modello dato dal par. 47
del famoso brano di Pomponio de origine juris (D. 1.2.2), un brano
che è stato il modello costitutivo per la maggior parte delle
trattazioni di storia del diritto pubblicate fino al XVIII
secolo40. Per esempio in un brano molto noto Giulio Pace parlava
38 Il lavoro di BRUNQUELL (n. 37) è scritto in usum auditorii; e quello di HEINECCIUS (n. 37) per studia juventutis. È opportuno richiamare l’attenzione sulla funzione dell’educazione giuridica nelle facoltà tedesche dell’Illuminismo, finalizzataa preparare i funzionari per i quadri burocratici dell’Impero Prussiano, su cui v. H. COING, L’insegnamento della giurisprudenza nell’epoca dell’Illuminismo, in L’educazionegiuridica, I. Profili storici, a cura di A. GIULIANI e N. PICARDI, Perugia, 1979, pp. 104-128.39 BRUNQUELL, Historia juris cit. (n. 37) per esempio inizia con una Praefatio dedicataa Boudoin a cui segue una dissertatio in cui annuncia una conjunctio di lingua, storia, antiquitates con la jurisprudentia; GRAVINA apre il suo lavoro con una Praefatioin cui esplicitamente dichiara di voler aprire le porte del diritto a storia elettere; ma tale presa di posizione non implica un giudizio su Bartolo, che anzi difende dalle critiche di Budeo, Duareno e Goveano, GRAVINA, De ortu et progressu cit., (n. 37) p 84.40 Devo quest’osservazione a G. CRIFÒ, Pomponius, liber singularis enchiridii D. 1.2.2 e la “storia del diritto”, in G. CRIFÒ, Materiali di storiografia romanistica, Torino, 1998, pp. 51-80, spec. 56-64, mettendo in evidenza la svolta impressa dal Lehrbuch der
- 23 -
di cinque scuole di interpreti, a partire dai glossatori sino al
suo tempo41. Ma in tale tradizione non si esprimevano giudizi di
condanna o di lode su tali scuole di interpreti. Tra gli autori
settecenteschi Gian Vincenzo Gravina (1664-1718) registra le
varie età della giurisprudenza antica e l’esistenza di quattro
scuole dopo il rinnovamento della giurisprudenza. Claude-Joseph
Ferrière (1680-1748) non parla di una rivalità tra scuole; il
carattere del mos italicus è dato da un mos studendi qualificato dal
famoso distico e della successione di ratio dubitandi e ratio
decidendi42. Il testo di Antoine Terrasson (1705-1782) contiene
accenti filo-bartoliani. Egli non solo non esprime un giudizio
negativo su Bartolo ma ne ricorda gli epiteti (Speculum, Lucerna
Juris, Magister, Pater, Lumen) e l’autorita dell’opinio Bartoli in Spagna,
aggiungendo: «Il s'en faut bien que les écrits de Bartole ayent
une si grande autorité en France. Ce proverbe François, résolu
comme Bartole, vient de ce que ce Jurisconsulte étoit ferme dans
ses sentiments, & les débitoit avec beaucoup d'assurance»43.
Geschichte des Römischen Rechts di GUSTAV HUGO (1790).41 GIULIO PACE, De iuris civilis difficultate ac docendi methodo, in NIKOLAUS REUSNER, Cynosura iuris, II, Spira, 1588, pp. 81-105.42 FERRIÈRE , Histoire cit. (n. 37), pp. 450-452.43 TERRASSON, Histoire cit. (n. 37), pp. 409-10.
- 24 -
Terrasson registra inoltre la stima goduta dalle sue opere in
Italia e Germania, notando che «ils l’ont été en France pendant
très long temps … j’ignore la raison pour laquelle ils y sont a
présent plus négligés qu’ils doivent être»44. Egli giudica «un
peu outré» il giudizio di Ferrière su Baldo, e senza battere
ciglio registra che Giovanni Nevizzano argomenta a favore del
matrimonio nei primi due libri della sua Sylva Nuptialis per poi
sostenere il contrario nei due libri successivi. In un testo
spesso citato, Johannes Hineccius (1681-1741) registra
l’ignoranza di filosofia e storia dimostrata da Bartolo e dalla
sua scuola, ma allo stesso tempo non manca di rilevare che il
loro stile interpretativo si impose nelle università Germaniche
del XV e XVI secolo. Egli sottolinea il nuovo splendore impresso
dalla scuola di Alciato e dai jureconsulti humaniores ma il punto
conclusivo del suo lavoro è una devastante critica dell’unione di
elegantiores litterae e diritto. Osserva come la continua derisione di
Giustiniano, la caccia alle antinomie e Tribonianismi non si è
risolta che in un danno per la costruzione di una più solida
giurisprudenza. Essi non sono «jureconsulti sed censores sine
44 FERRIÈRE, Histoire cit. (n. 37), p. 420.
- 25 -
populi suffragio creati». Come i critici descritti nella Tabula
di Cebes Thebanus (opera a contenuto moraleggiante ben conosciuta
sino al XVIII secolo) essi seguono le illusioni della Falsa
Erudizione.
Esaminiamo il testo di Berriat-Saint-Prix . La prima parte
del suo lavoro (Histoire du droit romain) è un esempio di storia
esterna: nel breve saggio introduttivo egli dichiara di voler
descrivere i fatti che determinano le norme, i corpora
legislativi, le opere principali ed i loro autori. Con questa
impostazione il diritto rimane una entità data e preesistente che
si muove nel tempo secondo leggi autonome; la sua indipendenza
dai fatti di cui si compone la storia esterna ne conferma anzi la
purezza. La storia così intesa è quindi ‘un commento alle leggi’.
Berriat-Saint-Prix dichiara di seguire la scia dei lavori
settecenteschi di Gravina, Heineccio, Brunquell, Hoffmann, Bach e
Pothier ma intende superarli in chiarezza e concisione: essi sono
inclini alla prolissità ed erudizione. Il suo lavoro punta alla
didattica, e vuole aiutare lo studente a trovare il filo rosso
per orientarsi tra le materie curricolari facendo di questa
materia una mera introduzione agli studi giuridici. Al neofita
- 26 -
intende offrire una mappa geografica dello scibile —
illustrandola «come i rami di una scienza». Coerentemente con la
natura legislativa del diritto Romano, la sua trattazione ne
descrive le sei fonti: leggi, actiones, editti del pretore,
responsi dei giureconsulti, decisioni dei pontefici, usi e
costumi. L’ultima fonte, in linea con le premesse, è menzionata
solo nel piano di lavoro e viene poi espunta dalla narrazione.
La seconda parte del suo lavoro è dedicata a Cuiacio. Questo
testo è stato la fonte di un autentico culto agiografico ed
ancora oggi è l’insuperato testo di riferimento sul grande
umanista francese45. Leggiamo che Cuiacio ebbe il merito di
ricomporre gl antici testi manipolati da Triboniano e di
restituirli alla loro originaria purezza. In questa puntigliosa
ricerca egli si mostrò come «l'incarnazione dell'esegesi», e fu
addirittura «più Romano dei Romani»46. Ma nel lievitare di questo
culto agiografico egli perviene ad una storia costruita su schemi
semplificati in cui il bartolismo e l’umanesimo non possono
essere esaminati autonomamente. L’essenza dell’umanesimo è data 45 Su questo lavoro SAVIGNY scrisse una Lettre à propos du livre de Berriat-Saint-Prix, in Thémis, ou Bibliothèque du jurisconsulte, IV (1822), pp. 193-207.46 LERMINIER, Introduction générale cit. (n. 30), p. 445 nota che «comme Cujas, il [Savigny] cherche et saisit le droit romain dans sa pureté native».
- 27 -
dalla vittoria sul bartolismo, quella del bartolismo di essere il
protagonista soccombente; da una parte Bartolo, dall’altra
l’anti-Bartolo, Cuiacio. A quest’ultimo fu conferito il destino
di iniziare il moderno corso della storia del diritto, chiudendo
definitivamente il medio evo gotico e la stagione dello
scolasticismo47. L’elemento propulsore di questa costruzione è il
mito codicistico di una legislazione senza interpretazione in cui
alla necessità di un testo legislativo chiaro corrisponde
l’urgenza di ricomporre nella sua purezza il testo romano. Questo
contesto fa di Cuiacio un eroe, e spiega il culto agiografico
che, iniziato alla fine del XVI secolo48, trova la più intensa
espressione nei manuali di storia del diritto ottocenteschi.
IV.
È giunto il momento di tirare le fila di questo discorso.
L’osservazione che il ‘bartolismo’ ha un’origine ottocentesca
potrebbe sembrare un mero dettaglio erudito, ma rivela importanti
47 DECOUS LEPEYRIÈRE, Discours sur Cujas, Paris, 1848, p. 4: «la destinée d’ouvrir les temps modernes».48 A partire da PAPIRE MASSON, Jacobi Cuiacii jurisconsulti vita, Parigi, 1590.
- 28 -
implicazioni quando ci volgiamo al contesto in cui tale termine
fa la sua comparsa. Di bartolismo si parla per la prima volta in
manuali di storia del diritto pubblicati in Francia nel XIX
secolo. Questi lavori determinano un nuovo corso della
storiografia giuridica, rompendo con la tradizione settecentesca
ancora legata al modello Pomponiano de origine juris, ed assorbono
l’ideologia codicistica di una legislazione senza
interpretazione. Essi costruiscono una narrativa storica in
termini semplificati: un medioevo da condannare ed un nuovo
inizio dato da Cuiacio. Il bartolismo, espressione
dell’armamentario dialettico-argomentativo del giurista-
interprete, diventa il bersaglio di una critica devastante. Tali
vicende ripropongono con chiarezza i rapporti complessi tra
teoria del diritto e storia del diritto e mostrano come la
storiografia giuridica non sia esente dal partire da premesse,
più o meno esplicite, riguardo una definizione di diritto e da
una visione delle sue fonti.
- 29 -
![Page 1: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Giuliani, A., "Una nota sul bartolismo," in: Proceedings of the conference on Bartolo da Sassoferrato. Nel VII centenario della nascita (2014) [forthcoming]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012517/631a7b50b41f9c8c6e0a373a/html5/thumbnails/29.jpg)






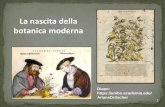









![La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312e0d5fc260b71020ed6a6/la-nascita-della-scienza-giuridica-in-lantichita-roma-a-cura-di-umberto-eco.jpg)




