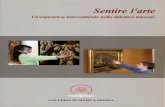La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., sat. 1.3.115-117
Frequenza, immaginabilità ed età di acquisizione delle parole: in che misura influenzano la...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Frequenza, immaginabilità ed età di acquisizione delle parole: in che misura influenzano la...
FREQUENZA, IMMAGINABILITÀ ED ETÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE:
IN CHE MISURA INFLUENZANO LA LETTURA
DEI BAMBINI ITALIANI?
Simone Mazzotta*, Laura Barca#^, Stefania Marcolini#°, Giacomo Stella+ e Cristina Burani#
* Istituto Santa Chiara, Lecce
# Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma
^ Università di Roma “La Sapienza”
° Università degli Studi di Trieste
+ Università degli Studi di Urbino
in stampa, Psicologia clinica dello sviluppo
Per corrispondenza: Cristina Burani Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR Viale Marx, 15 00137 Roma Italy phone (+39) 06-8609-0386 fax (+39) 06-824737 [email protected]
1
FREQUENZA, IMMAGINABILITÀ ED ETÀ DI ACQUISIZIONE DELLE PAROLE:
IN CHE MISURA INFLUENZANO LA LETTURA DEI BAMBINI ITALIANI?
Riassunto
In questa ricerca sono stati indagati gli effetti di frequenza, immaginabilità ed età di
acquisizione delle parole, sulla lettura dei bambini italiani di terza e quinta elementare, utilizzando
il compito di lettura ad alta voce di singole parole. I bambini di entrambi i livelli scolastici sono più
veloci ed accurati nella lettura di parole molto frequenti, e sono più rapidi con le parole apprese
prima. I bambini di terza elementare si mostrano maggiormente influenzati dall’età di acquisizione
rispetto a quelli di quinta. I bambini delle due classi sono altresì più veloci nella lettura di parole
molto immaginabili, ma soltanto quando poco frequenti. Questi risultati confermano che la lettura
lessicale è efficacemente utilizzata anche dai piccoli lettori di una ortografia trasparente, nella quale
però anche le variabili semantico-lessicali svolgono un ruolo più modesto ma significativo.
2
FREQUENCY, IMAGEABILITY AND AGE OF ACQUISITION OF WORDS:
HOW DO THEY AFFECT ITALIAN CHILDREN’S READING ALOUD?
Abstract
In this research, the effects of word frequency, imageability and age of acquisition, on
Italian children’s reading aloud, are investigated. Two groups of children in the 3rd and 5th grades
performed the task of single-word reading aloud. Children in both groups were faster when reading
aloud high-frequency words and early-acquired words. They were also more accurate in reading
aloud high-frequency words. Children in the 3rd grade were influenced more by age of acquisition
than children in the 5th grade. Children in both grades were also faster at reading aloud highly
imageable words, but only when they had low-frequency. These results confirm that lexical reading
aloud is successfully used by young readers of a shallow orthography. Lexical-semantic variables
have a smaller but significant role.
3
Introduzione
Tra le variabili lessicali e semantiche che si ritiene influiscano sui processi di lettura, la
frequenza scritta, l’immaginabilità e l’età di acquisizione delle parole figurano tra quelle
maggiormente esplorate (per una bibliografia ragionata si veda Barca, 2002). La frequenza può
essere definita come l’occorrenza di una parola nella lingua di una popolazione; l’immaginabilità
esprime la proprietà di una parola di evocare un’immagine mentale, una rappresentazione visiva o
altra esperienza sensoriale (Paivio, Yuille e Madigan, 1968); l’età di acquisizione, infine, indica
l’età alla quale una parola e il suo significato sono stati appresi per la prima volta in forma scritta
e/o parlata (Carroll e White, 1973). In diversi lavori sulla lettura di adulti di lingua inglese (lingua
ad ortografia irregolare o “profonda”), i contributi della frequenza e dell’età di acquisizione
appaiono rilevanti (Gerhand e Barry, 1998; Morrison e Ellis, 1995, 2000), mentre rimane dibattuto
quello dell’immaginabilità. Strain, Patterson e Seidenberg (1995) rilevano che le prestazioni di
lettura degli adulti normolettori esibiscono effetti di immaginabilità in interazione con la frequenza:
le parole con un alto valore di immaginabilità vengono lette più rapidamente e correttamente
rispetto a quelle con un basso valore di immaginabilità, ma solo quando sono parole poco frequenti
e irregolari. Strain e Herdman (1999) riscontrano effetti di immaginabilità anche per le parole
regolari di bassa frequenza, e trovano che l’immaginabilità influenza soprattutto le prestazioni dei
lettori meno abili. Shibahara, Zorzi, Hill, Wydell e Butterworth (2003) confermano i risultati di
Strain et al. (1995), mostrando la persistenza dell’effetto di immaginabilità anche quando l’età di
acquisizione, ad essa molto correlata, viene controllata. Di contro, Monaghan e Ellis (2002)
attribuiscono gli effetti che Strain et al. (1995) assegnano all’immaginabilità proprio all’età di
acquisizione, come sembrano indicare diversi studi (ad esempio Brown e Watson, 1987; Brysbaert,
Lange e Van Wijnendaele, 2000; Coltheart, Laxon e Keating, 1988; Gerhand e Barry, 1998;
Morrison e Ellis, 1995; 2000).
4
Gli studi sulla lettura dei bambini di lingua inglese confermano l’importanza della frequenza
della parola. In una ricerca condotta da Jorm (1977) sulla lettura di bambini da 8 a 10 anni, le parole
di alta frequenza risultavano più facili da leggere sia per i bambini “buoni lettori” che per i “cattivi
lettori”, mentre solo questi ultimi risultavano più accurati nella lettura di parole molto immaginabili
rispetto a quelle poco immaginabili (si veda anche Baddeley, Ellis, Miles e Lewis 1982). Risultati
simili sono stati ottenuti da V. Coltheart et al. (1988) con bambini di 10 anni, ma, analogamente a
quanto suggerito da Monaghan e Ellis (2002) per gli adulti, l’effetto di immaginabilità è stato
attribuito dalle autrici alla confusione con l’età di acquisizione: le parole molto immaginabili
verrebbero lette più accuratamente in quanto sono state anche acquisite prima.
Questi dati possono essere interpretati facendo riferimento a diversi modelli di riconoscimento
ed elaborazione di parole, tra i quali il più diffuso è il modello di lettura a due vie proposto da M.
Coltheart e collaboratori (Coltheart, Curtis, Atkins e Haller, 1993; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon
e Ziegler, 2001). Questo modello prevede una fase iniziale di analisi delle caratteristiche visive
dello stimolo, cui seguono due possibili processi di elaborazione: uno lessicale ed uno non lessicale
(o sublessicale). La via lessicale di lettura prevede un accesso alle rappresentazioni immagazzinate
nel lessico mentale, ed elabora la parola intera attraverso l’attivazione delle corrispondenti
rappresentazioni ortografica e fonologica. Queste rappresentazioni sono sensibili alla frequenza
degli stimoli, per cui le parole incontrate spesso in forma scritta necessitano di una minore
attivazione rispetto alle parole incontrate meno frequentemente. Tale via è utilizzata nella lettura di
parole conosciute e permette di leggere correttamente le parole irregolari, la cui pronuncia vìola le
regole di corrispondenza grafema-fonema di una data lingua (la cui applicazione porterebbe a
commettere degli errori). La via non lessicale non prevede invece accesso al lessico, ma utilizza un
processo di scomposizione analitica dello stimolo in singoli grafemi che vengono poi messi in
corrispondenza e riassemblati nei relativi fonemi. Si tratta quindi di un processo di analisi
sequenziale dello stimolo, che procede da sinistra verso destra (risultando quindi più lenta rispetto
alla via lessicale), e viene utilizzata principalmente nella lettura di parole nuove regolari, e di non-
5
parole (per le quali non ci sono informazioni immagazzinate in memoria). Entrambe le vie vengono
attivate in parallelo, e la probabilità che una delle due prevalga sull’altra dipende da vari fattori
quali il tipo di stimoli, la composizione della lista, l’abilità di lettura, o la lingua implicata.
In una lingua definita ad ortografia “profonda” come l’inglese, in cui esistono molte irregolarità
ed eccezioni nella corrispondenza tra forma ortografica e forma fonologica di una parola, la
possibilità di recuperare una rappresentazione ben consolidata della parola sembra essenziale, con
conseguenti ed attesi effetti di frequenza. L’italiano, al contrario, è una lingua ad ortografia
trasparente, che consente cioè la lettura corretta di tutte le parole (escludendo poche eccezioni, tra
cui le parole con accentazione sdrucciola) tramite l’applicazione di regole di corrispondenza
grafema-fonema, senza necessità di consultare il lessico mentale. Questo potrebbe, in linea di
principio, ridimensionare il ruolo della frequenza nella lettura di parole in italiano, e più in generale
nelle lingue ad ortografia trasparente o “superficiale”, come il tedesco, il turco e il serbo-croato
(Frost, Katz e Bentin, 1987; Monaghan e Ellis, 2002). Ciò nonostante, effetti lessicali emergono
nella lettura ad alta voce sia di adulti (Barca, Burani e Arduino, 2002; Bates, Burani, D’Amico e
Barca, 2001) che di bambini di lingua italiana, già a partire dalla seconda elementare. I bambini
italiani, infatti, mostrano un utilizzo precoce della lettura lessicale (Burani, Marcolini e Stella, 2002;
Marcolini e Burani, 2003), leggendo più velocemente le parole di alta rispetto a quelle di bassa
frequenza, ed essendo più rapidi e corretti nella lettura di parole rispetto a quella di non-parole
(Brizzolara, Chilosi, Cipriani e De Pasquale, 1994; Martini, Brizzolara, Pecini, Dinetti e Negrin,
2002; Maschietto e Vio, 1998; Tressoldi, 1996).
Immaginabilità ed età di acquisizione delle parole sembrano invece giocare un ruolo irrilevante
nella lettura degli adulti italiani (Barca et al., 2002; Bates et al., 2001), mentre influiscono
fortemente, e in una varietà di lingue compreso l’italiano, in compiti nei quali prevalgono processi
di tipo semantico, quali la denominazione di figure. In quest’ultimo compito, effetti di
immaginabilità e di età di acquisizione si riscontrano sia negli adulti (Bates et al., 2001; Bates et al.,
2003) che nei bambini (D’Amico, Devescovi, & Bates, 2001). Per l’italiano, non esistono invece
6
studi sistematici per l’età evolutiva riguardanti il contributo alla lettura delle variabili semantico-
lessicali (immaginabilità ed età di acquisizione).
Questa ricerca è stata progettata per colmare tale lacuna, con l’obiettivo di determinare in quale
misura le variabili di immaginabilità ed età di acquisizione, oltre che di frequenza, modulano i
processi di lettura in età scolare. Ipotizziamo che, rispetto all’inglese, l’immaginabilità delle parole
possa avere in italiano un ruolo ancora meno rilevante, data la trasparenza dell’ortografia. Inoltre se,
in modo simile a quanto ipotizzato per l’inglese, immaginabilità ed età di acquisizione delle parole
giocano un ruolo più rilevante nei casi in cui non si è ancora stabilito un legame efficiente ed
immediato fra rappresentazione ortografica e fonologica della parola, ci si può aspettare un ruolo
più rilevante di queste variabili nei bambini più piccoli e/o nella lettura di parole poco frequenti.
Tali variabili potrebbero risultare utili anche in ambito clinico (si veda anche Tressoldi, 1996).
Da un lato sarebbe importante verificare se le proprietà semantico-lessicali delle parole e la loro
frequenza di utilizzo sono altrettanto rilevanti nei bambini italiani che incontrano difficoltà di
lettura, dall’altro, qualora questi effetti fossero verificati, i dati ricavati da uno studio che cerca di
isolare in modo più accurato le diverse variabili, potrebbero anche essere utilizzati per la
predisposizione di materiali per la rieducazione. A tutt’oggi, i bambini italiani vengono rieducati
senza alcuna attenzione agli effetti di facilitazione di natura semantico-lessicale.
Nel primo esperimento, abbiamo studiato in che modo la frequenza nello scritto infantile e il
valore d’immagine delle parole influenzano la velocità e l’accuratezza di lettura ad alta voce dei
bambini italiani, utilizzando quattro liste di parole variate ortogonalmente per le variabili prese in
esame. Sulla base di precedenti ricerche condotte con bambini italiani (Burani, et al., 2002;
Marcolini e Burani, 2003), ipotizziamo che, anche in questo studio, le parole di alta frequenza
verranno lette più velocemente ed accuratamente di quelle di bassa frequenza. Inoltre, se
l’immaginabilità influenza velocità e correttezza di lettura prevalentemente nei casi di minore
efficienza e automatizzazione del processo di lettura, se ne potranno rilevare effetti maggiori nella
lettura di parole poco frequenti e/o dei bambini più piccoli.
7
Nel secondo esperimento, abbiamo esaminato in che misura l’età alla quale una parola viene
appresa influenza la lettura ad alta voce dei bambini in età scolare, utilizzando due liste di parole
variate per età di acquisizione. Le uniche ricerche disponibili sugli effetti di questa variabile nel
caso di lettori di lingua italiana sono state condotte con adulti (Barca et al., 2002; Bates et al.,
2001), e da queste emerge un ruolo molto modesto dell’età di acquisizione. Non avendo indicazioni
riguardo alle prestazioni di bambini italiani, prendiamo a riferimento lavori condotti con bambini
normolettori di lingua inglese (Coltheart, et al., 1988), nei quali l’età di acquisizione sembra avere
un ruolo maggiore rispetto agli adulti. Un quadro analogo potrebbe emergere anche per la lingua
italiana. In tal caso, ipotizziamo che i bambini italiani potrebbero leggere in maniera più veloce e/o
accurata le parole apprese precocemente nel corso della loro vita.
Esperimento 1
Metodo
Partecipanti
La ricerca è stata condotta in due scuole elementari della provincia di Lecce. Attraverso la prova
“lettura di parole isolate” di Sartori, Job e Tressoldi (1995), sono stati selezionati 67 bambini
normolettori, 18 maschi e 16 femmine di terza elementare, e 18 maschi e 15 femmine di quinta
elementare, la cui velocità di lettura era compresa all’interno di una deviazione standard sopra o
sotto la media del campione normativo di riferimento. La prova è stata svolta individualmente, in
un’aula libera e tranquilla appositamente designata, e sono stati misurati i tempi di inizio (onset)
della lettura e gli errori commessi.
8
Materiali
Le parole sono state estratte dal database di Burani, Barca e Arduino (2001a), disponibile sul sito
http://www.istc.rm.cnr.it/material/database. Sono state costruite quattro liste sperimentali, di 25
parole ciascuna, variate ortogonalmente per immaginabilità1 e frequenza nello scritto infantile
(tratta dal “Lessico Elementare” di Marconi, Ott, Pesenti, Ratti, e Tavella, 1993). Le liste sono così
costituite: i) parole molto frequenti e immaginabili (ad es. “fata”); ii) parole molto frequenti e poco
immaginabili (ad es. “tipo”); iii) parole poco frequenti molto immaginabili (ad es. “pala”); iv)
parole poco frequenti e poco immaginabili (ad es. “fama”). Gli stimoli sono pareggiati fra le liste
per le seguenti caratteristiche: struttura sillabica, lunghezza media in lettere, fonemi e sillabe,
numero dei vicini ortografici (numero di parole ortograficamente simili ad una parola data, ottenuto
sostituendo una lettera per volta nella parola, si veda Coltheart, Davelaar, Jonasson, e Besner,
1977), tipo di accentazione (piana o sdrucciola), e tipo di fonema iniziale (Balota e Chumbley,
1985). Data l’elevata correlazione che sia immaginabilità che frequenza intrattengono con l’età di
acquisizione delle parole (in questa selezione di parole, rispettivamente -.55 e -.66), non e’ stato
possibile pareggiare i set di items secondo questa dimensione, in particolare le parole molto
frequenti nello scritto risultano essere anche acquisite presto e viceversa (nella sezione “analisi dei
dati” verrà descritto come si è tenuto conto della variabile età di acquisizione e della sua possibile
interazione con frequenza ed immaginabilità). Nella Tabella 1 sono riportate le statistiche
descrittive (media e deviazione standard) relative alle variabili psicolinguistiche caratterizzanti le
parole dei diversi set sperimentali.
1 I valori di immaginabilità sono stati ottenuti da Burani et al. (2001a) mediante somministrazione di questionari a studenti universitari di madrelingua italiana, cui veniva chiesto di esprimere il giudizio sulla parola utilizzando una scala a sette punti, da 1) “poco immaginabile” a 7) “molto immaginabile” (per una descrizione dettagliata della metodologia utlizzata si vedano Barca et al., 2002, e Burani et al., 2001a). Si potrebbe obiettare che il valore di immagine calcolato sugli adulti non corrisponda a quello attribuito dai bambini. A nostra conoscenza, esiste per l’italiano un solo studio che ha ottenuto valori di immaginabilità mediante giudizi forniti da bambini di 10 anni (Cornoldi e Pra Baldi, 1978). Purtroppo le parole in comune fra i nostri studi e quello di Cornoldi e Pra Baldi non sono molte. Un’analisi correlazionale condotta sugli items comuni ha comunque mostrato una rassicurante elevata correlazione fra i giudizi forniti dagli adulti e quelli dei bambini (r = .79 considerando i 75 nomi in comune fra Burani et al., 2001 e Cornoldi e Pra Baldi; r = .83 considerando le 12 parole in comune fra il presente studio e quello di Cornoldi e Pra Baldi).
9
Infine, per ogni lista è stato bilanciato il numero degli items con frequenza = 0, e quello delle
difficoltà ortografiche contenute nelle parole, cosicché risulta pareggiato il numero delle doppie e
quello delle lettere C e G, per la corretta pronuncia delle quali è necessario considerare le lettere che
seguono (si veda Barca, Burani e Ellis, 2003).
– Inserire Tabella 1 circa qui –
Apparato
È stato utilizzato un computer con il supporto del software SuperLab Pro 2.0 (Cedrus 2002); i
tempi di reazione (corrispondenti all’inizio della pronuncia della parola) sono stati rilevati mediante
un microfono connesso ad un dispositivo ad attivazione vocale (voice key). Le parole erano
presentate in stampatello maiuscolo con font Arial 23, e venivano presentate al centro dello
schermo, bianche su sfondo nero. Gli stimoli sono stati presentati in ordine casuale all’interno di 6
blocchi. L’ordine di presentazione dei blocchi era variato per ogni partecipante.
Procedura
Ogni partecipante è stato testato singolarmente in una stanza quieta. Ai bambini veniva chiesto di
leggere il più velocemente ed accuratamente possibile le parole che comparivano sullo schermo del
computer, e venivano familiarizzati con il compito mediante una sessione di pratica, composta da
10 stimoli. La sequenza sperimentale prevedeva la presentazione di un punto di fissazione (+) che
restava al centro dello schermo per 500 ms., seguito da un intervallo (300 ms.), e sostituito poi dalla
parola target che rimaneva visibile fino a che non veniva data la risposta, per un tempo massimo di
3000 ms. Tra una sequenza e l’altra vi era un intervallo di 1200 ms. Al termine di ciascun blocco
10
era prevista una pausa, a discrezione del bambino. Ogni sessione sperimentale durava
complessivamente circa 20 minuti.
Analisi dei dati
I tempi inferiori a 250 ms. sono stati considerati dati persi (missing data), e quindi eliminati. Si è
poi fatta distinzione tra gli stimoli che erano letti correttamente ma che non avevano attivato il voice
key (per esempio, a motivo della voce troppo bassa del bambino) e quelli che invece non venivano
letti, considerando osservazioni mancanti i primi, e non-risposte i secondi. Queste ultime sono state
aggiunte al computo degli errori veri e propri, vale a dire la sostituzione di fonemi (es.: buca
anziché nuca), gli errori di accento (es.: òrtica anziché ortìca) e le false partenze (quando il
bambino inizia a leggere la parola, interrompe la lettura, e poi legge correttamente, ad es.: bu-
bugia).
I risultati, tempi di reazione e percentuali di errori, sono stati sottoposti ad analisi della varianza
(ANOVA) a tre vie (classe x frequenza x immaginabilità). Per tenere conto sia della variabilità fra i
partecipanti che della variabilità fra le parole sperimentali, sono state effettuate due distinte analisi
della varianza, una per partecipanti ed una per items. L’utilizzo di entrambe le ANOVA, per
partecipanti e per items, rappresenta una procedura sperimentale più conservativa e da tempo
condivisa (si veda Clark, 1973).
Inoltre, essendo la variabile età di acquisizione correlata sia alla frequenza che
all’immaginabilità, è stata condotta una analisi della covarianza (ANCOVA) al fine di considerare
possibili interazioni tra la covariata età di acquisizione ed i fattori oggetto di studio.
Nella Figura 1 sono riportate le medie dei tempi di reazione (a) e le percentuali di errori (b) per
ciascuna delle due classi, 3^ e 5^ elementare.
– Inserire Figura 1 circa qui –
11
Risultati e discussione
L’ANOVA sui tempi di reazione mostra effetti principali significativi: classe (F1(1, 65) = 23.31,
p < .0001, MSE = 151679.1; F2(1, 95) = 475.77, p < .0001, MSE = 5603.42), frequenza (F1(1, 65) =
74.06, p < .0001, MSE = 9320.2; F2(1, 95) = 13.91, p < .001, MSE = 48561.63), ed immaginabilità,
significativa solo nell’analisi per partecipanti (F1(1, 65) = 5.85, p < .05, MSE = 3499.8; F2 < 1).
Significative sono anche le interazioni frequenza x classe (solo per items: F1(1, 65) = 2.21, p > .1,
MSE = 9320.2; F2(1, 95) = 3.93, p = .05, MSE = 5603.42), e frequenza x immaginabilità (solo per
partecipanti: F1(1, 65) = 3.67, p < .06, MSE = 3284.7; F2 < 1). Dall’analisi post-hoc (test di Duncan)
condotta sulle medie per items emerge che entrambe le classi mostrano un vantaggio nella lettura di
parole frequenti (p < .001). Seguendo la procedura descritta in Cohen (1977), è stata condotta
un’analisi più approfondita dell’interazione classe x frequenza, dalla quale risulta che l’ampiezza
dell’effetto frequenza è rilevante in ugual misura in entrambe le classi ( d = .73 sia per la terza che
per la quinta elementare). Inoltre, le parole molto immaginabili sono lette più velocemente di quelle
poco immaginabili, ma solo quando sono di bassa frequenza (p < .003).
Quando nell’analisi per items viene introdotta l’età di acquisizione come covariata scompare
l’effetto principale di frequenza (F2 < 1) mentre restano invariati l’effetto classe (F2(1, 95) = 475.77,
p < .0001, MSE = 5603.42) e l’interazione frequenza x classe (F2(1, 95) = 3.93, p = .05, MSE =
5603.42), con effetto significativo della frequenza per entrambe le classi (p < .0001).
L’ANOVA sugli errori esibisce un effetto principale del fattore classe (F1(1, 65) = 34.18, p <
.0001, MSE = .08; F2(1, 95) = 63.02, p < .0001, MSE = 4.69), e della frequenza (F1(1, 65) = 131.49,
p < .0001, MSE = .04; F2(1, 95) = 27.86, p < .0001, MSE = 18.31), mentre l’immaginabilità non è
significativa (F1(1, 65) = 2.36, p > .1, MSE = .02; F2 < 1). E’ risultata significativa l’interazione
classe x frequenza (F1(1, 65) = 18.16, p < .001, MSE = .04; F2(1, 95) = 17.14, p < .001, MSE =
4.69), con la frequenza significativa al post-hoc per entrambe le classi (p < .0001). L’ampiezza
12
dell’effetto frequenza (Cohen, 1977), calcolata per ciascuna classe, mostra che i bambini sono
largamente più corretti quando devono leggere parole di alta frequenza, e questo vale soprattutto per
i bambini di terza elementare (rispettivamente d = .94 e d = .70 per le classi terza e quinta
elementare). E’ significativa anche l’interazione classe x immaginabilità (ma solo per partecipanti:
F1(1, 65) = 4.06, p < .05, MSE = .02; F2 (1, 95) = 1.9, p > .1, MSE = 4.69). Quando l’età di
acquisizione viene inclusa nell’analisi come covariata, l’immaginabilità resta solo marginalmente
significativa (F2 (1, 95) = 3.82, p = .05, MSE = 17.30) e il contributo della frequenza viene
ridimensionato pur rimanendo significativo (F2(1, 95) = 4.92, p < .05, MSE = 17.30). Restano
invece invariati l’effetto della classe (F2(1, 95) = 63.02, p < .0001, MSE = 4.69) e l’interazione
frequenza x classe (F2(1, 95) = 17.14, p < .0001, MSE = 4.69), con effetto della frequenza per
entrambe le classi (p < .0001).
L’effetto della frequenza sulla velocità e sull’accuratezza, riscontrato in tutte le analisi, indica
che questo fattore influenza in maniera notevole la lettura dei bambini sia di terza che di quinta
elementare. L’immaginabilità sembra fornire un debole ma significativo contributo ai tempi di
reazione, mostrando che questa variabile semantica giocherebbe un ruolo, anche se modesto, nella
lettura dei bambini delle elementari. L’interazione frequenza x immaginabilità sembra accreditare
l’ipotesi secondo cui la lettura dei bambini si avvantaggia dell’immaginabilità solo nel caso delle
parole poco frequenti.
Per quanto riguarda i dati emersi dall’ANCOVA, il fatto che l’ingresso nell’analisi della
variabile età di acquisizione determini la scomparsa dell’effetto frequenza, nel caso dei tempi di
reazione, o il suo ridimensionamento, per quanto riguarda gli errori, non fa che confermare le
perplessità iniziali sulla confusione di queste due variabili. Alcuni studi condotti con adulti di lingua
inglese, infatti, non erano riusciti a rilevare effetti di frequenza indipendenti dall’età di acquisizione
(Morrison e Ellis, 1995), sebbene altri invece avessero evidenziato effetti distinti (Morrison e Ellis,
2000) o additivi indipendenti (Gerhand e Barry, 1998) per ciascuna delle due variabili. Un’analoga
possibile confusione tra frequenza ed età di acquisizione è suggerita anche da studi condotti con
13
adulti di lingua italiana, che rilevano una forte correlazione tra queste due variabili (Barca et al.,
2002; Burani et al., 2001a).
Obiettivo del secondo esperimento, quindi, e’ stato di indagare il ruolo dell’età di acquisizione
nella lettura dei bambini. A tal fine si sono utlizzate liste di parole variate per età di acquisizione e
bilanciate secondo altre dimensioni lessicali e sublessicali.
Esperimento 2
Metodo
Partecipanti
Hanno preso parte a questo esperimento gli stessi bambini selezionati per l’esperimento
precedente.
Materiali
Sono state utilizzate due liste di 39 parole ciascuna, tratte da Burani, Barca e Arduino (2001b),
variate per età di acquisizione2 (parole acquisite prima vs parole acquisite dopo) e controllate per le
stesse variabili della precedente batteria. Nella Tabella 2 sono riportate le statistiche descrittive
(media e deviazione standard) relative alle variabili psicolinguistiche caratterizzanti le parole dei
due set sperimentali.
2 I valori di età di acquisizione sono stati ottenuti mediante somministrazione di questionari a studenti universitari di madrelingua italiana, cui era chiesto di indicare l’eta’ alla quale una parola ed il suo significato sono stati appresi in forma parlato o in forma scritta (per una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata si vedano Barca et al., 2002, e Burani et al., 2001a). Anche in questo caso viene discusso quanto i valori di età di acquisizione ricavati dagli adulti corrispondano a misure più “oggettive” ricavate direttamente dai bambini. Molti studi hanno mostrato che i valori di età di acquisizione ricavati direttamente dai bambini correlano altamente con le stime ottenute dagli adulti (si veda Rinaldi, Barca e Burani, 2004).
14
– Inserire Tabella 2 circa qui –
Apparato e procedura
Apparato e procedura sono gli stessi impiegati nell’esperimento 1.
Analisi dei dati
Dopo aver trattato i dati e classificato gli errori seguendo la stessa metodologia impiegata nel
primo esperimento, tempi di reazione e percentuali di errori sono stati sottoposti ad analisi della
varianza (ANOVA) a due vie (classe x età di acquisizione). Per le stesse ragioni indicate nella
descrizione dell’esperimento 1, si è deciso di condurre sia ANOVA per partecipanti che per itemsi.
Nella Figura 2 sono riportate le medie dei tempi di reazione (a) e le percentuali di errori (b) relative
alle due liste di parole, per ciascuna delle due classi (3^ e 5^).
– Inserire Figura 2 circa qui –
Risultati e discussione
L’ANOVA sui tempi di reazione mostra un effetto principale della classe (F1(1, 65) = 30.71, p <
.0001, MSE = 75879.24; F2(1, 76) = 593.76, p < .0001, MSE = 4918.57) e dell’età di acquisizione,
quest’ultimo statisticamente significativo solo nell’analisi per partecipanti (F1(1, 65) = 14.35, p <
.001, MSE = 2344.58; F2(1, 76) <1). Emerge inoltre, sebbene solo nell’analisi per partecipanti, una
interazione significativa classe x età di acquisizione (F1(1, 65) = 4.85, p < .05, MSE = 2344.58;
F2(1, 76) <1). L’analisi post-hoc mostra che le parole acquisite prima vengono lette più
15
velocemente delle parole acquisite tardi, ma solamente dai bambini di 3^ (p < .001; per la 5^
elementare, p>.1).
L’ANOVA sugli errori esibisce un quadro simile, con un effetto principale della classe (F1(1, 65)
= 31.85, p < .0001, MSE = 6.75; F2(1, 76) = 74.28, p < .0001, MSE = 4.3) e un’interazione classe x
età di acquisizione, limitatamente all’analisi per partecipanti (F1(1, 65) = 4.77, p < .05, MSE = 3.08;
F2(1, 76) = 2.89, p < .1, MSE = 4.29). L’età di acquisizione è significativa al post-hoc solo per i
bambini di 5^ (p < .05), i quali commettono un maggior numero di errori quando leggono le parole
acquisite prima.
L’effetto dell’età di acquisizione sulla velocità di lettura dei bambini sembra assegnare a questa
variabile un ruolo più rilevante rispetto alle prestazioni degli adulti. L’interazione classe x età di
acquisizione che si riscontra nel presente esperimento di lettura, mostra che l’effetto di età di
acquisizione sulla velocità di lettura, è statisticamente significativo solo per i bambini di terza.
Possiamo dunque ritenere che il contributo dell’età di acquisizione si riduca progressivamente man
mano che si consolida l’apprendimento di lettura e scrittura, fino a scomparire in età adulta.
Discussione generale
Nel primo degli esperimenti qui riportati, la frequenza della parola influisce sia sull’accuratezza
che sulla velocità di lettura dei bambini, confermando risultati precedentemente osservati sia su
bambini (Brizzolara et al., 1994; Burani et al., 2002; Marcolini e Burani, 2003; Martini et al., 2002;
Maschietto e Vio, 1998; Tressoldi, 1996) che su adulti italiani (Barca et al., 2002; Bates et al.,
2001). Questo risultato smentirebbe l’idea che ipotizza gli effetti della frequenza ridotti o addirittura
inesistenti per quelle lingue che hanno corrispondenze ortografico-fonologiche regolari, come
l’italiano (Frost et al., 1987; Monaghan e Ellis, 2002). Al contrario, tali effetti suggeriscono che la
16
lettura lessicale sia disponibile e relativamente efficiente già nei bambini di terza e di quinta
elementare.
Di un certo interesse è il modesto effetto dell’immaginabilità che risulta influenzare
significativamente la velocità di lettura dei bambini solo per le parole di bassa frequenza. Queste
parole sono state incontrate e lette poche volte dai bambini e presumibilmente le loro
rappresentazioni ortografiche presentano connessioni dirette poco consolidate (quindi poco
efficienti) con le rispettive rappresentazioni fonologiche. In questo caso, la possibilità di formarsi
più facilmente una immagine mentale del referente della parola faciliterebbe il recupero della sua
forma fonologica. Le parole di alta frequenza, invece, per le quali esiste una buona connessione
diretta fra rappresentazione ortografica e fonologica, non beneficerebbero di un contributo
aggiuntivo dell’immaginabilità della parola stessa. Questi risultati sono coerenti con quanto
riportato da Strain et al. (1995) e da Shibahara et al. (2003) su adulti di lingua inglese, per i quali
l’immaginabilità sembra modulare la codifica fonologica quando sono deboli le connessioni tra le
rappresentazioni ortografica e fonologica di una parola, ossia nel caso di parole irregolari di bassa
frequenza; ne estendono tuttavia il contributo, come fanno anche Strain e Herdman (1999), alle
parole regolari di bassa frequenza. Inoltre, gli effetti di immaginabilità sulle prestazioni dei bambini
e la loro assenza su quelle degli adulti (Barca et al., 2002; Bates et al., 2001; Burani et al., 2001b),
confermano indirettamente quanto riportato da Strain e Herdman (1999) a proposito della relazione
tra immaginabilità ed abilità di codifica fonologica, e quindi il ruolo prevalente dell’immaginabilità,
se non addirittura esclusivo, nei lettori meno abili.
L’età di acquisizione, introdotta nell’analisi del primo esperimento come covariata, ha
ridimensionato il ruolo della frequenza, come del resto prevedibile, essendo le due variabili
altamente correlate (Barca et al., 2002; Bates et al., 2001; Burani et al., 2001a; 2001b). Il secondo
esperimento qui riportato, che indaga specificamente il ruolo dell’età di acquisizione, mostra come
questa variabile influenzi le latenze nella lettura. Questo risultato concorda con la letteratura sulle
prestazioni di normolettori adulti (Morrison e Ellis, 1995; 2000) e di bambini (Coltheart et al.,
17
1988) di lingua inglese, disattendendo parzialmente le aspettative di Monaghan e Ellis (2002) sulla
marginalità dell’effetto di età di acquisizione in lingue ad ortografia regolare. Infatti, sebbene l’età
di acquisizione sembri giocare un ruolo irrilevante nel caso degli adulti italiani (Barca et al., 2002;
Bates et al., 2001; Burani et al., 2001b), le prestazioni dei bambini rivelano un quadro abbastanza
diverso, esibendo effetti di età di acquisizione sulla velocità di lettura. È plausibile ritenere che, nel
caso di ortografie regolari come l’italiano, gli effetti dell’età di acquisizione si affievoliscano con il
tempo, man mano che le connessioni tra le rappresentazioni ortografica e fonologica delle parole si
consolidano con l’esperienza e con l’esercizio della lettura, fino a quasi dissolversi nell’età adulta.
Di questo andamento si possono cogliere indizi non solo attraverso il confronto tra le prestazioni dei
bambini riportate in questa ricerca e quelle degli adulti presenti in letteratura, ma anche analizzando
le differenze tra le stesse due classi prese in esame in questo studio: i bambini di terza, lettori meno
abili, ne risultano infatti maggiormente influenzati rispetto ai bambini di quinta, lettori più abili.
I dati rilevati e le precedenti considerazioni possono essere facilmente accordati con il modello
di lettura a due vie descritto nell’introduzione (Dual-Route Cascade (DRC) Model nella versione
computazionale di Coltheart et al., 2001). Per quanto riguarda l’effetto frequenza, quando la parola
da leggere è regolare, come la maggioranza delle parole italiane, la via lessicale e quella
sublessicale attivano la stessa sequenza di fonemi, cosicché la parola viene letta velocemente ed
efficientemente. Se poi la parola è di alta frequenza, e quindi è stata incontrata molte volte in forma
scritta, le connessioni tra il lessico ortografico di ingresso e quello fonologico di uscita saranno
maggiormente consolidate e risulteranno più efficienti nel produrre la risposta in tempi più rapidi
rispetto alla via non lessicale.
Il modello DRC potrebbe in linea di principio rendere conto (sebbene non lo faccia
effettivamente nella sua implementazione computazionale, per cui si veda Monaghan e Ellis, 2002)
anche degli effetti di immaginabilità e di età di acquisizione, dal momento che prevede un sistema
semantico in relazione sia col sistema ortografico che con quello fonologico, estendendo così la via
lessicale diretta. L’immaginabilità risulta infatti avere un ruolo limitato alle parole di bassa
18
frequenza o irregolari, in cui il legame tra rappresentazione ortografica e fonologica è debole. In
questi casi in cui la via lessicale è più lenta, l’attivazione delle informazioni semantiche
permetterebbe di velocizzare il processo di lettura. L’effetto di età di acquisizione, ancor più di
quello di immaginabilità, sembra in relazione alle abilità di lettura dei partecipanti (essendo
significativo solo per i lettori meno abili). Si può dunque pensare che le parole acquisite prima
abbiano rappresentazioni più stabili rispetto alle parole acquisite dopo (Ellis e Lambon Ralph,
2000), il che porterebbe ad una loro più rapida e corretta elaborazione. Con il progredire delle
abilità di lettura e a seguito dell’automatizzazione del processo di lettura (quindi in adulti e bambini
più grandi), altri fattori (quali, ad esempio, la frequenza scritta della parola) risulterebbero invece
essere più rilevanti.
Questo lavoro, oltre a contribuire all’indagine sul ruolo delle variabili semantico-lessicali nella
lettura dei bambini in età evolutiva, suggerisce alcune applicazioni in ambito clinico. I materiali
utilizzati nell’esperimento 1, contrastano aspetti di frequenza e immaginabilità delle parole, in
condizioni in cui sono calibrate una serie di variabili psicolinguistiche rilevanti nel compito di
lettura. Queste liste possono quindi essere utilizzate come strumento di approfondimento
diagnostico, per rilevare aspetti di lettura lessicale e/o semantico-lessicale nei bambini con dislessia
evolutiva. Potrebbero inoltre essere utilizzati per costruire liste di apprendimento per bambini con
dislessia in grado di compensare meglio e in modo graduale le difficoltà di accesso al lessico
presenti in questi bambini. Attualmente, i materiali sono in corso di standardizzazione con bambini
normo-lettori di scuola elementare, come prova di lettura presentata cartaceamente. Anche la prova
di “Lettura di parola isolate” della batteria Sartori, Job e Tressoldi (1985) intende stimare il ruolo
delle caratteristiche di frequenza e immaginabilità delle parole nei processi di lettura. Utilizzando
tale batteria, è stato osservato che già dalla 2^ elementare la familiarità con la parola, influenzata
dalla frequenza d’uso, favorisce una lettura più veloce ed accurata (Tressoldi, 1996). Tuttavia, i
valori di frequenza delle parole nella prova di Sartori e coll. (1985) sono ricavati da un lessico
scritto relativo a lettori adulti, mentre i materiali della presente ricerca hanno una frequenza ottenuta
19
dal lessico scritto infantile (Marconi e coll., 1993). Inoltre, i materiali della nostra ricerca sono
bilanciati, nei diversi gruppi, per svariate caratteristiche psicolinguistiche che possono influire sulla
prestazione. Infine, l’inserimento dei valori di età di acquisizione permette di valutare, anche a
livello clinico, il ruolo di tale variabile. Per questi motivi si può indicare che, per la valutazione
sistematica di aspetti lessicali e semantici nella lettura dei bambini, sia auspicabile l’utilizzo di
nuovi materiali più controllati per diverse caratteristiche psicolinguistiche.
20
Riferimenti bibliografici
Baddeley, A.D., Ellis, N.C., Miles, T.R., Lewis, V.J. (1982). Developmental and acquired dyslexia:
A comparison. Cognition, 11, 185-199.
Balota, D.A., Chumbley, J.I. (1985). The locus of word-frequency effects in the pronunciation task:
Lexical access and/or production? Journal of Memory and Language, 24, 89-106.
Barca, L. (2002). Lessico e ortografia nella lettura ad alta voce di adulti e bambini di lingue diverse.
Età evolutiva, 73, 118-128.
Barca, L., Burani, C., Arduino, L.S. (2002). Word naming times and psycholinguistic norms for
Italian nouns. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 34, 424-434.
Barca, L., Burani, C., Ellis, A.W. (2003). Context-sensitive rules and word naming in Italian. XIII
Conference of the European Society for Cognitive Psychology. Granada, 17-20 settembre, 2003.
Bates, E., Burani, C., D’Amico, S., Barca, L. (2001). Word reading and picture naming in Italian.
Memory and Cognition, 29, 986-999.
Bates, E., D’Amico, S., Jacobsen, T., Szekely, A., Andonova, E., Devescovi, A., Herron, D., Lu, C-
C., Pechmann, T., Pleh, C., Wicha, N.Y.Y., Federmeier, K.D., Gerdjikova, I., Gutierrez, G.,
Hung, D., Hsu, J., Iyer, G., Kohnert, K., Mehotcheva, T., Orozco-Figueroa, A., Tzeng, A., Tzeng,
O. (2003). Timed picture naming in seven languages. Psychonomic Bulletin & Review, 10, 344–
380.
Brizzolara, D., Chilosi, A.M., Cipriani, P., De Pasquale, L. (1994). L’apprendimento del linguaggio
scritto in bambini con difficoltà di linguaggio orale: continuità o discontinuità? In G. Masi, A.
Martini (a cura di), Apprendimento e patologia neuropsichica nei primi anni di scuola, 124-135.
Roma: Borla.
Brown, G.D.A., Watson, F.L. (1987). First in, first out: word learning age and spoken word
frequency as predictors of familiarity and word naming latency. Memory and Cognition, 15, 208-
216.
21
Brysbaert, M., Lange, M., van Wijnendaele, I. (2000). The effects of age-of-acquisition and
frequency-of-occurrence in visual word recognition: Further evidence from the Dutch language.
European Journal of Cognitive Psychology, 12, 65-85.
Burani, C., Barca, L., Arduino, L.S. (2001a). Una base di dati sui valori di età di acquisizione,
frequenza, familiarità, immaginabilità, concretezza, e altre variabili lessicali e sublessicali per 626
nomi semplici dell’italiano. Giornale Italiano di Psicologia, 4, 839-854.
Burani, C., Barca, L., Arduino, L.S. (2001b). Frequency in the child written lexicon and adult word
naming time. XII Conference of the European Society for Cognitive Psychology. Edinburgh, 5-8
settembre, 2001.
Burani, C., Marcolini, S., Stella, G. (2002). How early does morpholexical reading develop in
readers of a shallow orthography? Brain and Language, 81, 568-586.
Carroll, J.B., White, M.N. (1973). Word frequency and age of acquisition as determiners of picture-
naming latency. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 25, 85-95.
Clark, H.H. (1973). The language as-fixed-effect fallacy: A critique of language statistics in
psychological research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 12, 335-359.
Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences (Rev. ed.). New York:
Academic Press.
Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-Route
models of reading. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance,
20, 1197-1211.
Coltheart M., Davelaar E., Jonasson J.T., Besner D. (1977). Access to the internal lexicon. In S.
Dornic (a cura di) Attention and performance, 6, 535-555. London: Academic press.
Coltheart, M., Rastle, K., Perry, C., Langdon, R., Ziegler, J. (2001). DRC: A dual route cascaded
model of visual word recognition and reading aloud. Psychological Review, 108, 204-256.
Coltheart, V., Laxon, V.J., Keating, C. (1988). Effects of word imageability and age of acquisition
on children’s reading. British Journal of Psychology, 79, 1-12.
22
Cornoldi, C., Pra Baldi, A. (1978). Il valore di immagine nei bambini: norme per 257 nomi e usi
nella ricerca applicata. Formazione e Cambiamento, 3, 275-295.
D’Amico, S., Devescovi, A., Bates, E. (2001). Picture naming and lexical access in italian children
and adults. Journal of Cognitive Development, 2, 71-105.
Ellis, A.W., Lambon Ralph, M.A. (2000). Age of acquisition effects in adult lexical processing
reflect loss of plasticity in maturing systems: Insights from connectionist networks. Journal of
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 26, 1103-1123.
Frost, R., Katz, L., Bentin, S. (1987). Strategies for visual word recognition and orthographical
depth: A multilingual comparison. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and
Performance, 13, 104-115.
Gerhand, S, Barry, C. (1998). Word frequency effects in oral reading are not merely age of
acquisition effects in disguise. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and
Cognition, 24, 267-283.
Jorm, A.F. (1977). Effect of word imagery on reading performance as a function of reader ability.
Journal of Educational Psychology, 1, 46-54.
Marcolini, S., Burani, C. (2003). Sviluppo della lettura morfo-lessicale in una lingua a ortografia
regolare. In G.T. Scalisi, M. Orsolini, C. Maronato (a cura di), Bambini in difficoltà
nell’apprendimento della lingua scritta, 24-38. Roma: Edizioni Kappa.
Marconi, L., Ott, M., Pesenti, E., Ratti, D., Tavella, M. (1993). Lessico Elementare. Dati statistici
sull'italiano letto e scritto dai bambini delle elementari. Bologna: Zanichelli
Martini, A., Brizzolara, D., Pecini, C., Dinetti, D., Negrin, E. (2002). Aspetti diagnostici e
riabilitativi in bambini dislessici italiani. In I. Arcolini, G. Zardini (a cura di), I disturbi di
apprendimento della lettura e della scrittura, 223-235. Milano: Angeli.
Maschietto, D., Vio, C. (1998). Acquisizione delle competenze alfabetiche ed ortografiche di lettura
e di scrittura: proposte per un modello evolutivo. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 2, 51-66.
23
Monaghan, J., Ellis, A.W. (2002). What exactly interacts with spelling-sound consistency in word
naming? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 28, 183-206.
Morrison, C.M., Ellis, A.W. (1995). Roles of word frequency and age of acquisition in word naming
and lexical decision. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 21,
116-133.
Morrison, C.M., Ellis, A.W. (2000). Real age of acquisition effects in word naming and lexical
decision. British Journal of Psychology, 91, 167-180.
Paivio, A., Yuille, J.C., Madigan, S.A. (1968). Concreteness, imagery, and meaningfulness values
for 925 nouns. Journal of Experimental Psychology Monograph Supplement, 71, 1-9.
Rinaldi, P., Barca, L., Burani, C. (2004).Caratteristiche semantiche, grammaticali e di frequenza
delle parole del “primo vocabolario del bambino”. Psicologia clinica dello sviluppo, 8, 119-143.
Sartori, G., Job, R., Tressoldi, P.E. (1995). Batteria per la valutazione della dislessia e disortografia
evolutiva. Firenze: O.S.
Shibahara, N., Zorzi, M., Hill, M.P., Wydell, T., Butterworth, B. (2003). Semantic effects in word
naming: Evidence from English and Japanese Kanji. The Quarterly Journal of Experimental
Psychology, 56A, 263-286.
Strain, E., Herdman, C.M. (1999). Imageability effects in word naming: An individual differences
analysis. Canadian Journal of Experimental Psychology, 53, 347-359.
Strain, E., Patterson, K., Seidenberg, M.S. (1995). Semantic effects in single-word naming. Journal
of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 21, 1140-1054.
Tressoldi, P.E. (1996). L’evoluzione della lettura e della scrittura dalla II elementare alla III media.
Età Evolutiva, 37, 43-55.
24
Ringraziamenti
Questo lavoro è stato realizzato nell’ambito del Progetto MIUR-COFIN 2002115744-008.
Ringraziamo l’editor di PCS, Cesare Cornoldi, e due revisori anonimi per gli utili commenti su una
versione precedente del manoscritto.
25
Tabella 1. Statistiche descrittive relative alle variabili caratterizzanti le parole appartenenti ai quattro set sperimentali. Esperimento 1
Freq Imm EA Lett Fon Sill Vic
AF/AI media 147,9 5,5 2,8 5,8 5,6 2,6 1,4 d.s. 158,3 0,8 0,7 1,7 1,6 0,8 2,1
AF/BI media 154,7 3,3 3,9 5,8 5,6 2,6 1,4 d.s. 149,7 0,6 1 1,7 1,5 0,8 1,6
BF/AI media 9,6 5,5 4,3 5,8 5,6 2,6 1,4 d.s. 9,8 0,5 0,8 1,7 1,6 0,8 1,8
BF/BI media 7,0 3,3 5,4 5,8 5,5 2,6 1,4 d.s. 8,1 0,5 0,7 1,8 1,8 0,8 1,8
Nota: AF/AI: alta frequenza/alta immaginabilità; AF/BI: alta frequenza/bassa immaginabilità;
BF/AI: bassa frequenza/alta immaginabilità; BF/BI: bassa frequenza/bassa immaginabilità; Freq:
frequenza nello scritto; Imm: immaginabilità; EA: eta’ di acquisizione; Lett: lunghezza in lettere;
Fon: lunghezza in fonemi; Sill: lunghezza in sillabe; Vic: numero di vicini ortografici.
26
Tab. 2. Statistiche descrittive relative alle variabili caratterizzanti le parole appartenenti ai due set sperimentali. Esperimento 2.
EA Freq Imm Lett Fon Sill Vic
AP media 2,8 33,3 5,3 6,0 5,6 2,6 1,3 d.s. 0,4 27,4 0,8 1,4 1,3 0,6 2,2
AD media 4,5 25,5 4,9 6,2 5,8 2,6 1,3 d.s. 0,4 28,5 0,7 1,5 1,3 0,6 1,9
Legenda: AP: parole acquisite prima; AD: parole acquisite dopo; EA: eta’ di acquisizione; Freq:
frequenza nello scritto; Imm: immaginabilità; Lett: lunghezza in lettere; Fon: lunghezza in
fonemi; Sill: lunghezza in sillabe; Vic: numero di vicini ortografici.
27
Figura 1. Esperimento 1: frequenza x immaginabilità
a) Media dei tempi di reazione
700
800
900
1000
1100
1200
terza quintaCLASSE
TEM
PI D
I REA
ZIO
NE
BF/AI
BF/BI
AF/AI
AF/BI
AF/AI
AF/BI
Legenda: AF/AI: alta frequenza/alta immaginabilità; AF/BI: alta frequenza/bassa immaginabilità;
BF/AI: bassa frequenza/alta immaginabilità; BF/BI: bassa frequenza/bassa immaginabilità.
b) Percentuale di errori
0
5
10
15
20
25
terza quintaCLASSE
% E
RRO
RI BF/AI
BF/BI
28
Figura 2. Esperimento 2: parole acquisite prima vs parole acquisite dopo
a) Media dei tempi di reazione
700
800
900
1000
1100
1200
terza quinta
CLASSE
TEM
PI D
I REA
ZIO
NE
A P
A D
Legenda: AP: parole acquisite prima; AD: parole acquisite dopo
b) Percentuale di errori
0
5
10
15
20
terza quintaCLASSE
% E
RR
OR
I
A P
A D
29