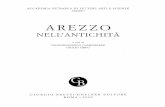Il riuso delle fortificazioni medievali: il caso di Gravina in Puglia (Italia)
Fortificazioni medioevali e poteri nel territorio comunale di Badia Tedalda (Arezzo)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Fortificazioni medioevali e poteri nel territorio comunale di Badia Tedalda (Arezzo)
131
Simone De Fraja
FortiFicazioni medioevali e poteri nel territorio comunale di Badia tedalda1
Considerazioni preliminari: il contesto storico e geografico
dai primi anni del secolo Xiii si trovava ad operare sul territorio segnato dal primo tratto del marecchia, l’abbazia dei tedaldi, derivata dalla fusione di due preceden-
ti monasteri. Tappa fondamentale per l’oculato progetto di recupero di terre e fortificazioni mes-
so in atto dell’abate tedalgrado per lo sviluppo dell’abbazia medesima e l’esplicazione della propria signoria2, fu una pronuncia di Simone paltrinieri cardinale presbitero del titolo di San martino. tale lodo fu emesso il 3 giugno 1267, a causa di una insorta lite confinaria tra l’Abbazia, che rivendicava i propri territori, e Guido ed Ugo di Carpegna,
1. Nelle more di stampa di questo contributo è purtroppo improvvisamente scomparso il caro Ingegner Dino Palloni, riminese, profondo conoscitore del medioevo e dei castelli. A Dino questo lavoro dedico con amicizia.
Questo contributo costituisce una sintesi del ben più ampio studio che dal 2007 sta giungendo in dirittura di arrivo. da tempo la pro loco di Badia tedalda ha chiesto di riportare alla memoria le vicende storiche del Badiale con particolare riferimento alle strutture fortificate ancora esistenti, ovvero ai ruderi delle stesse, affinché divenissero fruibili anche mediante un progetto di rivalorizzazione materiale e documentale.
La proposta di studio, ha intuito il valore storico e scientifico di molte realtà quasi scomparse, il valore della memoria storica e la potenziale fruibilità per il pubblico delle stesse in un equilibrato connubio tra territorio e storia, tra paesaggio e uomo, tra naturale ed artificiale.
In questa sede è necessario tuttavia tener conto dello spazio a disposizione e quindi è altresì necessario procedere ad una sintesi ed una selezione dei siti oggetto di indagine offrendo, sostanzialmente, una panoramica storica e materiale dell’eredità medioevale presente nel comune di Badia Tedalda. Da tale confine convenzionale, entro cui la ricerca si è svolta è necessario talvolta prescindere per la comprensione delle vicende ben più ampie in cui il territorio si è trovato coinvolto.
Si sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: paSQui, Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo, a cura di U. Pasqui, voll. I-IV, Arezzo-Firenze, Bellotti-Sinatti-Vieusseux, 1899-1937 (I: Arezzo-Firenze, Vieusseux-Bellotti, 1899; II: Arezzo, Bellotti, 1916; III: Firenze-Arezzo, Regia Deputazione di Storia Patria-Sinatti, 1937; IV (“Appendice”): Arezzo, Bellotti, 1904); POTITO, A. Potito, Badia Tedalda e i suoi castelli nei secoli, Rimini 1985; DIPLOMATICO C., Codice diplomatico dei conti di Carpegna (secoli XII-XIV) a cura di S. Cambrini e T. di Carpegna Falconieri, “Studi montefeltrani” - Fonti 3, San Leo 2007; REPETTI, E. rePetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze, Tofani, Allegrini e Mazzoni, 1833-1846; “Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze” [=AMAP]; “Notizie di Storia” [=Nds]; ASF - BF, archivio di Stato di Firenze, fondo S. Maria della Badia detta Badia Fiorentina;
2. a. Czortek, La signoria dell’abate Tedalgrado in alta Valmarecchia, in “Studi montefeltrani”, 20 (1999), San Leo 1999
132
Simone De Fraja
Ranieri dell’Ancisa nonché i signori di Monte Domito che “per quello che mi è stato detto è vicino a Mon della Breve dove adesso non sono più habitationi, ma si vede solo le rovine delle case ci sono state”3. la pronuncia riconosce all’abbazia un ampio ter-ritorio corrispondente all’estremità occidentale della Massa Trabaria il cui limite est si snoda dal “castrum Caraggi” (oggi Villa Carigi)4 lungo il marecchia sino a Stiavola e che, attraverso monterano, giunge sino all’alpe della luna. ad ovest il lodo sancisce come riferimenti la zona di Frassineto e la direttrice che da palombatoio5, giunge al monte Arduino (presso Poggio val d’Abeto) non lontano dal Monte Loggio; i limiti nord e sud dell’area di pertinenza dell’Abbazia coincidono con quelli della Massa Trabaria. Una versione volgare del lodo annota che il confine stabilito “pigliando il suo principio dalla via di piano di rogna, incominciando nel mezzo della marechia, venendo per decta via di piano di rogna insino alla chiusura di Santo pietro, et dalla decta via per una semita et via da venire insino alla casa de claudi, intrando per decta semita nel rio de canali, et venendo dal decto rio per la via de Schiavola insino al palazo di valdicuia, et salendo per la ripa insino alla sommità di Monte Rano, et da Monte Rano per la serra insino a monte maggiore et da indi insino al monte della luna et da indi per la serra insino al monte di Frassineto, et da indi insino al palombatorio, et per la forma insino a casa di lupardi, et per dieta forma insino a casa di lupardelli, et dalla decta casa ascendendo insino al monte delli albuini venendo per la forma’ al monte del nastello, et da indi per la serra insino al monte de Loccio venendo per la forma sì come acqua descende nella marechia da dua parti verso al castello di Sancto pietro et il castello di caragi et venendo per la Marechia incominciando da Piano de Rogna”6.
3. DiPLomatiCo C., p. 68.4. In località Sodacci di Villa Cariggi, lungo l’itinerario di mezzacosta che da Rofelle conduceva a Gattara,
tra la vegetazione sono stati individuati cumuli di pietre e materiali lapidei di crollo probabilmente riferibili ad una struttura turriforme. Più in basso, a quota 508 s.l.m., presso il vocabolo Villa Carigi o Cariggi, insiste una struttura turriforme a pianta quadrangolare con lato circa metri 4,80; l’aspetto formale evidenzia più fasi di intervento facendo apparire il manufatto collocabile tra il tardo secolo XIII e la fine del secolo XIV. nei pressi esisteva inoltre la chiesa di San martino di cariggi. per tali siti si vedano le schede in Archeologia del Paesaggio nel territorio di Casteldelci, Montefeltro. Atlante dei siti medievali dell’alta e media vallata del Senatello, a cura di A. L. Ermeti e D. Sacco, Pesaro 2007, pp. 74-75.
5. Tra il Sasso di Cocchiola e San Patrignano esiste un’area nella cartografia attuale denominata “Palombatoio”; tuttavia in una carta del secolo XVI pubblicata in C. ViVoLi, Il disegno della Valtiberina, mostra di cartografia storica (secoli XVI-XIX), Anghiari-Sansepolcro ottobre 1992-gennaio 1993, Rimini 1992, un rilievo orografico posto lungo la catena dell’Alpe della Luna, ma prima del Passo di “Fraxinetum”, è indicato come “Palombatoio”. Nella medesima carta acquerellata è presente anche il Monte Arduino localizzabile alle spalle di montebotolino presso l’attuale poggio val d’abeto.
6. a. Czortek, La signoria dell’abate Tedalgrado in alta Valmarecchia, cit., fornisce la versione in volgare del paltrinieri con alcune differenze, cita e. agnoLetti, Viaggio per le valli alto tiberine toscane, Città di Castello 1980, pp. 328-329, (ASF, Corporazioni religiose soppresse del governo francese, 78, 152, c. 118rv). DiPLomatiCo C., doc. 49, 1267 giugno 3, “confinia hec sunt videlicet: incipiendo principium via per Pian di Rogna in medio Marecchie veniendo per dictam viam di Pian di Rogna usque ad clausuram Sancti Petri, et a dicta via per quandam semitam veniendo usque ad domum Gidorum intrando per dictam semitam in rivo de Canali et veniendo a dicto rivo per viam di Stiavole usque ad palatium di Valdicuia et ascendendo per ripam usque ad sumitatem Montisrani et a Monterano per serra usque ad montem Maiorem et abinde usque ad montem della Luna, et abinde per senam usque ad montem de Frassineta et abinde usque ad Palombatorium et per formam usque ad serra Poggi veniendo per formam usque ad domum Lupardorum, et per dictam viam
133
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
Le vicende storiche delle fortificazioni presenti nell’attuale comune di Badia Tedalda (Fig. 1) risultano intimamente connesse alle vicende della Abbazia dei Tedaldi; benché non siano esclusivamente oggetto di atti giuridici a cui presero parte i vari abati per la gestione dei beni, i riferimenti alle fortificazioni assumono rilievo e divengono frequenti specialmente negli anni in cui l’abate tedalgrado avviò il programma di riorganizzazione dei possessi dell’abbazia ed il recupero di beni usurpati ovvero durante l’abbaziato del successore abate niccolò. alcuni siti vengono inoltre in rilievo in relazione alle contro-versie scaturite con i comuni confinanti con la Massa Trabaria di cui il Badiale andava a costituire l’estremità occidentale maggiormente esposta agli attriti confinari con il comune di Arezzo e di Città di Castello. Altri siti ancora appaiono nominati nelle carte come termini geo-referenzianti fondamentali nell’individuazione di confini e terre. Tut-tavia, alcune fortificazioni rimangono più emarginate rispetto al fulcro rovente che nel secolo XIII si snoda principalmente lungo il primo tratto del Marecchia; ciò è forse in primo luogo dovuto alla posizione periferica, rispetto all’Abbazia, nonché alla posizione confinaria con i possessi vantati da potenti famiglie locali, risultando quindi difficilmen-te controllabili da parte dell’abbazia medesima.
Le fortificazioni medioevali nel territorio
Di particolare interesse, poiché la documentazione scritta sembra tacere al riguardo, sono i resti della fortificazione posta sul Poggio della Regina a quota 1.043 s.l.m. A meno di voler supporre che tale postazione sia annotata nelle carte con altra deno-minazione, peraltro allo stato ignota, solo il toponimo ed i cumuli di pietre sulla vetta artificialmente modellata in più punti documentano la presenza di una fortificazione. Il sito tuttavia sorgeva nei pressi di uno snodo di itinerario di crinale che, verso nord-est, toccava Montefortino e quindi Sestino; non lontano dal Poggio della Regina un ulteriore itinerario montano, attraverso il passo di Montelabreve, sede di altra fortificazione, met-teva in contatto la valle dell’Auro, la zona di Borgo Pace ed il Biturgense. Sul “Poggio” gli esigui lacerti murari, principalmente ammassi di pietre sciolte che si adattano alle forme tagliate nella roccia della sommità, conservano tuttavia anche alcuni avanzi di opera muraria, apparentemente non legata, costituita essenzialmente da lastre di pietra. Il toponimo, inoltre, pare fare probabile riferimento ad una viabilità di certa importanza, forse una “via regina”; non è da escludere, comunque, nell’impossibilità di una prova unidirezionale, un riferimento toponomastico7 che cautamente permetta di formulare
usque ad domum Lupardelli, et a dicta domo ascendendo usque ad montem Albuini, veniendo per formam ad montem Nastelli et abinde per serram usque ad montem della Faggeta, et abinde usque ad montem Arduinum, et abinde usque ad montem Locii veniendo per formam sicut aqua descendit in Amaricula a duabus partibus vers castri Sancti Petri et castri Caraggii o et veniendo super Amaricula usque ad principium fluminis quod mittit in Amariculam incipendo a Pian di Rogna”. Tali confini sono ben individuabili attraverso le località riportate nella carta in ViVoLi, Il disegno della Valtiberina, cit., tavv. viii e iX.
7. a. FatuCChi, Un capolavoro di scultura inedito tra Tuscia e Romania, in “AMAP”, LIII (1991), p. 49; a. FatuCChi, Premesse e connessioni altomedievali degli insediamenti benedettini tra Tuscia e Romania, in I Benedettini nella Massa Trabaria, Sestino, 6 settembre 1980, Sansepolcro 1982.
134
Simone De Fraja
ipotesi, anche sulla scorta della vetustà materiale dell’insediamento, ed essere ricondotto ad altri toponimi similari quali, “Prato della Regina” nonché “Termine della Regina”.
Una delle più antiche citazioni relative a sito di fortificazione, nel Badiale, è relativa a montefortino8 (“ad Monfortinum”) tuttavia citato nel 1223 unicamente quale termine confinario nell’atto di vendita intervenuto tra Guido di Miratoio ed i conti di Carpegna Ugo e Rainerio; il conoide roccioso sul quale giacciono i resti del sito fortificato, il cui toponimo rinvia proprio alle opere murarie fortificatorie9, conserva tracce di una cinta in muratura che, realizzata in blocchi e lastre di arenaria di piccole e medie dimensioni con scarso legante, segue il profilo orografico. A sud-ovest una fossa, forse artificialmente accentuata ed utilizzata anche nell’ultimo conflitto mondiale, separa il rilievo dal circo-stante declivio. ciò che rimane della cinta, in molti casi tratti della fondazione, presenta nel fronte ovest e sud-ovest una leggera scarpatura, posta in essere anche per motivi di staticità della costruzione, per la quale è possibile ipotizzare una ristrutturazione basso-medioevale così come per alcuni tratti del complesso10. I lacerti murari affiorano soltanto per alcune decine di centimetri conservandosi, tuttavia, parzialmente interrati come lun-go il fronte nord-est: parte delle pendici del rilievo e tutta la cima sono invase da rovi e pruni cosicché una accurata ispezione risulta attualmente impraticabile (Figg. 2, 3).
Le fortificazioni di Cicognaia e Santa Sofia di Marecchia, oggi nell’enclave ammini-strativo del comune di Badia tedalda presentano una buona documentazione materiale (rispetto alle altre fortificazioni del Badiale) ed una continuità abitativa, soprattutto nel caso di Cicognaia. Qui la civiltà rurale e contadina ha mantenuto sino all’ultimo conflitto mondiale, senza operare eccessive alterazioni, l’utilizzo delle strutture che, particolar-mente nel caso di Santa Sofia, risultano tuttavia abbandonate da periodi precedenti. En-trambi i siti fortificati, aggettanti sulla valle del sottostante Marecchia e dotati di ottima visuale, erano corroborati dalla presenza di torre cilindrica che presso Santa Sofia, il cui toponimo potrebbe costituire riferimento ad una fase altomedievale dell’insediamento, si mantiene in pessime condizioni statiche e per scarso elevato; tale complesso difen-sivo conserva elementi costruttivi che possono indurre ad ipotesi di ammodernamenti diacronici in funzione del mutare delle esigenze difensive e realizzati, dunque, median-te ristrutturazione del perimetro murario nonché mediante conservazione di parte di strutture precedenti (Figg. 4, 5). Di Cicognaia non sussistono notizie scritte anteriori
8. DiPLomatiCo C., doc. 15, 1223, gennaio 31. 9. rePetti, ad vocem, “Fu Monte Fortino uno dei feudi de’conti di Montedoglio, sebbene contrastato
dagli abati della Badia Tedalda, ai quali ultimi, venne rivendicato, mercé un lodo del 1277 [leggasi 1267]. nel secolo Xiv monte Fortino trovavasi annoverato fra i castelletti dell’appennino e della massa trabaria stati concessi in feudo dall’imperatore Lodovico il Bavaro a Neri figlio di Uguccione della Faggiuola”. Il documento menzionato dal repetti, tuttavia non menziona montefortino la cui citazione più antica risale, quale termine confinario, ad un atto del 1223; cfr. DiPLomatiCo C., doc. 15, 1223, gennaio 31.
10. Una eventuale ristrutturazione della fortificazione, così come per altre strutture della zona, può essere ascritta al secolo XIV allorché questa parte di Appennino entrò a far parte dei possessi dei Faggiolani sostenitori dell’Imperatore Arrigo VII (di Lucimburgo). La tradizione individua i ruderi come appartenenti alla “Rocca di Arrigo VII di Lucimburgo”.
135
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
alla “Descrizione” del 135611 ove il sito appare annoverato nella forma “Cicegnace” unitamente a Santa Sofia, Gattara e Miratoio (Fig. 6).
la torre cilindrica di cicognaia, realizzata mediante corsi lapidei che vedono l’in-serimento di grossi blocchi cubici per la regolarizzazione del filare, pare piena e priva dell’accesso sopraelevato a meno di supporlo ad una quota particolarmente elevata ed ormai perduto. Le esigue dimensioni della torre e l’apparente vetustà fanno pensare ad una torre con semplice funzione di avvistamento, una sorta di coffa12 per l’avvista-mento. La torre cilindrica di Santa Sofia di Marecchia ( Fig. 18), di minor circonferenza rispetto a quella di Cicognaia, ha una superficie interna libera di circa metri 1,80 con spessore murario di poco inferiore e realizzato a sacco con paramento in pietre spaccate di medie dimensioni.
è comunque dalla metà del secolo XIII che i documenti cominciano a fornire mag-giori informazioni utili per la costruzione, più organica, di una panoramica relativa alle fortificazioni.
Un documento contenente patti di concordia (9 novembre 1257)13 attesta l’esistenza consolidata di alcuni insediamenti, anche fortificati con le loro pertinenze e aggregati minori da essi dipendenti. Otto località della Massa Trabaria occidentale, sostanzialmen-te coincidente con il Badiale, in forza del trattato intervenuto tra il comune di arezzo ed i Massani, dovevano dunque essere restituite al detto comune mediante la reintegrazione di “possessionem et quasi infrascriptarum terrarum, scilicet castri Abbatie Tedaldi, Cokiole, sancti Pa-terniani, Fresciane, Caprilis, Arsicci, Montisbottolini, Roselle (sic) et villarum et curiarum earundem manualiter”. Un atto successivo di qualche anno (21 febbraio 1264)14, pur non trattandosi di formale atto di sottomissione, palesa che, di fatto, i Rofellani, promettendo fedeltà a domenico leti da cocchiola, si rimettono all’abbazia dei tedaldi impegnandosi a difenderne i diritti. da tale promessa scaturisce una serie di obblighi non soltanto in fa-vore dell’Abbazia ma anche al comune ed università dei castelli della medesima Abbazia di cui il citato Domenico era sindaco. Alcune delle località rivendicate anni prima dagli aretini entrano nell’egida del monastero dei tedaldi ed il complesso di castelli dell’ab-bazia appare costituito, in quest’ anno, oltreché dalla medesima Abbazia fortificata dei Tedaldi – ovvero il già nominato “Castrum Abbatie” luogo di espressione ed amministra-zione della giustizia nonché centro di emanazione del potere di banno del dominus castri e quindi, in questo caso, dell’abate – dal “castrum Sancti Paterniani, castrum Cuchiolis, castrum Caprili”. Di alcuni di essi, in contrasto con una documentazione scritta di un certo spes-sore e peso quantitativo, rimangono poche tracce materiali, come nel caso di Fresciano, lentamente eroso dalle frane, o come nel caso di rofelle più volte interessato da devasta-
11. a. theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, Roma 1862, t. II, doc. CCCXXV, p. 33912. D. PaLLoni - g. rimonDini, Castelli e fortificazioni, in Il Montefeltro, vol. 2, Ambiente, storia, arte nell’alta
Valmarecchia, a cura di G. Allegretti e F. V. Lombardi, Macerata Feltria 1997, p. 286; inoltre si veda F. V. LombarDi, Le torri del Montefeltro e della Massa Trabaria, Rimini 1981.
13. PaSQui II, doc. 605.14. Potito, cit., p. 20; Czortek, La signoria dell’abate Tedalgrado, cit. pp. 12-13, l’autore analizza il
rapporto giuridico che, mercé tale atto, si è instaurato tra gli uomini di Rofelle e l’Abbazia dei Tedaldi.
136
Simone De Fraja
zioni militari e smottamenti del terreno. Altre fortificazioni sono rimaste interessate da processi di ristrutturazione con conseguente modifica delle forme castellane cosicché si è persa l’identità della “domus sive palatium et turrim positam et fundatam in castro et poggio Mon-tis Bottolini”15 sebbene l’attuale nucleo abitativo sviluppatosi attorno alla chiesa e la domi-nante posizione del rilievo orografico sopra cui si erge lascino intuire, se non certamente le forme castellane, almeno l’area della antica fortificazione. Anche l’aggregato di San patrignano16, connotato dalle rustiche volumetrie, evidenzia frazionate fasi di sviluppo nonché una evidente separazione tra l’abitato aperto e il modesto rilievo, noto come “il Castellaccio” ove si trovava l’antica chiesa ed il ricetto difensivo probabilmente protetto da semplici dispositivi difensivi non esclusi interventi in muratura tutt’oggi da riscoprire. Sebbene attraverso differenti percorsi genetici, il “castrum” medioevale comincia a figurare nelle aree rurali e montane verso i secoli IX e X obbedendo ad una variegata gamma di interessi particolari, destinazioni e funzioni, per iniziativa di indipendenti poteri laici, od ecclesiastici, piuttosto che seguendo una linea precisa che solo un potere unitario avrebbe potuto prevedere e pianificare. Non si esclude, ovviamente, in tale pro-cesso, una ristrutturazione di situazioni preesistenti, nonché l’impianto di postazioni od insediamenti fortificati i quali, nel corso del tempo e mediante una visione diacronica, possono suggerire un utilizzo simultaneo da parte di un unico proprietario relativo ad affermato lignaggio.
pur nella piena cognizione di una generale incompletezza documentale per il Ba-diale, si assiste ad una tarda certificazione di realtà qualificata come “castrum”, riferibile, mediamente, alla seconda metà del secolo XIII. Una presenza dunque avanzata nel tempo rispetto alla media delle fortificazioni della Massa Trabaria delle quali si ha noti-zia dalla prima metà, o comunque dalla metà, del secolo XI17 in cui i documenti larga-mente menzionano la formula “curtis cum castro” ovvero “castrum et eius curtis”. Analoga situazione, riferibile alla metà del secolo XI, si verifica anche per le fortificazioni dei dintorni di arezzo e, ad esempio, nella valle del torrente cerfone, ponte tra arezzo e la valtiberina18. Rispetto alle attestazioni delle fortificazioni del Badiale, quelle relative al “castrum Montis Bettolini et villam de Rufello et castrum Frisciana et eius curtem”19 risalgono gli anni Trenta del secolo XIII (24 ottobre 1232) figurando dunque tra le citazioni più antiche delle fortificazioni presenti nell’alta valle del Marecchia.
15. ASF - BF, 1290, settembre, 8. Inoltre Potito, cit., p. 24.16. per San patrignano ed in particolare per la vita rurale del luogo m. t. toCCi - a. SantuCCi, Testimonianze
di ruralità montana, Badia tedalda 2001.17. F. V. LombarDi, Gli insediamenti castellani medievali nella Massa Trabaria, in La montagna tra Toscana e
Marche. Ambiente, territorio, cultura, società dal medioevo al XIX secolo, Atti del convegno (Sestino-Badia Tedalda, 1982), a cura di S. Anselmi, Milano 1985.
18. Fondamentalmente si vedano E. CorteSe, L’incastellamento nel territorio di Arezzo (secoli X-XII), in Castelli, storia e archeologia del potere nella Toscana medievale, a cura di R. Francovich e M. Ginatempo, vol. I, Firenze 2000; J.-P. DeLumeau, Arezzo. Espace et societè, 715-1230, I-II, Rome 1996; S. De Fraja, Fortificazioni medioevali in Valcerfone, arezzo 2011.
19. C. troya, Del Veltro allegorico de’ Ghibellini, Napoli 1856, p. 278, doc. III. Si nomina, nel documento, inoltre un “Castrum Vecclum” di cui non è possibile con sicurezza individuarne il riferimento attesa la genericità del toponimo.
137
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
a titolo di esempio, per la valle del torrente cerfone nell’aretino il documento re-lativo al sito fortificato di Ficarolo costituisce la guida per l’individuazione delle entità di cui era composto un castello di X-Xi secolo che, letto in parallelo con altra coeva documentazione aretina, fornisce una precisa idea di cosa s’intendesse materialmente per “castrum”, di quale fosse la dimensione e delle varie unità di cui era generalmente composto. Si ha dunque notizia, nel 1064, di un appezzamento terriero “cum castello et muris et carbonariis et cum accessoribus et ingressis et regressis de castello et edificio de loco Ficarolo”20. è probabile che il detto “castellum” fosse delimitato da una cinta, probabilmente inizialmente in legname, terra, pietre sciolte e altro materiale deperibile, e dalle relative aree adibite a carbonaie21 circonvicine il recinto; l’insediamento poteva constare, inoltre, di un edificio, forse realizzato con l’uso promiscuo di pietra e legno22, adibito a fortificazione o, come successivamente andò affermandosi mediante accorgi-menti architettonici, a residenza.
Il termine “castrum” viene usato per designare una varietà di modi di conformazione della struttura fortificata e dell’insediamento sia esso sede di autorità dalla quale è eser-citato il potere sugli uomini presenti nell’abitato o nel territorio individuato e sfruttato, sia esso sede di una semplice postazione militare e sorveglianza anche in funzione di interessi economici: spesso coinvolge anche una protezione perimetrale dell’abitato sia essa in muratura, legname, opera in terra o semplice barriera costituita da edifici raccolti intorno ad un nucleo.
Numerose varianti materiali del “modello base” compaiono tuttavia nella documen-tazione successiva in riferimento a fortificazioni difensive variamente sofisticate.
In molti casi il sostantivo “castrum” indica una realtà fortificata verosimilmente come sopra descritta ma in altri casi intende ancora un aggregato abitativo posto in una posi-zione ben difendibile che sfrutta il vantaggio altimetrico dello sperone roccioso su cui si erge o il limite naturale fornito dal ciglio di un dirupo nonché potenziato presso lati maggiormente accessibili da un fosso asciutto. Situazione simile è immaginabile, a fine secolo Xiii, per l’insediamento di rofelle di Badia tedalda, munito di torre,23 posto sul ciglio di un borro e protetto “cum sticato”24 ligneo.
Alcune fortificazioni occupano posizioni del tutto eccezionali, ognuna contraddi-stinta da una precisa caratteristica rispondente ad una preminente funzione o comunque
20. DeLumeau, Arezzo. Espace et societè , cit., p. 577, n. 48; p. 345, n. 133.21. a. a. Settia, Il tempo della terra e del legno. Elementi difensivi esterni nei castelli italiani, in Oltre le mura,
l’apparato delle cinte fortificate medievali, Padova 2008.22. L’evidenza documentale offre infatti, dalla metà del secolo XI, numerose attestazioni di località già
definite come “castrum”, con le relative implicazioni edilizie, politiche, amministrative nonché militari. è tuttavia nel picco di tale proliferazione di fortificazioni, o subito dopo, che si verifica l’importante svolta per cui, a livello locale e non solo nazionale, prende avvio un processo di conversione in muratura o comunque, più generalmente, di costruzione in pietra, delle strutture realizzate in legno, o materiali deperibili, divenendo così, il legno stesso, strutturale supporto alla pietra e non già il contrario di quanto, secoli prima, si era verificato.
23. ASF - BF, 1290, settembre, 8, vendita di beni in Montebotolino nonché di parte “de domnicato de turris de Rofelle”.
24. ASF - BF, 1291, giugno, 28.
138
Simone De Fraja
un discrimine di prevalenza di una funzione sull’altra attesa la polifunzionalità di tali edifici e il loro fondamentale ed imprescindibile ruolo di difesa.
Una delle migliori posizioni topografiche sfruttata prevalentemente per il controllo del tratto viario, che congiungeva le due sponde del marecchia, era occupata dal castello di Fresciano; tale posizione, praticamente imprendibile ed al contempo inevitabile per l’utente dell’itinerario, tuttavia, si è rivelata una delle più infelici nel corso del tempo attesa la massiccia erosione cui è andata incontro l’alta ripa del fiume e le numerose conseguenti frane che hanno cancellato quasi del tutto la documentazione materiale della fortificazione.
L’assetto geologico dell’Alta valle del Marecchia è caratterizzato da strati marnoso-arenacei generalmente coperti dalla “Coltre” della Valmarecchia; si distinguono inoltre strati di vario spessore di Scisti varicolori che appaiono evidenti nelle fratture rocciose esposte nelle strette valli a “v” ove la franosità è maggiormente diffusa e condizionata anche da situazioni di squilibrio energetico in seguito a recenti movimenti. L’alto gra-diente di franosità di alcune aree del territorio, in cui gli stati rocciosi hanno dato luogo a rilievi particolarmente accentuati, è sicuramente una concausa che ha contribuito, e con-tribuisce tutt’oggi, alla rovina di alcune delle strutture fortificate maggiormente presenti nella documentazione archivistica conservatasi. Inoltre, in relazione all’impetuosità dei corsi d’acqua che discendono dai rilievi solcando profondamente gli strati, antiche pa-leofrane presentano parziali riattivazioni proprio in conseguenza della massiccia azione erosiva dei fiumi.
Uno dei dissesti più significativi della zona ha coinvolto la località Tramarecchia ove è presente un corpo di frana quiescente da oltre un cinquantennio che, negli anni Trenta del 1900, aveva provocato lo sbarramento del Marecchia che scorre all’interno del pro-fondo canyon alla base del versante.
La fortificazione di Fresciano (Frazione Fresciano di Sotto) sorgeva dunque al ter-mine di un terrazzamento a picco sull’alveo del Marecchia che, in quel tratto, scorre sul fondo di un canyon tagliando gli strati marnoso-arenacei ad alto grado di franosità. Qui vi giungeva un raccordo viario proveniente dall’antico percorso che dal passo di Frassineto tramite Montebotolino e Rofelle, giungeva sino a Ranco (Fig. 7) ed al Marecchia: il ramo stradale lambiva la fortificazione abbassandosi di quota sino a scendere quasi all’alveo del fiume che attraversava mediante un ponte per Tramarecchia, eloquente toponimo, per giungere o presso San patrignano o per proseguire sino ai piedi di Badia tedalda. La fortificazione occupava una fortissima posizione ottimamente difendibile: benché dotata di visuale limitata al profondo alveo del marecchia ed alle retrostanti montagne, sfruttava l’indotto del limitrofo percorso viario e la sua diramazione per tramarecchia mediante l’attraversamento obbligato dal ponte25 (Figg. 8, 9).
La potente azione erosiva del fiume, prescindendo dai rovinosi terremoti che hanno
25. a. a. Settia, Castelli e strade del nord Italia in età comunale: sicurezza, popolamento, strategia, in Luoghi di strada nel Medioevo fra il Po, il mare e le Alpi occidentali, a cura di G. Sergi, Torino 1996; E. naSaLLi roCCa Di CorneLiano, Lo scacchiere tra Ceno, Taro e Via Emilia nella sistemazione dei castelli, delle pievi, delle strade, in “Archivio Storico per le provincie parmensi”, s. IV, XXIII (1971);
139
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
ripetutamente scosso il Badiale, ha attivato nel corso del tempo vari corpi di frana su entrambe le sponde del canyon: in particolare, dissesti del terreno e delle rocce sottostanti la fortificazione hanno provocato il crollo – a più riprese – di ampie sezioni fortificate facendo arretrare il fronte del terrazzamento con conseguente perdita delle strutture.
anche l’abbazia dei tedaldi occupava una fondamentale posizione di controllo non solo della vallata sottostante ma anche dell’importante antico percorso e connessi snodi viari che confluivano alla base dello sperone roccioso su cui si ergeva unitamente al borgo fortificato.
L’insediamento si è sviluppato secondo il profilo orografico del poggio subcircolare: ad una estremità trovava sede il nucleo religioso distinto dall’aggregato abitativo sorto lungo la via di crinale che conduceva al monastero; per la difesa doveva contare essen-zialmente sul dislivello altimetrico e sulle mura delle abitazioni che costituivano l’arti-ficiale prolungamento della protezione naturale. La conformazione chiusa dell’abitato, tagliato dalla strada che giungeva da occidente, terminava ad est con l’abbazia fortificata ben distinta dal resto dell’insediamento come lascia intendere la “Relazione sulla torre di Badia” del 9 giugno 1612 secondo cui, sebbene successivamente ad alcuni ammoder-namenti delle strutture, si poteva rilevare che “quel Castello oltre all’ esser forte da se per natura haveva anche una buona fortezza con un cinto di mura su le cui teste sono ancora duoi baluardi tondi, che si guardano l’un l’ altro, sopra le mura di questa fortezza dice, che ci è una grande e bella Torre di pietre concie” 26 (Fig. 10).
Si è inoltre più volte accennato, pur nella quasi assenza di documentazione relativa, alla fortificazione di Montelabreve, sorta presso un importante nodo viario ed antichi itinerari di crinale sottoposti al controllo dell’alta torre di cui il complesso era dotato. Indiscutibile appare l’importanza del rilievo orografico: esso costituisce un passo mon-tano di facile accesso per la vallata del Metauro e del Tevere garantendo la possibilità di transito, da nord verso sud; un passo dunque montano ben praticabile, a quota inferiore ai mille metri, uno snodo viario presso cui confluivano anche altri itinerari che sfrutta-vano i crinali per Montefortino ed il Passo di San Cristoforo nonché per Le Colubraie passando dal Sasso Aguzzo e l’antica fortificazione del Poggio della Regina.
Sulla cima del rilievo di Montelabreve è stato possibile individuare i resti della strut-tura fortificata medioevale; tracce di un edificio quadrangolare, forse una torre, si evi-denziano al colmo di un significativo dosso, formato anche da materiali di crollo e posto all’estremità ovest della sommità. La muratura, il cui elevato non supera alcune decine di centimetri, è realizzata mediante l’impiego di blocchi e lastre di arenaria locale spaccati di medie dimensioni (Fig.11).
a pochi metri dal manufatto, una depressione del terreno conserva i resti di un modesto ambiente quadrangolare privo di intonaco. Nella parete nord di tale struttura murata, parallela ad un lato della struttura sopra descritta, si apre una piccola cavità qua-drangolare poco profonda, quasi un piccolo stipo, delimitata da conci e da una lastra in funzione di architrave.
26. Potito, cit., pp. 65-67
140
Simone De Fraja
Pare che l’antico appellativo dell’acuto rilievo orografico su cui oggi rimangono i resti della fortificazione sia stato “Mons Cabrenna”27. durante il basso medioevo e nel corso del secolo Xvii28, il toponimo “Cabrenna” non è presente nei documenti ad oggi noti ma la località compare come “Monte breve”, “Monte del breve”, o con successive similari scritture fino ad essere cristallizzato, alla metà del secolo XIX, con l’attuale di-zione29. Il toponimo, qualora non messo in relazione con la presenza della capra in tale area montana, come da alcuni sostenuto30, può essere riferibile ad interessante antico substrato linguistico31 rimasto legato a tale area con particolare morfologia orografica. Qui le cronache registrano un fatto d’arme avvenuto l’8 luglio 1406 quando
ottaviano delli ubaldini havendo guerra con il comune di castello cavalcò al castello di Pietralonga con cento cavalli; era capo della brigata predetta il conte Odoardo dell’Aquila e Gasparo di Pozzo d’Arezzo. Venne la spia alla Città di Castello come il detto Taviano era cavalcato nel luogo predet-to e subito la gente di castello, a piedi e a cavallo andò al detto castello e cacciorono il detto Taviano con la brigata perfino al castello di Monte del Breve; era del conte Antonio d’Urbino et il comune di Castello, combat-tette il detto castello et ne mandò a terra lo steccato pigliorno 40 priggioni; fu preso il detto conte dell’Aquila e XXII caporali della detta brigata e fu stracciato il pennone del detto conte; e se non fusse stato alcuno cittadino, saria preso anco il detto taviano 32.
è dunque dalla seconda metà del secolo XIII che il piano di recupero attuato dall’a-bate tedalgrado33 e poi da niccolò della Badia dei tedaldi, la costituzione di una signoria
27. rePetti, ad vocem, cita, come per altre località tra cui Montefortino, un documento del 1277 [leggasi 1267] con cui, a seguito di vertenza insorta tra i Carpegna e Montedoglio contro l’Abbazia dei Tedaldi (in persona dell’abate Tedalgrado) furono assegnate a quest’ultima alcune terre tra cui quelle site presso il “Monte Cabrenna”. Il documento in parola non annota tale sito, DiPLomatiCo C., doc. 15, 1223, gennaio 31; In generale si veda W. Venturini, Montelabreve e i Venturini, Città di Castello 1980.
28. G. MUZI, Memorie civili ed ecclesiastiche di Città di Castello, vol. II, Città di Castello 1844 ad annum 1406, p. 198; F. m. CimareLLi, Istorie dello Stato d’Urbino, 1642, Libro Secondo, cap. 6, p. 182.
29. Il “Catasto Lorenese” del 1824-26 registra la forma “Montelebreve” così anche per l’omonimo fosso che scende dal rilievo posto alle spalle dell’abitato.
30. Venturini, Montelabreve e i Venturini, cit,.; resta tuttavia incerta la corrispondenza toponomastica tra il “Mons Cabrenna” e Montelabreve.
31. Forse un gentilizio etrusco da mettere in relazione con i tanti toponimi dell’area toscana uscenti in -na; sebbene si versi in territorio prettamente umbro e scarsi siano i toponimi etruschi conservatisi, la presenza di questa popolazione nei territori della Massa Trabaria e Montefeltro è ottimamente documentata.
32. a. aSCani, Due cronache quattrocentesche, Città di Castello 1966, p. 101 (P. Laurenzi, Historie di Città di Castello e di altri luoghi circonvicini, trascritte da Luigi Andreucci nell’anno 1772).
33. a. bonSignori, Brevis historia S. Angeli Tedaldae Abbatiae, riferibile al secolo Xvii, in aSF, corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 78, 172; Czortek, La signoria dell’abate Tedalgrado, cit., p. 12., sulla scorta del Bonsignori, scrive che nella “prima metà del XIII secolo l’abbazia dei Tedaldi perde parte dei propri territori in favore dei vicini signori di Montedoglio, di quelli di Monte Domito e di Ranieri dell’ancisa. è Ugo di Montedoglio che nei primi anni ‘40 sottrae all’abate, Guido, i castelli di Santa Sofia,
141
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
unitaria, permette un sorta di compattazione immobiliare di castelli sottoposti, sebbene anche con vicende alterne, alla Abbazia medesima. Si è dunque visto che il 21 febbraio 126434, i Rofellani promettono fedeltà a Domenico Leti da Cocchiola, sindaco dell’Ab-bazia, impegnandosi a difenderne i diritti cosicché il complesso di castelli dell’Abbazia appare costituito da “Castrum Abbatie, castrum Sancti Paterniani, castrum Cuchiolis, castrum Caprili”. Nel progetto di Tedalgrado non dovettero comunque essere mancate situazioni di contrasto con altri signori limitrofi in fluido movimento per un tentativo di espan-sione atteso l’intervenuto lodo (1267)35 per una insorta lite confinaria tra l’Abbazia, che rivendicava i propri territori, e Guido ed Ugo di Carpegna, Ranieri dell’Ancisa nonché i signori di monte domito. l’ampio territorio riconosciuto dalla pronuncia – di fatto – disegnava una vasta area all’interno della quale gravitavano, divenendo in tal modo di pertinenza dell’Abbazia, numerose fortificazioni con le relative corti; il lodo sebbene non espressamente menzioni le località sede di castello, comprende comunque le loca-lità di Santa Sofia, Cicognaia, Montefortino, Montelabreve, Monterano San Patrignano, Rofelle, Caprile (Fig. 12), Pratieghi (Fig.13) con i relativi insediamenti. Tuttavia, non tutti i castelli compresi nell’area risultavano di pertinenza assoluta dell’Abbazia né alla stessa dovevano aver giurato fedeltà; Fresciano, infatti, diviene dell’abate Tedalgrado soltanto dopo una doppia operazione di acquisto del relativo compendio attuata in due tempi: il 27 gennaio 127136 e il 8 maggio 128137 allorquando il diritto può dirsi completato mediante l’acquisto della seconda metà della fortificazione, unitamente alle numerose famiglie che popolavano l’insediamento. l’abate niccolò, deceduto o non più operati-vo Tedalgrado, il 10 giugno 129438 raccoglie il giuramento di fedeltà dagli uomini della Badia, Presale, Pianello, Monteviaio (Monteviale), San Patrignano, Rofelle, Caprile e cocchiola. è possibile quindi rilevare che di fatto, nei primi decenni del secolo XIV, il Badiano era completamente soggetto all’abbazia dei tedaldi.
alla morte di enrico vii, arezzo si trovava sotto la nominale signoria del re di na-poli Roberto d’Angiò ma la signoria della città fu affidata a Guido Tarlati (1321). Questi già da tempo aveva ottenuto – de facto – i poteri di gestione del governo, intraprendendo così un serrato importante programma di espansione e riconquista del territorio, spe-cialmente delle postazioni strategiche delle vallate di accesso alla città. Il piano fu inter-rotto nel 1327 dalla sua morte ma tosto continuato dal fratello, piero tarlati, che più volte era stato fidato generale del vescovo, braccio destro ed efficiente alter ego durante
Cicognaia, Monte Rotondo e la villa di Arsicci. Al tempo dell’abate Guglielmo i conti di Monte Domito si impossessano di altre località di pertinenza dell’abbazia, fra le quali la Ripa e Castellacciola; Ranieri dell’Ancisa occupa i territori verso la Pianca, Fresciano e Montebotolino”.
34. Potito, cit., p. 20; Czortek, La signoria dell’abate Tedalgrado, cit., pp. 12-13; l’Autore analizza il rapporto giuridico che, mercé tale atto, si è instaurato tra gli uomini di Rofelle e l’Abbazia dei Tedaldi.
35. DiPLomatiCo C. p. 68.36. ASF - BF, 1271 (gennaio, 27). La pergamena contiene anche un successivo atto del 1281 (maggio, 8)
anch’esso relativo alle sorti di Fresciano.37. ASF - BF, 1281 (maggio, 8).38. ASF - BF, 1294 (giugno, 10).
142
Simone De Fraja
le più importanti operazioni militari e gli assedi39. Per quanto qui interessa, in relazione ai territori ad oriente della città di Arezzo, morto il vescovo Guido, i Tarlati, l’anno seguente (1328), avevano “impetrato dal Bavero titolo de la signoria d’Arezzo e de la Città di Castello, le quali teneano, e de la terra del Borgo a Sansipolcro”40; i Burgensi, in-tendendo ottenere l’indipendenza, reputando imminente l’espansione dei tarlati anche su Sansepolcro in ordine all’estensione dei domini verso est, “si misono a la difensione […] per essere liberi”. Il 20 ottobre di quell’anno un notevole contingente di Aretini agli ordini di Piero Saccone, fanti e cavalieri, “con loro amistà misono assedio con oste a la terra del Borgo a Sansipolcro, la quale era molto forte e di mura e de’ fossi”41. nel giro di poco tempo molte terre entrano nell’egida dalla famiglia tarlati ma, tornatosene Ludovico di Baviera in Germania, essi fecero “atto di sottomissione al papato, ne ot-tengono il perdono e cercano di diventarne vassalli per le terre del patrimonium Petri”42 da essi già occupate. Intanto, nel 1330, l’abbaziato del monastero dei Tedaldi era pas-sato, allo scadere del secolo Xiii, da tedalgrado a niccolò che partecipò all’elezione di Pier Saccone nonché di Tarlato Tarlati da Pietramala quale “protettore e difensore generale del monastero, delle persone dei castelli della Badia”43, presale, rocchetta, San Paterniano, Rofelle, Fresciano, Caprile, Cucchiole e Arsicci (Fig. 14). Nel 1333-34 pier Saccone pose sotto assedio casteldelci, sottraendolo ai della Faggiuola, ove fu-rono impiegati ventisei battifolli ed ove il blocco perdurò “usque ad pasca Natalis”44, in pieno rigore invernale. nello stesso anno i rappresentanti della massa, completamente in mano ai tarlati che si erano spinti in avanzata valmarecchia, si accomandano, con le loro terre e castelli, ad arezzo con l’omaggio di palii per la festa di San donato. in questi anni la gestione di quest’angolo della Massa Trabaria da parte dei Tarlati incon-trò forti resistenze specialmente da parte di Ribaldo da Gattara; numerose infatti le testimonianze documentali45 relative a tensioni e contrasti sfociati in reiterate azioni di disturbo poste in essere mediante scorrerie, furti e devastazioni; a Ribaldo dovette ben presto unirsi anche uguccio di ranieri della Faggiola ed i tarlati si trovarono costretti a scrivere ai rettori delle masse, con special riferimento alla massa trabaria, appellandosi inoltre alla chiesa romana, per riferire e lamentarsi delle prepotenze sui massani e sulle terre ad essi ormai sottoposte.
La fortificazione che appare nella documentazione (1329) come “Mons Bethiolinum” probabilmente il Montebotolino, viene confermata – unitamente a quella di “Pratiegum” – da lodovico il Bavaro ai della Faggiola unitamente ad una ventina di altri castelli
39. S. De Fraja, Assedianti e assedianti nelle formelle del cenotafio Tarlati, in “NdS”, 20 (2008).40. g. ViLLani, Nuova Cronica, Parma 1991, Libro undicesimo, cap. CXXII; Annales Arretinorum Maiores,
ad annum 1328, “Et die xx mensis octobris, Arretini iverunt, cum maxima quantitate peditum et militum, in exercitum ad Burgum S. Sepulcri [...] et ibi positi sunt battifolles, die xx mensis novembris”.
41. ViLLani, Nuova Cronica, cit., libro undicesimo, cap. cXXii.42. L. berti, Arezzo nel tardo medio evo (1222-1440). Storia politico-istituzionale, Arezzo 2005, p. 43.43. Potito, cit., p. 33.44. Annales Arretinorum Maiores, a cura di a. Bini, in Rerum Italicarum Scriptores, XXIV, Pt. I, Città di
Castello, S. Lapi, 1902-1912, ad annum 1333, p. 25.45. PaSQui iii, appendice, pp. 303-306.
143
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
nonché “terras et castra antecesssores vestri tenuerunt et possiderunt”46. nel giro di pochi anni tale consorteria entra in possesso di un elevato numero di fortificazioni, terre ed inse-diamenti posti nell’angolo occidentale tra le attuali regioni toscana e romagna. inoltre, all’interno del trattato relativo alla “Pace di Sarzana”47 si individuano alcune fortificazio-ni, oggi poste all’interno del comune di Badia Tedalda, già oggetto di contesa, definiti-vamente assegnate alla consorteria dei Faggiolani. Tra queste vi figura la fortificazione “Montis Rotundi”, nel 1232 già citata come villa48, il “castrum Montis Brectolini”, il “castrum Rastellae”, in cui sembra doversi leggere Rofellae, già citato nel detto documento del 1232, nonché Frisciana.
La fortificazione di Rofelle
alcuni documenti permettono di ripercorrere le fasi evolutive dell’insediamento forti-ficato di Rofelle che, nel 1232, doveva consistere in un aggregato semplice ed aperto e sostanzialmente privo di mura comparendo come “villam de Rufello”49; alla fine degli anni Cinquanta del secolo XIII il 9 novembre 125750 rofelle compare tra le terre e ca-stra rivendicate dagli Aretini contro i Massani nella forma di “Roselle”; verosimilmente nell’arco di tempo tra il 21 febbraio 1264, anno in cui Acattabene sindaco del castello di Rofelle giura fedeltà all’abate Tedalgrado, e il 28 giugno 1291, anno in cui si comincia la ricostruzione della fortificazione, il castello di Rofelle dovette subire una distruzione da parte dei Massani, lo si definisce “dextructum et dissipatum”51, che avevano agito contro l’abate. tuttavia tale rovinoso evento, nonostante l’enfatizzazione documentale indica-ta, dovette risparmiare quantomeno parte delle strutture se l’8 settembre 1290 “Rigo cataneus”52, figlio del nobile Pulegrino di Montebotolino, vende proprio al “religioso viro domino Tedelgrado” una porzione “de domnicato de turris de Rofelle” struttura che, a meno di non ipotizzarla giacente nei dintorni, doveva essere sopravvissuta allo smantellamento della fortificazione. è dunque agli ultimi anni del secolo XIII che la fortificazione di rofelle verosimilmente appariva come nucleo di rustiche costruzioni con almeno una torre53, difese da un fosso asciutto “cum sticato”54 ligneo presso i lati più esposti; esso era stato fondato sul terrazzamento sul ciglio di un dirupo e si era sviluppato lungo un’antica direttrice viaria per Montebotolino e Fresciano (e il passo di Frassineto) nonché, dall’e-stremità opposta, verso la valle del Marecchia e la via Maior; a fine secolo XIII l’anonima
46. troya, Del Veltro allegorico de’ Ghibellini, cit., p.322 doc. XIX, 1329, febbraio, 15.47. troya, Del Veltro allegorico de’ Ghibellini, cit., p.329, doc. XXI, 1353, marzo, 31.48. troya, Del Veltro allegorico de’ Ghibellini, cit., p. 276, doc. III, 1232, ottobre, 24.49. troya, Del Veltro allegorico de’ Ghibellini, cit., p. 278, doc. III.50. PaSQui II, doc. 605.51. ASF - BF, 1291, giugno, 28, “Cum olim castrum quod vocabatur de Rofelle quondam in plano Sorbi positum [...]
fuerat dextructum et dissipatum [...]”.52. ASF - BF, 1290, settembre, 8.53. ASF - BF, 1290, settembre, 8, vendita di beni in Montebotolino nonché di parte “de domnicato de turris
de Rofelle”.54. ASF - BF, 1291, giugno, 28.
144
Simone De Fraja
Historia annota “castrum Roffellis, a Thedelgrado iterum edificato”55 e documenti successivi atte-stano la persistenza del “castrum”. Il 15 gennaio 132456 Rofelle rinnova la propria fedeltà all’abbazia dei tedaldi nella persona dell’abate niccolò ma, in seguito ad una vertenza giuridica circa la vendita del molino dei duci insorta tra i rofellani ed il medesimo abate, il successivo abate Angelo abbatté e smantellò le opere fortificatorie di Rofelle.57
La fortificazione di Fresciano
Il riferimento più antico alla fortificazione di Fresciano, “castrum Frisciana et eius curtem”, è contenuto in un atto del 24 ottobre 123258 con cui uguccione di taddeo di casteldelci (poi da Fresciana) sottopone alcuni castelli alla protezione della Chiesa e del papa Ono-rio III contro, un simbolico canone annuo di un falcone da caccia e precisamente “unum asturem, et unum cereum unius librae cerae plebi Xistini de Massa nomine census vel pensionis”.
Quasi trent’anni dopo, la fortificazione è oggetto di ulteriore atto di vendita interve-nuto il 10 aprile 125859 tra Ugo di Montedoglio ed Uguccione Novello, figlio di Uguc-cione di Taddeo di Casteldelci, relativo alla metà del castello di Fresciano. Uno studio di F. v. lombardi60 ha posto in rilievo l’atto relativo alla vendita della residua metà del castello avvenuta nello stesso anno 1258, il 13 settembre: è Ranieri della Faggiola, figlio del fu Ranieri di Casteldelci, che vende o rivende ad Uguccione Novello (figlio di Uguc-cione di Taddeo da Fresciana, già da Casteldelci, sostanzialmente cugino ex patre del venditore) “medietatem castri totius de Fresciana pro indiviso et medietatem ipsius curie et distritcus”.
Uguccione Novello, dunque, acquistando le due metà dei diritti e dei possessi relativi a Fresciano, ricompone il compendio immobiliare attraverso l’acquisto da venditori di-versi cosicché, nell’autunno 1258 egli è l’unico pieno proprietario. è dunque probabile che tra il 1232 e il 1258 il castello sia caduto tra i beni dei Montedoglio, verosimilmente tramite un matrimonio, e per evitare la frammentazione della proprietà e l’eventua-le dispersione dei beni sia stato riacquistato da Uguccione Novello. In attuazione del proprio disegno di espansione e assoggettamento di castelli con le relative pertinenze, investimenti economici e fondiari in favore dell’abbazia dei tedaldi, tedalgrado il 27 gennaio 127161 acquista da Uguccione Novello da Fresciano alcuni diritti reali e perso-nali su vassalli e uomini di Fresciano unitamente alle loro abitazioni nonché su terre ed edifici. Uguccione, dunque, con la detta alienazione rogata in “Pian delle Vigne” non
55. Historia Abbatiae Thedaldi cc. 142 ASF, Carte Strozziane, s. II, 147; il passo è citato anche in Czortek, La signoria dell’abate Tedalgrado, cit., p. 26, n. 87.
56. Potito, cit., pp. 31-32.57. Potito, cit., p. 37.58. troya, Del Veltro allegorico de’ Ghibellini, cit., p. 278, doc. III. 59. F. V. LombarDi, L’origine dei Faggiolani, in “Studi montefeltrani”, 1 (1971), p. 59 e ss.60. LombarDi, L’origine dei Faggiolani, cit., cui si fa riferimento anche per alcune considerazioni successive.
Di particolare importanza la “ricostruzione” delle parentele dei Faggiolani e l’albero genealogico proposto dallo Studioso a p. 63.
61. ASF - BF, 1271 (gennaio, 27). La pergamena contiene anche un successivo atto del 1281 (maggio, 8) anch’esso relativo alle sorti di Fresciano.
145
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
lontano dalla fortificazione di Fresciano, avvia un processo di spoliazione dei propri diritti in favore dell’Abbazia che, dopo dieci anni, completa l’acquisto relativo al mede-simo compendio di beni; Tedalgrado, infatti, l’8 maggio 128162 sottoscrive un ulteriore atto di compravendita per il completamento del quadro della proprietà. In Orticeto, nella diocesi di Sarsina (ovvero Bobbio), presso la casa di Uguccione da Fresciano, la moglie di Berardo, figlio di Uguccione, ratifica l’avvenuta vendita a Tedalgrado di tutta la corte di Fresciano, nonché della fortificazione, unitamente alle numerose famiglie che popolavano l’insediamento. Anche Fresciano dunque, come i castelli circonvicini, entra sotto il controllo dell’Abbazia dei Tedaldi, nell’università dei castelli: il 20 luglio 132663 il successore di tedalgrado, niccolò, concede a livello a tal Sado di Berigio di Fresciano alcuni appezzamenti di terreno il cui provento (40 lire di Ravenna) viene destinato “in muratione castri Frexiane”; nel 1330, il destino della fortificazione è compreso nelle sor-ti del Badiale ed entra sotto la protezione di pier Saccone tarlati di arezzo64 per poi comparire, nel 1356, nella descrizione albornoziana65 tra le terre della massa trabaria controllata dalla chiesa e, successivamente, tra i beni dei montedoglio.
La fortificazione sorgeva al termine di un terrazzamento a picco sull’alveo del Ma-recchia (Frazione Fresciano di Sotto) che, in quel tratto, scorre sul fondo di un canyon tagliando gli strati marnoso-arenacei ad alto grado di franosità. Qui vi correva un rac-cordo viario proveniente dall’antico percorso che dal passo di Frassineto tramite mon-tebotolino e rofelle, giungeva sino a ranco ed al marecchia: il ramo stradale lambiva la fortificazione abbassandosi di quota sino a scendere quasi all’alveo del fiume che attraversava mediante un ponte per Tramarecchia, eloquente toponimo, per giungere o presso San Patrignano o per proseguire sino ai piedi di Badia Tedalda. La fortificazione occupava una fortissima posizione ottimamente difendibile: benché dotata di visuale limitata al profondo alveo del marecchia ed alle retrostanti montagne, sfruttava l’indotto del limitrofo percorso viario e la sua diramazione per tramarecchia mediante l’attraver-samento obbligato dal ponte66.
le rovinose piene del marecchia hanno più volte travolto l’attraversamento e, verso la metà degli anni Ottanta del 1900, hanno definitivamente distrutto e abbattuto l’ultimo ponte esistente che, per quanto rimane delle spallette ed in base ad alcune foto, pare conservasse i segni di una ristrutturazione ottocentesca. la potente azione erosiva del fiume, prescindendo dai rovinosi terremoti che hanno ripetutamente scosso il Badiale, ha attivato nel corso del tempo vari corpi di frana su entrambe le sponde del canyon: in particolare, dissesti del terreno e delle rocce sottostanti la fortificazione hanno provo-cato il crollo – a più riprese – di ampie sezioni fortificate facendo arretrare il fronte del terrazzamento con conseguente perdita delle strutture.
62. ASF - BF, 1281 (maggio, 8).63. ASF - BF, 1326 (luglio, 20); Potito, cit., p. 32.64. Potito, cit., p. 33.65. theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, cit., t. II, doc. CCCXXV, p. 339.66. Settia, Castelli e strade del nord Italia in età comunale…, cit.; naSaLLi roCCa Di CorneLiano, Lo scacchiere
tra Ceno, Taro e Via Emilia…, cit.
146
Simone De Fraja
alcuni testimoni67 ricordano distintamente che ancora negli anni Cinquanta e Ses-santa era visibile buona parte del recinto castellano rivolto a nord ed ad ovest; ricordano alcuni ambienti quadrangolari con elevato di oltre un metro nonché la torre detta ‘La torre di Fresciano’. alcune foto68 relative agli anni Settanta del 1900 mostrano come l’attività combinata dell’erosione e dei sismi avesse già pesantemente influito sul fronte franoso della scogliera provocando il distacco di ingente quantità di roccia e parte delle strutture castellane. Alcune fotografie, ormai datate, mostrano come almeno i due terzi della fortificazione risultino già perduti: nelle immagini persiste una torre quadrangola-re, non integra nella sua altezza, il cui zoccolo di fondazione è parzialmente esposto sul baratro dunque l’area della fortificazione rivolta verso il Marecchia risultava già franata intorno al 1970. Le medesime testimonianze riferiscono che a seguito delle abbondanti piogge invernali (anni Ottanta) il Marecchia si era molto innalzato nell’alveo e l’impo-nente azione erosiva esercitata alla base della scogliera fece rovinare non solo il ponte per Tramarecchia ma anche la torre scapitozzata la quale, in unico blocco, rovinò sul fondo del canyon. oggi rimangono gli ultimi tratti murari rivolti a nord, con opera a filaretto, ove sono precariamente attestati con parte delle fondazioni a vista ancora ag-grappate a banchi di terreno già segnati da ampie fratture.
La fortificazione di Santa Sofia di Marecchia
Il castello di Santa Sofia sorgeva, a quota 594 metri s.l.m., ad ovest dell’attuale agglome-rato urbano e industriale di Santa Sofia, sulla cresta di un promontorio dominante la sot-tostante vallata del fiume Marecchia. La sommità del rilievo, individuata dal toponimo Castellaccio, conserva i ruderi dell’impianto fortificato. La relazione ottica attivabile da tale postazione offre un cono visivo di circa 250 gradi essendo la stessa intercettata dalle propaggini del Monte Zucchetta ad ovest e a nord; entro tale visuale sono compresi il castello di cicognaia e la torre di Bascio, diretti interlocutori nella rete comunicativa dell’epoca.
il complesso militare, sorto ed accresciutosi in più fasi costruttive, si presenta come un’area in declivio occupata dai ruderi, distribuita su più piani dovuti sia a dislivelli rocciosi sia agli strati di crollo. di forma poligonale allungata la struttura fondamentale giaceva in senso nord-est / sud-ovest cui si giungeva tramite una strada il cui traccia-to, ancora oggi, si inerpica attraverso edifici recenti o rimaneggiati in più epoche che conservano tuttora elementi, anche di reimpiego, pertinenti al momento medioevale di quello che era l’abitato sottostante il castello o, più probabilmente, un insieme di annessi di pertinenza del castello medesimo. i ruderi del lato sud presentano un paramento di oltre 5 metri contraddistinto da una alta scarpa piuttosto accentuata; la sezione muraria
67. Si tratta in particolare del signor Tiberio Rossi, che ci ha guidato ed illustrato i ruderi della fortificazione di Fresciano e del fratello Liano Rossi che ci ha messo cortesemente a disposizione alcune fotografie (28.05.2010).
68. g. F. Di Pietro - g. F. FaneLLi, La Valle Tiberina Toscana, Arezzo 1973, pp. 434-435; LombarDi, Le torri del Montefeltro e della Massa Trabaria, cit.
147
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
gradualmente si rastrema con l’altezza e l’apparecchiatura è connotata, così come in quasi tutti i prospetti conservati, dall’impiego di pietre locali, spaccate, di piccole e me-die dimensioni poste su filari abbastanza regolari, talvolta sdoppiati.
Il lato ovest dell’area è coinvolto da notevoli blocchi murari di crollo relativi alle mu-raglie che univano la porzione sopra descritta con l’angolare ancora rimasto, i cui resti, si innalzano per oltre 8 metri dal falsato piano di campagna esterno. Uno di questi blocchi mostra ancora le tracce di una probabile catena realizzata mediante due travi in legno annegate nella muratura, oggi scomparse, con funzione statica dell’angolo.
Così come indicato nel Catasto Lorenese ed individuato dai rilievi eseguiti, il lato nord-ovest della fortificazione era contraddistinto da una rilevante rientranza, delimitata da due strutture aggettanti, pseudo bastionali, di cui rimane l’angolare esterno già descritto; quest’ultimo presenta, sul fianco nord-est che delimita la rientranza della fortificazione, una feritoia entro nicchia con arco ribassato realizzato con pietre disposte a coltello (Fig. 5). La strombatura passante lo spessore murario di circa 1,50 metro, sfocia in una ristret-ta apertura verso l’esterno parzialmente rovinata e posta, nel paramento esterno, al ter-mine della scarpa basale appena visibile poiché interrata. L’impossibilità di determinare con certezza il piano del pavimento interno pone in difficoltà anche la individuazione della funzione esatta di questa feritoia. Benché a prima vista essa possa apparire come progettata come bombardiera, potrebbe essere stata realizzata per l’impiego di armi meccaniche, atteso il dislivello di circa 80-100 cm dal piano interno all’apertura, anche se compatibile, ancora, con l’uso di armi montate su cavalletto. Questi ed altri elementi potrebbero essere indizi per una datazione, relativa, dei manufatti superstiti benché nul-la escluda un riutilizzo continuo delle strutture con diacronici ammodernamenti.
da tale struttura un lungo tratto murario si dirigeva a nord-est ed oggi ne rimango-no poche tracce se non unicamente una alta scarpata costituita da frane e crolli. in tale area, stando all’indicazione del catasto lorenese, doveva trovar luogo una speculare e similare struttura angolare come quella superstite posta a sud-ovest e sopra descritta.
al nord / nord-est, pur essendo illeggibile il paramento esterno connotato dalla pre-senza di numerosi elementi di crollo, si conservano per qualche metro di alzato, le tracce di una torre sub circolare dotata di due piccole aperture quadrangolari, poste sullo stes-so piano, affacciantisi ad est. ai piedi di tale struttura, verso est, si conserva l’imbocco della cisterna, quasi completamente ripiena di detriti lapidei ed intonacata (Fig. 18).
Il lato nord-est dell’altura è interessato da un lacerto di un notevole tratto murario di circa metri 2,50 di lunghezza con spessore di circa 1,35 metro che incontra, ortogo-nalmente, la strada che lambendo l’altura conduce verso nord; il lacerto è dotato di un consistente zoccolo di fondazione scoperto.
Tutta la porzione sud-ovest dell’area è costituita da una alta scarpata rocciosa che costeggia il sentiero sulla quale si pone un pianoro, quasi pianeggiante, con scarsi resti di muratura erratica.
Le fonti documentali mostrano una frequentazione del sito dal secolo XIII sino a tutto il secolo Xviii sebbene ciò non comporti un continuo evolversi della struttura in sé; l’aspetto formale sopravvissuto, fa propendere per una collocazione del manufatto
148
Simone De Fraja
a fine secolo XIV o prima metà del secolo XV. Così come il tipo di feritoia soprav-vissuta, non prettamente arciera, così come il tipo di scarpa molto alta, la forma quasi pre-bastionale del lato ovest, ed accorgimenti compatibili con la tecnologia della polvere da sparo, fanno pensare ad una collocazione tardo trecentesca del manufatto. la torre circolare tuttavia costituisce un elemento di differenziazione, probabilmente più antico ed inglobato nelle successive strutture, ben potendo non essere coeva alla realizzazione dell’apparato murario in cui risulta compresa.
La fortificazione di Caprile
La prima citazione di Caprile è contenuta nel diploma di Ottone I di Sassonia del 96769, in funzione di delimitazione territoriale. il toponimo, comune nelle aree montuose in relazione alla presenza della capra, è legato ad un’area intensamente boschiva, “forestum quod dicitur Caprile”, che ne condivideva la denominazione; si attesta così non solo la vetustà dell’insediamento ma anche l’importanza dello stesso, sia perché utilizzato per una confinazione di terre di notevole interesse politico ed economico, sia perché indivi-dua ancora l’attenzione per la riserva arborea, fonte anche di ricchezza nell’orma della tradizione della successiva costituzione della provincia della Massa Trabaria dalla quale venivano prelevate notevoli quantità di legname per farne soprattutto travi.
Nessun dubbio sussiste circa l’individuazione del frequente toponimo Caprile con quello insistente oggi sotto il comune di Badia Tedalda; il diploma imperiale infatti, utilizzando il limite costituito dalla foresta di Caprile, delimita un’area circoscritta e cioè “Cortem Paterno et Casam maiorem seu foresto de Tribleo quod est in iam dicto comitatu Aretino in Massa Uerona”. Si tratta della zona di Montecoronaro70, a Sud di verghereto, ove ebbe sede l’abbazia camaldolese del trivio, posta nei pressi dell’altra grande riserva bosco-sa costituita appunto dal foresto de tribleo, individuata dai limiti del montefeltro, di Bagno di Romagna, della Verna ed del Monte Calvano nonché, a sud-est, proprio dal “forestum quod dicitur Caprile”. Due documenti, del 1291 e del 1294, attestano la presenza di uomini del castello di Caprile; nessun’altra informazione circa l’aspetto formale della fortificazione o dell’insediamento.
i sopralluoghi effettuati nell’autunno 2007 hanno tuttavia individuato resti di mura-
69. Il documento è redatto ad Ostia il 7 dicembre 967, “Monumenta Germaniae Historica”, Diplomata Regvm et Imperatorvm Germaniae, t. I, Hannover 1879-1884, doc. 352, p. 484, “cortem Paterno et Casam maiorem seu foresto de Tribleo quod est in iamdicto cornitatu Aretino in massa Verona et habet ab uno latere forestum quod dicitur Caprile, ab alio latere montem Feltri, a tertio latere Balneum, a quarto latere percurrunt eius fines usque in Petrauerna et Caluane que de ipso foresto pertinent”.
70. rePetti, ad vocem: “Abazia del Trivio, (S. Maria) nell’Appeninno di Verghereto, presso Monte Coronaro […] Ebbe nome di Trivio dalla tripartita via che all’Alvernia, alle Balze ed a Verghereto e Bagno si dirige. Fra i tre più elevati gioghi della catena centrale dell’appennino, sopra uno sprone che diramasi dal dorso del Bastione a quello fra il Comero e la Cella di S. Alberigo, in mezzo alle scaturigini del torrente Rapina donde il Tevere e il Sario si disserrano, risiedono tuttora pochi avanzi di questo celebre monastero dell’ordine di Camaldoli”. In proposito g. Cherubini, Una comunità dell’Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell’abbazia del Trivio al dominio di Firenze, Firenze 1972.
149
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
ture attribuibili, per tecnica e materiale, al periodo medievale, probabilmente riferibili, attesa la posizione e le dimensioni del lacerto, ad elementi di fortificazione.
La parte più antica dell’abitato, quella posta a nord della chiesa, è delimitata ad ovest, da un evidente scoglio roccioso la cui sommità appare particolarmente regolarizzata ed ove giacciono i lacerti murari della fortificazione. Il castello di Caprile doveva probabil-mente insistere su questo pianoro, posto ad est delle ultime case dell’aggregato lambito anche dalla via proveniente da Arsicci, dotato di ampia visuale nonché posto in posi-zione dominante rispetto alla sottostante vallata solcata dal marecchia. allo stato non è possibile individuare la forma delle strutture ma unicamente significative depressioni o demarcazioni del terreno. Resiste infatti solo un breve tratto in muratura (ne appare il “sacco”), realizzato con pietre spaccate di dimensione varia e legate con tenace malta chiara; l’area sulla quale doveva insistere la fortificazione risulta invece ben riconoscibile in forza del perimetro del ciglio dello scoglio roccioso, naturale confine e difesa della struttura fortificata.
150
Simone De Fraja
The essay analyzes the history of medieval fortifications on the land, the western corner of Massa Trabaria, bathed by the first stretch of the river Marecchia. The available documents are largely re-lated to the Abbey of Tedaldi and retain references to the fortifications that especially prospered under Abbot Tedalgrado and Niccolò. The documentation, however, provides useful data from the middle of the thirteenth century; the combination of sources available, the documents and the ruins of the fortifi-cations survived, allow the construction of a general framework of the valley in the Middle Ages and the enhancement of the inheritance material now almost forgotten and lost. The essay, which is however a synthesis of larger work still in progress, examines in detail some of the fortifications of which has remained the documentary references and material.
151
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
Fig. 1. il territorio comunale di Badia tedalda. Si indicano le principali fortificazioni di cui si è trattato nel testo dovendo tuttavia,
per ovvie ragioni di spazio, tralasciarne altre ugualmente significative.1. Castrum Abbatie. 2. Rofelle. 3. Pratieghi. 4. Caprile. 5. Fresciano. 6. Cicognaia.
7. S. Sofia di Marecchia. 8. Montefortino. 9. Poggio della Regina. 10. Montelabreve.
152
Simone De Fraja
Fig. 2. Montefortino, il caratteristico profilo del rilievo sul quale insisteva la fortificazione presso un antico itinerario di crinale.
Fig. 3. Montefortino, particolare della muratura dei ruderi della fortificazione.
153
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
Fig. 4. Santa Sofia di Marecchia, fronte sud della fortificazione.
154
Simone De Fraja
Fig. 5. Santa Sofia di Marecchia, la nicchia della feritoia posta sul lato ovest della fortificazione e il rilievo grafico (elaborazione F. Pizzolato).
Fig. 6. Foto storica dell’insediamento di cicognaia. Si nota la torre cilindrica e l’agglomerato insediativo. rimangono
ancora leggibili un tratto murario saliente dotato di scarpatura riferibile ad una tarda ristrutturazione del complesso ed una cisterna.
155
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
Fig. 7. ranco, interno voltato dell’edificio turriforme presente nel complesso tardo medioevale sorto con prevalente funzione di dogana presso la via per rimini alla confluenza del fiume Marecchia con il torrente presale.
Fig. 8. Fresciano, il ciglio del canyon del fiume Marecchia; si notano alcuni resti della fortificazione sul bordo estremo della frana.
156
Simone De Fraja
Fig. 9. Fresciano, blocco della torre della fortificazione precipitato nel sottostante canyon del Marecchia (per cortesia famiglia Rossi).
Fig. 10. Foto storica della abbazia dei tedaldi. Si nota la chiesa con la torre campanaria, la torre abbattuta nel 1923 ed il piccolo nucleo abitativo.
157
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
Fig. 11. montelabreve, resti del basamento della torre
quadrangolare realizzata con pietre spaccate di medie dimensioni.
Fig. 12. caprile, blocchi di pietre e calce sulla sommità del rilievo di Caprile
appartenenti alla fortificazione diruta.
Fig. 13. Arsicci, presso Caprile, tracce di muratura relativa ad edificio fortificato medioevale.
158
Simone De Fraja
Fig. 14. Pratieghi, vista del sacco del paramento della fortificazione sovrastante il paese.
159
FortiFicazioni medioevali e poteri a Badia tedalda
Fig. 15. rofelle, localizzazione dei ruderi della fortificazione al vocabolo “Il castello” lungo il “Fossone”.
160
Simone De Fraja
Fig. 16. Localizzazione de i resti della Fortificazione di Fresciano in località Fresciano di Sotto (A) e relativa viabilità che, per mezzo di
attraversamento fluviale (B), giungeva a Tramarecchia e Badia Tedalda.
Fig. 17. Fresciano, particolare della muratura del castello sulla scogliera ora sul ciglio della frana.