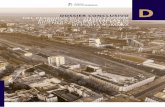M. Gargini, M.A. Vaggioli, Entella. Le fortificazioni. Nuove indagini nell'area della porta di...
Transcript of M. Gargini, M.A. Vaggioli, Entella. Le fortificazioni. Nuove indagini nell'area della porta di...
C L A S S E D I L E T T E R E E F I L O S O F I A
SERIE IV VOL. IX, 2PISA 2004
A N N A L ID E L L A
S C U O L A N O R M A L E S U P E R I O R E D I P I S A
Pubblicazione semestraleAutor. Trib. Pisa n. 7/64 del 28 dicembre 1971
Direttore responsabile Enrico Castelnuovo
Periodico associato all’Unione Stampa Periodica ItalianaISSN 0392-095x
SCAVI DI ANTICHITÀ
NOTIzIED E G L I
C O M U N I C A T E D A L L A
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Rassegna Archeologica del Laboratorio di Storia, Archeologia
e Topografia del Mondo Antico
473
8. ENTELLA. LE FORTIFICAzIONI. NUOVE INDAGINI NELL’AREA DELLA PORTA DI NORD/OVEST (SAS 19; 2005)
Nell’ottobre 2005 una breve campagna di scavo ha interessato l’area delle fortificazioni di NordOvest, sia nel settore del bastione semicircolare (SAS 25)1 che in quello della porta (SAS 19). In quest’ultimo i lavori si sono svolti dal 5 al 20 ottobre e si sono avvalsi della collaborazione di alcuni archeologi e della disponibilità di un escavatore meccanico.
Scopo principale dell’intervento era la verifica di alcune situazioni il cui scavo era rimasto da concludere nella precedente campagna 2003, nonché l’ampliamento del saggio ad Ovest della porta ellenistica indagata precedentemente.
Per chiarezza di esposizione, come nelle relazioni precedenti2 gli interventi vengono descritti per aree omogenee, procedendo da Est verso Ovest e da Nord verso Sud.
8.1. Area del cortile e della porta ellenistica
Nell’area del cortile3 e in quella della porta ellenistica, dove alla fine della campagna 2003 erano rimasti ancora da asportare i lacerti di alcuni strati, è stato messo in luce ovunque il piano stradale più antico. Nella parte
Un sincero ringraziamento alle dott.sse Daniela Divita e Donata zirone e al dott. Pietro Piazza per la collaborazione sul campo, alla dott.ssa Maria Cristina Panerai per i rilievi grafici (che sono stati successivamente rielaborati dal geom. Cesare Cassanelli), e al geom. Piero Gargini per il disegno dei materiali ceramici. Preziosi sono stati anche i suggerimenti ricevuti, in particolare da A. Corretti, C. Michelini, M. de Cesare, S. Frey-Kupper per la classificazione di alcuni reperti.
1 Vd. Michelini, infra.2 Per le precedenti campagne nel settore della porta urbica di NordOvest vd.:
Vaggioli 1999, 80-82; Gargini 1999; Gargini, Vaggioli 2002; Eaed. in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006.
3 Si definisce in questo modo il settore compreso tra la porta classica – e poi quella medievale – ad Est e la porta ellenistica ad Ovest.
127
128
129
474 michela gargini - maria adelaide vaggioli
Nord del cortile, ripulendo dal terriccio depositatosi dopo la conclusione della campagna precedente lo strato giallastro di marna/trubo 19191, su cui si fonda il muro 19114 – costituente il limite settentrionale del cortile stesso –, ha cominciato ad affiorare la roccia naturale sottostante, in questa zona in precedenza non individuata. In particolare, il banco roccioso, non visibile nella parte centrale del cortile, sembra riaffiorare presso il muro 19114 e, oltre il suo limite Ovest, nell’area della porta ellenistica, soprattutto presso l’estremità orientale del muro 19165 che ne costituisce la delimitazione Nord. Tale andamento del banco roccioso sembra compatibile con l’ipotesi che tutte le murature situate a Nord del cortile e della porta ellenistica (e dunque la struttura arcaica a blocchetti gessosi saldamente connessi indivi-duata nell’ambiente III, la cortina difensiva tardoarcaica ad essa sovrapposta e la cinta muraria più esterna di epoca classica addossata alla precedente4), dei quali non sono ancora stati evidenziati i livelli di fondazione, siano stati saldamente edificati sul banco roccioso affiorante.
Nella zona centrale e meridionale del cortile, invece, si è concluso lo scavo del battuto stradale 19195, in precedenza asportato solo nel settore Nord, mettendo in luce ovunque il sottostante basolato 19204. Rimuovendo lo strato 19195, composto da scaglie di gesso, piccoli ciottoli e frustuli ce-ramici e laterizi accuratamente compattati, sono stati evidenziati ampi tratti del livello stradale più antico, composto da roccia livellata (soprattutto nel settore sud-occidentale) e, dove il banco naturale è meno affiorante, da grossi basoli tondeggianti, appiattiti, accuratamente connessi. Lo strato 19195 ha restituito materiali ceramici e laterizi abbastanza numerosi, ma in condizioni estremamente frammentarie: si tratta di ceramica indigena dipinta e ingub-biata (tra cui due orli ingrossati di ciotole e un frammento di piede a disco), alcuni frammenti di vernice nera (tra cui un orlo di coppa e uno di coppetta databili tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.5, alcune anse e pareti di ceramica comune, alcuni frustuli laterizi, una scoria di ferro.
4 Per le strutture murarie presenti nel settore a Nord della porta ellenistica vd. Vaggioli in Gargini, Vaggioli 2002, 493-495; Gargini, Vaggioli. in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, 341-342.
5 Fr. di coppa a vernice nera. Orlo a breve tesa ingrossata. Pasta rossastra (M. 10R 5/6), dura, compatta, con minuti inclusi bianchi abbastanza frequenti; vernice nera (M. 10YR 3/1), semilucida, coprente, scrostata. Alt. max. cm 2,5; largh. max. cm 3,1. Il frammento, avvicinabile alla serie 2643 di Morel 1981, 199, pl. 62, è confrontabile con esemplari da Monte Iato (Studia Ietina IV 1991, 117, n. 530, tav. 16: 300 a.C. ca.) e da Montagna dei Cavalli (Castiglione 1997, 311, fig. 3, n. 16: fine IV sec. a.C.). – Fr. di coppetta a vernice nera. Orlo leggermente ingrossato e arrotondato.
139a-b
139a
139b
475entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
Di particolare difficoltà si è rivelata la distinzione tra il livello d’uso 19195 e il sottostante piano stradale 19204, nel quale i materiali sopra-stanti si sono spesso profondamente infissi, colmandone tutte le irrego-larità e rendendo poco chiara l’individuazione dell’interfaccia; si sono pertanto distinti i materiali relativi al contatto tra i due strati (attribuiti a US 19195/19204) da quelli riferibili con certezza allo strato sottostante (US 19204): dal primo proviene tra l’altro un frammento di coppetta o stemmed dish a vernice nera6 , dal secondo un piccolo frammento di piede a tromba, riferibile ad una coppa di tipo ionico b2, verosimilmente di produzione coloniale7.
Pasta grigiastra nel nucleo (M. 10R 4/1) e marrone-rossastra in superficie (M. 10R 5/4), dura, con rari e minutissimi inclusi bianchi; vernice da nera a marrone (M. 10R 2.5/1 - 5YR 4/3), semilucida, abbastanza coprente. Alt. max. cm 1,6; largh. max. cm 1,9. Simile al tipo C 20A della necropoli di Lilibeo, attestato tra fine IV e inizi III sec. a.C.: cfr. bechtold 1999, 63, tav. III, 36-37. Dallo stesso strato provengono anche altri reperti a vernice nera: 1 fr. di orlo indistinto leggermente estroflesso e 2 frr. di piedi ad anello di skyphoi, 1 fr. di piede a stelo di coppa, 1 fr. di parete con attacco di ansa a bastoncello di kylix.
6 Fr. di coppetta o stemmed dish a vernice nera. Orlo ingrossato, estroflesso e pendulo. Pasta rosso chiaro (M. 10R 6/8), dura, abbastanza compatta, con rari e minuti inclusi bianchi; vernice nero-grigiastra (M. 2.5Y 2.5/1), con riflessi metallici, coprente, piuttosto spessa. Alt. max. cm 1,2; largh. max. cm 2,1. In mancanza del piede, il frammento potrebbe essere attribuito sia ad una coppetta (confrontabile con de Cesare in Entella 1994, 177, n. 2, tav. XXVI, 6; Tardo 1999, 170, n. 231, fig. 170: produzione diffusa in ambito coloniale tra VI e V sec. a.C.; in particolare gli esemplari di Colle Madore si datano tra fine VI e inizi V a.C.; Del Vais 2003, 344, n. 135, fig. 285), sia ad uno stemmed dish (per il quale vd. de Cesare in Entella 1994, 173-174, n. 3 e tav. XXIV, 4: tipo convex and small, ricondotto a Sparkes, Talcott 1970, 304, n. 968, fig. 9: 500 a.C.; Del Vais 2003, 325, 343, n. 127, fig. 285: tipo convex and small, produzione siceliota del primo venticinquennio del V sec. a.C.); in generale, per una recente messa a punto sulla produzione e per una datazione di questa forma in ambito siciliano fino alla fine del V sec. a.C., cfr. Michelini 2002b, 166-168, e in particolare n. 6, tav. I (datato 500-480 a.C.; fino alla fine del V a.C.?). Dallo stesso strato provengono inoltre: 1 piccolo fr. di parete con decorazione a tremuli, di produzione corinzia; 1 fr. di orlo indistinto lievemente rientrante di skyphos ovoide, 1 parete di forma aperta (kylix ?) attica, 1 fr. di massiccio piede a stelo, molto consunto, forse di coppa di tipo C.
7 Fr. di coppa a vernice nera. Piede troncoconico a tromba, con largo appoggio e profilo esterno arrotondato; evidenti linee di tornio sulla faccia superiore del piede. Pasta grigia nel nucleo e arancio-rosata in superficie (M. 2,5YR 6/6), dura, compatta, saponosa, a frattura netta, con minutissimi inclusi biancastri a bassa frequenza; vernice nera (M. 10YR 2/1), semilucida, sottile, coprente, scrostata. Risparmiati l’interno del piede (ingubbiato), l’appoggio (tranne un filetto), la fascia laterale del piede. Alt. max.
139c139e
139c
139e
476 michela gargini - maria adelaide vaggioli
In tutto il settore sud-occidentale del cortile, nell’area prospi-ciente il tratto definito 19209-19210 del muro di terrazzamento meridionale, è significativamente elevata la quota a cui affiora il banco roccioso: qui esso sembra tagliato e regolarizzato per costituire sia il piano stradale, sia anche la fondazione del muro di terrazzamento stesso, come ha confermato la prosecuzione dello scavo dello stato giallastro di trubo/marna 19193 che copre la roccia 19199 e delimita il percorso viario a ridosso del muro. Gli scarsi materiali rinvenuti nello strato 19193 ne confermano la cronologia, già precedentemente indicata nella prima età ellenistica, in particolare nella seconda metà del IV sec. a.C.8: nella campagna 2005 sono stati raccolti, insieme ad alcuni frammenti di ceramica indigena ingubbiata e dipinta (tra cui orli di anfore o ciotole e di una oinochoe trilobata) e di ceramica comune, frammenti di vernice nera tra cui una parete di kylix di produzione attica e un frammento di fondo e piede di skyphos9.
Dal banco roccioso affiorante sono stati asportati anche gli ultimi resti di alcuni blocchi pertinenti forse al crollo (US 19155) del muro di terrazzamento meridionale, violentemente caduti sul piano stradale e in esso profondamente infissi, e talora saldati, a causa dello scio-glimento e poi del ricompattamento del gesso di cui sono composti. Nella parte sud-orientale del cortile, invece – dove il banco roccioso è meno evidente –, l’asportazione di alcuni blocchi disciolti e ricom-pattati non ha evidenziato roccia livellata, ma alcuni nuovi tratti di basolato, che, come quelli portati in luce in precedenza, sono disposti in discreta pendenza verso Est: si confermano quindi l’andamento
cm 1,9, largh. max. 1,7. Cfr. indicativamente Studia Ietina II 1984, 61, K 1693, Abb. 5, 2, taf. 28, 3 (terzo quarto del VI sec. a.C.); Michelini 1999, 120, fig. 129g; Tardo 1999, 167 n. 23 e fig. 166.
8 Vaggioli in Gargini, Vaggioli 2002, 481-482; Gargini in Gargini, Mi-chelini, Vaggioli 2006, 343.
9 Fr. di skyphos a vernice nera. Piede ad anello inclinato a sezione squadrata, con leggera risega sulla faccia interna e appoggio piano. Pasta arancio chiaro (M. 5YR 7/8), dura, compatta, con minuti vacuoli; vernice nera (M. 10YR 2/1), lucente, sottile, coprente, più diluita all’interno del piede; risparmiati appoggio, fondo esterno e un filetto all’attacco tra il fondo e l’esterno del piede. Alt. max. cm 1,7; largh. max. cm 2,8. Produzione attica o imitante prototipi attici; avvicinabile a Michelini in Parra et al. 1995, 49, fig. 30,5 (vicino a Morel 1981, 311, pl. 131, tipo 4373 b: ultimo quarto del IV sec. a.C.); Termini Imerese 1993, 126, n. 942, fig. 191; Polizzi 1997, 108, n. 7, fig. 5 (da Solunto, ultimo quarto del IV sec. a.C.); bechtold 1999, 66, varietà C, tipo SK 1C, n. 49, tav. V (da Lilibeo, 350-325 a.C.).
139f
139f
477entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
del tracciato viario più antico (US 19204) e la sua connessione con la porta della fase classica (e protoellenistica) che si apriva sul lato meridionale della torre10.
Lo scavo dei livelli stradali è stato concluso anche nell’area della porta ellenistica che si trova a Ovest del cortile: nello spazio intermedio tra i due muri delimitanti il passaggio (US 19165 a Nord e 19168 a Sud), è stato scavato 19201, livello d’uso stradale individuato alla fine della precedente campagna e distinto dal soprastante battuto 1919411 perché caratterizzato da ciottoli, pietre e frammenti laterizi e ceramici di dimensioni maggiori. Lo strato 19201 ha restituito numerosi frammenti di ceramica indigena ingubbiata e dipinta (tra cui 3 orli e 1 fondo di ciotole o coppette), vari di ceramica acroma (tra i quali 1 pomello di coperchio), alcuni frammenti di ceramica a vernice nera (tra cui un piede di skyphos12, un orlo di coppetta riferibile ad una tipologia derivata da prototipi attici di V sec. a.C. e am-piamente diffusa in ambito coloniale nel corso del IV13, e altri frammenti
10 Per questo basolato, in precedenza evidenziato solo nel settore settentrionale del cortile, cfr. Vaggioli in Gargini, Vaggioli 2002, 483-484; Gargini in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, 342.
11 Il piano d’uso 19194 costituisce la prosecuzione, nel settore della porta elle-nistica, dello strato 19195 presente nell’area del cortile.
12 Fr. di skyphos a vernice nera. Piede ad anello inclinato a sezione squadrata, con appoggio piano e risega all’attacco tra parete e fondo. Pasta giallina in superficie (M. 7.5YR 8/2) e grigia nel nucleo (M. 10R 7/1), abbastanza dura, compatta, con minutissimi inclusi bianchi, a media frequenza; vernice da nera a marrone (M. 10YR 2/1), opaca, sottile, coprente; appoggio e fondo esterno risparmiati. Alt. max. cm 2,2; largh. max. cm 3,8; diam. piede cm 6,8. Cfr. Epifanio 1982, 65, fig. 7, 56 (fine IV sec. a.C.); Vassallo 1990, 44, n. 14, fig. 14 (seconda metà IV-inizi III a.C.); Casti-glione 1997, 313-314. n. 46 e fig. 6 (seconda metà IV sec. a.C.); Zancle 1999, 111, z/32 (prima metà del IV sec. a.C.); burgio 2002, 131, nn. 84.23, 84.24, tav. XIII (seconda metà IV-inizi III a.C.).
13 Fr. di coppetta a vernice nera. Orlo indistinto, a labbro arrotondato e lieve-mente ingrossato all’interno. Pasta rossa (M. 10R 5/8), dura, compatta, con rarissimi e minutissimi inclusi bianchi; vernice nera (M. 2.5Y 2/0), opaca, sottile, coprente. Alt. max. cm 1,7; largh. max. cm 2,2. La forma ha una lunga tradizione, a partire da prototipi attici e di imitazione attica (per es. Tardo 1997, 88 e 91-92, n. 46, fig. 12, tav. II, 4: da Solunto, 500-480 a.C.; Kustermann Graf 2002, 235, 194/0805, tav. CXXX: da Selinunte, metà V sec. a.C.), fino alla fine del IV-inizi del III sec. a.C. (Epifanio 1982, 65, n. 16, fig. 7; Vassallo 1990, 103, n. 53, fig. 112-113, da Monte Chibbò, seconda metà V-inizi IV a.C.; bechtold in bechtold, Favaro 1995, 1065, n. 3, tav. CCXII, 3, da un contesto segestano databile tra fine V e inizi IV a.C.; Del Vais 1997a, 173, 180, n. 6, fig. 1; burgio 2002, 131, n. 84.20, tav. XIII; Corretti 2002, 440, fig. 49f, da Entella, ricondotta a tipi databili tra 375 e 350 a.C. ca.; Mi-
139g
139d
139g
139d
478 michela gargini - maria adelaide vaggioli
verosimilmente databili nel corso del tardo V-IV sec. a.C.14. Sono presenti inoltre alcuni laterizi, tra cui un frammento di tegola con dente curvilineo, che in base a numerosi confronti è databile in età classica15.
Lo strato 19201 costituisce, nel settore della porta ellenistica, il livello d’uso più antico, impostato sulla base sottostante, che qui – a differenza dell’area del cortile – è piuttosto disomogenea: essa infatti è costituita solo in parte dal banco roccioso affiorante (un grande lembo di roccia appiat-tita è stato evidenziato soltanto in prossimità del muro 19165), mentre in altre zone, dove la roccia 19199 si trova a quota inferiore, 19201 si appoggia sullo strato giallastro di marna/trubo che la ricopre (US 19198). Dunque il livello stradale 19201 ha spessore irregolare: minore dove il sottofondo è più solido, maggiore dove la quota inferiore e la minore consistenza dello strato sottostante hanno richiesto ripetuti rifacimenti, per compensare usure e affossamenti. Non è chiaro, al momento, se il battuto 19201 costituisca la pavimentazione originaria del settore della porta ellenistica, corrispondente al basolato 19204 rinvenuto nel cortile, o se invece in precedenza quest’ultimo proseguisse anche più a Ovest; è certo comunque che il battuto 19201 non si estende in tutta l’area del passaggio della porta, ma si interrompe bruscamente al termine dei recessi per i battenti: la mancanza, più oltre, di ogni traccia di pavimentazione relativa a questa fase non è al momento spiegabile, se non ipotizzando un
chelini 2002b, 181, nn. 56-57, tav. VI: IV a.C., piuttosto seconda metà del secolo; De Miro 2003, 106, n. 54, fig. 104: 375 a.C. ca., confrontata con Sparkes, Talcott 1970, 290, n. 757, fig. 8).
14 Si segnalano: un frammento, in pessimo stato di conservazione, di orlo di skyphos di tipo A simile a Sparkes, Talcott 1970, 260, n. 349, fig. 4 (400-375 a.C.); un fr. di piede di coppetta avvicinabile a Locri II 1989, 156, n. 129, tav. XXIV (inizio IV sec. a.C.); un fr. di orlo con interno risparmiato (con rivestimento rosato), perti-nente verosimilmente ad una coppetta simile a Michelini 1994, 272, n. 2, tav. LV, 2 (produzione siciliana derivante da prototipi attici, con numerose attestazioni in Sicilia in contesti di IV sec. a.C.), avvicinabile anche a Vaggioli 1995, 958-959, n. 3, tav. CLXXI, 2; per una sintesi sulla forma cfr., in generale, Michelini 2002b, 177.
15 Fr. di tegola piana con listello a profilo curvilineo. Alt. tot. cm 5,4; alt. piano cm 3. Il frammento, identico ad altri provenienti da US 19217 (vd. infra, 488-489), è confrontabile con laterizi rinvenuti in altri contesti siciliani databili tra l’età tardoarcaica e quella classica, tra cui Segesta (bechtold in bechtold, Favaro 1995, 1060, 3 e tav. CCIX, 1 (da uno strato di età classica, precedente alla metà-seconda metà del V sec. a.C.); Himera (Himera II 1976, 441-442, fig. 12,5: V sec. a.C.) e la stessa Entella (Vaggioli 1999, 61-62, fig. 67e (con bibl. di confronto).
143e
130
143e
479entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
più tardo intervento di ristrutturazione dell’area, che ha asportato i livelli più antichi scendendo fino al terreno sterile 19198.
8.2. Ambiente III e cinta muraria ad Ovest
Nell’ambiente III, scavato nel 2003 fino al livello corrispondente alla fase che precede l’impianto del sistema difensivo tardoarcaico e classico ora rimesso in luce, l’intervento si è limitato alla pulizia delle emergenze rimaste esposte, cioè la struttura muraria 19178 nella parte occidentale e il battuto pavimentale 19179 in quella orientale16. Mentre la prima – com-posta da blocchetti di gesso di dimensioni piccole e medie, saldamente connessi – non ha restituito alcun reperto, dalla seconda provengono due frammenti di pareti di pithoi di fabbrica indigena: l’uno ingubbiato, riconducibile a una produzione entellina, l’altro invece con caratteristiche non compatibili con quelle degli impasti fino ad ora riconosciuti come locali17.
Ad Ovest dell’ambiente III, è stato ripulito un tratto della cortina muraria che si dirige verso il bastione semicircolare (SAS 25): in particolare, si è meglio evidenziata la cresta dei muri 19167 e 19159, precedentemente solo individuati sul lato interno – cioè quello meridionale – della cinta dopo l’asportazione con un mezzo meccanico dello strato superficiale di humus (19000) e del sottostante strato di interro post-medievale (19106). Il muro 19167, perpendicolare alla cortina, ha un andamento grosso modo Nord-Sud e delimita ad Ovest lo spazio convenzionalmente definito ‘am-biente III’, impostandosi sopra la parte occidentale della struttura muraria 19178; il muro 19159 invece, normale al precedente, alla cui estremità meridionale sembrerebbe legarsi, si dirige dall’ambiente III verso Ovest, ma al momento non ne è ancora determinabile la lunghezza totale.
Procedendo verso Ovest, è stata ripulita la superficie dello strato di terreno giallastro (19214) rimasto in situ, dopo l’asportazione dei livelli post-medievali nelle precedenti campagne, sul lato interno della cinta; da tale pulizia provengono, oltre a scaglie di pietra e a qualche ciottolo,
16 Vaggioli in Gargini, Vaggioli 2002, 493-496, in particolare 494-495; Ead. in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, 341.
17 Per la tipologia degli impasti della ceramica indigena ingubbiata e dipinta di Entella vd. Gargini 1995, 111-113, per quelli della indigena incisa e impressa Di Noto 1995, 83-84.
480 michela gargini - maria adelaide vaggioli
pochi frustuli ceramici: una parete di forma chiusa in ceramica indigena ingubbiata e dipinta, un fondo con piede ad anello di forma aperta in cera-mica comune, una parete a vernice nera con banda risparmiata all’esterno, un’ansa a nastro di brocca o anfora medievale, con superficie schiarita.
Poco ad Ovest dei due muri 19167 e 19159, la pulizia ha rimesso in luce lungo la cinta muraria una sepoltura a fossa terragna (Tomba 1), già precedentemente individuata e non scavata. Nonostante fosse stata protetta con un piccolo accumulo di terra e pietre, essa è stata gravemente danneggiata dall’erosione: alcuni frammenti di ossa, soprattutto lunghe, sono stati raccolti non più in connessione anatomica, mentre parte del piede sinistro, seppure ancora in connessione, non risultava comunque più in giacitura primaria, per lo spostamento causato da una radice. Si è cercato, con grande difficoltà, di delimitare il taglio (19222) praticato nello strato 19214 per l’inserimento della tomba, e asportando uno strato di terra fine, di colore marroncino (19216), è stata evidenziata la parte rimasta dello scheletro, costituita dalla sola gamba destra, conservata dal piede a parte del femore. Il defunto era deposto in direzione Est-Ovest, con piedi ad Ovest, e giaceva in decubito dorsale su alcuni piccoli ciot-toli arrotondati e frustuli laterizi, disposti a formare una sorta di letto di deposizione, rinvenuti sul fondo della buca nella zona dove doveva trovarsi in origine la parte superiore, ora perduta, del corpo18. La presenza di tale elemento conferma che la sepoltura non è casuale, come avrebbero potuto suggerire la mancanza di corredo e la dispersione delle ossa19, ma è stata intenzionalmente scavata nello strato 19214, attualmente ancora da indagare ma comunque riferibile ad una fase di abbandono della cinta muraria, verosimilmente compresa tra il tardo ellenismo e l’età post-medievale. Per quanto la sequenza stratigrafica lasci dunque aperta, al momento, la possibilità che la tomba sia riferibile ad epoca medievale, tuttavia la posizione del defunto in decubito dorsale e l’orientamento – opposto rispetto a quello di tutti gli inumati di rito islamico fino ad oggi individuati ad Entella – ne rendono poco probabile la pertinenza alla fase di rioccupazione della Rocca da parte di genti musulmane tra
18 Lo studio antropologico della sepoltura è in corso da parte del dott. P.F. Fabbri, al quale va un sentito ringraziamento per queste informazioni preliminari.
19 La dispersione delle ossa sembra, piuttosto, spiegabile con una scarsa profondità della fossa, ed è stata certamente accentuata dall’erosione, come è stato possibile verifi-care almeno per quanto riguarda il periodo intercorso tra l’asportazione del soprastante strato 19106 (nel 2001) e l’ottobre 2005; è forse ipotizzabile anche l’azione di animali selvatici per spiegare la totale scomparsa di tutta la parte superiore del corpo.
131-132
481entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
la fine del X-inizi XI secolo e la metà del XIII20: infatti, benché siano comunque note nel mondo islamico sia sepolture con orientamento diverso da quello riscontrato costantemente ad Entella, sia deposizioni in decubito dorsale – per quanto molto meno numerose di quelle, cano-niche, sul fianco destro21 –, nel nostro caso sembra molto difficile che il defunto potesse avere comunque il volto rivolto in direzione della Mecca – unica condizione, questa, assolutamente irrinunciabile per un fedele di religione islamica –. bisogna ritenere, piuttosto, che si tratti o di una sepoltura medievale non di rito islamico, oppure di una deposizione di epoca successiva o precedente. L’orientamento richiama quello di alcune tombe scavate nella necropoli A, in particolare quelle riferibili al IV-prima metà del III sec. a.C.22, per quanto esse siano costantemente accompagnate da corredi; inoltre sembra poco ragionevole ipotizzare la collocazione di una sepoltura sulla cortina muraria in un’epoca in cui il sistema difensivo era ancora in funzione, come sembra sia rimasto almeno fino alla fine del II sec. a.C.23 Continuò ad essere utilizzata più a lungo, invece, la strada d’accesso alla città, il cui abitato si contrasse progressivamente nel settore meridionale del pianoro sommitale24: la via che saliva dal vallone Nor-dOvest rimase infatti in uso fino alla prima età imperiale, e potrebbe non essere incompatibile con tale frequentazione la presenza di una tomba ai suoi margini, tra le strutture della fortificazione ormai in disuso. In attesa di ricavare più puntuali indicazioni cronologiche dallo scavo dello strato 19214, al momento si può dunque ipotizzare soltanto che il defunto, non di fede islamica, sia stato deposto in una fossa di scarsa profondità scavata nello strato di abbandono della cortina muraria in un’epoca compresa tra il tardo ellenismo e la formazione dello strato 19106, successivo alla rioccupazione dell’area in epoca medievale.
Maria Adelaide Vaggioli
20 Per una sintesi delle vicende di Entella in età medievale cfr. recentemente Corretti et al. 2004 e, da ultimo, Corretti, Michelini, Vaggioli c.d.s.
21 Per attestazioni di sepolture in decubito dorsale e con orientamento diverso da quello riscontrato costantemente ad Entella cfr. Guglielmino 1995, 113-114 e bagnera, Pezzini 2004, 271-282, entrambi con bibliografia.
22 Di Noto 1999; Di Noto, Guglielmino 2002, 526-530; Fabbri 2002, 534.
23 Vaggioli in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, 345. 24 Per una sintesi delle ultime fasi insediative sulla Rocca di Entella in età im-
periale vd. da ultimo Vaggioli in Corretti et al. 2006, 575, con bibliografia citata a nota 64.
482 michela gargini - maria adelaide vaggioli
8.3. Settore a Sud della porta ellenistica
Nel settore a Sud della porta ellenistica, dove il banco roccioso risale rapidamente verso le estreme pendici di Pizzo Giustiziere, l’area è stata ripulita asportando l’abbondante strato di terreno scuro di formazione recente (US 19215) scivolato dalla sezione Sud dello scavo e insinuatosi in profondità in tutte le cavità e gli avvallamenti del banco di roccia affiorante rimasto esposto dopo la fine della campagna di scavo 2003. Lo strato, molto friabile, di colore nerastro, pieno di radici, ha restituito, insieme a reperti recentissimi che ne confermano la formazione posteriore al 2003 (lattine, bottiglie di plastica ecc.), materiali ceramici scivolati per dilavamento dall’area soprastante, tra i quali si ricordano: alcuni frammenti di ceramica indigena, sia incisa e impressa25 che ingubbiata e dipinta (tra cui si segnalano, in particolare, un frammento di orlo di bacino e uno di ciotola imitante prototipi greco-orientali26, un frammento di piede a disco di kotyle (?) di produzione corinzia, ceramica a vernice nera sia di fabbrica
25 Si tratta di 2 frr. di pareti (l’una con decorazione a bande di angoli multipli, l’altra con denti di lupo riempiti a rotella semplice, alternati a triangoli vuoti: cfr. Di Noto 1995, 80-81, motivi e2 di fig. 1 e c5 di fig. 2 ), oltre ad 1 orlo di bacino con due solcature esterne.
26 Fr. di bacino indigeno ingubbiato. Orlo ingrossato e arrotondato, a profilo esterno angolato, con presa a linguetta, spessa e impostata all’esterno dell’orlo. Pasta rosso-marrone in superficie (M. 2.5YR 5/6), grigia nel nucleo (M. 2.5YR 5/1), dura, compatta, con rari e minuti inclusi biancastri, rarissimi e minutissimi inclusi lucenti in superficie; ingubbiatura avorio-giallastro (M. 10YR 8/4). Alt. max. cm 5,6; largh. max. 17,7; diam. orlo cm 50,5. Il frammento, che trova confronto con un esemplare da Monte Maranfusa (Termini 2003, 238, n. 38, fig. 207: scodellone, seconda metà VI-primo quarto V a.C.), è avvicinabile anche a frammenti da Entella (Canzanella 1990, 500 n. 2 e tav. CX, 6; Gargini 1994, 135 n. 5 e tav. VIII, 5). – Fr. di ciotola indigena ingubbiata. Orlo indistinto, leggermente rientrante e a spigolo nella parte interna del labbro; ansa orizzontale a bastoncello, impostata all’esterno dell’orlo; piccolo bottoncino circolare applicato sull’esterno dell’orlo. Pasta grigia nel nucleo (M. 7.5YR 5/1) e arancio chiaro in superficie (M. 7.5YR 7/4), dura, compatta, con rarissimi e minuti inclusi arancio in frattura, minutissimi ma frequenti inclusi lucenti in super-ficie; tracce di ingubbiatura avorio (M. 10YR 8/3) all’interno e all’esterno. Alt. max. cm 4; largh. max. 9; diam. orlo cm 19,6. La forma è attestata a Monte Maranfusa: vd. Denaro 2003a, 295-296, n. 79, fig. 250 (ciotola biansata di produzione coloniale di derivazione greco-orientale, databile dalla seconda metà del VI al V sec. a.C.). Tra gli altri materiali di produzione indigena restituiti dallo strato, si segnalano inoltre alcuni orli: 1 di ciotola, 1 di anfora e 3 di bacili, uno dei quali con presa a linguetta.
139h-i
139h
139i
483entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
attica27 che coloniale28, un’ansa a nastro ingrossato, verosimilmente per-tinente ad un’anfora greco-italica, alcuni frammenti di ceramica acroma medievale29.
Soltanto nella parte inferiore dell’area, cioè quella più a Nord, a ridosso del muro 19168 che costituisce la delimitazione meridionale della porta ellenistica, rimosso lo strato di dilavamento recente non è affiorato direttamente quello che sembra il banco roccioso, ma si è evidenziato invece un lembo di stratigrafia. Verso l’estremità occidentale del muro, infatti, completata la pulizia è stata messa in luce una striscia di terreno giallastro, piuttosto compatto, che costituiva un residuo dello strato 19203, non totalmente asportato nel 2003. Completandone lo scavo30 è risultato evidente che verso Ovest tale strato si affossava, colmando una sorta di naturale avvallamento formato dal banco roccioso naturale proprio in corrispondenza della terminazione occidentale del muro 19168, presso il vecchio limite del saggio 2003.
All’estremità Est della porta ellenistica, nell’angolo formato dal rac-cordo tra la sua struttura meridionale 19168 e il muro di terrazzamento del cortile – nel suo tratto Nord-Sud definito 19210 –, sono state asportate, evidenziando meglio il filo Sud del muro 19168, alcune pietre ancora pertinenti a US 19162, strato già parzialmente scavato in precedenza31 e interpretato come crollo del muro 19168. Quest’ultimo lembo di 19162 ha restituito numerosi frammenti di ceramica indigena ingubbiata e dipinta (tra cui un orlo di anfora o hydria32 e una parete di grosso pithos decorato
27 Sono riconducibili a produzioni attiche 3 frammenti di kylikes raccolti a contatto con la sottostante US 19203, a cui ragionevolmente possono essere attribuiti: oltre ad 1 ansa a bastoncello, si tratta di 1 parete a figure nere che conserva parte di una piccola testa maschile a ds. con particolari graffiti e traccia di ritocchi in paonazzo, e 1 parete di floral band cup con parte di una catena a piccoli cerchi, entrambe databili tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C.
28 Tra la ceramica a vernice nera, si segnalano 2 frr. di piedi di skyphoi, 1 fr. di orlo di stemmed dish, 1 fr. di piede di coppa.
29 Si tratta di alcune anse e pareti di anfore o brocche, tra cui un frammento di vaso con filtro.
30 Da quest’ultimo lembo di US 19203 provengono 8 frammenti di ceramica indigena ingubbiata e dipinta (tra cui 2 orli di ciotole, 1 delle quali con presa a lin-guetta forata) e 1 fr. di tegola piana; ad essi devono essere aggiunti i frr. di ceramica figurata rinvenuti sulla superficie dello strato e asportati nel corso della pulizia: cfr. supra, nota 27.
31 Lo strato è stato individuato nel 2001.32 Fr. di anfora o hydria indigena ingubbiata e dipinta. Orlo estroflesso con labbro
139l
136
139l
484 michela gargini - maria adelaide vaggioli
con due fasce parallele in bruno), alcuni frustuli di pareti a vernice nera, oltre a un’ansa di skyphos, e un frammento di orlo di anfora di produzione greco-occidentale, riconducibile al tipo MGS II33.
Le pietre sottostanti risultano invece profondamente infisse, rivelando l’appartenenza a uno strato diverso, forse una struttura più antica (US 19227), composta da pietre non squadrate saldamente connesse, che mo-stra molte affinità con la muratura 19178 individuata a Nord della porta ellenistica, nell’ambiente III. Ad entrambe le strutture sono stati addossati i muri della porta ellenistica, ma, data l’analogia della tecnica muraria, esse sembrerebbero piuttosto riferibili ad una struttura inizialmente unitaria, che è stata successivamente tagliata nella sua parte centrale per realizzare il percorso stradale all’interno del varco di accesso, ed è stata riutilizzata invece a Nord e a Sud per addossarle i due muri della porta stessa.
A Sud del muro 19168, rimossi lo strato recente 19215 e il lembo residuo di 19203, è invece venuto in luce, accanto alla struttura 19227, uno strato (19225) di terreno marrone-giallastro, compatto, granuloso, con carboncini, granuli di gesso e frammenti ceramici. Per quanto di ridotta estensione, esso ha restituito – come già i soprastanti 19202 e 19203 – una notevole quantità di ceramica, in particolare di produzione indigena: 54 frammenti di dipinta e ingubbiata (tra cui ciotole, oinochoai e bacini, uno dei quali conserva tracce di lucidatura sull’orlo34), 10 pareti di ceramica
spiovente e angolato, a sezione triangolare. Pasta marrone (M. 5YR 4/2) nel nucleo e arancio rossastro (M. 2.5YR 5/6) in superficie, dura, abbastanza compatta, con minu-tissimi inclusi bianchi a media frequenza; ingubbiatura avorio (M. 2.5Y 8/2) su tutta la superficie, più scrostata all’interno; vernice all’esterno dell’orlo da marrone (M. 5YR 4/2) a marrone bruciato (M. 5YR 4/4); scarse tracce di fasce verniciate all’interno. Alt. max. cm 2,8; largh. max. cm 8,5; diam. orlo 18,6. L’esemplare, la cui frammentarietà non consente di determinarne con certezza la forma, trova confronti a Monte Chibbò (Vassallo 1990, 101, fig. 107, n. 28: anfora; il sito è databile tra seconda metà VI e fine V a.C.), ad Agrigento (De Miro 2000, n. 553, fig. 112 (hydria, fine VI-inizi V a.C.), a Monte Maranfusa (Campisi 2003, 199, n. 216, fig. 190: anfora o hydria), a Monte Saraceno di Ravanusa (Calì 2003, 104, n. 24 e fig. 22: hydria, fine VI-V sec. a.C.).
33 Fr. di anfora di tipo MGS II. Orlo indistinto, leggermente ingrossato e ap-piattito, arrotondato all’esterno; collo cilindrico. Pasta arancio-rosato (M. 5YR 6/6), dura, compatta, con rari minuti inclusi neri e minutissimi bianchi; tracce di sottile ingubbiatura arancio chiaro all’esterno e sull’orlo (7.5 YR 7/6). Alt. max. cm 3,8; largh. max. cm 7,3; diam. orlo cm 11,5. Riconducibile ad un’anfora a echino di produzione greco-occidentale (MGS II), morfologicamente avvicinabile a Corretti in Corretti, Capelli 2003, 294-295, nn. 22-23, tav. LIV (tipo attestato a Entella, con varianti, dalla seconda metà del V agli anni finali del IV sec. a.C.).
34 Fr. di bacino indigeno. Orlo ingrossato, pendulo, a sezione triangolare. Pasta
140a
133-134
140b
140a
140b
485entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
d’impasto con tracce di esposizione al fuoco, 8 frammenti di ceramica comune tra cui un orlo di mortaio35, un peso da telaio troncoconico con foro passante, una parete forse pertinente a uno skyphos a bande, alcuni frammenti di vernice nera (tra cui un piede di kylix36, due orli indistinti di skyphoi o kylikes e un orlo con attacco del collo di brocca o anfora37). Si tratta, sostanzialmente, di un nucleo omogeneo di materiali testimonianti una intensa frequentazione di questa zona in età arcaica, ai quali si asso-
grigio scuro nel nucleo (M. 10YR 5/1) e arancio-rosato in superficie (M. 2.5YR 6/6), dura, ruvida, abbastanza compatta, con inclusi bianchi medi, a media frequenza; tracce di lucidatura sull’orlo esterno. Alt. max. cm 3,9; largh. max. cm 8,7; diam. orlo cm 38.
35 Fr. di mortaio in ceramica comune. Orlo a tesa pendula, con estremità rivolta verso il basso e assottigliata. Pasta da marrone (M. 5YR 5/4) a rosata (M. 2.5YR 6/6), molto dura, compatta, ruvida al tatto, con rari vacuoli, minutissimi inclusi bianchi e neri piuttosto frequenti; tracce di ingubbiatura gialla (M. 2.5Y 8/4) sulla superficie interna della vasca e sopra l’orlo; esterno non visibile per incrostazioni. La parete interna della vasca è resa ruvida da grossi inclusi grigiastri affioranti. Alt. max. cm 4,8; largh. max. cm 7,1. Affine ad esemplari attestati a Maranfusa (Termini 2003, 244, n. 63, fig. 208: fine VI-primi decenni V sec. a.C.) e Himera (Himera II 1976, 554, n. 1).
36 Fr. di kylix di tipo C. Piede troncoconico a stelo, con lieve spigolo nella parte superiore e largo appoggio. Pasta arancio (M. 5YR 6/6), dura, compatta, con rari e minutissimi inclusi bianchi; scarse tracce di vernice nera sulla parte superiore del piede. Alt. max. cm 1,7; largh. max. cm 7,9; diam. piede cm 8. Cfr. Studia Ietina IV 1991, 38, nn. 96-97, tav. 4 (ultimo quarto VI-prima metà V sec. a.C.); Guglielmino 1997, 942, tav. CLXXXVII, 10; de Cesare in Entella 1994, 179, n. 4 e tav. XXVI, 11, con ampia bibl. di confronto; biondi 1995, 1181-1182, n. 5 e tav. CCLXVI, 5: fr. con iscrizione, databile tra fine VI e metà V sec. a.C.
37 Fr. di anfora o brocca a vernice nera. Orlo a tesa orizzontale, con labbro ingrossato e rialzato segnato all’esterno da due solcature; collo cilindrico. Pasta grigia nel nucleo (M. 5YR 5/1) e rosso chiaro in superficie (M. 2.5YR 6/4), dura, compatta, con rari e minutissimi inclusi bianchi; vernice da nera a marrone (da M. 5YR 2.5/1 a 2.5YR 3/2), opaca, sottile, diluita all’interno e sulla parte superiore della tesa. Alt. max. cm 1,8; largh. max. cm 4; diam. orlo cm 8. Il frammento, che non trova confronti puntuali nella tipologia di Morel 1981, è avvicinabile ad anforette dalla necropoli A di Entella, che sono state ricondotte ad una produzione variamente articolata nelle forme. In particolare, il nostro frammento è simile ad un tipo che è stato confrontato con esemplari della necropoli di Libertinia, datati alla seconda metà del IV sec. a.C. (Michelini 1992, 465, tav. LIII, 2, con bibliografia precedente); frammenti simili provengono da altri contesti siciliani: cfr. per es. Epifanio 1982, 67-68, fig. 7, 1 e 11 b (olpe da Cozzo Mususino); Vassallo 1990, 44, n. 16, fig. 15 (da Cozzo Tutusino, fine IV sec. a.C.); bechtold in bechtold, Favaro 1995, 1088-1089, 4 e tav. CCXVIII, 7 (da Segesta, anforetta (?) o brocca di produzione locale/regionale, ricondotta al tipo 5472 a1 o alla serie 5380 di Morel 1981, 367, pl. 173 e 357-358, pl. 166-167, datati rispettivamente al 300 +/-20 a.C. e alla seconda metà IV-inizi III).
140c
140e140f
140c
140e
140f
486 michela gargini - maria adelaide vaggioli
ciano sporadiche attestazioni di interventi riconducibili alla seconda metà del IV sec. a.C.: una situazione analoga a quella riscontrata in precedenza negli strati soprastanti (US 19202, 19203)38, e che era stata ipoteticamente ricondotta all’azione di taglio dei livelli più antichi effettuata nei decenni finali del IV secolo per l’inserimento della porta ellenistica. Tale ipotesi potrebbe trovare anche in questo nuovo strato una conferma.
Sotto a 19225, è affiorato uno strato caratterizzato da evidenti tracce di bruciato, sulla cui superficie si distinguevano frammenti ceramici di discrete dimensioni, tra cui una porzione di orlo di pithos. Si tratta vero-similmente di un piano d’uso, al cui livello lo scavo in questo settore si è al momento arrestato.
Michela Gargini
8.4. Ampliamento ad Ovest della porta ellenistica
Oltre alle verifiche e agli approfondimenti in settori già preceden-temente oggetto di indagine, la campagna 2005 è stata finalizzata alla realizzazione di un consistente ampliamento dello scavo ad Ovest della porta ellenistica, per verificare la prosecuzione del percorso stradale che si dirige verso l’interno della città e l’eventuale presenza di altre strutture murarie. Dopo un’attenta osservazione dell’andamento del terreno e della sezione stratigrafica esposta ad Ovest della porta ellenistica, si è ritenuto opportuno realizzare tale estensione con un mezzo meccanico. L’ampliamento, effettuato procedendo verso Ovest con passaggi successivi, ha interessato globalmente un più ampio settore rettangolare di m 8,20 Nord-Sud x 7 ca. Est-Ovest e, ad Ovest di esso, un settore più ristretto, di m 5,50 Nord-Sud x 7 Est-Ovest. Nel primo, nella cui parte meridionale il banco roccioso affiora a quota assai elevata, la stratigrafia antropizzata è stata asportata per buona parte con mezzo meccanico; nel secondo, l’escavatore si è arrestato invece al livello di abbandono post-antico.
Iniziando dalla sezione del saggio 2003 e procedendo verso Ovest, si è cominciato così ad asportare l’humus 19000, cui hanno fatto seguito un livello composto da un’altissima percentuale di ciottoli (19034) e poi uno strato di abbandono post-medievale (19106) che ha restituito
38 Per lo scavo di tali strati nella campagna 2003 cfr. Vaggioli in Gargini, Vaggioli 2002, 496.
135
487entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
numerosi materiali, tra i quali si segnalano soltanto un frammento di stelo e attacco del piede di grossa kylix (di tipo C?) con scarse tracce di vernice nera, un orlo a fascia di anfora medievale con superficie schiarita, numerosi frammenti di tegole con dente curvilineo, alcuni dei quali con incastro nella parte inferiore. Dal settore più occidentale, è significativo il rinvenimento di un’anforetta quasi completamente ricostruibile: si tratta di un esemplare di piccole dimensioni (alt. cm 20,6 ca.), mancante delle anse, di parte dell’orlo e del collo e con una piccola lacuna sulla spalla. L’orlo (diam. cm 8,5) è a fascia, il collo largo e cilindrico, la spalla inclinata, il ventre globulare, il fondo con basso piede ad anello a profilo esterno continuo con la parete (diam. cm 8,2); sul collo e nel punto di massima espansione della spalla si riconoscono gli attacchi delle anse. L’esemplare è solo indicativamente avvicinabile al tipo Ardizzone D, e in particolare alla variante D1, pur differenziandosene per le minori dimensioni e per l’accentuata rotondità del ventre: caratteri che lo avvicinano piuttosto ad una anforetta rinvenuta a Piazza Armerina, anche se per il momento il reperto entellino resta privo di confronti precisi39.
Sotto a US 19106, in asse con il percorso stradale precedentemente individuato attraverso lo spazio della porta ellenistica, è venuto in luce uno strato marrone-grigiastro, composto da ciottoli, pietre e frr. laterizi disposti di piatto. Si tratta della prosecuzione del percorso medievale, già individuato più ad Est e definito US 19171 nel settore della porta elleni-stica, 19146 nel cortile, 19040 nell’area all’interno della porta medievale e 19147 (con rifacimento 19117) all’esterno di essa40. La quota di questo nuovo tratto, più elevata di un metro rispetto a quella immediatamente all’interno della porta medievale, ha permesso di confermare l’andamento della strada individuata in precedenza, ricostruendo un percorso che, più ripido all’esterno del varco di accesso e in lieve pendenza al suo interno, saliva in direzione Ovest verso il centro della città.
Sotto al piano di calpestio medievale, è emerso uno strato di terra scura con alcuni ciottoli (US 19228), interpretabile come livello di ab-
39 Ardizzone 1999, 25, tipo D, variante D1, per la quale vd. D’Angelo s.d., 60, n. 1, fig. 8 (dalle volte della zisa, contesto di XII secolo); barresi 2006b, 146 (XII-XIII sec.) L’esemplare entellino (inv. E 6586), che ha un impasto marrone-rossastro (M. 10R 5/4), duro, ruvido, con inclusi bianchi e bruni di piccole e medie dimensioni a bassa frequenza, presenta una ingubbiatura di colore biancastro (M. 2,5Y 7/4).
40 Per la descrizione del percorso stradale medievale precedentemente individuato, cfr. Gargini 1999, 95-96; Ead. in Gargini, Vaggioli 2002, 467, 469-472; Vaggioli in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, 345-346.
137
488 michela gargini - maria adelaide vaggioli
bandono postantico; da esso provengono, tra l’altro, anche alcuni reperti di età medievale, comprendenti frammenti di anse, di fondi con piedi ad anello e di un orlo indistinto con ansa complanare a bastoncello, relativi a brocche o anfore acrome.
Segue poi un consistente livello di colore più chiaro, composto da terra marrone mista ad una altissima percentuale di pietrame di piccola pezzatura e di forma irregolare e di ciottoli di medie e piccole dimensioni, oltre che ad alcuni blocchi gessosi erratici e a numerose scaglie di gesso disciolto e percolato, che conferisce una colorazione biancastra a tutto lo strato. Di consistenza incoerente e di spessore irregolare – minore ad Est e invece notevole nella parte centrale dell’ampliamento –, questo strato, che è stato definito US 19217, è in pendenza da Sud verso Nord e da Ovest verso Est; la sua estensione comincia poco ad Ovest del limite occidentale dello scavo 2003 e comprende tutta l’area interessata dall’ampliamento eseguito con il mezzo meccanico, proseguendo oltre i suoi limiti meridionale e occidentale. Lo strato si caratterizza, oltre che per la colorazione biancastra assunta dal terreno in presenza di gesso disciolto, per una notevole quantità di frammenti laterizi – coppi semicircolari e tegole piane con listello curvi-lineo – dei quali è stata effettuata una campionatura sulla base dei diversi profili41. È interessante osservare che, pur con lievi varianti, i listelli delle tegole sono tutti dello stesso tipo (curvilineo, non particolarmente schiac-ciato né allungato), e le dimensioni degli esemplari, con scarti nell’altezza compresi entro 0,6 cm per quanto riguarda il piano e 1,1 cm per il listello, sembrano compatibili con la messa in opera su uno stesso tetto, o rivelano comunque una cronologia di produzione piuttosto omogenea. Inoltre, due delle tegole campionate sono assolutamente identiche a quella rinve-nuta nel battuto stradale 19201: la sua datazione in età classica (V-prima metà del IV sec. a.C.) sembra trovare conferma, oltre che dal contesto di scavo, da numerosi confronti42. Tutto ciò potrebbe suggerire l’ipotesi che
41 Gli esemplari campionati di tegole piane hanno un’altezza totale compresa tra cm 4,6 e 5,7 e un’altezza del piano variabile da cm 2,5 a 3,1. I due frammenti dei quali in questa sede si illustra il profilo sono confrontabili rispettivamente: il primo con esemplari da siti classici del territorio imerese (Himera III 1988, 154, fig. 148,3; 160, fig. 156) e con un frammento da Entella (Vaggioli 1999, 61-62, fig. 67d), il secondo con reperti da Segesta (bechtold in bechtold, Favaro 1995, 1060-1061, tav. CCX, 1: da un contesto precedente la metà-seconda metà del V sec. a.C) e da Himera (Himera II 1976, 441-442, fig. 12,4: V sec. a.C.) e dal suo territorio (Himera III 1988, 185, fig. 185: da un sito di VI-V sec. a.C.).
42 Vd. supra, nota 15 e testo relativo.
143f
143g
489entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
i materiali di copertura contenuti nello strato provengano tutti da uno stesso contesto, posto in opera in epoca classica e del quale non si può, al momento, valutare la durata, in considerazione dei ripetuti riutilizzi a cui i laterizi erano comunemente soggetti. Per quanto riguarda invece i reperti ceramici – assai numerosi – restituiti dallo strato, bisogna rilevare in primo luogo l’alta percentuale di materiali residui, sia di epoca arcaica e classica che ellenistica: ceramica indigena incisa e impressa43 e ingub-biata e dipinta (tra i numerosi frammenti, un orlo di ciotola e quattro di bacino, uno dei quali trova un preciso confronto a Monte Maranfusa44, un peso da telaio parallelepipedo con foro passante, con faccia superiore decorata da un piccolo cerchio inciso con tre raggi, un’ansa a bastoncello di kotyle corinzia, due frammenti di arula della stessa tipologia di un esemplare rinvenuto in precedenza nel riempimento del torrione di età classica prospiciente alla porta urbica45, numerosi frammenti a vernice nera, tra cui sono degni di nota un orlo di coppa o stemmed dish46,
43 Si segnalano 1 orlo indistinto e 1 fr. di parete carenata di forma aperta, deco-rato con cerchielli concentrici entro spazio triangolare delimitato da triangoli rigati e denti di lupo riempiti a reticolo: cfr. Di Noto 1995, 80-81, motivi a1 di fig. 2, e1 e g3 di fig. 1.
44 Fr. di orlo e vasca di bacile indigeno ingubbiato. Orlo ingrossato e arrotondato all’esterno, vasca a profilo convesso. Pasta grigia nel nucleo (M. 2.5YR 5/1) e arancio-rosato in superficie (M. 2.5YR 6/8), molto dura, abbastanza compatta, con minuti vacuoli, rari e minutissimi inclusi lucenti; tracce di ingubbiatura avorio giallastro (M. 10YR 8/3) all’esterno. Alt. max. cm 4,2; largh. max. cm 7; diam. orlo 38. Il frammento trova confronto a Monte Maranfusa: vd. Termini 2003, 238-240, nn. 42-43, fig. 207 (scodelloni, seconda metà VI-primo quarto V sec. a.C.).
45 I due frr. di arula, con coronamento aggettante a fascia rilevata nella parte superiore, a sezione squadrata, delimitante verosimilmente uno spazio per offerte, conservano tracce di ingubbiatura avorio sulla superficie esterna e sono analoghi ad un esemplare edito da Gargini in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, nota 152, 364 e fig. 179 g, per il quale cfr. reperti da Himera (belvedere 1982, 81-82: fine V sec. a.C.; 103-105: 430-409 a.C.; 85, fig. 20, nn. 121, 178) e da Agrigento (De Miro 2000, 234, n. 1327, fig. 125: seconda metà VI sec. a.C.).
46 Fr. di di coppa o stemmed dish. Orlo leggermente rientrante, ingrossato e arrotondato all’esterno, distinto dalla vasca da una solcatura sulla superficie esterna; vasca a profilo convesso. Pasta arancio-marrone (M. 5YR 5/4), dura, compatta, con rari e minutissimi inclusi bianchi, rossastri e lucenti; vernice nera (M. 2.5/N), opaca, sottile, diluita all’esterno e scrostata. Alt. max. cm 4,1; largh. max. cm 6,3; diam. orlo cm 10. Cfr. vari esemplari da Entella: de Cesare in Entella 1994, 117, n. 3, tav. V, 2; 224, 4, tav. XL, 14; 245, n. 13, tav. XLVI, 6 (con diametro maggiore); cfr. inoltre, da Maranfusa, Del Vais 2003, 341, n. 119, fig. 284 (tipo convex and small di produzione coloniale, datato tra gli ultimi decenni del VI e i primi del V sec. a.C.).
140d
143a-d
140g
140d
143a-d
140g
490 michela gargini - maria adelaide vaggioli
un piede di kylix di tipo C rinvenuto a contatto con lo strato sottostante47, tre coppette48, un fondo di coppa con doppio cerchiello inciso e palmetta impressa49. Abbondante anche la ceramica comune, rappresentata in par-
47 Fr. di coppa a vernice nera. Piede a stelo, ingrossato all’esterno, con appoggio piano e lieve spigolo nella parte esterna. Pasta arancio-rosato (M. 2.5YR 6/4), mol-to dura, compatta, con frequenti minutissimi inclusi scuri; vernice nera (M. 1 For Gley 2.5/N), semilucida, diluita, poco uniforme, scrostata; appoggio e parte esterna risparmiati. Alt. max. cm 1,7; largh. max. cm 6,4; diam. piede cm 8. Il frammento è confrontabile con coppe di tipo C da Caulonia (Tréziny 1989, n. 120, fig. 36, V sec. a.C.) e Colle Madore (Tardo 1999, 194, n. 343, fig. 192: produzione coloniale, fine VI-primi decenni V sec. a.C.).
48 Fr. di coppetta a vernice nera. Orlo indistinto all’interno e leggermente ingrossato all’esterno, con labbro assottigliato; vasca a profilo continuo all’interno e con leggera carenatura all’esterno. Pasta grigia nel nucleo (M. 10R 5/1) e marrone-rosato (M. 10R 6/4) in superficie, dura, compatta, liscia, con rari e minutissimi inclusi bianchi; vernice nera (M. 3/N), opaca, sottile, coprente, scrostata all’esterno. Alt. max. cm 2,4; largh. max. cm 3,3. Cfr. Michelini in Parra et al. 1995, 47, fig. 28, 9-10 (simile ad una forma attestata a Ordona, ultimo terzo del IV sec. a.C.: cfr. Morel 1981, tipo 2631a, 196, pl. 61). – Fr. di coppetta a vernice nera. Orlo indistinto, lievemente ingrossato, labbro arrotondato; bassa vasca a profilo convesso; largo piede ad anello, inclinato, con appoggio piano. Pasta grigia nel nucleo (M. 2.5YR 6/1) e arancio-rosato (M. 2.5YR 6/6) in superficie, dura, abbastanza compatta, con rari inclusi bianchi e lucenti, minutissimi; vernice rossastra (M. 10R 5/6), opaca, sottile, coprente, scrostata all’interno e quasi completamente perduta all’esterno; appoggio ed esterno del piede risparmiati. Alt. cm 2,8; largh. max. cm 4,9; diam. orlo cm 6,2; diam. piede cm 6. Molto simile ad un esemplare da Mozia: Michelini 2002b, 181, n. 60, tav. VI (IV sec. a.C., riferita a Morel 1981, 241, pl. 82: serie 2971, produzione della Sicilia e dell’Italia meridionale del IV sec. a.C.). – Fr. di coppetta a vernice nera. Orlo legger-mente rientrante all’interno, a breve tesa, a sezione triangolare, con labbro assottigliato. Pasta da rosata (M. 10R 5/3) a grigia (M. 10R 5/1), dura, compatta, liscia, con inclusi bianchi minuti e minutissimi ad alta frequenza; vernice nera (M. 3/N), opaca, sottile, coprente, scrostata. Alt. max. cm 1,4; largh. max. cm 1,8. Cfr. biagini 1995, 1161, n. 2 e tav. CCLVI, 1 (da un contesto segestano compreso cronologicamente tra V e III sec. a.C.); Corretti 2002, 442, fig. 61 (da Entella, riconducibile alla serie 1514, tipica di produzioni dell’Italia meridionale e della Sicilia intorno al 300 a.C.: Morel 1981, 118, pl. 20).
49 Fr. di coppa a vernice nera. basso piede ad anello lievemente inclinato, con breve appoggio piatto, solcatura all’esterno tra il piede e la vasca, spigolo sul fondo esterno; sul fondo interno doppio cerchiello inciso e palmetta radiale con volute e 5 foglie, impressa. Pasta grigia (M. da 10Y R 7/1 a 6/1), molto dura, compatta, liscia, depurata; vernice nera (M. 10YR 3/1), semilucida, sottile, coprente, aderente; appoggio risparmiato, fascia verniciata tra faccia interna del piede e fondo esterno e risparmio sul fondo esterno oltre lo spigolo. Alt. max. cm 1; largh. max. cm 4,6; diam. piede cm 5,8. La forma ricorda quella di altri esemplari rinvenuti ad Entella: cfr. per es. Gargini in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, 365, nota 157 e fig. 180m, con riferimento a
140h141a-c
142a
140h
141a
141b
141c
142a
491entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
ticolare da numerosi vasi per la preparazione, come bacini e mortai: tra essi si riconoscono due esemplari di bacini ellenistici con orli a tesa (uno dei quali con ansa orizzontale applicata50), ed altri di forma e cronologia varia51 ; ad essi si affiancano contenitori da conserva di grandi dimensioni, rappresentati da cinque frammenti di orli a tesa e tre di fondi di pithoi; sono attestate, inoltre, alcune anfore, tra cui si riconoscono due orli moda-nati riferibili ad un tipo ben noto ad Entella in contesti protoellenistici52.
Parra, Michelini 1988, 1512, tav. CCLXXX, 1 (inseribile nella serie n. 803-808 di Sparkes, Talcott 1970, 293-294, fig. 8, databile tra 380 e 310 a.C.). Per la palmetta cfr. indicativamente ibid., 309, n. 1051, pl. 59 (375-350 a.C.).
50 L’esemplare è riconducibile ad un tipo ben noto ad Entella: cfr. Michelini in Parra et al. 1995, 54, fig. 34, 4-8, con bibliografia.
51 Fr. di bacino o mortaio in ceramica comune. Orlo a tesa leggermente ricurva e pendente, labbro arrotondato, vasca a profilo convesso con lieve carenatura esterna. Pasta grigia nel nucleo (M. 2.5YR 5/1) e arancio-rosato in superficie (M. 2.5YR 6/8), dura, compatta, con rari e minuti inclusi bianchi. Alt. max. cm 4,5; largh. max. cm 6,3. Morfologicamente molto vicino ad un esemplare di Mozia: Vecchio 2002, 234, tav. 24, 1, tipo 78, confrontato con reperti di Kaulonia e Himera di fine VI-inizi V a.C.). La forma, attestata già in età arcaica (Allegro, Vassallo 1992, 92, n. 38, fig. 3), prosegue in epoca ellenistica (cfr. De Miro 2000, 231, n. 1303, fig. 114: IV-III sec. a.C.; Himera III 2002, 328, n. 175.8, fig. 240, da un insediamento ellenistico). – Fr. di bacino in ceramica comune. Orlo a larga tesa pendente, con labbro squadrato; alla sommità largo cordolo appena distinto, superiormente appiattito; due lievi solca-ture sulla faccia inferiore, una solcatura su quella superiore; vasca a profilo convesso. Pasta arancio (M. 2.5YR 6/8), dura, compatta, con inclusi grigi minutissimi a media frequenza e medi rari. Alt. max. cm 5,6; largh. max. cm 15,2; diam. orlo cm 36,5. Cfr. Epifanio 1982, 69, fig. 15, 2 e fig. 16 (da un insediamento di età timoleontea e agatoclea); de Cesare in Entella 1994, 171, n. 13, tav. XXV, 1 (fine IV-inizi III a.C.); per la forma avvicinabile anche a Lancel 1987, 105, 151b1, pl. 4 (da byrsa, IV sec. a.C.); ibid., 107, 172b1, pl. 7 (III sec. a.C.); Locri II 1989, 297, n. 347 e tav. XXXIX (tipo H2a, tardo IV e III sec. a.C.); Vaggioli 1995, 936, n. 2, tav. CLXVI, 6; Del Vais 1997b, 194, A4, fig. 1: (da Marineo, con bibliografia di confronto da contesti siciliani di IV-III sec. a.C.); Finocchi 2003, 41-42, tipo 5 (con altri confronti in ambito sardo, IV-III sec. a.C.). – Fr. di bacino in ceramica comune. Orlo a tesa pendente e lievemente ricurva, sommità piatta e labbro arrotondato, vasca a profilo convesso. Pasta rosata (M. 2.5YR 6/6), dura, compatta, con rari inclusi bianchi minuti e minutissimi, lucenti minutissimi a media frequenza. Alt. max. cm 4,1; largh. max. cm 10,7; diam. orlo 35. Avvicinabile a Del Vais 1997b, 187, 194, n. 4, fig. 1 (da Marineo, forma tipica della Sicilia ellenistica); burgio 2002, 126, n. 80.4, tav. XI; Vecchio 2002, 234-236, tav. 25.1 (da livelli moziesi di IV-III sec. a.C., confrontato con esemplari di seconda metà V e IV-III sec. a.C.).
52 Fr. di anforetta in ceramica comune. basso orlo estroflesso, ingrossato e sagomato all’esterno, superiormente appiattito, con faccia interna concava. Pasta arancio (M. 5YR 6/6), dura, abbastanza compatta, con inclusi lucenti molto frequenti e minuti. Diam.
141d, f-g
142b-c
141d
141f
141g
142b
492 michela gargini - maria adelaide vaggioli
Ma nello strato sono presenti anche elementi più recenti, diffusi in epoca tardo-repubblicana e nella prima età imperiale: un orlo di patera a vernice nera che trova un puntuale confronto a Luni53, frammenti di anfore – tra cui un puntale e un’ansa di Dressel 1, manufatti con un impasto ricco di inclusi augitici, tipico dell’area tirrenica –, alcuni massicci piedi a disco con solcature sulla faccia inferiore, pertinenti a mortai; a tale forma è riferibile inoltre un esemplare che conserva l’intero profilo54.
Alla stessa epoca appartengono poi alcune ceramiche da cucina, tra cui pentole o tegami con orlo a tesa55.
orlo cm 16; alt. max. 2,4. – Fr. di anforetta come la precedente, da cui si distingue per l’orlo meno schiacciato. Pasta come la precedente. Diam. orlo cm 20; alt. max. 2,5. Per la tipologia di entrambi i frammenti si rimanda, in generale, a Michelini in Parra et al. 1995, 56 e fig. 38, 1-3; per il profilo vd. in particolare Michelini 1994, 268, n. 10, tav. LIII, 10.
53 Fr. di patera a vernice nera. Orlo a tesa orizzontale con labbro assottigliato; bassa vasca rettilinea, con carena all’esterno sotto la tesa. Pasta da grigia (M. 2.5YR 4/1) a rossastra (M. 2.5YR 5/6), dura, compatta, depurata; vernice nera (M. 2.5Y 2.5/1), opaca, sottile, coprente. Alt. max. cm 1,3; largh. max. cm 4,6; diam. orlo cm 22,4. Il frammento trova puntuale confronto in un esemplare di Luni (Luni II 1977, 97, tav. 72, 3) ricondotto alla forma Lamboglia 36, diffusa nel II e ancora nel I sec. a.C. (Lamboglia 1952, 183); è inoltre avvicinabile a frammenti rinvenuti in contesti siciliani di età medio-tardoellenistica: Epifanio 1982, 67, n. 12, fig. 7; Vaggioli 1995, 893, n. 2 e tav. CLIX, 2.
54 Fr. di mortaio in ceramica comune. Orlo indistinto, lievemente ingrossato e squadrato, superiormente appiattito; bassa vasca tronco-conica; fondo piano con sol-cature concentriche sulla base di appoggio. Pasta arancio-rosata (M. 2.5YR 6/6), dura, compatta, con minuti inclusi bianchi e scuri a media frequenza. Alt. cm 8,9; diam. orlo cm 38; diam. piede cm 28,6. benché non trovi al momento confronti puntuali, l’esemplare è avvicinabile a Lancel 1987, 105, 151c2, pl. 4 (da byrsa, secondo quarto del II sec. a.C.; Olcese 1993, 133, 296, n. 335, figg. 20, 77 (bacino, da uno strato da Albintimilium di fine I sec. a.C.-prima età augustea).
55 Fr. di di pentola in ceramica comune. Orlo leggermente rientrante, a tesa incurvata verso il basso, con labbro squadrato; parete verticale. Pasta grigia nel nucleo (M. 2.5YR 5/1) e arancio-rosata all’esterno (M. 2.5YR 6/8), dura, con numerosi piccoli vacuoli e minutissimi inclusi bianchi a bassa frequenza. Alt. max. cm 5; lar-gh. max. cm 11,6; diam. orlo 24. Il frammento, molto vicino ad un esemplare da bolsena (Bolsena 1995, 178, n. 454, fig. 55: marmitta, I a.C.-prima metà I d.C.?), è avvicinabile anche a reperti da Akrai (Pelagatti 1970, 488, fig. 75 c: profilo tipico del II-I sec. a.C.), Cosa (Dyson 1976, 117, fig. 43, n. 22-II-12: casseruola, con tesa più lunga e curva, da un contesto databile all’età di Caligola-primi anni di Claudio), Luni (Luni II 1977, 392, tav. 196, 6, con confronti datati nella prima metà del I sec. d.C.), Albintimilium (Olcese 1993, 219, nn. 105, 106, 107: da metà I sec. a. C. a età augustea), Cartagine (Fulford, Peacock 1994, 60, 10, fig. 4.5, 10.2: dalla seconda
142d
141e
142e-f
142c
142d
141e
142e
493entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
La cronologia dello strato 19217 è determinabile con una certa pre-cisione perché, oltre alle indicazioni fornite dai numerosi reperti ceramici, ha restituito una moneta, un asse di Panormo del tipo coniato da Tiberio per il Divus Augustus, datato al 15-16 d.C.56. Questa emissione – una delle più tarde della zecca di Panormo – restò in uso almeno fino alla metà del I sec. d.C., ed effettivamente le tracce di usura riscontrabili sull’esemplare entellino ne confermano la circolazione per un periodo abbastanza lungo, che potrebbe essere analogo a quello degli esemplari rinvenuti a Monte Iato in strati di distruzione datati intorno alla metà del I sec. d.C.57.
Lo strato 19217 è stato asportato completamente con l’escavatore nel settore più esteso dell’ampliamento, mentre nella parte più occidentale,
metà del I agli inizi del II sec. d.C.), Segesta (Michelini 1995, 824-825 n. 13 e tav. CXL, 2, con ampia bibliografia di confronto tra II e I sec. a.C.), Ercolano (Scatozza Höricht 1996, 139-140, fig. 4, 3); Pompei (Di Giovanni 1996, 84-86, n. 2211e, fig. 14, con numerosi confronti con materiali di I sec. d.C.); Canepa 2003, 140, tav. 35/5 (da uno strato di III sec. d.C.). Per l’impasto, che non presenta le caratteristiche della ceramica da fuoco, il frammento entellino è confrontabile con una pentola da un contesto di Alife databile nella prima metà del I sec. d.C.: vd. Gasperetti 1996, 55, fig. 13, 64. – Fr. di tegame o pentola in ceramica comune. Orlo a tesa orizzontale, con labbro squadrato lievemente ingrossato; parete tronco-conica. Pasta arancio (M. 2.5YR 6/8), dura, ruvida, compatta, con rari e minutissimi inclusi biancastri. Scarse tracce di annerimento sull’orlo. Alt. max. cm 2; largh. max. cm 7,3; diam. orlo cm 24. Lo stato di conservazione del frammento non consente di stabilire se si tratti di un tegame o di una pentola. Nel primo caso cfr.: Dyson 1976, 52, fig. 11, 16-IV-4 (da un contesto databile intorno a metà II a.C.); Bolsena 1995, 169, n. 417, fig. 48 (ca. 175-90 a.C.); nel secondo caso cfr. Olcese 1993, 139, fig. 21, n. 109; 221, fig. 43 (età augustea; il tipo però è presente ad Albintimilium, in percentuali basse, tra I sec. a.C. e I d.C.); Termini Imerese 1993, 135-136, 239, nn. 1059, 1083; 68, n. 36; 107, n. 649; de Cesare 1995a, 742, n. 11 e tav. CXXIII, 7 (ricondotto al tipo II di Termini Imerese, attestato dal II sec. a.C. al I d.C. e oltre); Corretti 1999, 138, fig. 159 d (da Entella, da uno strato databile tra seconda metà II e prima metà I sec. a.C.); burgio 2002, 93, n. 38.6, tav. VI (frequente a Termini Imerese in contesti di I sec. a.C.-I d.C.). Vd. inoltre Gallo 2001, 115 e 124, n. 131 e tav. XVIII: da Pompei, prima metà II a.C.; Himera III 2002, 141, n. 93.10, fig. 226.
56 Panormos, Tiberio per Divus Augustus, Asse, 15-16 d.C., Cn. Domitius Proculus, A. Laetorius, IIviri: D/[PANHORMI-TANORVM]; testa di Divus Augustus a s., a s. fulmine, sopra astro; R/CN DO[(MI) PROC(VL) A LAETO(R)] IIVIR; Capricorno, in basso Triquetra. Per il tipo, cfr. Gabrici 1927a, 162 nr. 339-341; RPC I 1992, 172-173, n. 644. La moneta, come tutti i reperti numismatici da Entella, è in corso di studio da parte della dott.ssa S. Frey-Kupper, che ringraziamo sentitamente per queste informazioni e per la consueta, generosa disponibilità.
57 Per la distruzione della casa a peristilio 1 di Monte Iato, che segna una cesura in-sediativa nella città intorno alla metà del I sec. d.C., vd. Studia Ietina VIII 1999, 300.
138
142f
494 michela gargini - maria adelaide vaggioli
dove ha uno spessore piuttosto consistente, ne è rimasta in situ la parte inferiore (che è stata definita 19224), ancora da scavare.
Sospeso lo scavo con il mezzo meccanico, è stata effettuata una pulizia manuale dell’area, evidenziando questa situazione: nella parte meridionale del saggio, dove emergenze rocciose sono visibili a quota più elevata, sotto lo strato 19217 compare direttamente 19221, strato gialla-stro di marna/trubo, apparentemente sterile, che si dispone sulla roccia naturale (19199) livellandone le irregolarità, analogamente a quanto già verificato nel limitrofo settore a Sud della porta ellenistica. In un piccolo avvallamento del banco roccioso, dove lo strato giallastro si mescola al terreno più scuro per la presenza di una radice, è stato raccolto il piede di coppa a vernice nera di tipo C segnalato in precedenza58.
Le emergenze rocciose, che nella zona a Sud della porta ellenistica affiorano in lievissima pendenza da Est verso Ovest, quasi in corrispon-denza del limite del saggio 2003 cominciano invece a risalire invertendo la pendenza, e formando così, proprio sulla linea della vecchia sezione del saggio, una sorta di ‘sacca’ parzialmente colmata dallo strato 19203, a Ovest della quale comincia ad estendersi 19217. In tutta questa nuova porzione meridionale dell’area indagata, la stratigrafia antropizzata precedente 19217 appare quasi inesistente, ma non è chiaro se essa sia integra, o se eventuali livelli di frequentazione precedente possano essere stati obliterati o asportati da fenomeni naturali o da interventi antropici che al momento non sono stati identificati.
Più a Nord, dove la roccia non emerge, la sequenza stratigrafica è invece più articolata: sotto 19217 si individua, presso l’angolo NordEst dell’ampliamento, una lente, di forma più o meno circolare, definita 19218: le caratteristiche della terra, arrossata e annerita, la qualificano come un focolare, che insiste sopra 19220, sottile strato marroncino, piuttosto compatto e argilloso. Quest’ultimo è interpretabile come un livello di abbandono, sotto al quale, nella parte settentrionale dell’ampliamento, compare poi uno strato grigiastro compatto, in lievissima pendenza da Ovest verso Est. Definito 19219, esso è composto da pietrame, ciottolini, frammenti laterizi, frustuli ceramici, e si estende soltanto nella fascia in asse con la porta ellenistica: tale ubicazione, oltre alle sue caratteristiche e alla quota, conferma che si tratta della prosecuzione verso Ovest della strada tardoellenistica 1918059.
58 Vd. supra, nota 47 e testo relativo.59 Per lo scavo del piano stradale 19180 nell’area della porta ellenistica vd. Vag-
495entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
Lo scavo 2005 si interrompe a questo livello, mentre nella parte più occidentale dell’ampliamento rimane ancora in situ la parte inferiore dello strato 19217 (definita 19224); ai margini Sud di tale area, dove lo strato 19217-19224 si trovava a livello più alto ed è stato completamente asportato, comincia invece ad affiorare uno strato di terra marroncina, piuttosto friabile, definito 19223.
8.5. Conclusioni
La campagna 2005 ha consentito dunque, pur nella sua brevità e con le limitate forze a disposizione, di concludere l’indagine in alcuni dei set-tori precedentemente indagati, fornendo sostanziali conferme alle ipotesi già formulate60; inoltre l’ampliamento effettuato nel settore occidentale ha predisposto per i futuri interventi un’area notevolmente ampia, utile sia per verificare su più vasta scala le situazioni già incontrate nel vecchio saggio, sia per affrontare problematiche nuove, emerse proprio nel corso dell’ultima indagine.
Nell’area già indagata in precedenza, la rimozione dei lacerti di strati rimasti in situ alla fine della campagna 2003 ha permesso di riportare in luce in tutto il settore del cortile e della porta ellenistica le strutture relative alla più antica fase di utilizzo dell’area come accesso alla città dal vallone NordOvest, attraverso una porta protetta da un sistema di fortificazione. L’impianto delle murature attualmente in luce (torre quadrangolare sul cui lato Sud si apre la porta, cortina muraria e muro di terrazzamento) era stato già precedentemente datato ad epoca classica (nel corso della seconda metà del V sec. a.C.), e lo scavo dei livelli stradali ad esse collegati (19204 e 19201) ha ora sostanzialmente confermato tale cronologia. Resta da chiarire, invece, l’articolazione del sistema difensivo in età tardoarcaica, poiché l’insistere delle murature successive impedisce di ricomporre in un sistema unitario gli scarsi indizi finora emersi relativi a strutture for-tificatorie riferibili a tale epoca, costituiti da un tratto di cortina muraria (individuata finora solo fino all’area dell’ambiente III) e forse di una
gioli in Gargini, Vaggioli 2002, 489-490; Ead. in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, 345.
60 La sequenza e la cronologia delle fasi riconosciute (fino alla campagna di scavo 2003) nell’area della porta di NordOvest sono sintetizzate in Gargini, Vaggioli 2002, 497-499 e da ultimo Eaed. in Gargini, Michelini, Vaggioli 2006, 341-347.
496 michela gargini - maria adelaide vaggioli
torre sottostante quella attualmente visibile. Continuano a mancare, al momento, elementi che possano indiziare la presenza in quest’area di una porta urbica precedente a quella di V sec. a.C., anche se non se ne può escludere l’eventuale esistenza sotto le murature successive. La presenza di materiali tardoarcaici nei livelli viari più antichi può infatti spiegarsi come residuale – e dunque attestare genericamente l’intensa frequentazione dell’area in epoca precedente l’impianto difensivo di età classica – ma non è da escludere che si possa connettere, invece, ad una esistenza del basolato stradale già in età tardoarcaica, in rapporto a strutture di fortificazione che al momento restano comunque di difficile lettura e, nel caso di un eventuale ingresso alla città, totalmente ignote.
Elementi di conferma alle ipotesi precedentemente formulate sono venuti anche dall’indagine condotta nell’area circostante la porta ellenisti-ca, dove le stratigrafie individuate nel ristretto spazio tra il pendio roccioso che sale verso Pizzo Giustiziere ed il muro costituente la delimitazione meridionale della porta stessa hanno evidenziato una situazione molto simile a quella già riscontrata, tra il muro settentrionale e la cortina, nell’ambiente III. Si tratta, in entrambi i settori, di attestazioni di un’intensa frequentazione in epoca arcaica, in una fase che la sequenza stratigrafica dell’ambiente III aveva indicato chiaramente come preceden-te all’impianto della cortina muraria di fine VI-inizi V sec. a.C. Anche nell’area a Sud della porta ha cominciato ad emergere, forse, traccia di una struttura muraria del tutto analoga a quella connessa, nell’ambiente III, al livello d’uso precedente all’impianto della cinta muraria tardoar-caica; in entrambi i settori a tali murature si sono addossati poi i muri della porta più interna, e in entrambi i settori l’indagine si è al momento arrestata su livelli con consistenti tracce di uso, di cui il prossimo scavo dovrà chiarire caratteri e cronologia. In particolare, nel settore a Sud della porta, negli strati soprastanti il piano d’uso rimasto in situ, si è evidenziata la presenza – scarsa ma significativa – di alcuni elementi più tardi in un panorama ceramico caratterizzato dalla massiccia presenza di prodotti indigeni, in associazione con rare ceramiche d’importazione (soprattutto attiche) o loro imitazioni. I pochi reperti più tardi (anfore corinzie b e MGS II, anforetta a vernice nera) sembrano riferirsi ad un momento – il IV secolo, e presumibilmente la seconda metà – che, rimandando ai coevi rinvenimenti dell’angolo SudOvest del cortile, non possono che rafforzare l’ipotesi precedentemente formulata di una consistente ristrutturazione edilizia connessa all’impianto di una porta più interna. Tale intervento ha inciso profondamente sulle stratigrafie
497entella. le fortificazioni: porta di nord/ovest
arcaiche presenti nell’area, tagliandole fino alla roccia di base o al terre-no sterile, e risparmiandone solo le parti laterali, alle quali i muri della porta sono stati addossati.
L’assoluta mancanza, invece, di reperti di epoca più avanzata, coerente con la cronologia della porta interna attualmente in luce – costruita, con il relativo piano stradale, intorno alla metà del II sec. a.C. –, potrebbe costituire ulteriore conferma all’ipotesi che essa sia stata messa in ope-ra, dopo il grande crollo che ha obliterato la porta classica e il cortile intermedio, in maniera frettolosa e poco accurata, riutilizzando blocchi già presenti nell’area e posizionandoli, dopo una sommaria pulizia delle macerie, senza effettuare nuovi tagli nelle stratigrafie presenti. Il cattivo stato di conservazione delle stratigrafie in questa zona, causato dai radicali interventi successivi, rende tuttavia estremamente labili gli indizi rimasti, invitando comunque ad una necessaria prudenza interpretativa.
In particolare, resta poco chiaro il rapporto tra gli strati insediativi arcaici – che dovevano estendersi, senza soluzione di continuità, tra la roccia affiorante a Sud e l’ambiente III – ed il passaggio della strada più antica, lasciando aperta la possibilità che un primo intervento, seppure limitato, di sbancamento dei livelli di VI secolo sia avvenuto già nel corso del V, per permettere il passaggio della via d’accesso connessa con la porta di età classica.
Conferme alla seriazione cronologica precedentemente proposta ven-gono anche dalla vasta area ad Ovest, interessata dall’ampliamento 2005. Infatti la sequenza di livelli stradali e di strati di abbandono si è riproposta analoga a quella già individuata nei settori più ad Est, mostrando, anzi, una maggiore articolazione nella presenza – dopo una prima fase di obli-terazione del percorso viario in uso tra il II sec. a.C. e il I d.C. – di una seppur saltuaria frequentazione testimoniata dal focolare 19218.
Ma dall’ampliamento realizzato nel 2005 emergono anche proble-matiche nuove, relative soprattutto alle più tarde fasi dell’occupazione dell’area in età imperiale. Esse sono legate all’interpretazione dello strato 19217, che si configura come un imponente scarico di materiali realizza-to, sulla base della cronologia suggerita dalla moneta tiberiana, intorno o poco dopo la metà del I sec. d.C. La sua deposizione segna la completa obliterazione della strada che dava accesso alla città dal vallone NordOvest, e dunque il definitivo abbandono dell’area, in significativa concomitanza con la progressiva dissoluzione dell’abitato entellino, ridotto ormai al solo settore meridionale della Rocca e destinato ad estinguersi tra i decenni finali del I e gli inizi del II sec. d.C. La prosecuzione delle indagini do-
498 michela gargini - maria adelaide vaggioli
vrà chiarire la provenienza dell’enorme massa di materiali scaricati sulla strada, accanto alla cortina muraria ormai in disuso, e le motivazioni di tale intervento, che va a colmare un’area assai vasta (di cui peraltro non conosciamo ancora i limiti Sud e Ovest), in precedenza apparentemente non interessata da interventi edilizi. A livello di organizzazione spaziale, il dato più significativo emerso dalla campagna 2005 è proprio la totale mancanza di strutture murarie nell’area situata all’interno della porta ellenistica: per quanto sia ancora prematuro fare affermazioni prima del necessario completamento dell’indagine, a livello di ipotesi di lavoro si potrebbe suggerire l’esistenza di un’area di rispetto immediatamente a ridosso della cinta muraria.
Infine, dalla prosecuzione delle indagini nell’area occidentale ci si può ora aspettare una lettura su più vasta scala anche dei livelli stradali più antichi, dei quali si spera di poter arrivare ad una più precisa definizione cronologica, mentre lo scavo della cortina muraria – nella campagna 2005 limitato al solo intervento sulla Tomba 1 – dovrà chiarirne la complessa evoluzione ed i rapporti con le strutture preesistenti.
Maria Adelaide Vaggioli
585
Allegro 1972 = N. Allegro, Tipi della coroplastica imerese, in Quaderno Imerese, I. Studi e materiali, Roma 1972;
Allegro, Vassallo 1992 = N. Allegro, S. Vassallo, Himera. Nuove ricerche nella città bassa (1989-1992), in «Kokalos», XXXVIII, 1992, 79-150;
Amari 1880-1881 = M. Amari (a cura di), Biblioteca arabo-sicula, trad. it., Torino-Roma 1880-1881;
Amari 1933-1939 = M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, a cura di C.A. Nallino, Catania 1933-19392;
Ampolo c.d.s. a = C. Ampolo, L’architetto di Segesta e le iscrizioni degli edifici pubblici della città, in Ritorno a Segesta. Ricerche storiche, archeologiche ed epigrafiche a confronto. Atti delle giornate di studio (Pisa, Scuola Normale Superiore, 15-16 dicembre 2003), a cura di C. Ampolo, Pisa c.d.s.;
Ampolo c.d.s. b = C. Ampolo, Ricchezza e edifici pubblici nella Sicilia ellenistica. L’agorà di Segesta e le opere pubbliche attestate dalle iscrizioni nel loro contesto storico, in Crisi e trasformazioni. L’Italia meridionale nel IV e III secolo a.C. Atti della Giornata di Studi per D. Mertens (Roma, 26-28 giugno 2006), c.d.s.;
Ampolo, Parra 2003 = C. Ampolo, M.C. Parra, Segesta. Scavi nell’area dell’agora (2002-2005, campagna primaverile): risultati e prospettive di ricerca, in Not-ScASNP 2003, 391-402;
Ampolo, Parra c.d.s. = C. Ampolo, M.C. Parra, Il lato ovest dell’agora di Segesta. Presentazione preliminare dei nuovi dati, in Ritorno a Segesta. Ricerche storiche, archeologiche ed epigrafiche a confronto, Atti delle giornate di studio (Pisa, Scuola Normale Superiore, 15-16 dicembre 2003), a cura di C. Ampolo, Pisa c.d.s.;
Andreadaki-Vlazaki, Papadopoulou 2005 = M. Andreadaki-Vlazaki, E. Papa-dopoulou, The Habitation at Khamalevri, Rethymnon, during the 12th Century BC, in Ariadne’s Threads. Connections between Crete and the Greek Mainland in the Late Minoan III (LM IIIA2 to LM IIIC). Proceedings of the International Workshop held at Athens (Scuola Archeologica Italiana, 5-6 April 2003), ed. by A.L. D’Agata, J. Moody, E. Williams, Athens 2005, 353-397;
Archeologia dell’Adriatico 2003 = L’Archeologia dell’Adriatico dalla Preistoria al Me-dioevo. Atti del Convegno Internazionale (Ravenna, 7-9 giugno 2001), a cura di F. Lenzi, Firenze 2003;
Archeologia e Territorio 1997= AA.VV., Archeologia e Territorio, Palermo 1997;Ardizzone 1999 = F. Ardizzone, Le anfore recuperate sopra le volte del palazzo della
Zisa e la produzione di ceramica comune a Palermo tra la fine dell’XI ed il XII secolo, in «MEFR(M)», CXI, 1999, 7-50;
badami 2000 = M. badami, Indagine geologica sul Monte Barbaro a Segesta, in Terze Giornate Internazionali 2000, 47-55, tavv. III-VI;
bagnera, Pezzini 2004 = A. bagnera, E. Pezzini, I cimiteri di rito musulmano nella Sicilia medievale. Dati e problemi, in La Sicile à l’époque islamique. Questions
586 abbreviazioni bibliografiche
de méthode et renouvellement récent des problématiques, in «MEFR(M)», CXVI, 2004, 231-302;
bailey 1975 = D.M. bailey, A Catalogue of the Lamps in the British Museum: Greek, Hellenistic and Early Roman Pottery Lamps, Oxford 1975;
barone 1995 = R. barone, Anatomia comparata dei mammiferi domestici, I, Osteo-logia, bologna 1995, 1-673;
barresi 2006a = P. barresi, L’insediamento medievale: notizia sulle campagne di scavo 2004-2005, in Iblatasah Placea Piazza. L’insediamento medievale sulla villa del Casale: nuovi e vecchi scavi. Mostra archeologica (Piazza Armerina, 8 agosto 2006-31 gennaio 2007), a cura di P. Pensabene, C. Sfameni, Piazza Armerina 2006, 103-121;
barresi 2006b = P. barresi, Reperti provenienti dagli scavi 2004-2005, in Iblatasah Placea Piazza. L’insediamento medievale sulla villa del Casale: nuovi e vecchi scavi. Mostra archeologica (Piazza Armerina, 8 agosto 2006-31 gennaio 2007), a cura di P. Pensabene, C. Sfameni, Piazza Armerina 2006, 139-184;
bechtold 1999 = b. bechtold, La necropoli di Lilybaeum, Palermo1999;bechtold, Favaro 1995 = b. bechtold, A. Favaro, Il sistema difensivo di «Porta
di Valle», area 7000 (SAS 7), in Segesta 1995, 1023-1128;beck-bossard 1981 = C. beck-bossard, L’alimentazione in un villaggio siciliano del
XIV secolo, sulla scorta delle fonti archeologiche, in «AM», VIII, 1981, 311-319;bell 1981 = M. bell, Morgantina Studies, I - The terracottas, Princeton N.J.,
1981;belvedere 1982 = O. belvedere, Tipologia e analisi delle arule imeresi, in II Quaderno
Imerese, Roma 1982, 61-113;benelli et al. 1992 = M.V. benelli, M. de Cesare, M. Paoletti, M.C. Parra,
La pluristratificazione insediativa sul Monte Barbaro a Segesta (area 3000), in Giornate Internazionali 1992, 99-109;
benelli et al. 1995a = M.V. benelli, M. de Cesare, M.Paoletti, M.C. Parra, Lo scavo dell’area 3000 (SAS 3), in Segesta 1995, 662-755;
benelli et al. 1995b = M.V. benelli et al., Segesta. Parco archeologico e relazioni preliminari delle campagne di scavo 1990-1993, in Segesta 1995, 537-755;
benzi 1992 = M. benzi, Rodi e la civiltà micenea, Roma 1992 (Incunabula Graeca, XCIV);
berggren 1981 = G. berggren, Atlas of seeds, Stockholm 1981;bertsch 1941 = K. bertsch, Frückte und Samen, Stuttgart 1941;biagini 1995 = C. biagini, Lo scavo dell’area 11000 (SAS 11), in Segesta 1995,
1157-1163;bianco Peroni 1976 = V. bianco Peroni, I coltelli nell’Italia continentale, München
1976 (Prähistorische bronzefunde, VII, 2);bietti Sestieri 2003 = A.M. bietti Sesteri, L’Adriatico tra l’età del Bronzo e gli
inizi dell’età del Ferro (ca. 2200-900 a.C.), in Archeologia dell’Adriatico 2003, 49-64;
biondi 1995 = L. biondi, Iscrizioni elime, in Segesta 1995, 1179-1182;boessneck 1969 = J. boessneck, Osteological differences between Sheeps (Ovis aries
Linnè) and Goat (Capra hircus Linnè), in D.R. brothwell, E.S. Higgs, Science in Archaeology, London 19692, 331-358;
587abbreviazioni bibliografiche
Bolsena 1995 = Bolsena VII. La citerne et son mobilier. Production, importations et consommation IIIe siècle/debut Ier siècle av. J.-C. et deuxième tiers du Ier siècle ap. J.-C., Rome 1995 (Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, Suppl. 6);
bondì 2006 = M.L. bondì, Il castello di Calatamauro, in L’Abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro, tra memoria e recupero. Atti del Convegno di Studi (Chiusa Sclafani e Santa Maria del bosco, 17-18 aprile 2004), a cura di A.G. Marchese, Palermo 2006, 65-74;
bossard, beck 1984 = C. bossard, P. beck, Le mobilier ostéologique et botanique, in Brucato 1984, 615-671;
bossard, beck, Maccari-Poisson 1984 = C. bossard, P. beck, b. Maccari-Poisson, L’alimentation, in Brucato 1984, 749-773.
Brucato 1984 = Brucato. Histoire et archéologie d’un habitat médiéval en Sicile, éd. par J.-M. Pesez, Roma 1984, I-II;
burgio 2002 =A. burgio, Resuttano, Firenze 2002 (Forma Italiae, 42);Cadei 1995 = A. Cadei, Architettura. Introduzione, in Federico e la Sicilia 1995, I,
367-374. Calì 2003 = V. Calì, Abitato del terrazzo superiore. Campagne di scavo 1996-97, in
AA.VV., Il centro antico di Monte Saraceno di Ravanusa. Dall’archeologia alla storia, Campobello di Licata 2003, 99-105;
Cambini 1967 = A. Cambini, Micrografia comparata dei legni del genere Quercus. Riconoscimento microscopico del legno delle querce italiane, in Contributi scien-tifico-pratici per una migliore conoscenza ed utilizzazione del legno, Roma 1967 (C.N.R., X, 19-20);
Campisi 2003 = L. Campisi, La ceramica indigena a decorazione geometrica dipinta, in Monte Maranfusa 2003, 157-228;
Canepa 2003 = C. Canepa, Ceramica comune romana, in Nora, Area C. Scavi 1996-1999, a cura di b.M. Giannattasio, Genova 2003, 137-202;
Caneva 2005 = Caneva, La biologia vegetale per i beni culturali, II, Conoscenza e valorizzazione, a cura di G. Caneva, Firenze 2005;
Canzanella 1990 = M.G. Canzanella, Impianto artigianale (SAS 6), in Entella 1990, 472-501;
Canzanella 1993 = M.G. Canzanella, L’insediamento rurale nella regione di En-tella dall’età arcaica al VII sec. d.C. Materiali e contributi, in Ricerca di Entella 1993, 197-338;
Caramiello, Arobba 2003 = Caramiello, Arobba, Manuale di archeobotanica. Metodiche di recupero e studio, a cura di R. Caramiello, D. Arobba, Milano 2003;
Castelletti 1990 = L. Castelletti, Legni e carboni in archeologia, in Scienze in Archeologia. II ciclo di lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano-SI, 7-19 novembre 1988), a cura di T. Mannoni, A. Molinari, Firenze 1990, 321-394;
Castiglione 1997 = M.A. Castiglione, Ricerche a Montagna dei Cavalli. La ceramica a vernice nera, in Archeologia e Territorio 1997, 307-314;
Castiglioni, Rottoli 1997 = E. Castiglioni, M. Rottoli, I macroresti vegetali, in A. Molinari, Segesta II. Il castello e la moschea (scavi 1989-1995), Palermo 1997, 235-257;
588 abbreviazioni bibliografiche
Céramiques communes 1996 = Les céramiques communes de Campanie et de Nar-bonnaise. (Ier s. av. J.-C.-IIe s. ap. J.-C.). La vaisselle de cuisine et de table. Actes des Journées d’Étude (Naples, 27-28 mai 1994), éd. par M. bats, Naples 1996;
de Cesare 1995a = M. de Cesare, Materiali, in Segesta 1995, 693-755;de Cesare 1995b = M. de Cesare, SAS 15, in Entella 1994, 235-246;de Cesare, Paoletti, Parra 1997 = M. de Cesare, M. Paoletti, M.C. Parra,
Microstorie edilizie segestane sull’acropoli Nord, da età protostorica agli svevi, in Seconde Giornate Internazionali 1997, 375-380;
de Cesare, Parra 2000 = M. de Cesare, M.C. Parra, Il buleuterio di Segesta: primi dati per una definizione del monumento nel contesto urbanistico di età ellenistica, in Terze Giornate Internazionali 2000, 273-286;
de Cesare, Parra 2001 = M. de Cesare, M.C. Parra, Segesta. Area del bouleuterion (SAS 3; 1995, 1997), in NotScASNP 2001, 417-429;
Cherubini 1981 = G. Cherubini, La “civiltà” del castagno in Italia alla fine del Medioevo, in «AM», VIII, 1981, 247-280;
Corretti 1999 = A. Corretti, Un nuovo sondaggio nel vallone orientale (SAS 22), in Entella 1999, 133-140;
Corretti 2002 = A. Corretti, L’area del Palazzo fortificato medievale ed edifici anteriori (SAS 1, 2, 23), in NotScASNP 2002, 433-449;
Corretti, Capelli 2003 = A. Corretti, C. Capelli, Entella. SAS 3. Le anfore, in Quarte Giornate Internazionali 2003, 287-351;
Corretti, Michelini, Vaggioli c.d.s. = A. Corretti, C. Michelini, M.A. Vaggio-li, Frammenti di medioevo siciliano: Entella e il suo territorio dall’alto Medioevo a Federico II, in I recenti scavi nella Villa del Casale di Piazza Armerina: nuovi studi sul Medioevo siciliano, a cura di P. Pensabene, Roma c.d.s.;
Corretti et al. 2004 = A. Corretti, M. Gargini, C. Michelini, M.A. Vaggioli, Tra Arabi, Berberi e Normanni: Entella e il suo territorio dalla tarda antichità alla fine dell’epoca sveva, in La Sicile à l’époque islamique. Questions de méthode et renou-vellement récent des problématiques, in «MEFR(M)», CXVI, 2004, 145-190;
Corretti et al. 2006 = A. Corretti, A. Facella, M. Gargini, C. Michelini, M.A. Vaggioli, Per una carta storico-archeologica del Comune di Contessa En-tellina: dati archeologici preliminari (1998-2002), in Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra. Atti delle Quinte Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2003), Pisa 2006, II, 561-593;
Coulton 1976 = J. J. Coulton, The Architectural Development of the Greek stoa, Oxford 1976;
Coulton 1979 = J. J. Coulton, Doric Capitals; a Proportional Analysis, in «bSA», LXXIV, 1979, 81-53;
Dalcher 1994 = K. Dalcher, Das Peristylhaus I von Iaitas: Architektur und Bauge-schichte, zürich 1994 (= Studia Ietina VI);
D’Angelo s.d. = F. D’Angelo, Ceramica d’uso domestico della Sicilia medievale prove-niente dalla Zisa (Palermo, XII secolo), in «Atti del IX Convegno Internazionale della ceramica, Albisola 1976», Albisola s.d., 53-61;
589abbreviazioni bibliografiche
Del Vais 1997a = C. Del Vais, La Montagnola di Marineo. Ceramica a vernice nera di età ellenistica, in Archeologia e territorio 1997, 171-186;
Del Vais 1997b = C. Del Vais, La Montagnola di Marineo. Ceramica comune, in Archeologia e territorio 1997, 187-196;
Del Vais 2003 = C. Del Vais, La ceramica a figure nere, a figure rosse e a vernice nera, in Monte Maranfusa 2003, 307-346;
De Miro 1989 = E. De Miro, Agrigento. I. La necropoli greca di Pezzino, Messina 1989;
De Miro 2000 = E. De Miro, Agrigento. II. I santuari urbani. L’area sacra tra il tempio di Zeus e Porta V, Roma 2000;
De Miro 2003 = E. De Miro, Agrigento. I santuari extraurbani. L’Asklepieion, Soveria Mannelli (Cz) 2003;
De Simone 2003 = R. De Simone, Oggetti fittili, terrecotte, metalli, oggetti in pietra, astragali d’osso, in Monte Maranfusa 2003, 347-378;
Denaro 2003a = M. Denaro, Ceramica greco-orientale e classi di produzione coloniale, in Monte Maranfusa 2003, 281-300;
Denaro 2003b = M. Denaro, Le lucerne, in Monte Maranfusa 2003, 301-306;Detienne 1979 = M. Detienne, Violentes “eugénies”. En pleines Thesmophories :
des femmes couvertes de sang, in La cuisine du sacrifice en pays grec, éd. par M. Detienne, J.P. Vernant, Paris 1979, 185-241;
Dewailly 1992 = M. Dewailly, Les statuettes aux Parures du Sanctuaire de la Malo-phòros à Sélinunte, Naples 1992;
Di Giovanni 1996 = V. Di Giovanni, Produzione e consumo di ceramica da cucina nella Campania romana (II a.C.-II d.C.), in Céramiques communes 1996, 65-104;
Di Liberto 1998 = R. Di Liberto, Il castello di Calatubo. Genesi di un inedito impianto fortificato siciliano fra l’XI ed il XII secolo, in La Sicile des Émirs aux Barons. Châteaux et formes de pouvoir. Actes du séminaire organisé par l’École Française de Rome et l’UMR 9967 [5648] (Rome, 1996), Rome 1998, 607-673;
Di Maria 1997-1998 = D. Di Maria, La ceramica geometrica antica di Roca Vecchia, tesi di specializzazione, Università del Salento, Facoltà di beni Culturali, Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale, a.a. 1997-1998;
Di Noto 1995 = C.A. Di Noto, La ceramica indigena a decorazione geometrica incisa ed impressa, in Entella I 1995, 77-110;
Di Noto 1999 = C.A. Di Noto, Necropoli A. Tombe di età ellenistica, in Entella 1999, 155-161;
Di Noto, Guglielmino 2001 = C.A. Di Noto, R. Guglielmino, Entella: le ne-cropoli, in Da un’antica città di Sicilia. I decreti di Entella e Nakone. Catalogo della Mostra, Pisa 2001, 173-185;
Di Noto, Guglielmino 2002 = C.A. Di Noto, R. Guglielmino, Necropoli A. Le campagne del 2001 e del 2003, in NotScASNP 2002, 525-532;
Dizionario di archeologia 2000 = Dizionario di archeologia, a cura di R. Francovich, D. Manacorda, bari 2000;
Dyson 1976 = S.L. Dyson, Cosa: the utilitarian Pottery, in «MAAR», XXXIII, 1976;
Entella 1988 = AA.VV., Entella. Ricognizioni topografiche e scavi 1987, in «ASNP», s. III, XVIII, 1988, 1469-1556;
590 abbreviazioni bibliografiche
Entella 1990 = AA.VV., Entella. Relazione preliminare della campagna di scavo 1988, in «ASNP», s. III, XX, 1990, 429-552;
Entella 1994 = AA. VV., Entella. Relazione preliminare delle campagne di scavo 1990-1991, in «ASNP», s. III, XXIV, 1994, 85-336;
Entella 1999 = AA. VV., Entella. Relazioni preliminari delle campagne di scavo 1992, 1995, 1997 e delle ricognizioni 1998, in «ASNP», s. IV, IV, 1, 1999, 1-188;
Entella I 1995 = Entella I, a cura di G. Nenci, Pisa 1995;Epifanio 1982 = E. Epifanio, Ricognizione archeologica a Cozzo Mususino (Petralia
Sottana), in «SicA», XV, 1982, 61-72;Erdas, Gagliardi 2003 = D. Erdas, V. Gagliardi, Segesta. Settori occidentale e
settentrionale dell’agora (SAS 4; campagne 2003-2005), in NotScASNP 2003, 417-430;
Facella c.d.s. = A. Facella, Segesta tardoantica: topografia, cronologia e tipologia dell’insediamento, in Immagine e immagini della Sicilia e delle altre isole del Mediterraneo. Atti delle Seste Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice, 12-16 ottobre 2006)», Pisa c.d.s.;
Facella, Olivito 2003 = A. Facella, R. Olivito, Segesta. Aree del bouleuterion e della stoa meridionale dell’agora (SAS 3; 2002-2005), in NotScASNP 2003, 403-416;
Fabbri 2002 = P.F. Fabbri, Relazione antropologica preliminare sulle sepolture rinvenute nelle campagne di scavo 2001-2003, in NotScASNP 2002, 533-539;
Federico e la Sicilia 1995 = Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Archeologia e architettura, a cura di C.A. Di Stefano, A. Cadei, Palermo 1995;
Finocchi 2003 = S. Finocchi, Ceramica fenicia, punica e di tradizione punica, in Nora, Area C. Scavi 1996-1999, a cura di b.M. Giannattasio, Genova 2003, 37-62;
Fock 1966 = J. Fock, Metrische Untersuchungen an Metapodien einiger europäischer Rinderrassen, Dissertation, Universität München, 1996
Fulford, Peacock 1994 = M.G. Fulford, D.P.S. Peacock, Excavations at Carthage. The British Mission, II, 2: The Circular Harbour, North Side. The Pottery, Oxford 1994 (british Monographs in Archaeology, V);
Gabrici 1927a = E. Gabrici, La monetazione del bronzo della Sicilia antica, Palermo 1927;
Gabrici 1927b = E. Gabrici, Il santuario della Malophoros a Selinunte, in «MonAL», XXXII, 1927;
Gagliardi c.d.s. = V. Gagliardi, Segesta tardoantica: ceramica di importazione e circolazione di merci, in Immagine e immagini della Sicilia e delle altre isole del Mediterraneo. Atti delle Seste Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice, 12-16 ottobre 2006), Pisa c.d.s.;
Gallo 2001 = A. Gallo, Pompei: l’Insula 1 della Regione IX: settore occidentale, Roma 2001 (Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei, 1);
Gandolfo 1995 = L. Gandolfo, Le monete (1989-1992), in Segesta 1995, 1204-1260;
Gargini 1994 = M. Gargini, Ceramica indigena a decorazione geometrica dipinta e ingubbiata dalla Trincea nr. 1, in Entella 1994, 132-135;
591abbreviazioni bibliografiche
Gargini 1995 = M. Gargini, La ceramica indigena a decorazione geometrica dipinta, in Entella I 1995, 111-161;
Gargini 1999 = M. Gargini, Le fortificazioni nel vallone NO: la porta (SAS 19). Campagna di scavo 1995, in Entella 1999, 87-96;
Gargini, Michelini, Vaggioli 2006 = M. Gargini, C. Michelini, M.A. Vaggioli, Nuovi dati sul sistema di fortificazione di Entella, in Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra. Atti delle Quinte Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo (Erice, 12-15 ottobre 2003), Pisa 2006, I, 327-378;
Gargini, Vaggioli 2002 = M. Gargini, M.A. Vaggioli, Il settore nord-occidentale delle fortificazioni: l’area della porta (SAS 19; 2000, 2001, 2003), in NotScASNP 2002, 459-499;
Gasperetti 1996 = G. Gasperetti, La ceramica comune da mensa e dispensa nella Campania romana, in Céramiques communes 1996, 19-63;
Giannini 2006-2007 = S. Giannini, Contributo per lo studio della ceramica del Bronzo finale da Rocavecchia (LE): i materiali del Pozzo L-12 (scavi 1989), tesi di laurea, Università del Salento, Facoltà di beni Culturali, a.a. 2006-2007;
Giornate Internazionali 1992 = Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima. Atti del Convegno, Gibellina, 19-22 settembre 1991, Pisa-Gibellina 1992;
Giustizia 1985 = F. Giustizia, Gli animali cacciati e l’ambiente circostante, in Pa-leontologia e archeologia di un territorio, Roma 1985;
Greci in Occidente. Santuari 1996 = I Greci in Occidente. Santuari della Magna Grecia in Calabria, a cura di E. Lattanzi et al., Napoli 1996;
Grottanelli 1997 = C. Grottanelli, La carne e i suoi riti, in Storia dell’alimenta-zione, a cura di J-L. Flandrin, M. Montanari, Roma-bari 1997, 83-96;
Guglielmino 1994 = R. Guglielmino, Entella. Esplorazioni e saggi di scavo eseguiti nel 1990 a O della Necropoli A, in Entella 1994, 100-128;
Guglielmino 1995 = R. Guglielmino, La necropoli islamica di Entella, in Federico e la Sicilia 1995, 110-118;
Gugliemino 1997 = R. Guglielmino, Materiali arcaici e problemi di ellenizzazione ad Entella, in Seconde Giornate Internazionali 1997, 923-956;
Guglielmino 1999 = R. Guglielmino, I dolii cordonati di Roca Vecchia (LE) e il problema della loro derivazione egea, in Epi ponton plazomenoi. Simposio Ita-liano di Studi Egei dedicato a Luigi Bernabò Brea e Giovanni Pugliese Carratelli (Roma, 18-20 febbraio 1998), a cura di V. La Rosa, D. Palermo, L. Vagnetti, Roma 1999, 475-486;
Guglielmino 2000 = R. Guglielmino, Entella: un’area artigianale extraurbana di età tardoarcaica, in Terze Giornate Internazionali 2000, 701-713;
Guglielmino 2003 = R. Guglielmino, Il sito di Roca Vecchia: testimonianze di contatti con l’Egeo, in Archeologia dell’Adriatico 2003, 91-119;
Guglielmino 2005 = R. Guglielmino, Rocavecchia: nuove testimonianze di contatti con l’Egeo e il mediterraneo orientale nell’età del bronzo, in Emporia. Aegeans in the central and eastern Mediterranean. Proceedings of the 10th International Aegean Conference (Athens, 14-18 April 2004), ed. by R. Laffineur, E. Greco, Liège 2005, 637-651;
592 abbreviazioni bibliografiche
Guglielmino c.d.s. = R. Guglielmino, Le relazioni tra l’Adriatico e l’Egeo nel Bronzo recente e finale. La testimonianza di Roca, in Dall’Egeo all’Adriatico: organizzazioni sociali, metodi di scambio e interazione in età post-palaziale (XII-XI sec.a.C.). International Workshop (Udine, 1-2 dicembre 2006), c.d.s.;
Guglielmino, Pagliara 2001, = R. Guglielmino, C. Pagliara, Roca Vecchia. Quindici anni di ricerche in un sito costiero dell’età del bronzo, in NotScANSP 2001, 534-542;
Higgins 1954 = R.A. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the Departement of Greek and Roman Antiquities, British Museum, I, Oxford 1954;
Himera II 1976 = Himera II: campagne di scavo 1966-1973, a cura di N. Allegro, Roma 1976;
Himera III 1988 = Himera III: prospezione archeologica nel territorio, a cura di V. Alliata et al., Roma 1988;
Himera III 2002 = Himera III: prospezione archeologica nel territorio, a cura di O. belvedere et al., Palemo 2002;
Hinz 1998 = V. Hinz, Der Kult von Demeter und Kore auf Sizilien und in der Magna Graecia, Wiesbaden 1998;
Howland 1958 = R.H. Howland, Greek Lamps and their Survivals. The Athenian Agorà. Result of Excavations IV, Princeton 1958;
Iakovidis 1983 = S.E. Iakovidis, Late Helladic Citadels on Mainland Greece, Leiden 1983;
Isler 1995 = H.P. Isler, Monte Iato, in Federico e la Sicilia 1995, 121-150;Isler 2000 = H.P. Isler, Monte Iato. Guida archeologica, Palermo 2000;Jacomet 2006 = S. Jacomet, Identification of cereal remains from archaeological sites,
basel 2006²;Jacomet, brombacher, Dick 1989 = S. Jacomet, C. brombacher, M. Dick,
Archäobotanik am Zürichsee. Ackerbau, Sammelwirtschaft und Umwelt von neolitischen und bronzezeitlichen Seeufersiedlungen im Raum Zürich. Er-gebnisse von Untersuchungen pflanzlicher Makroreste der Jahre 1979-1988, zürich 1989;
Johns 1993 = J. Johns, Entella nelle fonti arabe, in ricerca di Entella 1993, 61-97;Kron 1992 = U. Kron, Frauenfeste in Demeterheiligtümern: das Thesmophorion von
Bitalemi. Ein Archäologische Fallstudie, in «AA», XLIV, 1992, 611-650;Kustermann Graf 2002 = A. Kustermann Graf, Selinunte. Necropoli di Manica-
lunga: le tombe della contrada Gaggera, Soveria Mannelli 2002;La Mantia 1918 = G. La Mantia, Codice Diplomatico dei re Aragonesi di Sicilia
(1282-1355), Palermo 1918, I;Lamboglia 1952 = N. Lamboglia, Per una classificazione preliminare della ceramica
campana, in «Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri, bordighera 1950», bordighera 1952;
Lancel 1987 = S. Lancel, La céramique punique d’époque hellénistiques et romaines, in Céramiques hellénistiques et romaines, II, éd. par P. Lévêque, J.P. Morel, Paris 1987, 99-137;
Lesnes 1998 = E. Lesnes, Châteaux du XIVe siècle en Sicile occidentale. Typologie, in-fluences, in La Sicile des Émirs aux Barons. Châteaux et formes de pouvoir. Actes
593abbreviazioni bibliografiche
du séminaire organisé par l’École Française de Rome et l’UMR 9967 [5648] (Rome 1996), Rome 1998, 701-718;
Lesnes 2001 = E. Lesnes, s.v. Calatamauro, in Castelli medievali di Sicilia, Palermo 2001, 298-299;
Linee guida 1999 = Linee guida del piano territoriale paesistico regionale, Regione Si-ciliana, Assessorato dei beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, Palermo 1999;
Locri II 1989 = Locri Epizefiri II. Gli isolati 12 e 13 dell’area di Centocamere, a cura di M. barra bagnasco, Firenze 1989;
Luni II 1977 = Scavi di Luni. Relazione delle campagne di scavo 1972-1973-1974, a cura di A. Frova, Roma 1977;
Lyman 1994 = R.L. Lyman, Vertebrate Taphonomy, Cambridge 1994 (Cambridge Manuals in Archaeology);
MacDonald 1986 = C. MacDonald, Problems of the Twelfth Century BC in the Dodecanese, in «AbSA», LXXXI, 1986, 125-151;
Maggiulli 2006 = G. Maggiulli, I dischi solari di Roca (Lecce): dati di scavo e analisi preliminare, in Studi di Protostoria in onore di Renato Peroni, Firenze 2006, 125-132;
Maggiulli c.d.s. a = G. Maggiulli, Asce e falci dal ripostiglio dei bronzi di Roca (LE): notizie preliminari, in «SAL », XII, c.d.s.;
Maggiulli c.d.s. b = G. Maggiulli, I ripostigli di Roca Vecchia (Le): analisi dei ma-teriali e problematiche archeologiche, in Dall’Egeo all’Adriatico: organizzazioni sociali, metodi di scambio e interazione in età post-palaziale (XII-XI sec.a.C.). International Workshop (Udine, 1-2 dicembre 2006), c.d.s.;
Malorgio 2006-2007 = I. Malorgio, Il pozzo in P1: un contesto della prima età del Ferro a Roca Vecchia, tesi di laurea, Università del Salento, Facoltà di beni Culturali, a.a. 2006-2007;
Mammina 1995 = G. Mammina, Le monete (1993), in Segesta 1995, 1260-1295;Manacorda 2004 = D. Manacorda, Prima lezione di archeologia, Roma-bari
2004;Matolcsi 1970 = J. Matolcsi, Historische Erforschung der Korpergrosse des Rindes
auf Grund von ungarischen Knochenmaterial, in «zeitschrift fur Tierzuchtung und zuchtunsbiologie», LXXXVII, 2, 1970, 69-137;
Monte Maranfusa 2003 = F. Spatafora, Monte Maranfusa. Un insediamento nella media Valle del Belice: l’abitato indigeno, Palermo 2003;
Maurici 1992 = F. Maurici, Castelli medievali di Sicilia. Dai Bizantini ai Normanni, Palermo 1992;
Maurici 1998 = F. Maurici, L’insediamento medievale nel territorio della provincia di Palermo, Palermo 1998;
Maurici 2002 = F. Maurici, Medioevo trapanese. Gli insediamenti nel territorio della provincia di Trapani dal tardo antico alle soglie dell’età moderna, Palermo 2002;
Merico 2004-2005 = M. Merico, Analisi di una struttura della prima età del ferro da Roca Vecchia (Melendugno, Lecce), tesi di laurea, Università del Salento, Facoltà di beni Culturali, a.a. 2004-2005;
Mertens 1984 = D. Mertens, Der Tempel von Se gesta und die Doriche Tempelbau-kunst des Griechischen Westens in Klassicher Zeit, Mainz am Rhein 1984;
594 abbreviazioni bibliografiche
Michelini 1992 = C. Michelini, La ceramica ellenistica di Entella. Notizie prelimi-nari, in Giornate Internazionali 1992, 463-481;
Michelini 1994 = C. Michelini, Un nuovo sondaggio sull’acropoli di Entella, in Entella 1994, 246-279;
Michelini 1995 = C. Michelini, Lo scavo dell’area 4000 (SAS 4: settore occidentale), in Segesta 1995, 755-855;
Michelini 1997 = C. Michelini, Le agorai di ambiente coloniale e il caso di Segesta, in Seconde Giornate Internazionali 1997, 1139-1158;
Michelini 1999 = C. Michelini, La cinta muraria sul versante NE della Rocca (SAS 20). Campagne di scavo 1995 e 1997, in Entella 1999, 111-131;
Michelini 2001 = C. Michelini, Segesta. Settori occidentale e settentrionale dell’agora (SAS 4; 1995, 1997), in NotScASNP 2001, 430-446;
Michelini 2002a = C. Michelini, Ceramica a vernice nera, in Mozia. Gli scavi nella “Zona A” dell’abitato, a cura di M.L. Famà, bari 2002, 165-201;
Michelini 2002b = C. Michelini, Il settore nord-occidentale delle fortificazioni: l’area del bastione semicircolare (SAS 25; 2001; 2003), in NotScASNP 2002, 500-514;
Milanesio 1996 = M. Milanesio, L’area sacra di Parapezza, in Greci in Occidente. Santuari 1996, 49-52;
Minniti 1999 = C. Minniti, L’utilizzazione dei molluschi nell’età del Bronzo di Coppa Nevigata, in «Atti del XIX Convegno sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia (San Severo 1998)», San Severo 1999, 177-197;
Molinari 1997 = A. Molinari, Segesta II. Il castello e la moschea (scavi 1989-1995), Palermo 1997;
Morel 1981 = J.-P. Morel, Céramique campanienne. Les formes, Roma 1981;Motta 2000a = L. Motta, s.v. Ambientale, archeologia, in Dizionario di archeologia
2000, 3-4;Motta 2000b = L. Motta, s.v. Archeobotanica, in Dizionario di archeologia 2000,
14-18;Motta 2000c = L. Motta, s.v. Bioarcheologia, in Dizionario di archeologia 2000,
44-46;Mylonas 1966 = G.E. Mylonas, Mycenae and the Mycenaean Age, Princeton
1966;Nannipieri 2006 = M. Nannipieri, L’Odigitria di Calatamauro, in L’Abbazia di Santa
Maria del Bosco di Calatamauro, tra memoria e recupero. Atti del Convegno di Studi (Chiusa Sclafani e Santa Maria del bosco, 17-18 aprile 2004), a cura di A.G. Marchese, Palermo 2006, 75-78;
Nenci 1990 = G. Nenci, Entella nel 1858 in una lettera inedita di François Sabatier a Michele Amari, in Entella 1990, 785-790;
Nicolì 2006-2007 = G. Nicolì, Analisi di un contesto del Bronzo finale da Rocavec-chia: US 1551, tesi di laurea, Università del Salento, Facoltà di beni Culturali, a.a. 2006-2007;
Nisbet 1990 = R. Nisbet, Paletnobotanica, in Scienze in Archeologia. II ciclo di lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano-SI, 7-19 novem-bre 1988), a cura di T. Mannoni, A. Molinari, Firenze 1990, 277-309;
NotScASNP 2001 = AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-
595abbreviazioni bibliografiche
Segesta, TP; 1995, 1997), Kaulonia (Monasterace, RC; 1999-2001). Sintesi delle ricerche a Roca Vecchia (Melendugno, LE), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, «ASNP», s. IV, VI, 2001 [2005], 411-555;
NotScASNP 2002 = AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi e delle ricognizioni ad Entella (Contessa Entellina, PA; 2000-2004), in Notizie degli Scavi di Antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, in «ASNP», s. IV, VII, 2, 2002 [2005], 431-564;
NotScASNP 2003 = AA.VV., Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2002-2005) e Kaulonia (Monasterace, RC; 2001-2005), in Notizie degli scavi di antichità comunicate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, in «ASNP», s. IV, VIII, 1-2, 2003 [2006], 387-473;
Olcese 1993 = G. Olcese, Le ceramiche comuni di Albintimilium. Indagine archeo-logica e archeometrica sui materiali dell’area del Cardine, Firenze 1993;
Orlandini 1957 = P. Orlandini, Tipologia e cronologia del materiale archeologico di Gela dalla nuova fondazione all’età di Ierone II, in «ArchClass», IX, 1957, 44-75;
Orlandini 1966 = P. Orlandini, Lo scavo del Thesmophorion di Bitalemi e il culto delle divinità ctonie a Gela, in «Kokalos», XII, 1966, 8-35;
Orlandini 1968 = P. Orlandini, Gela. Topografoia dei santuari e documentazione archeologica dei culti, in «RIA», XV, 1968, 20-66;
Orlandini 1968-1969 = P. Orlandini, Diffusione del culto di Demetra e Kore in Sicilia, in «Kokalos», XIV-XV, 1968-1969, 334-338;
Orlandini 2003 = P. Orlandini, Il Thesmophorion di Bitalemi (Gela): nuove scoperte e osservazioni, in Archeologia del Mediterraneo. Studi in onore di Ernesto De Miro, Roma 2003, 507-513;
Padoa 1982 = E. Padoa Manuale di anatomia comparata dei Vertebrati, Milano 1982;
Pagliara 2001 = C. Pagliara, s.v. Roca, in Bibliografia Topografica della Coloniz-zazione Greca in Italia e nelle Isole Tirreniche, XVI, Pisa-Roma-Napoli 2001, 197-229;
Pagliara 2003 = C. Pagliara, Il sito di Roca Vecchia nell’età del bronzo, in Archeologia dell’Adriatico 2003, 74-90;
Pagliara 2005 = C. Pagliara, Rocavecchia (Lecce): il sito, le fortificazioni e l’abitato dell’età del bronzo, in Emporia. Aegeans in the central and eastern Mediterranean. Proceedings of the 10th International Aegean Conference (Athens, 14-18 April 2004), ed. by R. Laffineur, E. Greco, Liège 2005, 629-635;
Pagliara, Guglielmino 2005 = C. Pagliara, R. Guglielmino, Roca: dalle curiosità antiquarie allo scavo stratigrafico, in Magna Graecia. Archeologia di un sapere. Catalogo della Mostra (Catanzaro, 19 giugno-31 ottobre 2005), a cura di S. Settis, M.C. Parra, Martellago 2005, 298-321;
Pagliara et al. c.d.s. = C. Pagliara et al., La sequenza cronostratigrafica delle fasi di occupazione dell’abitato protostorico di Roca (Melendugno, Lecce). Relazione preliminare della campagna di scavo 2005-Saggio X, in «Rivista di Scienze Preistoriche», LVII, c.d.s.;
Pales, Lambert 1971 = L. Pales, C. Lambert, Atlas osteologique des mammiferes, I, Herbivores, Paris 1971;
596 abbreviazioni bibliografiche
Paoletti, Parra 1991a = M. Paoletti, M.C. Parra, Lo scavo dell’area 3000 (SAS 3), in Segesta 1991, 829-856;
Paoletti, Parra 1991b = M. Paoletti, M.C. Parra, Lo scavo dell’area 4000 (SAS 4), in Segesta 1991, 856-867;
Paoletti, Parra 1991c = M. Paoletti, M.C. Parra, Il villaggio medievale di Segesta (area 3000), in L’età di Federico II nella Sicilia Centro-Meridonale. Atti delle Giornate di Studio (Gela, 8-9 dicembre 1990), a cura di S. Scuto, Agrigento 1991, 194-198;
Paoletti, Parra 1995 = M. Paoletti, M.C. Parra, Un complesso fortificato nel villaggio di Segesta, in Federico e la Sicilia 1995, 197-199;
Paoletti, Parra 2000 = M. Paoletti, M.C. Parra, Edilizia pubblica e privata a Segesta (XII-XIII sec.): il complesso fortificato nell’area dell’agora greca, in Mai-sons et éspaces domestiques dans le monde méditerranéen au Moyen Age. Atti del Colloquio Erice 1993, Rome-Madrid 2000 (Castrum, 6), 193-197;
Parisinou 1997 = E. Parisinou, Artificial Illumination in Greek Cult Practice of the Archaic and Classical periods: Mere Practical Necessity?, in «Thetis», IV, 1997, 95-108;
Parra 1997a = M.C. Parra, Un deposito votivo di fondazione ad Entella nel IV sec. a.C., in Seconde Giornate Internazionali 1997, 1203-1214;
Parra 1997b = M.C. Parra, Segesta: uso e reimpiego della città greco-romana in forme architettoniche ed edilizie di Calatabarbaro, in Sicilia occidentale e centro-meridio-nale: ricerche archeologiche nell’abitato. Atti Giornate di Studio (zürich, 28 feb-braio-3 marzo 1996), a cura di H.P. Isler, D. Käch, zürich 1997, 141-150;
Parra 2003 = M.C. Parra, Ad Entella, tra un granaio ed un oikos: nuovi dati sulla thysia di fondazione, Quarte Giornate Internazionali 2003, 1029-1048;
Parra 2006 = M.C. Parra, Note di architettura ellenistica a Segesta, intorno all’agora, in Sicilia ellenistica consuetudo italica 2006, 107-122;
Parra, Gagliardi 2006 = M.C. Parra, V. Gagliardi, Ceramiche africane dal Foro di Segesta: dati preliminari, in L’Africa Romana. Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell’Impero romano. Atti del XVI Convegno di studio (Rabat, 15-19 dicembre 2004), a cura di A. Akerraz, P. Ruggeri, A. Siraj, Roma 2006, 1615-1628;
Parra, Michelini 1988 = M.C. Parra, C. Michelini, Edificio ellenistico (SAS 3), in Entella 1988, 1495-1517;
Parra et al. 1994 = M.C. Parra, M. de Cesare, C.A. Di Noto, M. Gargini, Edificio ellenistico (SAS 3), in Entella 1994, 153-192;
Parra et al. 1995 = L’edificio ellenistico nella conca orientale, in Entella I 1995, 9-76;
Pelagatti 1970 = P. Pelagatti, Akrai (Siracusa). Ricerche nel territorio, in «NSA», XXIV, 1970, 436-523;
Pesez 1995 = J.M. Pesez, Calathamet, in Federico e la Sicilia 1995, 187-189;Pignatti 1982 = S. Pignatti, Flora d’Italia, bologna 1982;Pinakes di Locri 1996-1999 = I pinakes di Locri Epizefiri. Musei di Reggio Calabria e
Locri, a cura di E. Lissi Caronna, C. Sabbione, L. Vlad borrelli, in «ASMG», s. IV, 1996-1999;
597abbreviazioni bibliografiche
Polizzi 1997 = C. Polizzi, Materiali dalla necropoli punica di Solunto: studi prelimi-nari. Ceramica ellenistica, in Archeologia e Territorio 1997, 105-108;
Quarles Van Ufford 1941 = L. Quarles Van Ufford, Les terres cuites siciliennes. Une etude sur l’art sicilien entre 550 et 450, Assen 1941;
Quarte Giornate Internazionali 2003 = Quarte Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima. Atti del Convegno (Erice, 1-4 dicembre 2000), Pisa 2003;
Ricerca di Entella 1993 = G. Nenci (a cura di), Alla ricerca di Entella, Pisa 1993;Ritorno a Segesta c.d.s. = Ritorno a Segesta. Ricerche storiche, archeologiche ed epigrafiche
a confronto. Atti delle giornate di studio (Pisa, Scuola Normale Superiore, 15-16 dicembre 2003), a cura di C. Ampolo, Pisa c.d.s.;
Romeo 1989 = I. Romeo, Sacelli arcaici senza peristasi nella Sicilia greca, in «Xenia», XVII, 1989, 5-54;
Ronca 2004-2005 = A. Ronca, Materiale protogeometrico da Rocavecchia, tesi di laurea, Università del Salento, Facoltà di beni Culturali, a.a. 2004-2005;
RPC I 1992= M. Amandry, A. burnett, P.P. Ripollés, Roman Provincial Coinage. I. From the death of Cesar to the death of Vitellius (44 BC-AD 69), London-Paris 1992;
Rumscheid 1994 = F. Rumscheid, Untersuchungen zur Kleinasiatischen Bauorna-mentik des Hellenismus, Mainz am Rhein 1994;
Sabbione 1996 = C. Sabbione, Il santuario di Persefone in contrada Mannella, in Greci in Occidente. Santuari 1996, 32-39;
Scarano 2006 = T. Scarano, La ceramica decorata di tipo appenninico dei livelli del Bronzo Medio di Rocavecchia (Lecce): contributo per una rilettura di alcuni aspetti archeologici e cronologici della facies appenninica nella Puglia centro-meridionale, in Studi di Protostoria in onore di Renato Peroni, Firenze 2006, 133-145;
Scarano c.d.s. = T. Scarano, The fire level of the Appenninic fortification walls of Rocavecchia (Lecce, Italy): the typological classification of pottery assemblages as an instrument for functional characterizing of archaeological contexts, in 12th EAA Annual Meeting (Cracow, 19-24 September 2006), c.d.s.;
Scatozza Höricht 1996 = L. Scatozza Höricht, Appunti sulla ceramica comune di Ercolano. Vasellame da cucina e recipienti per la preparazione degli alimenti, in Céramiques communes 1996, 129-156;
Schäfer 2006 = Th. Schäfer, Decorazione architettonica e stucchi di Cossyra, in Sicilia ellenistica consuetudo italica 2006, 17-67;
Schirò 1887 = A. Schirò, L’antico castello di Calatamauro. Le sue dimensioni, la sua origine e le sue vicende, in «ASS», n.s. XII, 1887, 169-183;
Schmid 1972 = E. Schmid, Atlas of Animal Bones, Amsterdam-London-New York 1972;
Schoch, Pawlik, Schweingruber 1988 = W.H. Schoch, b. Pawlik, F.H. Schwein-gruber, Botanische Makroreste, Stuttgart 1988;
Schweingruber 1978 = F.H. Schweingruber, Mikroskopische Holzanatomie, Teufen 1978;
Schweingruber 1990 = F.H. Schweingruber, Anatomie europäischer Hölzer, bern und Stuttgart 1990;
Seconde Giornate Internazionali 1997 = Seconde Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima. Atti del Convegno (Gibellina, 22-26 ottobre 1994), Pisa-Gibellina 1997;
598 abbreviazioni bibliografiche
Segesta 1991 = AA.VV., Segesta. Storia della ricerca, parco e museo archeologico, ricogni-zioni topografiche (1987-1988) e relazione preliminare della campagna di scavo 1989, in «ASNP», s. III, XXI, 1991 [1992], 765-994;
Segesta 1995 = AA.VV., Segesta. Parco archeologico e relazioni preliminari delle campagne di scavo 1990-1993, in «ASNP», s. III, XXV, 1995 [1997], 537-1295;
Segesta I 1996 = Segesta I. La carta archeologica, a cura di R. Camerata Scovazzo, Palermo 1996;
Sfameni Gasparro 1986 = G. Sfameni Gasparro, Misteri e culti mistici di Demetra, Roma 1986;
Sguaitamatti 1984 = M. Sguaitamatti, L’offrante de porcelet dans la coroplastique geléenne, Mainz 1984;
Sicani, Elimi e Greci 2002 = Sicani Elimi e Greci. Storie di contatti e terre di frontiera, a cura di F. Spatafora, S. Vassallo, Palermo 2002;
Sicilia ellenistica consuetudo italica 2006 = Sicilia ellenistica, consuetudo italica. Alle radici dell’architettura ellenistica d’Occidente. Alle origini dell’architettura ellenistica d’Occidente. Atti delle giornate di studio (Spoleto, 5-7 novembre 2004), a cura di M. Osanna, M. Torelli, Roma 2006;
Sicilia greca 1989 = La Sicilia greca (= Det Grekiska Sicilien). Catalogo della mostra organizzata dalla Regione Siciliana-Assessorato regionale beni culturali e am-bientali (Malmö-Rooseum, 7 ottobre-15 dicembre 1989), Palermo 1989;
Siegel 1976 = J. Siegel, Animal Palaeopathology: Possibilities and Problems, in «Journal of Archeological Science», III, 1976, 349-384;
Spanò Giammellaro 2000 = A. Spanò Giammellaro, Scavi nella “zona K” di Mozia. L’ottava campagna di scavo (maggio-luglio 1994): i materiali, in Actas del 4. Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cadiz, 2-6 Octubre 1995), Cadiz 2000, III, 1377-1395;
Sparkes, Talcott 1970 = b.A Sparkes, L. Talcott, The Athenian Agora XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., Princeton N.J. 1970;
Spatafora 2002 = F. Spatafora, Entella. Il Santuario delle divinità ctonie di Contrada Petraro, in Sicani, Elimi e Greci 2002, 13-15;
Spatafora 2003a = F. Spatafora, La ceramica indigena a decorazione geometrica impressa e incisa, in Monte Maranfusa 2003, 109-156;
Spatafora 2003b = F. Spatafora, L’indagine archeologica, in Monte Maranfusa 2003, 19-86;
Spatafora 2008 = F. Spatafora, Entella: il Thesmophorion di Contrada Petraro, in Demetra: la divinità, i santuari, il culto, la leggenda. Atti del Congresso Internazionale (Enna, 1-4 luglio 2004), a cura di C.A. Di Stefano, Pisa-Roma 2008, 273-284;
Spatafora c.d.s. = F. Spatafora, Sacrifici, banchetto e libagioni del thesmophorion di Entella, in Cibo per gli dei uomini, cibo per gli dei. Archeologia del pasto rituale. Atti (Piazza Armerina, 4-8 maggio 2005), c.d.s.;
Spatafora, Di Salvo, Schimmenti 2006 = F. Spatafora, R. Di Salvo, V. Schim-menti, Entella: la necropoli islamica di Contrada Petraro. Antropologia e paleo-patologia per l’analisi storico-archeologica di un gruppo umano, in «MEFR(M), CXVII, 2, 2006, 301-312;
Spatafora, Ruvituso, Montali 2003 = F. Spatafora, A. Ruvituso, G. Montali,
599abbreviazioni bibliografiche
Entella: un santuario ctonio extra moenia, in Quarte Giornate Internazionali 2003, 1189-1201;
Spigo 2000 = U. Spigo, I pinakes di Francavilla di Sicilia, in «bA», LXXXV, s. VI, 111, 2000, 1-60 (Parte I) e in «bA», LXXXV, s. VI, 113, 2000, 1-78 (Parte II);
Stieglitz 1994 = R.R. Stieglitz, The Minoan Origin of Tyrian Purple, in «The biblical Archaeologist», LVII, 1, 1994, 46-54;
Studia Ietina ii 1984 = Studia Ietina II, Der Tempel der Aphrodite, a cura di H.P. Isler, zürich1984;
Studia Ietina IV 1991 = R.b. Caflisch, Studia Ietina IV. Die Firniskeramik vom Monte Iato, Funde 1971-1982, a cura di H.P. Isler, zürich 1991;
Studia Ietina VI 1994 = K. Dalcher, Studia Ietina VI, Das Peristylhaus 1 vom Iaitas: Architektur und Baugeschichte, a cura di H.P. Isler, zürich 1994;
Studia Ietina Viii 1999 = b. Hedinger, Studia Ietina Viii, Die frühe Terra sigillata vom Monte Iato, Sizilien (Ausgrabungen 1971-1988) und frühkaiserzeitliche Fundkomplexe aus dem Peristylhaus 1, a cura di H.P. Isler, zürich 1999;
von Sydow 1984 = W. von Sydow, Die Hellenistischen Gebälke in Sizilien, in «MDAI(R) », XCI, 1984, 239-358;
Tardo 1997 = V. Tardo, Ceramica d’importazione e di tradizione greca, in Archeologia e Territorio 1997, 75-94;
Tardo 1999 = V. Tardo, Ceramica di importazione, coloniale e di tradizione greca, in Colle Madore. Un caso di ellenizzazione in terra sicana, a cura di S. Vassallo, Palermo 1999, 162-198;
Taylour 1958 = W. Taylour, Mycenaean Pottery in Italy and Adjacent Areas, Cam-bridge 1958;
Termini 2003 = A. Termini, La ceramica indigena acroma e i grossi contenitori, in Monte Maranfusa 2003, 229-254;
Termini Imerese 1993 = O. belvedere, Termini Imerese. Ricerche di topografia e archeologia urbana, Palermo 1993;
Terze Giornate Internazionali 2000 = Terze Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima. Atti del Convegno (Gibellina-Erice-Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997), Pisa-Gibellina 2000;
Thèry-Parisot 2001 = I. Thèry-Parisot, Economie des Combustibles au Paléolithique. Expérimentation, Taphonomie, Anthracologie, Paris 2001;
Teichert 1969 = M. Teichert, Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widderristhöhe bei vor-und frühgeschichtlichen Schweinen, in «Kuhn-Archiv», LXXXIII, 3, 1969, 237-292;
Teichert 1975 = M. Teichert, Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widderisthöhe bei Schafen, in Archaeozoological Studies, ed by A.T. Clason, Amsterdam-Oxford-New York 1975, 51-69;
Tréziny 1989 = H. Tréziny, Kaulonia I. Sondages sur la fortification nord (1982-1985), Naples 1989 (Cahiers du Centre Jean bérard, XIII);
Vaggioli 1995 = M.A. Vaggioli, Lo scavo dell’area 4000 (SAS 4: settore meridionale), in Segesta 1995, 855-979;
Vaggioli 1999 = M.A. Vaggioli, Le fortificazioni nel vallone NO (SAS 14, SAS 19). Campagna di scavo 1992, in Entella 1999, 57-86;
Vaggioli 2003 = M.A. Vaggioli, Note di topografia nella Sicilia medievale: per una
600 abbreviazioni bibliografiche
rilettura della Jarīda di Monreale (Divise battallarii, Divisa Fantasine), in Quarte Giornate Internazionali 2003, 1247-1317;
Valentino 2003 = M. Valentino, La ceramica da fuoco e da cucina, in Monte Ma-ranfusa 2003, 255-267;
Vassallo 1990 = S. Vassallo, Santa Caterina Villarmosa, Firenze 1990 (Forma Italiae, 34);
Vassallo 2003 = S. Vassallo, Ceramica indigena arcaica ad Himera, in Quarte Giornate Internazionali 2003, 1343-1356;
Vecchio 2002 =P. Vecchio, Ceramica comune, in Mozia. Gli scavi nella “Zona A” dell’abitato, a cura di M.L. Famà, bari 2002, 203-273;
Veder greco 1988 = AA.VV., Veder greco. Le necropoli di Agrigento. Catalogo della mostra internazionale (Agrigento, 2 maggio-31 luglio 1988), Roma 1988;
Vernant 2003 = J.P. Vernant, L’universo, gli dei, gli uomini, Torino 2003;Villari 1995 = P. Villari, Le faune della tarda preistoria nella Sicilia orientale, Ente
Fauna Siciliana 1995;Vlad borrelli, Sabbione 1996 = L. Vlad borrelli, C. Sabbione, I pinakes locresi
della Mannella, in Greci in Occidente. Santuari 1996, 40-42;Voza 1976-1977 = G. Voza, L’attività della Soprintendenza alle antichità della Sicilia
orientale, in «Kokalos», XXII-XXIII, 1976-1977, II,1, 551-586;Voza 1989 = G. Voza, in Sicilia greca 1989;Wilkens 1995 = b. Wilkens, Animali da contesti rituali nella preistoria dell’Italia cen-
tro-meridionale, in «Atti del I Convegno Nazionale di Archeozoologia, Rovigo, 5-7 Marzo 1993», Rovigo 1995 (Quaderni Padusa, I), 201-207;
Yntema 1990 = D. Yntema, The Matt-Painted Pottery of Southern Italy, Galatina 1990;
zalkin 1960 = V.I. zalkin, Metapodialia variation and its significance for the study of ancient horned cattle, in «byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody Otdel biologicheskii», LXV, 1960, 109-126;
Zancle 1999 = Da Zancle a Messina: un percorso archeologico attraverso gli scavi, a cura di G.M. bacci, G. Tigano, Messina-Palermo 1999, I.
127.
Ent
ella
. SAS
19.
Pia
nta
gene
rale
del
l’are
a di
scav
o al
la fi
ne d
ella
cam
pagn
a 20
05.
128. Entella. SAS 19. Panoramica da Sud dell’area di scavo alla fine della campagna 2005.129. Entella. SAS 19. Veduta da Est dell’area del cortile con il basolato di età classica (US 19204).
Sullo sfondo la porta ellenistica.
130. Entella. SAS 19. Veduta da Ovest dell’area della porta ellenistica alla fine della campagna 2005. Sullo sfondo l’area del cortile e la porta medievale.
131. Entella. SAS 19. Rilievo della Tomba 1.
132. Entella. SAS 19. Tomba 1.
133. Entella. SAS 19. Area a Sud della porta ellenistica. Veduta da Ovest dello strato 19225.
134. Entella. SAS 19. Area a Sud della porta ellenistica. Veduta da Sud dello strato 19225.135. Entella. SAS 19. Panoramica da SudOvest di una parte dell’ampliamento 2005; in alto la
cortina muraria, e a destra la porta ellenistica.
136. Entella. SAS 19. Ceramica figurata: kylix a figure nere e floral band cup.
137. Entella. SAS 19. Anforetta medievale da US 19106.
138. Entella. SAS 19. Asse di Tiberio per Divus augustus (da US 19217).
ab
c d
e f g
h
i
l
139. Entella. SAS 19. Materiali ceramici da US 19195 (a-b), 19195/19204 (c), 19204 (e), 19193 (f ), 19201 (d, g), 19203 (h-i), 19162 (l).
a
b
c
d
e f
g h
140. Entella. SAS 19. Materiali ceramici da US 19162 (a), 19225 (b, c, e, f ), 19217 (d, g, h).