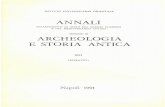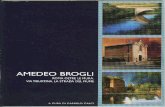Recenti rinvenimenti del Bronzo Finale da Farnese (VT), in PPEAtti IX
La porta e le mura di Rofalco (Farnese, VT): un primo inquadramento
Transcript of La porta e le mura di Rofalco (Farnese, VT): un primo inquadramento
La porta e le mura di Rofalco (Farnese, VT): un primo inquadramento
Lorenzo Somma
L’abitato fortificato tardo-etrusco di Rofalco, sito nell’entroterra vulcente, presenta elementi di grande interesse per quanto riguarda le strutture difensive, indagate da recenti scavi, e per l’impor-tante contributo che offre per lo studio della ro-manizzazione dell’Etruria1.
La vita dell’insediamento è decisamente breve, tra la metà del IV e i primi decenni del III seco-lo a.C. Se si esclude una sporadica occupazione durante l’età del Bronzo, il luogo non risulta oc-cupato stabilmente prima della fondazione della fortezza di epoca ellenistica. La costruzione delle opere difensive si inquadra bene nel generale cli-ma di tensione originato dalla crescente pressione romana, sensibile a partire dalla metà del IV seco-lo a.C. e particolarmente attiva nei decenni finali del secolo2. In tale epoca venne innalzata una po-derosa cinta muraria, attorno a un’area con forma oblunga ed asse est-ovest, vasta circa un ettaro e mezzo, posta ai margini di un più ampio piano-ro, sulla sommità del un ripido costone della valle dell’Olpeta.
Oggi Rofalco è immerso nella Riserva Natura-le della Selva del Lamone3, un fitto bosco che for-se in antichità non esisteva: la vegetazione doveva
verosimilmente essere più bassa e rada, e doveva consentire di spaziare molto più in profondità con lo sguardo rispetto ad oggi. La posizione del sito era strategica, controllando sia i rilievi retrostanti la piana di Vulci fino al mar Tirreno, sia il fosso Olpeta, affluente del più importante fiume Fiora4.
La cinta muraria
Le mura di Rofalco sono costituite da migliaia di blocchi di pietra lavica locale5: essi hanno forma irregolare e sono messi in opera a secco con le facce con andamento più piano rivolte verso l’esterno della muratura; blocchi di pezzatura inferiore disposti con perizia colmano i vuoti rendendo l’opera più stabile. Si tratta di una sorta di rozza opera poligonale, con struttura interna ad emplecton, che trova diversi confronti in territorio vulcente e chiusino6.
La cinta, lunga circa m 330, raggiungeva alme-no i 4 metri di altezza oggi visibili, con uno spesso-re che in alcuni punti raggiunge i 6 metri. Il tratto meglio conservato è l’arco di cerchio che abbraccia il sito a settentrione, sul lato più esposto verso l’in-terno del pianoro; verso sud infatti la cinta doveva
1 Il progetto di scavo archeologico e valorizzazione del sito di Rofalco (Farnese, VT) viene condotto dal 1996, dal Gruppo Archeologico Romano in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meri-dionale e l’ente Riserva Naturale della Selva del Lamone. Desidero ringraziare, per gli utili suggerimenti e scambi di opinioni, i colleghi Luca Pulcinelli e Orlando Cerasuolo, che ha anche realizzato la documentazione grafica delle strutture e dei materiali, nonché naturalmente tutti i volon-tari che hanno partecipato alle campagne di scavo. Per una panoramica del sito si veda cerasuoLo, PuLcineLLi 2010; per un quadro delle conoscenze archeologiche sul territorio Frazzoni 2012 (con bibliografia precedente).
2 Una chiara traccia di tale clima è costituita dalla fretta con cui vennero realizzate diverse opere di fortificazione, riu-tilizzando materiali preesistenti, come nel caso di Ghiaccio Forte (Firmati 2012, p. 173; taLocchini 1986, pp. 19-22). Si
vedano anche le osservazioni fatte per Musarna, in territorio tarquiniese (Bérard, Broise, JoLivet 2001, pp. 72-75). Per il caso di Rofalco, non è impossibile che la costruzione di alcune delle strutture abitative e utilitarie presenti nel sito abbia preceduto di qualche tempo la realizzazione della cin-ta muraria.
3 Per una presentazione della Riserva mantero 2007.4 Per una storia degli studi si rimanda a cerasuoLo
2009; cerasuoLo, PuLcineLLi 2010; L. PuLcineLLi, in Fraz-zoni 2012, pp. 11-18 (con bibliografia precedente).
5 Si tratta di una trachite molto tenace e difficilmente lavorabile con la quale è stata edificata la maggioranza delle strutture nell’abitato.
6 Firmati 2012, p. 173 (con altra bibliografia); da ricor-dare anche il caso della cinta muraria interna dell’abitato di Talamonaccio, ai confini settentrionali del teritorio vulcente (sensi 1987, pp. 15-16).
2 Lorenzo somma
proseguire lungo il costone rivolto al fosso Olpeta, ma qui i crolli e le condizioni naturali rendono solo intuibile l’andamento della struttura (fig. 1).
Le mura erano poi dotate di tre torri piene a pianta quadrata di circa 6 metri di lato, aggettanti verso l’esterno, poste a distanze irregolari e concen-trate nel tratto nord-occidentale. In prossimità delle stesse sono stati individuati i resti di tre rampe per l’accesso alla sommità delle strutture, simili a quel-la presente presso la Porta Nord-Ovest di Ghiaccio Forte7. Le mura sono da immaginarsi completate – verosimilmente – da strutture lignee o in mattoni crudi, come rampe, scalinate, torrette e cammina-menti, di cui non restano però tracce evidenti.
architettura deLLa Porta est
L’accesso al sito avveniva, in antico, attraverso una struttura collocata all’estremità orientale dell’inse-diamento; esso è l’unico accesso finora noto con
certezza, e di sicuro il principale8. Oggi invece il sentiero di ingresso al sito conduce i visitatori da ovest, attraverso un varco moderno nelle mura, e prosegue poi verso est, in direzione della porta originaria. In epoca antica una strada di cui resta-no labili tracce sotto forma di massicciata (larga nel tratto ancora visibile circa 4 metri) si bifor-cava poco ad est della porta: da un lato, facen-do un’ampia curva verso sud, univa Rofalco con il fondovalle; dall’altro, mantenendo la quota del costone, garantiva il collegamento con i diversi siti coevi individuati nella zona9.
La porta (fig. 2) è dominata da un bastione, ricavato da un accumulo naturale di blocchi vul-canici (localmente detto ‘murcia’) regolarizzato e adattato alla funzione di postazione d’avvista-mento, alto quasi 8 metri e dotato di rampe. La struttura del bastione è a freccia, con un angolo avanzato verso est, quasi retto, rivolto verso un eventuale assalitore. Il bastione è parte integran-
7 deL chiaro 1976, p 10; Firmati 2012, p. 174.8 La presenza di un ipotetico varco meridionale in
corrispondenza dell’Area 1000 fu suggerita dall’esistenza di un sentiero che era possibile percorrere da valle fino a non molti anni or sono (incitti 1999, pp. 8-10); tuttavia la presenza di una vera e propria porta è inverificabile
per via dell’assenza di strutture. È invece da escludere che l’accesso settentrionale segnalato in pianta in ren-deLi 1985 fosse antico, trattandosi infatti del risultato di un’opera moderna di spietramento per permettere il tran-sito di bestiame.
9 Frazzoni 2012, p. 71.
Fig. 1. Pianta generale dell’abitato.
3La Porta e Le mura di roFaLco (Farnese, vt): un Primo inquadramento
te delle strutture di accesso al sito e ha il ruolo strategico di difendere in profondità il lato destro della porta e di costringere la via di ingresso in un passaggio obbligato piuttosto stretto tra il bastione stesso ed il dirupo10.
La porta vera e propria, chiamata Porta Est (o Area 4000), nel suo aspetto definitivo si compone di due ambienti lastricati quadrangolari posti in successione (fig. 3).
Partendo dall’esterno, è articolata in un primo vano (l’ambiente est o ambiente 1), avente forma quasi quadrata, profondo m 4,50 e largo m 4,80. Esso è delimitato a nord e a sud da murature in blocchi di tufo11 (USM 1 e USM 7) che foderavano
rispettivamente il bastione soprastante e il tratto terminale della cinta muraria meridionale. Il tufo giallastro qui impiegato è lavorato in blocchi re-golari, apparentemente disposti tutti per taglio, misuranti sulla faccia vista cm 90 × 50 e con una profondità di cm 40. Il primo filare, rinvenuto in posto in quasi tutto l’ambiente, risultava non inte-ramente visibile in antico poiché in fondazione al di sotto del piano di spiccato. Qui è possibile osser-vare alcune particolarità costruttive di un certo in-teresse. Il muro settentrionale si trova parzialmen-te a contatto con la superficie rocciosa irregolare e fessurata che costituisce la sostruzione naturale del bastione: in questo punto i blocchi di tufo, fa-
10 Alcuni interessanti esempi di grandi ‘bastioni’ spor-genti ad angolo retto collegati in qualche modo con antiche porte sono conservati nei centri etruschi di Bettona (Peru-gia) e Cortona (cfr. infra, nota 26), ma anche Musarna, in territorio tarquiniese (PuLcineLLi 2012). La disposizione della porta richiama da vicino, come si vedrà, l’esempio della cinta muraria di Volterra (cfr. infra, nota 27).
11 Il tufo impiegato nella costruzione della Porta e
delle altre strutture dell’abitato, ove esso è presente, non è locale come la trachite ma potrebbe verosimilmente prove-nire da Poggio Fravolone, località posta all’incirca di fronte al sito, sul versante opposto della valle dell’Olpeta. In tale località è peraltro segnalata una necropoli etrusca in cui sa-rebbero stati ritrovati «vasi figurati attici», probabilmente da riferire piuttosto ad uno o più insediamenti produttivi di epoca ellenistica (cfr. Frazzoni 2012, pp. 71, 120).
Fig. 2. Pianta di dettaglio dell’estremità orientale delle fortificazioni, con il bastione e la porta.
4 Lorenzo somma
cilmente lavorabili, sono stati sagomati ad hoc per aderire alle asperità dei grandi massi vulcanici12. Risulta evidente l’intento decorativo e la volontà di monumentalizzare questa struttura particolarmen-te importante e rappresentativa dell’insediamento.
Un discorso a parte merita il muro (USM 3), solo parzialmente conservato, che delimitava il lato orientale del vano, in cui si doveva aprire il varco di accesso più esterno (fig. 4). Di questo, a causa dei crolli e di alcuni interventi moderni, si conserva solamente lo stipite settentrionale. Si tratta anche in questo caso di un muro realizzato in blocchi di tufo simili a quelli utilizzati nel resto della struttura, anche se di dimensioni differenti, e posti in opera con l’ausilio di zeppe e riempitivi di pezzame minuto. Interessante la presenza, nel grosso blocco terminale che doveva costituire la spalla dell’apertura centrale, di un incasso ad an-golo retto che suggerisce la presenza di una qual-che forma di battente o chiusura anche sulla porta
esterna. Il dato si può ricavare dal fatto che esso poggia sopra il lastricato di pavimentazione che sembra anzi proseguire al di sotto di esso, lastri-cato addossato invece, come si è detto, alla parte bassa delle altre pareti (USM 1 e 7), fino all’al-tezza del piano di spiccato. Il muro settentrionale dunque non presenta alcun tipo di fondazione, e forse a causa di ciò risulta parzialmente dislocato e fessurato. Se tale ricostruzione venisse conferma-ta l’aggiunta di questo elemento avrebbe quindi trasformato una porta ‘a tenaglia’ in una vera e propria struttura ‘a camera interna’.
Altri due tratti murari in tufo (USM 2 e USM 10), disposti in senso nord – sud, separavano l’am-biente est dal successivo ambiente ovest; le due strutture, inframezzate da una soglia di cui si dirà più innanzi, erano costituite almeno in parte da blocchi di dimensioni analoghe a quelli sopra de-scritti: fa eccezione un esemplare che non ne ri-spetta il modulo, trattandosi di un blocco lavorato
Fig. 3. Vista complessiva dei due ambienti lastricati della Porta, dall’esterno del sito (E-NE).
12 Risultava chiaramente meno dispendioso in termini di tempo ed energie modificare dei blocchi in tufo piuttosto
che tentar di lavorare una roccia tenace come quella lavica che caratterizza tutta la Selva del Lamone.
5La Porta e Le mura di roFaLco (Farnese, vt): un Primo inquadramento
sino ad assumere le dimensioni di cm 55 × 55 × 15. Esso è stato rinvenuto posizionato di piatto sopra al primo filare di USM 2, lo stipite settentrionale, in posizione terminale presso la soglia. L’USM 10, che doveva essere grossomodo speculare al prece-dente, a sud di esso, non è interamente visibile a causa di un albero cresciuto presso l’angolo con USM 7 (fig. 5).
L’ambiente ovest (ambiente 2) presenta alcuni tratti in comune col precedente, come le dimen-sioni (m 4,70 × almeno 4,20) e la pavimentazione a lastricato, che si legava direttamente, ad ovest, con una in ciottoli di pietra lavica locale, caratteri-stica delle strade interne e degli altri spazi scoperti dell’abitato. L’ambiente 2, che presenta il lato oc-cidentale interamente aperto, costituisce in realtà una sorta di prolungamento a corridoio del primo vano, al di là della porta principale descritta so-pra (fig. 6). A differenza dell’ambiente 1, i due lati
lunghi nord e sud (USM 5 e 6) sono realizzati con la muratura in grossi blocchi irregolari di pietra lavica, originariamente regolarizzati con zeppe e spezzoni più piccoli, che si ritrova impiegata in diverse strutture all’interno dell’abitato13. Dei due muri, realizzati in una tecnica piuttosto rozza che contrasta singolarmente con l’opera quadrata cui si affiancano, si conserva solamente il primo filare, e non è semplice avanzare ipotesi sull’aspetto degli alzati.
Il lastricato dei due ambienti è composto da blocchi basaltici poligonali posti in opera su uno strato preparatorio di terra sterile giallognola sab-bio-argillosa. La sistemazione del basolato è suc-cessiva alle strutture murarie (fatta eccezione per la già citata USM 3) in quanto esso vi si appoggia (fig. 7). Tale genere di pavimentazione, in luogo dell’acciottolato che caratterizza normalmente le strade interne e gli altri spazia cielo aperto, è
Fig. 4. L’USM 3 e l’angolo con l’USM 1, visti dall’interno dell’ambiente 1.
Fig. 5. I due ambienti lastricati (1 e 2) dell’Area 4000, foto-grafati dalla sommità del bastione soprastante: al centro è il cavo della soglia, oggi consolidato mediante riempimento con sabbia.
13 Frazzoni 2012, p. 113.
Fig. 6. I due ambienti della Porta Est (Area 4000) fotografati dall’interno del sito (O).
Fig. 7. Particolare del lastricato dell’ambiente 1 (USM 9) che si appoggia al muro meridionale in blocchi di tufo (USM 7).
6 Lorenzo somma
per ora un caso unico in Rofalco14 e sottolinea l’importanza data alla porta e la volontà di mo-numentalizzarla. La pavimentazione del vano est presenta purtroppo alcune sostanziali lacune15; nell’ambiente ovest, dove invece è integra, essa si lega direttamente con una strada (USM 16) che conduceva nell’abitato16.
La soglia che divide i due ambienti, infine, è posta tra i due stipiti nord e sud (USM 2 e 10) ed è ampia cm 250 × 70; essa è costituita da una cavità risparmiata nella pavimentazione (con i lati lunghi opportunamente regolarizzati da blocchi di piccole dimensioni) che in antico doveva essere occupata da un elemento in materiale deperibile o comunque non più presente perché rimosso. La soglia si trova ad una quota leggermente rialzata rispetto alle estremità opposte dei due ambienti: in altre parole, i due ambienti sono ‘in salita’ verso la soglia interna.
stratigraFia e ricostruzione deLLa Porta est
Si è dato inizio all’indagine stratigrafica dell’Area 4000 nell’agosto 2006, durante l’undicesima cam-pagna di scavo a Rofalco: partendo dalla rimozio-ne della vegetazione e di un consistente strato di crollo di blocchi in trachite provenienti dal bastio-ne difensivo, è stato possibile nell’arco di due sole campagne riscontrare la presenza di due ambienti e percepire un’idea complessiva della loro confor-mazione. Dal 2008 in poi, a lastricato pressoché interamente visibile, ci si è potuti concentrare dapprima sullo scavo della soglia intermedia, poi sui due tagli che intaccavano la pavimentazione dell’ambiente est17, e infine sulla comprensione di una particolare situazione stratigrafica nella porzione settentrionale dell’ambiente ovest. Dal 2009 si è scelto di ampliare le indagini anche alle strutture annesse alla Porta propriamente intesa e situate all’interno dell’abitato: esse, già parzial-
mente visibili, sono state portate alla luce con pro-gressivi interventi di sfoltimento della vegetazione, e hanno consentito di individuare un ‘Settore NO’ (o ambiente 3), posto in posizione sottostante la terrazza occidentale del bastione e delimitato da un perimetro rettangolare in blocchi lavici, forse un recinto con alzati in materiale deperibile, e di altre strutture a valle della Porta, tra la strada in-terna e il tratto meridionale delle mura difensive, tuttora in corso di scavo.
In entrambi gli ambienti, dopo l’iniziale rimo-zione della vegetazione e di uno strato di massi lavici provenienti in prevalenza dall’alto del ba-stione, si sono rinvenuti crolli di blocchi di tufo pertinenti alle murature descritte nel paragrafo precedente, nonché elementi fittili di copertura. Nell’ambiente est, maggiormente sconvolto da in-terventi successivi all’abbandono, i blocchi tufacei formavano un unico strato (US 12) insieme a tego-le e coppi, mentre nel vano occidentale, con strati-grafia intatta, tali blocchi (US 5) erano ben distinti dai sottostanti laterizi (US 7) che erano a diretto contatto del lastricato. Le tegole e i coppi appar-tenevano non tanto a falde poste a copertura de-gli ambienti (che sono invece da immaginarsi per buona parte scoperti) quanto più probabilmente a tettoie pertinenti a camminamenti perimetrali che dovevano assicurare il controllo dall’alto della porta, o ad altre strutture circostanti.
Le misure dei blocchi ancora in posto nell’am-biente 1 suggeriscono l’adozione di un modulo di circa cm 30, corrispondente grossomodo al ‘piede attico’ di cm 29,6, adottato dai romani almeno dal III sec. a.C. e già ben noto anche in ambito etru-sco18. Non è possibile effettuare una stima dell’ele-vato di queste strutture, dato il numero assai ridot-to di blocchi rinvenuti19; in via del tutto ipotetica si può comunque supporre la presenza di come minimo sei filari, anche in rapporto alla confor-mazione dell’adiacente bastione.
14 Gli ambienti delle altre aree presentano nella quasi totalità dei casi un battuto di terra atto a regolarizzare le asperità del banco roccioso, ad eccezione dell’ambiente 1 dei magazzini (Area 2000) il cui piano di calpestio è costitu-ito da blocchi di tufo (saBBatini cds.).
15 La principale interessa tutta la porzione orientale ed è dovuta a poderosi interventi di scavo clandestino (locali testi-monianze orali parlano addirittura dell’impiego di esplosivi) avvenuti nel secolo scorso con lo scopo di rinvenire eventuali depositi di fondazione. Qui lo scasso ha obliterato completa-mente gli strati fino al banco roccioso, ivi compresa la par-te sud-orientale delle strutture in tufo. La seconda lacuna
è invece un taglio rettangolare, posto a ridosso dell’USM 1 (muro settentrionale in tufo), effettuato ad opera di F. Rittato-re Vonwiller, che condusse le prime ricerche note sul sito. Per una ricostruzione degli studi ed interventi sull’area precedenti lo scavo sistematico si veda cerasuoLo 2009, pp. 23-25.
16 Gli assi viari all’interno di Rofalco erano costituiti da una sorta di acciottolato in piccoli frammenti di pietra lavi-ca, ma essendo stati portati alla luce solo in minima parte non ne è ancora noto il tracciato completo.
17 Cfr. supra, nota 15.18 Cfr. LugLi 1957, pp. 191-193.19 Ciò è dovuto sia ai crolli a valle che interessano tutta
7La Porta e Le mura di roFaLco (Farnese, vt): un Primo inquadramento
Nella porzione settentrionale dell’ambiente ovest, grossomodo in corrispondenza della fascia lar-ga circa cm 70 priva di lastricato, era presente una particolare situazione di crollo di piccoli blocchi tra-chitici (US 6) coperti dalle tegole di US 7: il dato è interessante, in quanto ciò significa che la struttura relativa all’US 6 è collassata per prima, e le tegole vi si sono successivamente adagiate sopra. Potrebbe trattarsi dei resti di un bancone o forse di una ram-pa in pietra e materiale ligneo, che poteva consen-tire l’accesso a camminamenti e/o al bastione. Per quanto riguarda la sottostante fascia risparmiata, essa presenta uno strato di battuto molto simile alla preparazione, dove non sono state individuate con certezza tracce che attestino con maggior sicurezza l’esistenza di quanto descritto; sembra comunque da escludere la presenza di una canaletta, come quel-le osservabili in posizioni analoghe nelle tre porte di Ghiaccio Forte20, poiché l’incasso non prosegue nel contiguo ambiente 1 e sondaggi effettuati in prossi-mità dello stipite settentrionale USM 2 non hanno rivelato l’esistenza di condotte sotterranee.
Lo scavo della soglia ha restituito cospicue tracce di bruciato, presenti anche in altri punti, il che potrebbe avvalorare l’esistenza di un elemen-to in legno o in altro materiale deperibile, nonché la distruzione violenta del sito mediante incendi contestuali all’azione violenta che ne decretò l’ab-bandono.
i rePerti deLLa Porta est
Trattandosi di luogo di passaggio, l’Area 4000 ha restituito reperti archeologici in misura decisamen-te minore rispetto al resto del sito, o anche ai due ambienti 3 e 4 immediatamente adiacenti. Oltre ai numerosi frammenti di tegole (alcune con segni al-fabetici incisi) e coppi rinvenuti nei livelli di crollo, le forme vascolari riscontrate21 includono diversi esem-plari in impasto rosso-bruno, principalmente olle, piatti, coperchi e anfore domestiche, diffusi in en-trambi gli ambienti; almeno un mortaio in impasto
chiaro-sabbioso, proveniente dall’angolo nord-orien-tale dell’ambiente 1; due dolia di medie dimensioni, esternamente dipinti, rinvenuti in posto sul lastricato del medesimo ambiente; un deep-askos in ceramica fine acroma, purtroppo assai lacunoso; alcune forme in bucchero grigio e altre in vernice nera, tra le quali è opportuno segnalare un kantharos ad anse annodate di produzione volterrana22, rinvenuto nell’ambiente 2 presso US 6, un’olla stamnoide con decorazione lineare, un framento di poculum in ceramica decorata a silhouette23. Tra gli instrumenta si segnalano un peso da telaio troncopiramidale con segno a croce inciso sulla sommità (fig. 8).
Un’evidenza suggestiva da riconnettere con tutta verosimiglianza alla fine violenta dell’inse-diamento, è data dal rinvenimento di almeno nove proiettili da fionda fittili. I rinvenimenti, significa-tivamente, sono stati effettuati in particolar modo nell’ambiente est e in corrispondenza della so-glia. I proiettili sono realizzati a stampo con dop-pia matrice speculare, e hanno come di consueto forma affusolata e aerodinamica. In alcuni casi si sono riscontrate imperfezioni di fabbricazione: un proiettile presentava una doppia traccia incrocia-ta del codolo di giuntura dei due stampi, come se fosse stato plasmato in due tempi; altri esemplari presentavano invece impressioni digitali involonta-rie dovute a un’eccessiva pressione nella manipo-lazione tra l’estrazione dallo stampo e la cottura. Un solo esemplare, infine, d’impasto grigio scuro, è realizzato interamente a mano anziché a stampo e reca sulla superficie numerose impronte digitali ben visibili. Molti dei proiettili presentano tracce di bruciato; è facile intuire che gli esemplari ritrovati in frammenti abbiano colpito un bersaglio e si sia-no infranti prima della distruzione e degli incen-di, come suggerisce il nerofumo presente anche in frattura. I proiettili da fionda, rinvenuti in numero piuttosto consistente anche in altri punti dell’abi-tato, costituiscono la maggior parte delle armi da offesa rinvenute a Rofalco, unitamente a due punte di lancia provenienti da altre aree24.
l’area, sia ai probabili riutilizzi dei materiali edilizi in epoche anche molto successive.
20 Firmati 2012, pp. 173-175.21 Per una panoramica sulle classi ceramiche attestate
nel sito cfr. ora saBBatini cds.22 La forma (vicina a Morel 3511a) è caratteristica della
produzione di Malacena e si data a partire dalla fine del IV a tutto il III secolo a.C. (serra ridgway 1996, p. 242). L’esemplare sembra mantenere l’aspetto fine e curato dei
prodotti più antichi della serie, anche se la vernice presenta alcuni difetti di cottura.
23 Forse da riferire alla produzione del Gruppo Roselle 1889, su cui cfr. donati 1976.
24 Proiettili simili, meno diffusi di quelli in piombo, sono stati rinvenuti anche in altri siti come Castel d’Asso (cera-suoLo, PuLcineLLi, ruBat BoreL 2009, p. 50, nota 20). Per i proiettili e una delle punte di lancia si veda cerasuoLo, PuLcineLLi 2010, p. 22.
9La Porta e Le mura di roFaLco (Farnese, vt): un Primo inquadramento
Sulle tegole rinvenute sono rare le marcature volontarie: si segnala solo la presenza di alcuni se-gni alfabetici graffiti, tra cui una «E» retrograda e una sorta di «A» inscritta entro un cerchio. Sono inoltre presenti digitazioni e impressioni varie, perlopiù casuali.
conFronti
Per la sua disposizione protetta da un bastione o saliente delle mura, la porta est di Rofalco si può classificare all’interno della diffusissima ed ampia categoria delle porte ‘scee’: anche se l’accesso non è propriamente obliquo rispetto alla linea delle fortificazioni, infatti essa sfrutta efficacemente lo stesso elementare ed antichissimo principio difen-sivo25. L’ampio bastione prominente rientra inve-ce all’interno di un ricco filone di realizzazioni di tipo ‘tradizionale’ diffusi nell’architettura militare etrusco-italica e in qualche modo in alternativa alle torri sporgenti, che solamente a partire da quest’epoca iniziano timidamente a venire impie-gate nelle opere di fortificazione26. Particolarmen-te interessante appare il confronto con la grande cinta muraria di Volterra, ricostruita proprio ver-so la fine del IV secolo a.C., dove due degli antichi accessi – la Porta all’Arco e il Portone – presenta-no a stessa compresenza di disposizione ‘scea’ in un dente delle mura ed evoluta struttura a camera interna27.
La struttura a tenaglia, e forse solo in un se-condo momento a camera interna (con l’US 3), che caratterizza la porta di Rofalco, di derivazione greca e punica, trova più di un confronto nel pa-norama etrusco coevo28 (fig. 9).
Il già citato sito fortificato di Ghiaccio Forte, nella valle dell’Albegna, costituisce probabilmente il confronto più stringente per cronologia, struttura, dimensioni e materiali associati29. I tre accessi che si aprono nella cinta muraria sono caratterizzati da struttura a camera in opera quadrata di blocchi di travertino e arenaria, con vano interno pavimen-tato e coperto, evidentemente con una struttura
lignea, per assicurare la continuità del cammino di ronda. A differenza di Rofalco, tuttavia, gli acces-si non presentano una disposizione ‘scea’: le due porte nord-ovest e sud-est sono però in posizione incassata e arretrata rispetto al tracciato murario, in modo da assicurare in ogni caso una forma di difesa radente. Le tre porte, che occupano l’intero spessore delle mura, erano dotate di soglie sia verso l’interno che verso l’esterno e presentano inoltre, in diversi stati di conservazione, una canaletta late-rale per il deflusso delle acque.
Anche la ben nota Porta Romanelli di Tar-quinia presenta molti punti di contatto con gli esempi appena descritti; si tratta tuttavia di una realizzazione decisamente più curata e di dimen-sioni nettamente inferiori, misurando all’interno solamente m 3,50 × 2,80. Va notata anche in que-sto caso la presenza della doppia porta, esterna e interna, testimoniata dagli incassi per i battenti e la pressoché completa mancanza di adeguati di-spositivi avanzati atti ad assicurare il tiro di fian-cheggiamento30
Il sensibile sviluppo in profondità della porta di Rofalco, tuttavia, sembra avvicinare la struttura ad altre realizzazioni sempre derivate dalle espe-rienze dei centri della Magna Grecia, quali le por-te dell’insediamento tarquiniese di Musarna o la stessa Porta Ovest di Vulci, che si datano nel corso del IV secolo a.C. o verso la fine di esso. La forma allungata, che richiama un vero e proprio corrido-io, è associata prevalentemente alla presenza di un aggere di sostegno, ma trova la sua ragione nella necessità di moltiplicare le linee di difesa sulla stra-da dell’attaccante. Va notato che, in questi esempi, la chiusura vera e propria sembra essere una sola, posta in posizione arretrata e più protetta, mentre verso l’esterno compare una semplice strettoia o tenaglia, chiusa tra due robusti stipiti31. Come è già stato osservato, i modelli da cui derivano tali realizzazioni si devono cercare nei centri greci o ellenizzati dell’Italia meridionale: estremamente significativo a questo proposito il confronto con la porta meridionale di Moio della Civitella, nel
25 adam 1992, pp. 10-14; sul tipo architettonico cfr. anche gasPerini 2008. Diversi esempi dall’Etruria meridio-nale in PuLcineLLi 2010.
26 Fontaine 1990, pp. 391-394; cfr. i casi di Bettona e Cortona (ibid., pp. 311-312; BatteLLi 2001; giuLierini 2012).
27 Pasquinucci, menicheLLi 2001; Fontaine 2008, p. 216.28 adam 1992, pp. 17-37; adam 1982, pp. 85-90. Per
l’ambito etrusco cfr. PuLcineLLi 2010, pp. 28-29, 36-37;
Firmati 2012, p. 175; PuLcineLLi 2012, pp. 197-198.29 Firmati 2012, pp. 173-175; rendini, Firmati 2008.30 Fontaine 1994, pp. 81-83; nel disegno originale, a
quanto si può ricostruire, la porta si sarebbe dovuta aprire direttamente nella fronte delle mura, senza alcuno specifico apprestamento difensivo aggiuntivo.
31 adam 1992, p. 32; Fontaine 2008, pp. 212-217. Su Musarna cfr. da ultimo PuLcineLLi 2012 (con altra bibliografia).
10 Lorenzo somma
territorio di Velia, la cui costruzione si deve datare nel corso del IV secolo a.C.32
Le ricerche dell’ultimo decennio hanno per-messo di apprezzare meglio gli elementi di novità presenti nella cinta muraria di Vulci, offrendo una testimonianza per certi versi sorprendente del la-voro degli architetti militari della città etrusca33. La sostanziale consapevolezza di alcune delle più recenti acquisizioni della poliorcetica ellenistica, in fatto di mobilità delle truppe e di impiego di macchine d’assedio (se non di artiglierie)34, sem-
bra trovare una conferma nella presenza anche in siti minori del territorio, quali Ghiaccio Forte e Rofalco, di soluzioni avanzate quali le porte a camera interna. Del tutto straordinaria, in questo senso, la presenza delle torri sporgenti nella cinta di Rofalco: come noto infatti questo fondamentale accorgimento difensivo si diffonde solo nel corso del IV secolo a.C., e in maniera non sistematica, nelle cinte fortificate dei centri della Magna Gre-cia, seguendo esempi provenienti dalla Grecia dal-la Sicilia35.
Fig. 9. Tavola comparativa delle porte di Tarquinia, Ghiaccio Forte e Cosa, in rapporto alla Porta Est di Rofalco.
32 greco, schnaPP 1983; PuLcineLLi 2010, pp. 37-39 (con bibliografia precedente). Utili confronti anche con i coevi centri lucani di Roccagloriosa (guaLtieri 1990), Croccia Cognato (tramonti 1984), Serra di Vaglio (greco 1990-1991).
33 moretti sguBini, ricciardi 2001; moretti sguBini 2008.
34 Bérard, Broise, JoLivet 2001, pp. 75-76; Fontaine 2008, pp. 215-216.
35 tréziny 2004.
11La Porta e Le mura di roFaLco (Farnese, vt): un Primo inquadramento
interventi di vaLorizzazione deLLa Porta est
Al fine di preservare per quanto possibile le strut-ture portate alla luce, nei limiti dei modesti mez-zi a disposizione e in attesa di un più esteso pro-getto di restauro e valorizzazione, si è deciso di effettuare limitati interventi di consolidamento e restauro che consentissero anche al visitatore una migliore comprensione dei resti monumentali. La collocazione del sito all’interno di un bosco fitto e rigoglioso e la relativa facilità di accesso data dal-la presenza di un sentiero escursionistico rende-vano infatti consigliabile provvedere in tal senso. L’incasso rettangolare della soglia è stato colmato dopo lo scavo con sabbia sterile, che ne consolida i margini e ne rende più evidente la forma, mentre il sentiero che passava in questo punto è stato op-portunamente deviato. Nell’ambiente est i muri in opera quadrata di tufo (USM 1, 2 e 7) sono stati in parte rialzati utilizzando alcuni dei blocchi meglio conservati rinvenuti in crollo. Infine il lastricato è stato risarcito, ove possibile, colmandone le lacune e mettendo nuovamente in opera degli scheggio-ni di pietra lavica opportunamente selezionati: lo stacco tra la pavimentazione originale e quella di restauro è sottolineato da frammenti di tegole di-sposti di coltello.
Lorenzo somma
BiBLiograFia
adam 1982: J.-P. adam, L’architecture militaire grecque, Paris 1982.
adam 1992: J.-P. adam, Approche et défense des portes dans le monde hellénisé, in S. van de maeLe, J.m. Fossey (a cura di), Fortificationes antiquae, Amsterdam 1992, pp. 5-43.
Alatri 2012: L. attenni, D. BaLdassarre (a cura di), Atti del IV Seminario internazionale sulle Mura Poligonali (Alatri, 7-10 ottobre 2009), Alatri 2012.
BatteLLi 2001: P. BatteLLi, Le mura di Bettona, in Fortifi-cazioni antiche 2001, pp. 55-67.
Bérard, Broise, JoLivet 2001: F. Bérard, h. Broise, v. JoLivet, Civita Musarna (Viterbo). La cinta mura-ria ellenistica, in Fortificazioni antiche 2001, pp. 69-80.
cerasuoLo 2009: o. cerasuoLo, Quattordici anni di ri-cerche nella fortezza tardo-etrusca di Rofalco, in L. Fraz-zoni (a cura di), Atti della giornata di studi in memoria di Mauro Incitti, Farnese 2009, pp. 23-36.
cerasuoLo, PuLcineLLi 2010: o. cerasuoLo, L. PuL-cineLLi (a cura di), La fortezza di Rofalco. Vita quotidia-na degli ultimi Etruschi, Acquapendente 2010.
cerasuoLo, PuLcineLLi, ruBat BoreL 2009: o. cera-suoLo, L. PuLcineLLi, F. ruBat BoreL, La fortezza tardo-etrusca di Rofalco nell’entroterra vulcente, in II Con-vegno nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia (••luogo e anno••), Salerno 2009, pp. 41-62.
Città murata 2008: La città murata in Etruria, Atti del XXV Convegno Internazionale di Studi Etruschi (Chianciano Terme-Sarteano-Chiusi, 30 marzo - 1 aprile 2005), Pisa-Roma 2008.
deL chiaro 1976: m.a. deL chiaro, Etruscan Ghiaccio Forte, Santa Barbara 1976.
donati 1976, L. donati, Ceramica etrusca ellenistica con ornati vegetali. Il Gruppo delle Bacche di Tarquinia, in Ar-chCl XXVII, 1976, pp. 88-98.
Firmati 2012: m. Firmati, Le mura di Ghiaccio Forte, presidio etrusco nella valle dell’Albegna, in Alatri 2012, pp. 171-177.
Fontaine 1990: P. Fontaine, Cités et enceintes de l’Ombrie antique, Bruxelles-Rome 1990.
Fontaine 1994: P. Fontaine, Tarquinia. L’enceinte et la porte nord. Contribution à l’architecture militaire étrusque, in AA, 1994, pp. 73-86.
Fontaine 2008: P. Fontaine, Mura, arte fortificatoria e città in Etruria. Riflessioni sui dati archeologici, in Città murata 2008, pp. 203-218.
Fortificazioni antiche 2001: L. quiLici, s. quiLici gigLi (a cura di), Fortificazioni antiche in Italia. Età repubblicana, Roma 2001 (ATTA, 9).
Frazzoni 2012: L. Frazzoni (a cura di), Carta archeolo-gica del Comune di Farnese, Bolsena 2012.
gasPerini 2008: L. gasPerini, Porte scee in Etruria meri-dionale, in Città murata 2008, pp. 83-89.
giuLierini 2012: P. giuLierini, Le mura etrusche di Corto-na: l’evidenza monumentale e gli studi archeologici, in Ala-tri 2012, pp. 113-120.
greco 1990-1991: e. greco, Serra di Vaglio (Potenza), in StEtr LVI, 1990-1991, pp. 611-614.
greco, schnaPP 1983: e. greco, a. schnaPP, Moio della Civitella et le territoire de Velia, in MEFRA 95.1, 1983, pp. 381-415.
guaLtieri 1990: m. guaLtieri, Il muro di fortificazione, in M. guaLtieri, h. Fracchia (a cura di), Roccaglo-riosa I, Napoli 1990, pp. 17-44.
incitti 1999: m. incitti, L’abitato fortificato di Rofalco nell’entroterra vulcente (Viterbo), in Archeologia Uomo Ter-ritorio 18, 1999, pp. 5-21.
LugLi 1957: g. LugLi, La tecnica edilizia romana, Roma 1957.mantero 2007: d. mantero, Riserva Naturale Selva del
Lamone, Roma 2007.moreL 1981: J.-P. moreL, Céramique campanienne: les formes,
Rome 1981.moretti sguBini, ricciardi 2001: a.m. moretti sgu-
Bini, L. ricciardi, Prime puntualizzazioni sulla cinta mu-raria di Vulci, in Orizzonti 1, 2001, pp. 63-74.
moretti sguBini 2008: a.m. moretti sguBini, Le mura di Vulci: un aggiornamento sullo stato della ricerca, in Città murata 2008, pp. 171-189.
12 Lorenzo somma
Pasquinucci, menicheLLi 2001: m. Pasquinucci, s. menicheLLi, Le mura etrusche di Volterra, in Fortifica-zioni antiche 2001, pp. 39-53.
PuLcineLLi 2010: L. PuLcineLLi, Etruria ellenistica: l’archi-tettura militare e l’urbanistica, in Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, Bollettino di Archeologia on line, 1, 2010, vol. speciale F/F8/4.
PuLcineLLi 2012: L. PuLcineLLi, Architettura militare etru-sca di epoca ellenistica: il caso di Musarna (VT), in Alatri 2012, pp. 189-199.
rendeLi 1985: m. rendeLi, L’oppidum di Rofalco nella Selva del Lamone, in A. carandini (a cura di), La roma-nizzazione dell’Etruria: il territorio di Vulci, Catalogo della mostra (Orbetello, 1985), Milano 1985, pp. 60-61.
rendini, Firmati 2008: P. rendini, m. Firmati, Ghiac-cio Forte: un oppidum nella valle dell’Albegna, in Città murata 2008, pp. 373-387.
saBBatini cds.: m. saBBatini, I granai di Vulci: i magazzini della fortezza di Rofalco, in Officina Etruscologia ••, in corso di stampa
sensi 1987: L. sensi, Gli scavi di G. Sordini sul Poggio di Talamonaccio, Firenze 1987.
serra ridgway 1996: F.r. serra ridgway, I corredi del Fondo Scataglini a Tarquinia, Milano 1996.
taLocchini 1986: a. taLocchini, Il Ghiaccio Forte, Roccastrada 1986.
tramonti 1984: a. tramonti, Croccia Cognato (Mate-ra), in StEtr LII, 1984, pp. 469-471.
tréziny 2004: h. tréziny, Aspects des fortifications ur-baines de la Grande-Grèce dans la deuxième moitié du IV s. av. J.-C., in Alessandro il Molosso e i “condottieri” in Ma-gna Grecia, Atti del XLIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto-Cosenza, 26-30 settembre 2003), Taranto 2004, pp. 595-631.