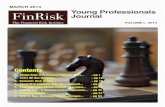Florilegio volume I
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Florilegio volume I
Introduzione
Per molti anni ho covato il progetto didedicarmi alla stesura di una sorta di diarioriflessivo, ovverosia di una collezione dipensieri sparsi che spesso mi capita dielaborare, su argomenti i più disparatipossibili, anche se ultimamente mi accorgo cheoramai mi cimento solo nell’analisi di due o treproblemi – se così vogliamo chiamarli – chem’assillano: l’anima, il mito, la mente poetica.Ammetto anche che ho fiammate di ritorno per lafilosofia e la logica, il che spesso m’induce arivalutare tutte le presunte conclusioni cheritengo d’aver raggiunto.
Ci fu un periodo, circa due lustri fa, chemi cimentai in un’impresa simile, spinto omeglio influenzato dalle riflessioni scritte delMaestro Zen Ryushui, il cui tempio frequentavonel tentativo di fare dello zen un sistemaportante della mia vita. Ogni tanto vado arivedere quelle pagine che ho stampate erilegate, accorgendomi ogni volta dell’errorecommesso nell’avere abbandonato quellabell’abitudine. Ma si sa, o meglio so di esserefatto così, un’alternanza di interessi, unapprofondire un argomento per poi passare ad unaltro e così via. Con qualche punto fermo,fortunatamente: la poesia e il disegno. Eproprio questi punti fissi, quasi cardinali,
-2-
dovrebbero aiutarmi a realizzare quale sia lavera natura della mia mente, o della mia anima,o di qualunque sia quella cosa che ci governa.
Questi pensieri sono dedicati a voi, bambinemie (ma credo che non sarete più tali quandoleggerete queste righe, semmai le leggerete,ovviamente); o forse, più che dedicate, questepagine sono compilate apposta per voi, nellasperanza che leggendole possiate esserestimolate nel meditare, nel ragionare intornoalle cose, nel capire la fondamentale importanzadi sapere pensare con la propria mente,sviluppando idee proprie, costruendo eall’occorrenza decostruendo sistemi diriferimento propri, non con il grandioso scopodi fondare scuole di pensiero, bensì con il piùmodesto seppur vitale fine di essere degliesseri umani emancipati, liberi, fruitoridell’intelligenza che l’evoluzione universale ciha donato, testimoni attivi delle bellezze deigiardini dell’anima che ognuno di noi possiede(o entro i cui confini vive, se vogliamoutilizzare una diversa prospettiva).
Non dimenticate mai che la curiosità per lecose del mondo e della psiche è sempre un bene enon deve mai languire; che la conoscenza spostasmisuratamente in avanti gli orizzonti dellanostra comprensione; che la creatività e ilpensiero attivo sono il bene più fecondo che sipossa perseguire; che i sentimenti e le emozioni
-3-
sono nutrimento per la nostra anima e chepercepirli e viverli è altrettanto importanteche provocarli positivamente nel nostroprossimo.
Scrivo queste righe non già alla fine di unlavoro annoso, seguito da una raccoltasistematica di tutti i miei pensieri; bensìall’inizio di quest’avventura, pertanto neppureio adesso so che cosa leggerete più avanti. Mipiace l’idea che vi rendiate conto che nelleggere queste righe, la persona che le hascritte non aveva la benché minima idea di ciòche avreste letto successivamente. Infatti non èmia intenzione ritornare successivamente suquesta presentazione.
Non mi rimane che augurarvi una buonalettura.
Milano, 9 novembre 2008
Prolegomeni ai pensamenti
Tempo fa, e credo siano passati otto anni, più o
meno, per svariati mesi tenni un diario, che per
l’occasione colli chiamare Diario Assoluto. Un progetto
ambizioso, in effetti non tanto diverso dal precedente,
se non per un fatto: era per me stesso, a mio esclusivo
beneficio. Forse per questo venni meno all’intento e non
ebbi la forza di continuare nell’opera.
-4-
E’ certamente vero che l’artista crea per sé, nel
senso che concretizza nella maniera a lui più consona un
impellente emotivo che ha scaturigine nella sua anima.
Ma è altrettanto vero che solo nella consapevolezza di
suscitare emozioni nel suo prossimo egli si sente
pienamente realizzato come artista. Così è nella mia
impellenza di disegnare; e così vorrei fosse in questi
miei scritti, che se pur pensati come strumento per
giocare con le mie idee, per costruire nuovi sistemi di
analisi delle cose, per liberare la mia creatività, sono
a vostro beneficio, bambine mie, anche se mai magari
verranno nelle vostre mani.
Pertanto ho ritenuto doveroso anticipare i
pensamenti voluto da questo intento con l’intero Diario
Assoluto. Sarà, comunque sia, anche un modo per
constatare come il mio modo di pensare sia cambiato nel
corso degli anni, o rimasto sempre lo stesso… sperando
almeno che non sia peggiorato nell’ortografia e nella
sintassi, sapendo già di essere pessimo nella
grammatica!
-5-
MALKUTH
PREFAZIONE
Ho cercato diverse volte di dare forma
all’introduzione che segue, ed inevitabilmente ogni
sforzo è valso solo a riempire il cestino. Da quando
iniziai ad interrogarmi su me stesso e su ciò che mi
circonda, sul mondo, gli altri, Dio e tutta la sequela
di argomenti di natura filosofica e religiosa che presto
tardi un individuo sensibile è portato ad affrontare, mi
sono sempre ripromesso di registrare le mie
considerazioni, degne o mediocri che fossero. Il
successo non mi ha mai arriso. Ora, mentre scrivo per
l’ennesima volta il preambolo al fatidico diario,
ritengo probabile che le circostanze siano quelle
giuste; la situazione di vita che sto affrontando ed i
progetti assunti assieme a Barbara, che nonostante i
momenti oscuri che avvolgono la nostra convivenza è la
persona adesso è sempre che più amo, mi stimola a
prendere la decisione: il diario assoluto. O, meglio,
Diario Assoluto. Non un vano elenco di insipide
considerazioni rubacchiate dai grandi pensatori che
considero i miei numi tutelari, ma la conseguenza di
-7-
vera esperienza di vita, unica fonte che consenta ad un
essere senziente di arrivare a conclusioni per lui
stesso in un dato momento definitive.
Mi chiedo se deve esistere un destinatario, un
qualcuno che dovrà prendere in mano queste pagine e
leggerle per trarre insegnamento od un semplice spunto
di riflessione, ma mi accorgo che pretendere ciò è
vanitoso ed oltremodo superbo. Lascio che questi fogli
di meditazione e cronaca, raccolti ed ordinati per
consentire la sequenza temporale della mia vita, siano a
portata di chi vorrà perdere alcuni minuti della sua
vita. Non pretendo nessun lettore, nemmeno tu, figlio
mio, che graviti ancora nei propositi miei e di Barbara.
Dove sei adesso? Voglio che tu sappia che gli sforzi
della mia vita volti a migliorarmi, ad arricchirmi, la
tensione che mi spinge alla ricerca della comprensione
del mondo e la pazienza richiesta dalla via che sto
seguendo sono indirizzati a beneficio della tua
educazione, nonché all’armonia della nostra famiglia. Io
so che la vita che Barbara creerà con il mio modesto
aiuto, la vita che sarai tu, maschio o femmina che sia,
buona o cattiva, non è che dare ad un altro essere
senziente la possibilità di vivere e di portare a
termine, o perlomeno tentare, lo scopo per il quale è
venuto al mondo, e che corrisponde alla realizzazione
della propria natura. Così il mio compito è quello di
-8-
guida, di maestro di vita, donandoti l’amore che alberga
nel mio cuore, la mia esperienza di vita, i miei
pensieri e la mia fede; e tu, quando il tempo avrà fatto
di te una persona matura e responsabile, saprai e dovrai
decidere cosa tenere e cosa eliminare.
Altre cose desidero esprimere, tuttavia mi accorgo
che una prefazione troppo lunga sa di artificioso e
ricercato, e col tempo tende a perdere la qualità di
immediatezza e sincerità che vorrei abbia per sempre. La
brevità è il veicolo della saggezza.
Termino queste vane righe con la promessa di
trascrivere le sole esperienze di vita e le poche
meditazioni che da queste scaturiscono, restando fedele
per quanto le mie forze me lo permettano al modello
proposto dal Buddha, il grande pensatore e maestro che
ha indicato la Via dell’Uomo.
-9-
ALEPH
3 marzo 1999
1.
Venerdì scorso ho sperimentato per la prima volta
quello che nello zen viene chiamato sanzen, o dokusan,
ovverosia colloquio con il maestro. Si è trattato di un
dialogo spogliato dalla sua veste formale che necessita,
questo perché il Maestro desiderava conoscermi e
riteneva inopportuno trasformare l’incontro in una
cerimonia che probabilmente mi avrebbe solo intimorito,
inibendo la mia volontà ad aprirmi.
Così come accaduto con Philip e Sergio, i due monaci
che ho assunto (senza il loro permesso, mi perdonino)
come guide nella lunga via dello zen, ho spiegato i
motivi, su richiesta del Maestro, che mi hanno spinto a
chiedere il permesso di frequentare il tempio. La
risposta è stata la stessa: conoscere me stesso e la
realtà che mi circonda. Da qui è nato un libero dialogo,
attraverso il quale sono emersi alcuni miei dubbi e mie
incertezze sulla vita e sulla religione, che il Maestro
ha vanificato con vivaci metafore e lucidissime
spiegazioni, entrambe svuotate da qualunque orpello
-10-
teorico ed intellettuale. Il Maestro opera sulla base
della vita di tutti i giorni, quella quotidianeità in
cui siamo immersi e che spesso disprezziamo, cercando
altrove spinte di emersione verso emozioni forti che ci
distolgano allo squallore. In verità non dobbiamo
fuggire, questo è quello che ho capito, comunque ci
portiamo dietro i nostri difetti, e dovunque andremo
trasformeremo la realtà che ci circonda (è meglio dire
la interpreteremo) in ciò da cui siamo sfuggiti.
La discussione ha avuto come perno i cinque
aggregati che compongono l’uomo, e che da diverse
settimane mi tormentano. L’analisi mi portava
irrimediabilmente al karma ed alla rinascita, due
concetti basilari del buddhismo; il Maestro mi ha
indicato la giusta chiave di lettura del karma ed ha
consigliato di evitare di pensare alla rinascita. Il suo
stesso maestro, il Venerabile Deshimaru, ne parlò solo
un paio di volte e dunque lui stesso non vede il motivo
di non fare altrettanto. E’ un uomo che nel parlare pare
saltare da un argomento all’altro, ma se si presta
attenzione è tutto collegato, ed ogni riferimento a
fatti della vita, ai problemi di Milano, della
delinquenza, ed altro ancora, ruota attorno al problema
affrontato in primis. Per questo è difficile per me,
ora, trascrivere in modo esauriente ed intellegibile
quello che il Maestro mi ha detto. Successivamente, nei
-11-
giorni a venire, disporrò di registrare su queste pagine
il risultato delle mie considerazioni, che da venerdì
hanno assunto una nuova prospettiva. A dire il vero, il
mio modo di intendere la vita sembra avere assunto
diversa prospettiva, e ciò è solo positivo. ne sono
felice.
Non ho parlato al Maestro del mio desiderio di
ricevere l’ordinazione monacale, anche se me lo ero
proposto. Quando era nella stanza con lui, devo
ammettere che non mi è nemmeno passato per la mente,
dacché ne deduco che non fosse quello il momento, o che
il mio proposito non è ancora giunto a maturazione.
Tuttavia non vedo altra strada per me se non quella
della via monacale, i cui benefici dovrò riversare
interamente nella vita famigliare. Io e Barbara abbiamo
deciso di avere/fare/creare (quale verbo bisogna usare?)
un bambino. Si tratta di permettere ad una vita di
manifestarsi, di esistere e di tentare il raggiungimento
della propria meta, qualunque essa sia (e noi veglieremo
affinché sia buona e giusta). Non vedo come un padre
deciso sulla Via del Buddha non possa non essere un buon
esempio ed un buon educatore. L’educazione prima di
tutto, e l’amore per la conoscenza, e l’umiltà, per non
confonderci con gli stolti, i gretti, i vanesi che
questa civiltà di fine secolo modella a seconda degli
stilemi e degli stereotipi che si moltiplicano e si
-12-
fagocitano a vicenda. E’ terribile, ma è il mondo che
abbiamo voluto e creato, dobbiamo viverci dentro, quale
modo migliore per sperimentare la nostra forza e la
nostra sincerità d’animo.
-13-
2.
Consideriamo l’essere umano come l’aggregazione
temporanea di cinque elementi, che si forma con la
fecondazione dell’ovulo e si disfa con il sopraggiungere
della morte. Si definiscono skandha, e sono: Forma,
Sensazione, Ideazione, Coscienza e Predisposizione.
Quest’ultimo è di difficile traduzione e si è soliti
chiamarlo col suo nome sanscrito samskara. lo studio
attento di questi aggregati è uno scopo che mi sono
prefisso, il punto dal quale voglio partire per la mia
indagine buddhistica, indagine che potrà essere
soddisfacente solo se si fa compagna di viaggio dello
zazen, strumento principe per la conoscenza suprema.
I risultati delle mie considerazioni (tutt’altro che
definitive) sugli aggregati è opera di quanto letto e di
quanto sentito dal Maestro, cosicché con discrezione
posso dire di avere base solide su cui operare; non
dimenticando lo zazen, grazie al quale a volte ottengo
intuizioni che meritano di essere prese in esame.
Inizialmente cercavo di vedere me stesso come
l’aggregazione degli skandha, ma seguendo il consiglio
del Maestro (considera gli altri come aggregati) mi è
divenuto facile il meditarci sopra. Infatti, quando
osservo una persona, come ad esempio un mio collega, io
noto la sua forma, ovverosia il suo corpo organico. E’
-14-
la struttura che supporta tutto il resto e attraverso la
quale avviene il contatto con l’esterno. La Forma è sede
dei sei sensi (uno dei passaggi della genesi
condizionata) e tradizionalmente è formata dai quattro
elementi: terra, acqua, aria e fuoco. C’è poco da
obiettare, se si presta un minimo di attenzione. Gli
antichi, qui in Europa come là in Asia, avevano la
Sapienza grazie alla quale riuscirono a decifrare alcuni
misteri dell’universo. Questo non è esoterismo, non è
scienza misterica, ma semplicemente razionalità,
indagine analitica della realtà, profonda meditazione. I
presocratici ebbero intuizioni sbalorditive ed è bene
fare alcuni esempi. Talete suppose che tutto ebbe
origine dall’acqua, e la scienza di questo secolo
ipotizza che l’idrogeno fosse esorbitante nei primi
istanti del Big Bang (l’acqua è composta per due terzi
di idrogeno). Anassimandro affermava che doveva esserci
una sorta di giustizia universale, una legge a cui gli
elementi e gli déi e gli uomini tutti si dovevano
attenere; qualcosa di impersonale, non identificabile a
Dio (il Dharma buddhista gli è molto simile). Inoltre,
Anassimandro era sicuro che la terra fosse uno fra i
tanti mondi e che i pianeti si evolvevano, come la vita
(l’uomo discendeva dai pesci e da qualche altro
animale). Teorie senz’altro straordinarie. Più tardi i
pitagorici scopersero che la terra era sferica.
-15-
Inutile continuare, per evitare un elenco di nomi e
fatti, ma è giusto ricordare che la sapienza degli
antichi greci, un faro delle civiltà europee, si spinse
molto avanti, tanto che si dovette aspettare questi
ultimi secoli per riguadagnare quello che andò perduto
durante il Medioevo. Il cristianesimo, fra le sue
pecche, annovera quella di avere causato il declino di
una profonda sapienza e dobbiamo ringraziare gli ordini
indipendenti dei frati e l’amore per la conoscenza del
primo Islam se sono giunti a noi questi insegnamenti.
Tornando alla forma. Dicevo che essa è composta dei
quattro elementi. La terra possiamo identificarla nel
carbonio, la base della vita. L’acqua, si sa,
rappresenta il settanta per cento del nostro organismo.
Il fuoco è l’energia che produciamo dal cibo, e l’aria è
l’ossigeno che abbisognamo per vivere. E su questo non
ci possono essere discussioni.
Il secondo aggregato è composto dai sei sensi:
vista, udito, olfatto, gusto, tatto e mente. Ebbene sì,
nella concezione buddhista, la mente non è un organo
superiore al naso, semplicemente diverso; e non potrebbe
essere differente in un sistema di pensiero che nega un
io superiore, qui in occidente facilmente assimilabile
alla mente. In realtà la Mente, questa volta con la m
maiuscola, ha un valore particolare nello zen, ma non è
-16-
il momento di parlarne, dato che la mia preparazione è
veramente misera.
Ritornando ai sensi, non posso esimermi dal
considerare le lezioni della filosofia occidentale,
nella fattispecie l’empirismo, che identifica nei
fenomeni acquisibili tramite i sensi l’unica fonte di
conoscenza. In effetti, i sensi sono lo strumento con il
quale noi percepiamo la realtà esterna. L’intero
apparato dei sensi si basa su una triplice struttura,
composta dall’oggetto del senso, l’organo sensoriale e
la sensazione. L’organo sensoriale produce una
sensazione, a cui segue la coscienza specifica o forma,
quando percepisce l’oggetto. L’occhio percepisce la
foglia e ne consegue la forma mentale della foglia, lo
stesso dicasi per il naso, l’orecchio, la lingua ed i
dermi. Per quanto riguarda la mente, il problema è
differente. La funzione della mente è il pensare, il suo
oggetto è il pensiero e l’organo è il cervello, che
definiamo mente. La differenza è che l’oggetto della
sensazione non è esterno, la forma mentale è creata
dalla mente stessa sulla base delle altre cinque
sensazioni. La mente si può definire come il senso che
organizza e riunisce gli altri e ne consegue che viene
identificata come la sede dell’io. A riguardo non ho
ancora idee precise; nel buddhismo si nega l’esistenza
dell’io, pertanto mi riprometto di affrontare la
-17-
questione quando la mia maturazione nello zazen sarà
accresciuta
Riepilogo il secondo aggregato nella seguente
tabellina:
Sensi Organ
o
Sensazion
e
Oggett
o
Vista Occhi
o
Vedere Forma
Udito Orecc
hio
Udire Suono
Olfat
to
Naso Odorare Odore
Tatto Pelle Toccare Materi
a
Gusto Lingu
a
Gustare Sapore
Mente Cerve
llo
Pensare Pensie
ro
-18-
Naturalmente, gli organi del senso trovano sede nel
corpo, nel primo aggregato. Non bisogna considerare i
cinque aggregati come cinque elementi separati
temporaneamente assemblati, bensì come entità virtuali,
con una precisa funzione.
Le percezioni sono formazioni mentali che seguono le
sensazioni. Quando vedo un amico, provo la sensazione di
vedere una persona; in un secondo momento percepisco,
attraverso una comparazione tra la persona vista e la
forma memorizzata del mio amico, che si tratta di
Giovanni. Questa è la percezione. La sensazione è un
impulso primario. Anche un pensiero nasce incontrollato,
e diventa percezione quando lo si è riconosciuto come
tale. si può definire, dunque, percezione come quel
riconoscimento della sensazione.
Al contatto segue la sensazione; alla sensazione
segue la percezione; alla percezione segue la coscienza.
Coscienza. Il termine ha un’accezione che comporta
un grande sforzo di comprensione. Cosa è la coscienza?
Perché esiste? Come si manifesta? Di cosa si nutre? La
psicologia e la psicoanalisi hanno fatto un campo di
battaglia della coscienza, decine e decine di scuole
sono sorte, indicandola come sede dell’Io e del Superio,
frazionandola in coscienza, subcoscienza ed inconscio,
ma senza arrivare ad illuminare il nocciolo della
questione: perché esiste.
-19-
Neppure io posso fare altrettanto. Posso affermare
che la coscienza è la consapevolezza di quello che siamo
e di ciò che ci circonda. Io ho coscienza di essere un
essere umano: so cosa sono gli esseri umani, ho studiato
l’argomento a scuola e tramite osservazione ed analisi
mi riconosco come tale. Sono cosapevole di pensare, dato
che osservo i miei pensieri nascere, li posso prendere e
guidare, e ne posso costruire di nuovi, di punto in
bianco. Sono cosciente di pensare. Sono cosciente di
camminare. Sono cosciente di stare scrivendo queste
frasi. Sono cosciente dei miei pensieri verso barbara.
La coscienza è consapevolezza delle nostre azioni, dei
nostri pensieri e delle nostre parole, e della realtà
esterna; consapevolezza che siamo noi a fare determinate
cose o sono altri a farle; consapevolezza di dove ci
troviamo. A volte la nostra coscienza è ingannata,
soggetta ad illusioni, in errore, ma anche in questi
casi assolve la sua funzione di consapevolezza.
Coscienza deriva da coniscire, che in latino significa
“con sapere”. Siamo coscienti perché sappiamo. E che
cosa sappiamo meglio di ogni altra cosa? Sappiamo bene
quello che vediamo, quello che ascoltiamo, quello che
odoriamo, quello che assaporiamo, quello che tocchiamo e
quello che pensiamo, in ultima analisi tutto quello che
passa attraverso i nostri sensi. Contatto, sensazione,
percezione… coscienza. Ad ogni sensazione la sua
-20-
coscienza: visiva, uditiva, olfattiva, gustativa,
tattile e mentale; si compenetrano a vicenda
strutturandosi nella complessa Coscienza.
Oltre, in questo stadio della mia ricerca, non posso
andare.
L’ultimo aggregato è difficile, non per altro perché
sankharaI è difficilmente traducibile. Può voler dire
“predisposizione”. Quando nasciamo abbiamo un patrimonio
genetico, in parte ereditato, una prima predisposizione.
Quando cresciamo l’ambiente in cui viviamo ci plasma,
una seconda predisposizione. L’educazione è una terza
predisposizione. Infine, bisogna considerare la
predisposizione che continuamente si forma in
conseguenza delle nostre azioni, delle nostre parole e
dei nostri pensieri. Questa predisposizione è il karma,
e qui si entra in un contesto che necessita
ponderatezza, profondità di analisi ed esperienza.
Quello che posso dire io rientra nella congettura.
Preferisco per il momento tralasciare.
Al karma segue la genesi condizionata e le quattro
verita esposte dal Buddha. Prima del karma, e dopo, ci
sono gli aggregati. Mi propongo di ritornare
sull’argomento, soffermandomi a lungo su ogni aggregato.
-21-
3.
Devo prendere una decisione la cui conseguenza non
sarà indifferente per la mia vita. Mi riferisco al bivio
davanti al quale mi trovo: abbandonare il karate per lo
zen, oppure proseguire con gli allenamenti, seguendo la
strada che ho fatta mia da quasi quindici anni. A prima
vista sembrerebbe assurdo mettere sulla stessa bilancia
karate e zen, tale che nella mia esistenza ve ne possa
entrare uno solo, come se tutte due rappresentassero
interpretazioni del mondo in contraddizione. La verità è
molto più semplice… e più bella. Queste attività (che
orribile sostantivo) costano, e la cifra richiesta
impone una scelta. Come si vede è una questione di
pragmatica, per questo l’ho definita una verità bella;
perché per una somma di denari – che sono la cosa più
aleatoria ed impermanente ed illusoria di questo mondo –
io devo decidere della mia salvezza. Poco importa, e
comunque nella mia intima profondità ho già deciso. Devo
solo giustificare questa scelta e considerare la
possibilità che me ne possa pentire un giorno a venire.
Ora voglio elencare i pro ed i contro.
Karate
Pro: salute, prontezza fisica, virilità, serenità
dovuta allo sfogo, autodifesa, linea, agilità ed
elasticità, probabile longevità, disciplina, amicizia.
-22-
Contro: momentanea mancanza di stimolo, spazio
temporale che impiegherei per attività che adesso trovo
più soddisfacenti, utilità limitata all’autodifesa ed
alla serenità, visto che la forma fisica posso
mantenerla con della corsa serale ed un buon vogatore e
la serenità è una prerogativa del mio modo di vivere.
Zen
Pro: pace interiore, possibilità di raggiungere la
comprensione totale, via per la salvezza, fascino
irresistibile, saggezza, verità, stimolo allo studio
della filosofia, possibilità di migliorarsi, altruismo,
felicità, disciplina ed educazione.
Contro: ampio spazio temporale da dedicarci (senza
alcun rimpianto), sacrifici, responsabilità, sforzo
duraturo per tutta la vita.
Quello che debbo fare è fermarmi, sedermi, prendere
questo elenco e meditarlo punto per punto. Tuttavia, so,
per certo, che solo l’intuito mi darà l’esatta
indicazione. Quello che posso dire con sicurezza è che
adesso, ne sono sorpreso, sono attaccato allo zen come
al karate, e sono solo passati pochi mesi da quando ho
iniziato a frequentare il tempio. Sto assistendo alla
nascita in me di un nuovo desiderio… no, alla
realizzazione di un desiderio che mi perseguita da
tantissimi anni, cioè la via religiosa (intesa come una
strada da seguire che non esclude la quotidianità della
-23-
vita, l’amore, il lavoro e tutti i problemi connessi).
Voglio che passino altri due o tre mesi prima di
prendere la decisione. Voglio vedere cosa succede, come
si evolve la trasformazione, dove vado a finire ed in
che modo.
-24-
4.
In tutti questi anni di vita, fra le poche verità
che posso dire di avere appurato c’è ne una che mi è
particolarmente cara. Desidero dispiegarla in tutta la
sua ampiezza, che è breve, perché la ritengo
strettamente legata alla dottrina buddhisa… E quale
realtà del mondo non è legata alla vita indicata dal
Buddha? Comunque sia, ecco di cosa si tratta.
Una persona manifesta se stessa nelle azioni, nelle
parole e nei pensieri. I pensieri ci sono celati, anche
se le loro conseguenze spesso si riflettono nelle azioni
e nei pensieri, mentre le opere e le favelle sono
oggetti immediati della nostra attenzione e della nostra
analisi; e per quanto noi ci sforziamo di esternare un
comportamento il più delle volte artificioso, fittizio
oserei dire, sempre una parte di noi stessi è presente
in quello che facciamo. Prima conclusione: noi siamo
quello che diciamo e facciamo. Anche quando mentiamo ed
assumiamo comportamenti precostruiti, siamo sempre noi,
indubbiamente. Seconda conclusione: vi sono
atteggiamenti, in alcuni circostanze della vita, che noi
ci sforziamo di controllare, ad esempio durante l’ambito
lavorativo, le cene di gala, le riunioni, la visita ai
parenti. Per lo più sono situazioni nelle quali è
necessario ostentare certe maniere per procurarci dei
-25-
vantaggi. Definiamoli comportamenti primari o maggiori.
Terza conclusione: nelle vicissitudini che riteniamo
banali, nella quotidianità, nelle faccende di casa,
insomma, in tutti quei momenti che non riteniamo
importanti per la realizzazione dei nostri desideri, noi
non riteniamo opportuno controllarci. Definisco questi
atteggiamenti come comportamenti secondari o minori.
Finale: manifestiamo il nostro vero essere nei
comportamenti minori, appunto perché non ritenendo di
controllarci ci lasciamo andare. Ed è questa la verità
cui sono giunto. Se vuoi scoprire le qualità di una
persona, osservala nelle minuzie, facilmente
individuerai la sua vera natura. Ugualmente si può fare
attraverso l’analisi dei comportamenti primari, salvo
che è necessario una maggiore attenzione, una più lunga
conoscenza della persona ed una certa infarinatura di
psicologia. Lo stesso non si può dire per i
comportamenti minori, vero specchio dell’animo umano.
Per questo il Buddha esorta alla purezza ed al controllo
in ogni momento della giornata, senza dividere la nostra
vita in momenti importanti e momenti trascurabili.
Da questa verità si possono trarre due corollari. Il
primo è che la nostra natura si manifesta attraverso
pensieri, parole ed azioni, tanto che forse è meglio
affermare che i pensieri, le azioni e le parole sono la
nostra natura. Il secondo corollario dice che noi siamo
-26-
portati a costruire comportamenti artificiali per
controllare le situazioni; ma, in ultima analisi, anche
queste artificità sono manifestazioni della nostra
volontà, ovverosia di noi stessi.
Per dare un senso a quanto sopra esposto,
bisognerebbe fornire un’adeguata accezione di natura, di
pensiero, parole ed azione, di manifestazione e di
essere. Posso concludere che un problema risolto ne
formula altri che a loro volta ne formano altri, e così
via.
Quello di cui mi rendo conto è che devo comunque
partire dal concetto buddhista dei cinque aggregati,
formulazione pragmatica e quanto mai efficace
dell’essere vivente, per potere discutere con un minimo
di soddisfazione dei problemi filosofici che mi stanno a
cuore.
-27-
5.
Per quanto non conducano a soluzioni, a volte i
dialoghi su taluni problemi filosofici possono tornare
utili, non per altro perché stimolano l’intelletto ed
accrescono la cultura personale. Siamo esseri senzienti,
liberi di pensare ed agire, e soffermarci di tanto in
tanto sulle questioni della filosofia non può che essere
un bene. Se ne ricava benessere interiore, pace mentale
e serenità nella vita. Oggi, fra colleghi, si è toccato
la questione universale della morte. L’umanità si è
evoluta influenzata dal problema della morte e credo che
le religioni trovano la ragione d’essere nel timore in
cui l’idea della morte getta ci si soffermi sopra a
ragionare. Siamo essere senzienti, come sopra detto, e
non è stupido chiederci cosa succede di noi quando la
vita fluirà fuori dal nostri corpo per lasciare a terra
un oggetto freddo giustamente definito cadavere.
A parlarne eravamo io, Antonella e Roberta, che per
lo meno sono in grado di affrontare queste discussioni
senza cadere nelle ingenue credenze di cui ancora soffre
l’umanità di questo secolo. Certo, la cultura cattolica
è bene impregnata nei loro ragionamenti, non è facile
riuscire a liberarsene per pensare da uomo libero, ma
non si ritraggono davanti a differenti concezioni ed
accettano il dialogo. E’ stata sempre una difficoltà per
-28-
me quella di trovare delle persone disposte a dialogare
di filosofia e religione, e dunque non posso che essere
felice di parlare con loro due, anche se alla fine non
si arrivi ad un accordo comune. Quello che conta, devo
dire, non è raggiungere un accordo comune, quanto la
discussione critica per trovare sempre nuove soluzioni.
E’ così, secondo me, che la filosofia cresce.
La morte, dunque. Morte contrapposta a vita. Ecco
che per definire l’una, bisogna descrivere l’altra. Sono
due opposti? Oppure morte non è che non-vita? Od è la
vita che è definibile come negazione della morte? Ora
cerco di analizzare il problema, anche sulla scorta di
quanto ci siamo detti in ufficio.
Quando cessano le attività biologiche di un
individuo, quando l’attività muscolare cessa, e dunque
il sangue non circola più con la conseguente mancanza di
distribuzione di ossigeno e di tutti gli altri elementi
vitali, sopraggiunge quella che viene definita morte,
ovverosia la cessazione di qualunque funzione vitale in
un organismo composto da una o più cellule, e nella
fattispecie di questa discussione, dell’uomo. Cosa
succede? Antonella mi ha parlato dell’anima, in cui
crede fermamente per via della sua fede cattolica,
mentre io mi sono limitato a dire che non so cosa
succeda; al contrario so, e con certezza, che il corpo
freddo che rimane non è più l’individuo che poco prima
-29-
viveva. E’ solo un cadavere. Certo, è quello che rimane
della persona, ma solo una parte, un componente, dello
stesso valore dei nostri ricordi. Che fine hanno fatto i
pensieri, i sentimenti e la coscienza di quella persona?
Io ragiono su linee di pensiero buddhiste, e vedo l’uomo
come un composto di cinque aggregati: corpo, sensazioni,
percezioni, coscienza e predisposizioni, di cui
precedentemente ho parlato e che in futuro riprenderò ad
analizzare. Qualcosa tiene uniti questi aggregati, non
so che cosa. So, che quando questa forza viene meno, i
cinque aggregati si scindono, e l’individuo cessa di
essere. L’ego non è più. Oltre non posso andare.
Da questa conclusione mi sono permesso di trarre un
corollario a mio parere del tutto coerente: è inutile
andare a trovare i propri cari al cimitero,
semplicemente perché i fiori li depositiamo su una tomba
che racchiude una massa putrescente di carne infetta che
tutto è tranne che la persona che ci è venuta meno.
Questa non esiste più, almeno nella sua rappresentazione
in questo mondo. Qualunque cosa sia diventata, non so
spiegarlo, nemmeno lo immagino, né voglio affidarmi a
teorie bizzarre sulla reincarnazione ed altre cineserie
del genere; non perché non siano rispettabili,
tutt’altro, ma si da il caso che siano lontanissime
dalla mia concezione, per quanto io frequenti un tempio
-30-
buddhista e mi stia lentamente e faticosamente
incamminando sulla via indicata dal Buddha.
Naturalmente, questo mio dire non ha trovato
sostenitori in Antonella e Roberta, che ritengono
doveroso rispettare la memoria dei propri cari andando
al cimitero. Io non ho contraddetto, non devo
contrastare le opinioni altrui. In questa sede dico solo
che un conto è rispettare la memoria dei propri cari, un
conto andare al cimitero, un altro conto ancora
ritualizzare questo ricordo attraverso cerimonie
religiose. Non aggiungo altro, tranne il dubbio che si
trattino di residui di un modo di pensare superstizioso.
Io ho una foto di mio padre, incorniciata sopra il
comodino, per non dimenticare l’uomo a cui devo la mia
vita, anche se ha commesso errori e avrebbe potuto
essere un padre migliore. Ma sono ben consapevole che
non c’è più l’essere vivente corrispondente
all’individuo Sergio Paghini, né in questo mondo, né in
qualsiasi altro ipotetico mondo. L’individuo Sergio
Paghini era tale in quanto un composto di varie qualità.
Alla sua morte, il composto si è disfatto, le qualità
deteriorate o sparite, e qualunque cosa ne sia rimasta,
anima, energia o cos’altro, non può essere identificata
con Sergio Paghini.
-31-
6.
Oggi ho riletto l’opuscolo informativo del tempio
del maestro Ryusui, e con meraviglia mi sono accorto che
alcune asserzioni contenute sono state da me
interpretate, o meglio comprese diversamente di quando
le lessi per la prima volta. Oso dire che si tratta di
una migliore comprensione, maggiore anche se non
definitiva (per fortuna!). Ho tratto piacere da questa
scoperta e mi chiedo se lo stesso può accadere per i
testi buddhisti che ho studiato i mesi passati. Potrebbe
darsi; dunque ritengo opportuno dedicarmi con calma e
ponderatezza alla rilettura del Dhammapada, del Sutra di
Hui Neng, e dei due sutra fondamentali della
Prajnaparamita. E’ anche vero che mi sono proposto di
passare un anno, il presente, di esclusive letture
filosofiche e buddhiste, evitando le riletture per così
potere ampliare lo spettro di indagine. Affido allo
zazen, strumento principe, il compito di illuminarmi
della vera saggezza. Non sono presuntuoso, dato che so
per certo che difficilmente questo potrà accadere, così
come so che le mie capacità di indagine filosofica sono
limitate. Quello a cui aspiro è la tenacia, lo sforzo e
la concentrazione per perseguire l’obiettivo, anche se
irraggiungibile.
-33-
7.
Sono pervenuto ad una conclusione. In verità già da
qualche settimana ruoto attorno a questo buco
gravitazionale, ed essendo partito da un’intuizione,
piuttosto che da una asettica elucubrazione, mi piace
pensare che abbia il sapore della verità.
La espongo con la maggiore brevità possibile,
evitando gli orpelli e le lungaggini che non fanno altro
che stimolare una personale interpretazione. La mia non
è stata una interpretazione, bensì un’intuizione nata da
osservazioni di esperienze personali.
Credo che solo attraverso l’analisi obiettiva di
esperienze di vita si possano trarre conclusioni valide,
anche se il dato soggettivo, e pertanto parziale,
pressoché sia dominante.
Vediamo di cosa si tratta.
Più di una volta mi è stato chiesto quale era la
ragione che mi avesse spinto a richiedere di essere
ammesso al tempio. E’ una domanda imbarazzante, perché
va a toccare corde intime, aspetti del mio pensiero che
di solito amo tenere in disparte in modo da ragionarci
sopra, senza permettere ad altri di fare altrettanto. Se
si esclude Barbara, il cui giudizio è per me di
fondamentale importanza, non ho nessuno con cui
condividere certe scelte di vita, e, tutto sommato, non
-35-
vedo perché dovrei cercare qualcuno a questo proposito.
I monaci del tempio, è vero, essendo di loro pertinenza,
non possono ammettere qualcuno senza averne verificato
la spinta interna; ma rimango, tuttavia, dell’avviso che
una simile domanda forse andrebbe posta alla fine della
sessione di prova, per evitare che l’interessato, preso
di sprovvista, risponda con frasi banali, senza senso. E
si rimane sorpresi, per forza di cose, giacché molte
volte operiamo delle scelte sulla base di semplici
intuizioni e non guidati da analisi razionali. Nel caso
in questione, non so di preciso come io sia giunto alla
decisione, in tre mi hanno fatto la stessa domanda, e la
mia risposta più o meno si è equilibrata sulla stessa
linea di tendenza. Con lo zen io voglio raggiungere la
comprensione totale della realtà. Considerata la
conclusione cui sono giunto e che mi appresto ad
esporre, ho trovata la soluzione alla domanda.
La nostra vita è un succedersi di eventi, una
sequenza temporale all’interno della quale una causa
origina un effetto che a sua volta sarà causa. Da un
punto di vita pragmatico, il momento attuale di un
essere vivente, l’evento che sta vivendo e che è
l’unico, in quanto presente, è l’effetto dell’evento
accaduto precedentemente, e così indietro nel tempo. Io
sto scrivendo sì perché ho deciso di esporre questa
conclusione – e dunque l’evento dello scrivere è
-36-
l’effetto della causa di voler esporre – ma anche perché
prima di accendere il computer mi sono seduto, e prima
di sedermi ero in piedi, e prima sono arrivato dal bagno
dove mi sono lavati i denti… e così via. Se ne deduce
che esistono due tipi di cause, e di conseguenza due
tipi di effetti: 1) un’origine causale dell’effetto, 2)
un’origine modale dell’effetto. Uno stesso effetto, così
come una stessa causa, che definisci origine, è
contemporaneamente dei sue tipi. In realtà non cambia
niente, solo l’interpretazione soggettiva. Vedo di
spiegare meglio le due origini, antecedendo la mia
definizione di evento.
Evento. Particolare situazione nella quale un essere
vivente si trova ad agire, intendendo il verbo agire
come il manifestarsi di azione, pensiero e parola.
Evento è l’azione attiva o passiva dell’individuo nei
confronti di una situazione che gli si crea attorno per
sua o meno spontanea volontà. La vita è un evento, a sua
volta suddivisa in sottoeventi, a loro volta
suddivisibili in microeventi. Più avanti cercherò di
avvalorare questa tesi.
Origine causale. Un evento accade in base ad una causa.
Può essere un atto di volontà dell’individuo che ha
creato la situazione, o il risultato di azioni avvenute
in passato. La causa dell’evento è il perché
quell’evento è stato voluto. Sto scrivendo queste note;
-37-
perché? Nell’atto dello scrivere chiarifico a me stesso
un’analisi fatta prima di addormentarmi tempo addietro.
E’ dunque la volontà di esporre e migliorare una tesi
che mi spinge a scrivere, ergo l’origine causale è la
volontà di critica (soltanto analizzando e criticando
una tesi se ne può ricavare la sua validità). Se poi
continuo il processo all’inverso, noto che l’origine
causale è a sua volta un effetto di quel ragionamento
serale di cui sopra. Altro esempio. Sto fumando la pipa.
So che mentre fumo la mia capacità di concentrazione può
aumentare, e ne traggo la conclusione che l’atto di
volontà di accendere la pipa è dovuto al desiderio di
ragionare al mio meglio.
L’origine causale riguarda la causa, la volontà,
l’atto decisionale che comporta l’evento, l’origine
prima che si differenzia dal modus operandi. Se io esco
per strada e nell’attraversare vengo investito, non si
pensi che non esiste l’origine causale di ciò. Bisogna
chiedersi: perché sono voluto uscire? Cosa andavo a fare
e perché? Mettiamo che sono uscito per andare in
libreria, nella speranza di trovare un testo sullo zen.
Non ci arriverò mai, stirato da una vettura condotta da
una donna che per un attimo si è distratta per dare
retta al figlioletto seduto accanto. L’evento, dal mio
punto di vista, è passivo, io ho subito, non volendo che
si verificasse l’incidente. Si direbbe un caso. E’ un
-38-
errore: il caso non esiste. Sono uscito con la precisa
volontà di cercare un libro, ed ho attraversato la
strada con un atto di volontà. In un certo senso ho
creato l’evento, assieme alla donna. L’evento in
questione è un nodo di due linee di causa ed effetto, la
mia e quella della donna, entrambi un succedersi di
situazioni volute, nelle quali si è agito con azioni,
pensieri e parole. Il caso non può esistere.
Origine modale. E’ strettamente legata alla precedente
e riguarda gli stessi eventi, solamente dal punto di
vista del modus operandi. Ritorno agli esempi
precedenti. Ho chiarito l’origine causale di queste
note, ma non bisogna tralasciare il modo in cui le sto
scrivendo:col computer. Perché ne ho uno. Perché l’ho
comprato. Perché sono entrato in un negozio. Perché lo
pagato. Non bisogna confondere l’origine modale con
l’origine causale, altrimenti dovrei specificare l’atto
di volontà che mi spinge a scrivere al computer. In
questo caso il motivo sarebbe la possibilità di scrivere
più velocemente, correggendo gli errori. Ma tutto ciò
non c’entra con l’origine causale. Vediamo l’altro
esempio. Vengo investito dalla macchina perché c’è una
macchina, e perché la donna l’ha comprata, e prima
ancora la scelta, e di quel modello per via della sua
disponibilità economica, perché il concessionario era
-39-
vicino a casa, e via dicendo. Anche qui abbiamo una
causa ed un effetto.
Mi rendo conto che non ho mantenuto le premesse di
esporre i due tipi di cause. Solo adesso mi accorgo di
una terza causa, di tipo temporale: l’origine temporale.
Origine temporale. E’ forse la madre di tutte le
origini, quella che esistendo permette il formarsi della
catena causa-effetto. E’ molto semplice. Io posso
scrivere in questo momento, ovverosia l’evento scrivere
si effettua grazie al fatto che un evento lo ha
preceduto, anche se nulla ha in comune. Prima di
scrivere sono stato in bagno per necessità fisiologiche.
L’operazione di defecare ha preceduto quella dello
scrivere, così come quella di giocare con Ciri – il cane
che vive con me e Barbara – è venuto ancora prima. Nulla
in comune tra i tre eventi, tranne il fatto che fanno
parte di una precisa sequenza temporale. Causa ed
effetto anche in questo caso? Il tempo è un succedersi
di eventi non legati tra loro se non dal fatto che si
susseguono? L’evento defecare ha anticipato quello dello
scrivere, e, dunque, su quali basi posso asserire che le
note che sto buttando già hanno un valore (posto che
l’abbiamo) maggiore della materia organica di scarto che
tramite lo scarico idrico ho convogliato alle fogne? Una
bella domanda senza risposta. Ma, a dire il vero, e
proprio a questo punto che volevo arrivare.
-40-
All’inizio di questa riflessione, ho specificato che
volevo esporre una mia conclusione, cosa che mi accingo
a fare, ora che ho in mano tutti i dati. Si tratta di
una conclusione legata ad una esperienza che sto
vivendo. Ritengo inutile formulare teorie astratte
legate ad osservazioni generali lontane dalla mia vita,
e quando le formulo devono essere il più possibili
vicine al mio vissuto.
Non intendo più in futuro dare una risposta
definitiva alla domanda: perché sono voluto diventare
buddhista? Da quanto sopra esposto, una risposta
definitiva esiste in base a cause precedenti, e dunque
crea una domanda che necessita di una risposta, e così
retrocedendo arrivo al momento della mia nascita. Tutto
quello che ho fatto e che ho pensato è la diretta
conseguenza della mia nascita. Per rispondere
esaurientemente al quesito perché sono buddhista devo prima
capire perché sono nato, e perché sono nati i miei
genitori, e perché esiste l’universo. Non può esserci
risposta, solo congettura. Devo, pertanto, dimenticare
la ricerca di questa risposta e rendermi conto che
l’atteggiamento che devo tenere è di assoluta
ricettività. Devo diventare piatto come l’oceano, liscio
ed immobile, in modo tale da accorgermi anche del cadere
di una microscopica goccia. Se l’oceano diventa
tumultuoso, tutto intento ad osservare se stesso, non si
-41-
accorge di nulla se non di se stesso e dei suoi
problemi. Dare una risposta vuole dire interpretare,
avere aspettative e speranze, e questo non può che
significare che sviare il mio percorso. Non posso
insinuare un filtro tra me e la via del Buddha, ma posso
e devo non volere niente, accettando tutto quello che mi
viene incontro.
-42-
8.
Sono quanto mai convinto che uno studio approfondito
del buddhismo debba partire dagli aggregati, ovverosia
dall’essere umano. Noi siamo lo strumento di analisi
della realtà, il parametro di identificazione e l’unico
filtro dal quale scaturisce ogni interpretazione; ne
conviene che senza una seria riflessione su codesto
mezzo di comunicazione, oserei dire medianico, non si
può iniziare il cammino indicato dal Buddha. Come dice
Popper, non esiste l’induzione, cioè la teorizzazione di
una o più osservazioni di accadimenti; il che vuol dire
che da pure osservazioni io non posso trarre nessuna
legge. Semmai il contrario. Lo studioso parte da un
azzardo, da un’ipotesi su un determinato campo, al che
segue l’osservazione mirata a confutare tale ipotesi, a
decretare la sua falsità; e fintanto che la sua fallacia
non è provata da serie di esperimenti, si può ritenere
valida. Condivido appieno questa linea di pensiero e
credo sia saggio applicarla anche al buddhismo. Voglio
partire da un’ipotesi di lavoro, nella fattispecie i
cinque aggregati, quindi osservare e sperimentare per
confutarla. Venticinque secoli di buddhismo dovrebbero
insegnarmi che non può essere abbattuta, ma sono
convinto che ognuno di noi deve camminare con le proprie
gambe e verificare di persona ogni parola del Buddha.
-43-
9.
Questi ultimi mesi posso definirli fra i più
significativi della mia vita. Sto assistendo ad una
crescita interiore che farò di tutto per trasferire in
ogni aspetto della mia vita quotidiana, perché ritengo
di poter raggiungere quella serenità basilare per il
benessere della mia famiglia. E più che mai è necessario
per me raggiungere questo scopo, non solo per amore di
Barbara, ma anche per nostro figlio, che se ancora non
esiste biologicamente già è presente nei nostri
pensieri. Sono felice quando vedo che ogni aspetto della
mia vita sta assumendo contorni sempre più definiti, e
se è vero che molto è da migliorare, è anche sì certo
che la sostanza è quella giusta per plasmare ciò che
desidero. E cosa desidero? La felicità di Barbara; la
serenità della famiglia; un bambino; la conoscenza; la
salute mia e di chi amo; tutto questo più ancora che il
benessere economico e la carriera. Ed ora mi accorgo,
dopo mesi di zazen e meditazioni, che non posso
pretendere l’avverarsi dei desideri sopra esposti senza
prima avere operato su me stesso. Se voglio la felicità
di Barbara, devo essere io stesso felice. Se voglio la
serenità della famiglia, devo essere io stesso sereno.
Felicità e serenità sono sintomi della libertà di
pensiero, del rispetto per ogni forma di vita e pensiero
-45-
e dell’amore per la conoscenza. La conoscenza ed il
desiderio di libertà intellettuale portano
all'emancipazione, i cui fiori sono serenità di spirito
e felicità di cuore. Solo la Via che sto seguendo mi può
donare l’emancipazione, ed io ne ho bisogno; non perché
senza di questa non possa amare Barbara, scrivere poesie
e vivere bene, bensì perché non sarei un uomo libero e
fiero e dunque degno di rispetto, e lo devo essere per
valorizzare ai più alti livelli la vita in comune con
mia moglie. Quante volte mi sono chiesto lo scopo del
matrimonio e dell’amore; i motivi profondi della nostra
unione e la fonte primaria del mio amore. Le risposte
sono poesie che ho scritto nei corsi di questi tre anni,
ma solo adesso mi rendo conto che non sono riuscito a
scorgere il vero valore del nostro matrimonio e
l’intrinseca bellezza di Barbara. Solo ora che capisco
che ogni aspetto della vita non va ripudiato, che
l’amore è il sentimento unico che ci sorregge e che la
libertà è l’unica via per il rispetto e che la
conoscenza è strumento e fine di emancipazione, posso
finalmente donarmi completamente al matrimonio e mirare
il suo significato. Che è quello di completare
l’individuo grazie all’aiuto di un altro individuo, di
permettere ad una nuova esistenza di venire al mondo e
di praticare quelle virtù che ci possono avvicinare
all’illuminazione. Il matrimonio è un campo di prova che
-46-
ci spinge al miglioramento, e senza amore non può
esservi matrimonio: il rispetto per l’altro lo pretende.
Altro vorrei dire sul matrimonio ed altro dirò.
Concludo questa brevissima dissertazione con il
ricordare a chi legge queste righe che il mio amore per
Barbara è sincero, e pulito come una fonte di montagna,
santo come i fiori sull’altare del Buddha, totale come
il cielo sopra di noi. Se è dentro di me è per una
ragione precisa e fondamentale e devo fare di tutto per
mantenerlo vivo, come il fuoco sacro. Perché è fuoco
sacro.
-47-
10.
L’umanità non ha fatto alcun progresso, dai tempi
della prima apparizione dell’homo sapiens sapiens ad
oggi. Non mi sto riferendo ad un progresso scientifico e
tecnologico, dato che nessuno può obbiettare la crescita
della conoscenza e dell’abilità umana sotto questo punto
di vista. Io parlo della spiritualità, non
esclusivamente religiosa, e della moralità. Dopo
un’attenta analisi, imparziale ed investigatrice,
chiunque si può rendere conto che l’umanità della Grecia
classica dei costumi, della società e del pensiero
rispecchia quella dell’Italia odierna, tanto per fare un
esempio. Certo, possiamo affermare che la democrazia e
la libertà individuale sono diventati due diritti
inalienabili, che il senso di rispetto e tolleranza e
difesa dei diritti umani è maggiormente sentito, che la
preoccupazione per la salvaguardia dell’ambiente si stia
facendo strada nel cuore di tutti noi… ma nella vita
pratica, nella quotidianità, nei piccoli gesti di tutti
i giorni siamo sicuri di essere cresciuti? Violenze ai
minori, stupri, rapine, omicidi, repressioni
psicologiche, autoritarismi ed altri comportamenti
similmente abietti sono all’ordine del giorno. Abbiamo
il telefonino e la navetta in orbita attorno alla Terra,
per non parlare di altre meraviglie tecnologiche, e la
-48-
scienza compie passi da gigante, nella fisica, nella
matematica e nella biologia, eppure lo spirito latita,
la filosofia si è rimpicciolita, le religioni sono
diventate una superstizione, la morale tanto cara a Kant
è una bandiera per gli ipocriti, la metafisica un genere
del fantastico, il rispetto per qualunque essere vivente
una campagna commerciale.
Al mondo, in questo momento, ci sono decine di
guerre in atto, piccole o grandi che siano, e mentre il
mondo cosiddetto civilizzato languisce nella pace e nel
benessere, dove vige la povertà, la miseria e la
tirannia le lotte non finiscono mai. Ma esistono i paesi
civilizzati? E che cosa è un paese civilizzato? Ci sono
paesi basati sull’economia e sull’uso di una fine
tecnologia, dove il capitalismo è imperante e la
mentalità affaristica è alla base della struttura
sociale; questo è il paese civilizzato di oggi. Ebbene,
io lo rinnego. Rinnego di essere italiano, se vuole dire
rinunciare ai valori umani e spirituali, che da secoli
sono additati da filosofi e maestri. Rinnego di essere
una persona civilizzata, se vuole dire privarsi della
libertà intellettuale per infarcirsi dei concetti
preconfezionati belli esposto sugli scaffali del tutto
pronto e facile.
Noi viviamo in una realtà che non corrisponde al
mondo realmente esistente. E’ un simulacro basato sul
-49-
bisogno superficiale e sfizioso immediatamente
soddisfatto da una risposta sempre più sofisticata che
genera una richiesta ancora maggiormente complessa ed
inutile. Il sistema in cui ci siamo imbrigliati non è
più governato dalla domanda dell’utenza, ma dalla
risposta del mercato; è la risposta che genera i
bisogni, e dato che i veri bisogni sono pochi e non
vendibili, ne consegue che siamo bombardati da articoli
vuoti e demenziali. In questo mondo artificiale,
illusoriamente sereno e ricco, bucherellato da migliaia
di valvole di sfogo (delinquenza, droga, discoteche,
tifo allo stadio, ecc.) ci siamo sigillati, sordi al
richiamo della Realtà, imbrigliati nel ciclo chiuso di
un falso progresso.
Dai venticinque ai venti secoli fa, più o meno,
l’umanità ha ideato scuole di pensiero stupefacenti. Io
ho deciso di appellarmi a questa tradizione, che è
giunta sino a noi grazie a uomini e donne quali Kant,
Russel, Gandhi, Madre Teresa di Clacutta, e molti altri
maestri nascosti ma ugualmente superiori, dalla cui
sapienza si può attingere liberamente per emanciparsi ed
aiutare l’umanità a ritrovare se stessa.
A guerra nella ex Jugoslavia sembra non finire mai,
come un emorragia che riversa sulla terra esausta la
linfa vitale dell’ultimo uomo. Bisogna battersi, nel
proprio piccolo, per sanare questa piaga.
-50-
11.
La prima esperienza di sesshin. Due giorni di zazen,
senza parlare, nel tempio giorno e notte. Sono passate
poche ore dalla sua fine e non trovo con che parole
descrivere l’accadimento. Ma che cosa è accaduto? Posso
veramente, adesso, seduto a tavolino, tracciare segni
intelligibili che potranno chiarire ad un lettore,
chiunque esso sia, l’esperienza da me vissuta? Ma,
ancora, quale esperienza? E’ stata una sofferenza, un
estenuante lotta a sopportare il male alle ginocchia, il
sonno, il desiderio di alzarsi, una lotta a contare le
respirazione, cercando disperatamente di non tenere
conto delle migliaia di pensieri che fiorivano e
rifiorivano senza sosta.
Se devo trarre un bilancio, non posso dire che esso
sia attivo… nemmeno a pari. Ho perso, lo ammetto, anche
se mi aggrappo alla labile scusante che essendo stata la
prima volta non ero preparato. Il primo zazen è passato
veloce, mi sentivo bene, tranquillo, concentrato sulla
respirazione, contando le inspirazione e le espirazioni.
Col secondo zazen è cominciato l’inferno. Sembrava non
finire più, le gambe mi dolevano, non riuscivo a
concentrarmi (in due ore non sono arrivato una sola
volta al dieci). Al terzo ho cambiato conteggio,
numerando solo le espirazioni. Qualcosa è migliorato,
-52-
effettivamente mi sentivo concentrato sulla respirazione
e sull’hara; tuttavia la mia mente era un campo di
battaglia, una fabbrica di sogni, visioni, desideri,
speranze, che nascevano e morivano ad un ritmo veramente
sconcertante. Spesso mi accorgevo che seguivo un
pensiero, costruendo una vera e propria trama, allora
mi buttavo tutto sull’espirazione e cominciavo
dall’inizio.
Momento magico è stata la cena. Un piccolo rituale,
il gassho prima di prendere il cibo e le bevande, lo
Shiguseigan iniziale, la consumazione del pasto in
silenzio, quasi fosse zazen anche quello. Ecco, cosa
traggo da questi due giorni. La vita, quella di tutto i
giorni, che ci pare banale e scontata, possiede aspetti
che noi trascuriamo e che dovremmo tutto al più quasi
santificare, onorare e rispettare. Come il momento nel
quale si ingeriscono alimenti, colazione, pranzo o cena
che sia. Oggi giorno trangugiamo con ingordigia, senza
soffermarci a pensare da dove viene quel cibo, come è
stato preparato, chi l’ha preparato e, cosa
fondamentale, chi era prima di diventare cibo, la sua
storia, che come la nostra affonda nelle radici del
tempo. Nel dojo, in seizan con il piatto in mano, dopo
l’invocazione, la pasta con le verdure (buona, devo
dire) era essenza di vita, alimento divino, unico e
raro. In quell’istante, decine di storie, da quella
-53-
della fabbrica della pasta a quella della pianta di
patate, sono confluite, concretizzate. Mi viene da dire,
realizzate, ma forse è troppo.
Credo che sia l’unica conclusione che sia sorta
dentro di me finito questo sesshin. Lo zazen non mi ha
dato nulla (certamente sono io incapace di afferrare
qualcosa). Già ora prendo la decisione di frequentare
anche quello successivo, iniziando già adesso a
praticare quotidianamente zazen con più tenacia,
assolutamente concentrato sulla respirazione. E
nient’altro. Solo respirazione.
-54-
12.
Sono consapevole del mio carattere ombroso e di
quell’atteggiamento che si potrebbe definire di
indifferenza. Indifferenza verso il mondo che mi
circonda, verso il prossimo, verso i sentimenti degli
altri, verso il loro dolore. A volte mi soffermo a
riflettere, domandandomi come mai persevero nel
fallimentare tentativo di modificare questa pecca.
Eppure ritengo di essere sensibile, sia alla bellezza
che ai sentimenti, e sicuramente sono comprensivo e
rispettoso verso qualunque comportamento al di là del
mio, né mi lamento di torti che eventualmente possono
essermi fatti (cosa che ultimamente non mi pare essere
mai accaduta, sicuramente in ambito familiare). Allora
cosa debbo fare? Non dubito dell’amore che provo verso
Barbara, altrimenti non sarei qui a scrivere queste
note, e poi perché sente sgorgare in me una continua
gioia nel vivere accanto a lei; tuttavia capita che la
ferisca con qualche parola o gesto fuori luogo, nel
tacerle alcune cose che faccio (in passato ho perfino
mentito, a mia sorpresa) o nel farle altre senza prima
chiederle un parere – cosa che ritengo indispensabile
all’interno dell’armonia di una famiglia (se c’è
armonia). Mi analizzo e scopro – non con piacere (a
seguito di esperienza vissuta) – che sono nel profondo
-55-
felice e soddisfatto con me stesso quando mi trovo ad
essere solo… ma non posso negare che non sopporterei di
vivere senza Barbara. Scopro che sono suscettibile al
dolore di chi amo, e ne soffro anch’io, pur non
lasciandomi trascinare e rimanendo su un’isola di pace
ed apparente freddezza; cosa che mi spaventa,
considerato che adotto lo stesso comportamento quando il
dolore m riguarda. Alla morte di mio padre m’imposi di
rimanere impassibile, di non versare una lacrima, di
mantenere lo stesso comportamento nell’ambiente
lavorativo (dove nemmeno avvertii che il giorno di ferie
richiesto lo usavo per assistere ai funerali del babbo)
e fra gli amici, così come a casa mia, dove continuai la
mia solita vita fatta di karate, letture e scrittura.
Forse un comportamento ereditato da mia madre,
qualcosa di genetico che mi porto appresso e che non
posso modificare – anche se questo mi suona come una
bella giustificazione per togliermi il peso dalla
coscienza. O, forse, un comportamento acquisito
inconsciamente, per replicare alla realtà in cui sono
cresciuto (e sarebbe dunque il tempo di cambiare).
Voglio cercare di capire meglio. Devo cercare di
capire meglio.
Ho un’idea della vita, o meglio di come un individuo
deve porsi di fronte ad essa per poterla affrontare, di
come la deve navigare, per usare un verbo oggi di moda.
-56-
Non bisogna mai contare su nessuno, esseri umani,
animali o ipotetiche divinità. Partiamo dall’assunto che
siamo soli, fini a noi stessi, bastanti a noi stessi, e
come tali responsabili totalmente delle nostre azioni e
degli accadimenti che attraversiamo. Qualunque problema
deve essere risolto senza aiuti esterni. Con questo non
voglio dire che l’altruismo è da rifiutare, che un aiuto
non è da accettare. Bisogna innanzi tutto sapersi
offrire, sempre e comunque, ma mai pretendere né tanto
meno aspettarsi. Dobbiamo avere un basamento di
indistruttibile granito nel nostro centro profondo e
fare affidamento su di esso per qualsiasi evenienza.
-57-
13.
Per quale motivo si vive? L’universo, nella sua
totalità, ha uno scopo? Che cosa è la Totalità?
Queste domande, inutile ed insondabili, ma da sempre
centri di gravità del pensare umano, mi tormentano
oramai da anni. Spesso… anzi, sempre, quando ho la
possibilità di mirare il cielo stellato, mi accade di
sprofondare in un senso di vuoto e di meraviglioso,
percepisco qualcosa di immenso, di incommensurabile che
strappa i miei pensieri e li trasporta su percorsi che
adesso non riesco a rievocare. Io so che non si tratta
di nulla di trascendentale, che al di fuori di me
stesso, non c’è nessuna forza che mi influenza e che
quello straniamento nasce esclusivamente da me stesso;
ma ciò non toglie il fatto che realmente il cielo
stellato che vedo è spaventosamente abnorme e che abissi
inimmaginabili separano il mio corpo dalle stelle
remote. Quello che mi rimane alla fine, oltre a
stupefacenza e gioia, è la consapevolezza che non siamo
nulla nella Totalità, né più e né meno importanti di un
asteroide che percorre nei milioni d’anni spazi gelidi,
assolutamente solitario. Appariamo e spariamo
nell’universo, più piccoli ed inutili della più piccole
ed inutile delle nostre cellule, che vive brevemente per
essere immediatamente rimpiazzata, lasciando alcun
-58-
ricordo. L’universo non ha memoria dell’umanità. Quando
la specie che rappresentiamo avrà esaurite le sue
possibilità, sicuramente verrà rimpiazzata e di lei la
natura non serberà una memoria, come tante fotografie su
un album di famiglia. Fra miliardi di anni, chiunque ci
sarà a vivere e pensare, difficilmente saprà qualcosa di
noi, o se lo saprà mai e poi mai sarà in grado di
provare i nostri sentimenti, le nostre paure, le nostre
arti. Così come noi nulla sappiamo, in verità, dei
pensieri di Giulio Cesare, del Buddha, di Mozart, o dei
grandi faraoni. Scrissero e parlarono… ma i loro sogni,
i loro più intimi pensieri, quello che facevano prima di
coricarsi, come mangiavano o si grattavano, come
camminavano o se mai si soffermavano a scrutare il cielo
stellato… insomma, tutto ciò che fa una persona… che ne
sappiamo noi? Gesù sognava? Ha mai avuto pensieri
d’amore verso una donna? Pizarro cosa provava nel suo
profondo per ciò che causò agli indigeni d’america?
Pietà, indifferenza, compassione, odio… chiese mai
perdono a Dio? Tutto questo non lo sappiamo, e così
quando muore un uomo se ne va un mondo intero, senza mai
più tornare. Si dissolve. Il mondo che viveva quando io
ero un bambino ora è morto, svanito nel nulla, ed i miei
ricordi nostalgici non so più se sono memoria del reale
abbellita dalla fantasia o solo un’invenzione della mia
mente. Potrei raccogliere nella coppa delle mie mani i
-59-
ricordi della mia infanzia - tanti anni spazzati dal
tempo, foglie volate oltre l’orizzonte mentale – e non
sapere distinguere il vero dall’artificioso. Ma, alla
fine, cosa non è inventato? Anche il ricordo più fedele
è una ricostruzione di un momento passato, di un
segmento della nostra vita che non c’è più e mai ci
risarà. Solo il presente, per quanto fuggente, è l’unica
realtà che possiamo vivere, solo adesso ed ora siamo
vivi e siamo qualcuno. Il prima ed il dopo sono pure
costruzioni mentali, ponti gettati sul nulla. Posso dire
che ogni istante un intero universo muore ed un altro ne
nasce.
Alla luce di quanto ho detto, ora più che mai certo
che solo il momento che viviamo esiste ed ha senso, mi
rendo conto di quanto sia importante e bella e sacra la
vita. L’universo è sacro, perché è aleatorio, un gigante
di foglie che si sfalda e si riforma (con foglie sempre
nuove per quanto identiche) ogni frazione infinitesimale
di tempo. Per questo bisogna battersi; non un al di là
ipotetico, un dio di pace ed amore, un messaggero di
luce, un maestro spirituale, un paradiso di gioia. Solo
per questo preciso momento mi devo battere, per queste
parole che sto scrivendo ora, per questi vestiti
semplici che porto ora, per questa musica che sento ora,
e per tutto ciò che esiste ora, buono o cattivo che sia,
per tutto ciò mi devo battere, per tutto ciò devo fare
-60-
zazen. Per i ladro e l’assassino, il poeta ed il
maestro, per Barbara e mio figlio che non c’è (eppure
c’è, perché il più piccolo attimo coincide con
l’eternità, dove tutto è compreso) per Alberto e mia
madre e miei fratelli, per Elisa e i miei colleghi, per
i soldati, il gorilla nella gabbia ed il gatto sotto i
ferri di uno sperimentatore. Per il Buddha, che tutto
aveva capito, per le sue parole ed il suo dharma che
cerco disperatamente di cogliere, per la macchina che io
e barbara abbiamo comprato, per le sinfonie di Beethoven
congelate in un disco di plastica e che vivono
nell’attimo che un fascio di luce lo colpisce. Per le
stelle e lo spazio vuoto e gelido. Io devo fare zazen
per l’universo. Io devo fare zazen perché esiste
l’universo.
-61-
14.
Cosa sia il tempo, nessuno può dirlo. Nel tentativo
di dare una risposta, ci sono cimentati filosofi,
scienziati e religiosi, ognuno col proprio bagaglio di
cultura ed esperienza, invariabilmente influenzante la
ricerca. E per quanto le ultime teorie fisiche (come
quella della relatività) forniscano un quadro generale
nel quale il tempo assume determinate caratteristiche,
ugualmente rimane un mistero il come sia sorto, che cosa
lo faccia trascorrere o meno, come misurarlo
correttamente, se esistano efficaci strumenti di
misurazione di esso. Il termometro misura la
temperatura, nel senso che il volume del mercurio si
modifica in base al calore presente nella materia
(gassosa, liquida o solida) con la quale viene a
contatto. Col cronometro non si può dire lo stesso. Il
cronometro non misura un evento esterno, evento che
influenza direttamente i meccanismi del cronometro. Il
cronometro, se non mosso da meccanismi interni,
indipendenti e bastanti a se stessi, non misura nulla.
Quello che misura il cronometro, è il concetto che
l’uomo a del tempo.
Io posso, nella mia piccolezza, aggiungere qualcosa
di interessante e nuovo – di stimolante, oserei dire – a
quanto già presente nella quasi sconfinata letteratura
-62-
sul tempo? Credo di no. Per questo le conclusioni –
piccole, piccole – che traggo or ora, sono note di
viaggio per me stesso, che col trascorrere del tempo
(sic!) modificherò od integrerò o sopprimerò del tutto.
Zazen è il perfetto strumento di misura del tempo.
Se zazen è profondo, è samadhi e la coscienza è vuota e
libera dalla discriminazione, allora zazen è al di fuori
del tempo, e dunque noi siamo al di fuori del tempo.
Perché? Perché noi siamo consci del tempo quando
pensiamo e facciamo cose e parliamo, o meglio quando nel
fare ciò siamo consapevoli di fare ciò, quando la
coscienza discrimina nel fare ciò. Ma se la coscienza è
pulita, se la nostra mente è concentrata sull’atto del
respirare e non si presta caso al sorgere e morire dei
pensieri, che come nubi nel cielo azzurro vanno e
vengono spazzate dal vento – mentre il quieto cielo
inamovibile permane – come facciamo a sapere che il
tempo trascorre? Senza punti di riferimento il tempo non
esiste, ed allora si prova la strana sensazione di fare
un’ora di zazen ed alla fine avere la sensazione che sia
passato solo qualche minuto, o viceversa, quando il
dolore ed il desiderio di alzarsi fanno sembrare qualche
minuto ere infinite. In zazen il tempo assume tutta la
sua relatività.
Eppure, mi dico, se dovessi rimanere tutta la vita
in zazen (un assurdo), senza pensieri tali che non
-63-
esisterebbe per me tempo, il mio corpo invecchierebbe
normalmente, ed alla fine morirei. Non è forse questo il
trascorrere del tempo? Dunque, un uno stesso spazio ed
in uno stesso istante possono esistere più tempi, una
pluralità di tempi, differenti gli uni dagli altri. Per
me il tempo non trascorre, ma per la candele che brucia
vicino a me, trascorre.
Forse, l’errore è di mettere il tempo dinanzi agli
eventi, mentre varrebbe il contrario. Una palla rotola…
e crea il tempo. Il tempo è una conseguenza del
movimento (anche il pensiero è movimento), dove c’è
quiete, immobilità, il tempo si esaurisce, anzi non
nasce. Per questo ci possono essere più tempi
contemporaneamente: ci sono più eventi che agiscono in
uno stesso spazio sovrapponendosi.
-64-
15.
L’indipendenza mentale, altrimenti definibile come
emancipazione, è la meta ambita che ogni essere umano
degno di se stesso dovrebbe aspirare. E’ una condizione
che allontana dalle convenzioni, le credenze, le
illusioni che secoli e secoli di civiltà hanno
accumulato nel nostro subconscio; pertanto è una scelta
che richiede coraggio e fermezza. E’ una scelta che
medito da tempo, ma che, in effetti, non sono ancora in
grado di fare… per la semplice ragione che comporta
decisioni e prese di posizioni inattuabili nella mia
attuale condizione di cittadino inserito nella realtà
sociale. Tuttavia, può darsi che sbagli le premesse.
Cosa vuole dire essere emancipati? Non cadere preda
delle illusioni della civiltà umana. Quali sono questi
errori? Come evitarli? E come condurre una nuova
esistenza in una società dove tutti si comportano
differentemente da te? L’unica risposta si trova nello
zen, per questo cerco di praticare con zelo zazen:
liberarmi ed andare oltre.
La civiltà umana è incoerente con la vita cosmica e
con il ciclo naturale del mondo che ci ospita,
altrimenti non sarebbero spiegabili le aberrazioni
causate dalla nostra specie, i danni e le catastrofi. Da
quando l’uomo ha sviluppato quello che si definisce
-65-
civiltà, si è sempre più allontanato dal resto del
consorzio mondiale, inseguendo brama, cupidigia, potere
e grandiosità, e costruendo costrutti teorici illusivi
inerenti alla creazione ed all’evoluzione dell’intero
cosmo. E personalmente ritengo che fra quanti si sono
accorti di tali errori, è possibile e bene annoverarvi
anche il Buddha. Di quanto rimane del buddhismo oggi, lo
zen rappresenta la sua parte più essenziale e pura, un
nucleo di sapienza immanente capace di risvegliarci alla
Verità. Ma quale verità?
Chi siamo. Perché ci siamo. Come dobbiamo stare e
dove dobbiamo andare. Ecco alcune domande a cui voglio
rispondere, ed a cui si può tranquillamente rispondere.
E poi: perché l’uomo è diverso dagli altri animali; se
ha uno scopo preciso, quale è quello del cavallo, o
della tigre, o della zecca; la civiltà è giusta; è bene
prodigarsi per favorire una permanenza indefinita della
specie umana o bisogna lasciare che l’evoluzione
continui, magari con la nostra estinzione. Domande sulle
quali mi cimenterò per tutta la mia vita, annotando su
queste pagine le meditazioni e le conclusioni, le
ipotesi e le correzioni di queste ipotesi, in una serie
di appunti che lascerò in eredità a miei figli, o
chiunque altro vorrà leggere per trarre spunto per
proprie riflessioni.
-66-
Chi siamo noi? Bellissimo quesito, la cui risposta è
molteplice: biologica, antropologica, filosofica,
fisiologica, religiosa, sociologica, psicologica,
biochimica, fisica ed altro ancora. Posso individuare
tre campi: scientifico (raggruppa la biologia, la
zoologia, la chimica e tutte le scienze che si presume
basarsi su leggi stabilite ed inequivocabili,
osservabili attraverso sperimentazioni; antropologico
(sociologia e psicologia, e come tali suscettibili di
modifiche nel corso del tempo); filosofico (termine che
uso momentaneamente in attesa di individuarne uno
migliore, e che sta per religione e metafisica e
filosofia, insomma per tutto ciò che vuole spiegare
l’uomo al di là di come è e di come fa, ma di cosa è.
I tre campi scindono la domanda in tre quesiti: come
siamo e perché lo siamo; cosa facciamo e perché lo
facciamo; cosa siamo e perché lo siamo. Non esiste un
quesito più importante dell’altro, e presumo che si
possono trovare soddisfazione in una unica risposta. La
Grande Risposta, che è anche la Verità. Ritengo anche
che il Buddha abbia trovato tale risposta e che alcuni
grandi maestri succedutogli la conoscano e la insegnino
a quei fortunati allievi che si sacrificano per
impararla. Simili maestri sono rari, dunque bisogna
imparare a cercare da soli. Io ho essenzialmente due
strumenti: zazen e la riflessione.
-67-
16.
L’altra sera, durante un allenamento nel dojo del
maestro Shirai, ho avuto modo di sperimentare quello che
barbara prova per il karate. Se mai dubitavo del suo
profondo amore verso questa disciplina, ora è stato
spazzato. Il ginocchio le ha ceduto in uno spostamento
di attacco, costringendola a riposare almeno per metà
lezione, cosa che evidentemente la turbata. Io ho
ignorato questo suo stato emotivo, e sarei andato a bere
la birra con i compagni di allenamento se lei non
insisteva col volere andare a casa… e fuori dalla
palestra è scoppiata in lacrime. Ho cercato di esserle
vicino, ma Barbara tende a chiudersi in questi momenti e
mi pare non abbia accettato il mio conforto. A casa è
rimasta in silenzio per tutta la sera, tanto che pensavo
pure io rientrassi fra le cose che la turbavano, e
malgrado mi fossi convinto di non avere fatto nulla di
male mi sono sentito in colpa. Così gira il mondo.
Ciò che mi preoccupa ora è la mia scelta.
Abbandonare il karate significa ferire Barbara. Malgrado
sia deciso a camminare lungo la via dello zen, il karate
ha permeato la mia vita per quindici anni, io e barbara
ci siamo conosciuti grazie ad esso e la maggior parte di
conoscenti sono compagni di allenamento. Pensavo di
-69-
essere riuscito a risolvere il problema, ma adesso
ritengo di dovere ricominciare le riflessioni.
-70-
17.
Ho terminato di leggere Il canto dell’immediato satori di
Yoka Daishi (traslitterazione in giapponese di Yung-Chia
Hsuan-Chu eh) famoso maestro cinese, allievo di Hui
Neng. Ho scritto leggere, e non studiare, perché un vero
studio di questo testo impone lunghi momenti di
riflessione ed una pratica più coerente e continuativa
della mia. Tuttavia non credo sia stata una lettura
indarna. Grazie al commento del maestro Deshimaru, devo
aggiungere. Deshimaru è probabilmente stato il maestro
zen che ha maggiormente influenzato lo zen occidentale.
Il Roshi del tempio che frequento, che non posso
chiamare mio maestro (una prerogativa esclusiva di chi
egli accetta come suo allievo – ma devo dire che adesso
come adesso non ci tengo particolarmente, non almeno
come praticare zazen) è stato allievo di Deshimaru, e
comparando i suoi scritti con i modi discorsivi di
Ryusui si intuisce.
Il commento di Deshimaru è bellissimo e
comprensibile, tanto che ho apprezzato maggiormente
questo che il poema vero e proprio. Deshimaru,
attraverso i versi di Daishi, esprime il suo personale
zen, semplice, pratico, completamente mondo da
esoterismi, misticismi ed inutili riferimenti a concetti
buddhisti lontani dalla mentalità occidentali, e
-71-
comunque proponenti verità non sperimentabili da esseri
umani comuni.
Mentre sono seduto a scrivere queste note, mi rendo
conto delle mie difficoltà nel riportare su carta le
impressioni che ho avuto nel leggere il commento di
Deshimaru. Sono sfuggenti, anche se ci posso riflettere
sopra. Probabilmente non sono abbastanza maturo, così
abbandona ora prima di esporre considerazioni non
appropriate o non coerenti con quanto ho provato.
Prima di chiudere voglio dire qualcosa. Capita
spesso che il nostro spirito, qualunque cosa si intenda
con questo termine, abbia dei moti che la nostra mente
non riesce a tradurre in suoni intelligibili (le
parole). Può essere per bassa cultura, o semplicemente
perché trattasi di moti non raziocinabili.
-72-
18.
Viviamo preda delle convenzioni. Sono come paraocchi
che ci spingono ad andare sempre avanti, consapevoli di
ciò che vive nelle zone buie (per noi) ma non desiderosi
di gettarci un’occhiata. Convenzioni sociali, morali,
religiose, politiche… ed altre ancora che ricoprono
tutta l’attività ed il pensare umano. Anche la scienza
ha le sue convenzioni.
Perché parlo di ciò? Due fatti ne sono la causa.
Uchiyama Roshi parla di valori mondani quando intende
quella serie di usi sociali che sono lontanissimi dalla
vera essenza dell’essere umano. Vera essenza dell’essere
umano è vivere la propria vita con purezza, che vuol
dire accettare totalmente la propria vita e scoprire che
essa coincide con noi stessi, con la nostra totalità.
Noi siamo la nostra vita. Le convenzioni ci portano
lontano da questa suprema via, lasciandoci infangati nei
valori ottusi e chiusi della società (che non sono da
rigettare, m vanno considerati per quello che sono,
senza attaccarsi ad essi con fede).
Mentre tornavamo a casa dalla montagna, dove avevo
avuto l’opportunità di riflettere sull’essere umano (si
era in macchina, ma non si viaggiava velocemente), un
uccello cadde sull’asfalto della strada. Ho bene
impresso il suo cadere ruotando, le ali inutili nello
-73-
stallo irreversibile, come se fossero spezzate o se
l’animale fosse stato investito da una tremenda folata
d’aria. Ancora adesso sento il tonfo sordo sull’asfalto
(forse più un’impressione, perché i finestrini erano
alzati ed il rumore del motore abbastanza forte da
coprire rumori esterni) e per un attimo un profondo
dispiacere sorse unito alla volontà di fermarmi per
soccorrere il povero volatile.
Non mi fermai, non so perché, per quanto il mio
cuore me lo implorasse. Convenzioni. Era solo un
uccello.
Per tutto il viaggio di ritorno fui pervaso
dall’angoscia, il tonfo risuonò nei meandri della mente
ed almeno una volta mi parve di percepire – o credere di
percepire – l’urlo di dolore dell’uccello.
Quell’uccello ero io. La sua vita era la mia, il suo
dolore il mio, la sua caduta la mia. Nel momento che lo
vidi, la mia vita e la sua erano parte del mio sé
assoluto. Quello che ho fatto è stato rigettare la mia
vita, non accettarla e non soccorrerla. E tutto questo
per una convenzione.
Ieri sera, mentre portavo fuori il Ciri, sono
passato vicino ad un parchetto. Il Ciri si avvicina ad
un mucchio di vestiti (così identificai l’oggetto), con
cautela. Ben presto compresi che era un uomo sdraiato a
pancia in su, le braccia dietro la nuca, un ginocchio
-74-
alzato. Non rimasi lì a lungo. Le convenzioni mi
obbligarono a non chiedermi se quella persona stava male
o se solo riposava (poteva essere morta). Normalmente
una persona non sta la notte sdraiata vestita in un
parco pubblico. Per questo mi allontanai in fretta,
perfino intimorito, come se avesse potuto aggredirmi (se
fosse stata in piedi, tutto sarebbe rientrato nella
normalità).
Come posso essere pronto a prendere i voti monacali?
Ho rifiutato la mia vita e sono fuggito davanti alla
anormalità (secondo i valori mondani); un monaco vive
con purezza, non rifiutando nulla, non pronunciando
giudizi (anche mentalmente). Molta strada ho da
percorrere.
-75-
19.
E’ necessario condurre un’esistenza il più possibile
coerente con pochi valori, ma ben stabiliti: onestà,
sincerità, rispetto. Mai e poi mai cercare il favore
degli altri, mentre non tirarsi mai indietro, per quanto
è possibile, dalle esigenze delle persone che
conosciamo. E ricordarsi sempre che la vita non è
circoscritta al nostro corpo, alla famiglia ed alla
casa, ma è tutto ciò che incontriamo. E mai indulgere al
pietismo ed all’indolenza; la vita, per quanto possa
essere ricca, è breve, e dunque dobbiamo ricavare da
essa il massimo. Quando sentiremo la morte approssimarsi
– ed è una speranza da coltivare quella in una morte
naturale, per vecchiaia – non dovremo rimpiangere una
vita vuota, passata in pigrizia.
Ogni giorno cerco di produrre qualcosa, di stimolare
chi mi vive accanto, di rendere felice Barbara. Mi
accorgo che è un compito molto difficile: spesso indulgo
in giochi che non mi danno nulla, e non sempre riesco a
rendermi disponibile nei confronti di Barbara… e questo
è un tasto dolente. Credo che il mio starmene a
scrivere, a fare zazen, a leggere, a curare la rivista e
giocare a scacchi mi allontani dalla persona che più amo
che desidero vedere felice. Eppure, al contempo, sento
che questo mio continuare a fabbricare e fare mi serve
-76-
per non sentirmi un uomo squallido, che se non lavora se
ne sta sul divano ad inebetirsi di televisione o a
leggere la gazzetta.
La civiltà contemporanea è un labirinto in cui è
facile perdersi. Siamo sottoposti ad una continua
tensione, la velocità e la frammentazione sono sistemi
di vita che siamo obbligati ad accettare. Noto che
difficilmente ci si impegna in lunghe discussioni, che
la dialettica è ridotta ad un paio di battute, che
ognuno esprime la propria convinzione senza la sincera
propensione a cambiarla se lungo la discussione ne
avverte la fallacia. Siamo costretti a fare le cose
subito, a pensare in una manciata di secondi, a dare una
risposta immediata, ad ascoltare canzonette e guardare
film spezzati dalla pubblicità, allucinanti giochi
televisivi imperniati su azione e reazione.
Sono perplesso e spaventato. Fondamentalmente sono
una persona che non riesce nell’immediatezza ad
analizzare una questione. Ho bisogno di tempo per
riflettere e ponderare, perché sempre in un secondo
momento mi accorgo di possibili alternative, quasi
sempre da preferire.
Frequentando il roshi, ascoltando il suo parlare
apparentemente disconnesso ma quanto mai preciso e
profondo, comprendo ora che ci sono ambiti nella vita
che vale la pena esplorare; modi di pensare che offrono
-77-
prospettive completamente differenti; valori per cui
vale la pena lottare.
Sul lavoro, la gente tendenzialmente si scanna.
Questo avviene quasi sempre alle spalle, una continua
proliferazione di dicerie, malignità, stupidaggine che
col tempo si accumulano sulle persone come marciume, e
la sporcizia alle volte sedimenta anche in chi da tutto
questo vuole astenersi. Sono le tentazioni dalle quali è
difficile fuggire. Spettegolare, ridere alle spalle,
lamentarsi di chi è assente, non ammettere i propri
errori, trattare male i subordinati… situazioni che
spesso raggiungono livelli di comicità. Manca il
rispetto, la disponibilità, la pazienza.
Non so che dire, tranne che ho intenzione di
continuare sulla mia strada.
-78-
20.
Si commettono sempre errori. Per quanto la nostra
volontà sia vigile, ed ogni nostra azione non sia
supervisionata, presto o tardi l’attenzione cede e si
compie un gesto, si dice una parola che sono causa di
malumori. A volte mi capita questo, con Barbara. Sono
certo del mio desiderio di non fare nulla che la
infastidisca, ammetto tuttavia che non sempre riesco
nell’intento. Il lupo perde il pelo ma non il vizio.
La vita non è facile, ancor di più quella di coppia.
Due universi che si integrano, interi sistemi planetari
che si scontrano, esplosioni, buchi neri che fagocitano
comete e soli... impossibile che tutto fili liscio. Io e
Barbara abbiamo passato almeno i primi due anni di
convivenza privati di serenità ed armonia. Ricordo che a
volte Barbara si turbava quasi ogni settimana.
Ritengo di essermi impegnato per migliorare la
situazione, ma capisco che sono ancora lontano da un
risultato apprezzabile. Il rispetto per l’altra persona,
se per di più amata, è fondamentale. La Via che seguo
non transige su questo aspetto. Se poi l’altro non si
impegna ugualmente nei propri riguardi… non importa,
perché si accorgerà del nostro impegno e farà
altrettanto. E’ così che la vita migliora.
-79-
21.
Nella vita di tutti noi capita che un’immagine, un
suono od un profumo rievochino passati nostalgici. Nel
mio caso, è l’infanzia ad irrompere nella mia memoria:
basta il rumore di un aereo ad elica, che vola basso in
una giornata d’estate, il cielo azzurro, il silenzio
rotto dal canto dei grilli, il sole incontestabile e
persistente. A volte, qua a Baggio, capita che queste
condizioni si verifichino, ed allora mi ritrovo a
Campagnano, sul lago Maggiore, bambino spensierato di
sette, otto anni, nel piccolo giardino di casa a cercare
quell’aereo, o mentre gioco con i miei piccoli amici, o
mentre cammino solo per andare a San Martino, in fondo
alla strada di ciottoli, dietro la curva che costeggia
il vecchio campanile.
E’ passato un quarto di secolo, e mi trovo a
considerare che quei pochi anni – mio padre conduceva la
famiglia alla fine delle scuole e ci raggiungeva durante
le sue ferie – sono stati i più felici di tutta la mia
esistenza terrena, per quanto questa non sia ancora
terminata. Non voglio asserire che ora sono una persona
triste, al contrario: mi rendo conto che in questi
ultimi mesi ho realizzato… o meglio, sto cercando di
realizzare cose che mi danno soddisfazione, dal
frequentare il tempio, alla rivista, dall’aver ripreso a
-81-
scrivere il romanzo al karate; e molte cose in futuro
miglioreranno, altre arriveranno, sperando nel cielo io
e Barbara riusciremo a dare la possibilità ad un essere
vivente di venire al mondo. Certo, il lavoro è una
macchia nera, per quanto stia cercando di praticare il
consiglio di Ryusui Roshi di trovarvi lo spirito e
seguirlo; alcuni giorni, spesso direi, la concentrazione
mi sfugge e la mia mente vola via. Lo zen vuole essere
la profondità e la totalità del quotidiano, il saper
vivere completamente ogni istante della propria vita, ed
in questo riscontro da parte mia manchevolezze e
negligenze. E’ per questo, forse, che rivado volentieri
con la memoria ai tempio dell’infanzia e non posso fare
a meno di considerarli il momento più felice. Ero solo
un bambino, quando giocavo, giocavo; quando studiavo,
studiavo… e se mangiavo, mangiavo. Nessuno dei
tormentosi pensieri che oggi mi perseguitano, nessuna
preoccupazione, nessuna angoscia per il domani.
Poco fa ero sdraiato a letto, cercavo di riposare
malgrado la calura, vicino a me Barbara si era già
addormentata. Ho sentito l’aereo e tutto un mondo è
morto per essere rimpiazzato da un altro. Ho esplorato
il piccolo paese dalle vecchie case di pietra e le
stradicciuole di sassi, vi sono ritornato, questa volta
da adulto, girando per i vicoli, fermandomi davanti al
monumento agli alpini, da dove si può ammirare il lago
-82-
Maggiore, arrivando a San Martino per andare a toccare
il famoso albero dal quale caddi fratturandomi l’omero,
cercando la grande roccia che con gli amici raggiungevo
fingendo di essere un bandito. Ricordo alcune parti del
paese, ma non so più da che parte si gira, quale
stradina si imbocchi per raggiungerle. Sdraiato, gli
occhi chiusi, ho ritrovato antichi sentimenti, il mio
cuore ha sorriso.
Da tempo ho preso la decisione di ritornare un
giorno a Campagnano. Ne ho parlato con barbara, si dice
d’accordo. Tempo che molto sia cambiato, prego che la
verità sia rimasta quella di allora.
Il bambino che giocava a Campagnano non è morto,
anche se nulla di lui è rimasto. Le cellule non sono più
le stesse, i pensieri non ritorneranno, il mondo visto
con i suoi occhi si è dissolto definitivamente. Ma quel
bambino è in me e non posso metterlo da parte. Questa
considerazione mi grava, perché so che ciò che ero ieri
non è oggi, e ciò che oggi non sarà domani, e ciò che
sarà domani non è ciò che è oggi ed era ieri. Il filo
che ci unisce è la memoria, una labile e fallace
duplicazione di immagini e suoni, quasi sempre non
comprovata da fatti incontestabili. Tutto il nostro
passato potrebbe essere una menzogna, un’illusione, e lo
è se riflettiamo sulla verità che solo il presente
-83-
esiste; ma se ci siamo, adesso, con i nostri ricordi,
vuole dire che qualcosa c’era ieri e ci sarà domani.
-84-
BETH
3 settembre 1999
1.
Il passaggio dalla prima alla seconda lettera è stato
dettato dall’ennesimo momento di litigio fra me e
Barbara. Inizio a pensare che in un matrimonio che si
vuole mantenere vivo per l’intera esistenza di chi vi
partecipa i momenti di disaccordo, di silenzi forzati,
di incomprensioni… insomma, di mancanza di armonia siano
maggiori di quanto mi aspettassi. Ancora una volta mi
rendo conto della necessità che io imponga a me stesso
una profonda e seria autoanalisi, al fine di evitare, o
perlomeno procrastinare al massimo, i disaccordi
coniugali. Analisi di chi sono, di come mi comporto, di
quello che dico, di come appaio a chi mi vive accanto.
In ufficio mi dipingono come una persona acida… e
pensare che sto facendo di tutto per essere paziente,
altruista e gentile. Dove sbaglio?
-85-
Devo essere sincero, comunque. Non ritengo che mi debba
assumere totalmente la responsabilità di quanto è
successo tra me e Barbara. Per quanto sono sempre
incline a ritenermi colpevole, questa volta, forse, il
mio errore era minimo. E’ vero, al momento di decidere i
gruppi di allenamento, io avrei dovuto stare con mio
moglie e le figlie del maestro, ma trascinato dal
desiderio di provare un forte allenamento sono rimasto
con Michelino e gli altri. Questo è stato un errore,
malgrado io fossi intenzionato a fare solo un paio di
giri di applicazione per poi inserirmi nel gruppo di
Barbara (alla fine non ho avuto la forza di farlo,
troppo preso dall’allenamento: ecco il grave errore – e
ne ero cosciente!). Tuttavia, Barbara non avrebbe dovuto
reagire così energicamente, insultandomi e non
rivolgendomi la parola. Perché pensa che non abbia
rispetto di lei come karateka? La amo, come potrei non
averne rispetto? Non è una pensa od una perdita di tempo
allenarmi con lei, perché, se pure è vero che come
karateka non ne abbia giovamento, come uomo, marito e
buddhista il merito di fare questo è alto, ed anche la
felicità che se ne trae. Questo Barbara dovrebbe
capirlo. Ed ecco che salta fuori la mia pecca: non
comunico abbastanza con la mia amata, non sono
abbastanza attento alla sua presenza, non le dimostro
totalmente il mio amore. In effetti, che senso ha
-86-
spartire le colpe? un po’ a me ed un po’ a lei? Il
Buddha insegna che se un’azione, od una parola od un
pensiero conducono ad una determinata conseguenza
(negativa o gioiosa che sia) chi ha eseguito quelle
azioni, dette quelle parola, fatti quei pensieri non può
esimersi dalla responsabilità. Nel buddhismo non esiste
dire: l’intento era buono. Se la conseguenza è letale,
allora le intenzione solo illusoriamente risultavano
benevole, mentre nella realtà erano sbagliate, fallaci,
senza altra possibilità. Dunque, io ho sbagliato, in
quello che ho fatto, in quello che detto dopo per
giustificarmi, in quello che ho pensato mentre decidevo.
Siamo figli delle nostre azioni, istante dopo istante.
Condivido questa asserzione, corrisponde immancabilmente
alla verità. Non importa che io stia qui, adesso, a
pensare e riflettere e giudicare su quello che Barbara
ha detto e fatto, e su quello che avrebbe o non avrebbe
dovuto e potuto dire. Importa, in un evento in cui sono
coinvolto attivamente, ciò che mi riguarda. Questo non
vuol dire evitare di dialogare con Barbara (ne sarò mai
capace?) sul suo comportamento; vuol dire non
tralasciare in primis cosa è meglio che io faccia
affinché le cose vadano per il meglio. Barbara è poco
paziente? Intransigente? Collerica? Cosa devo fare (io!)
per evitare di manifestare in lei questi stati, magari
facendole capire che a volte sbaglia? Non è questa
-87-
forse il modo giusto di vivere di un “vero adulto”, come
Uchiama Roshi chiama il bodhisattva?
Ecco che la seconda lettera ebraica è ora nel cielo
della mia coscienza per ricordarmi un voto che ora
faccio, davanti a me come uomo e marito e seguace della
Via, e davanti all’immagine del Perfetto affinché non
scivoli nel dimenticatoio.
Il voto
Faccio voto di ascoltare la voce di tutti
Faccio voto di non negarmi al bisogno di chi mi cerca
Faccio voto di rispettare qualunque creatura
Faccio voto di amare mia moglie in ogni istante
Faccio voto di non tradire o abbandonare la famiglia
Faccio voto di lottare e soffrire per la famiglia
Faccio voto di ricercare il senso delle cose
Faccio voto di coltivare la tolleranza
Faccio voto di nutrire la pazienza
Faccio voto di camminare con zelo e serietà
Faccio voto di mostrarmi benevolo e compassionevole
Faccio voto di superare gli ostacoli
Faccio voto di pregare per la salvezza degli esseri
viventi
Faccio voto di dedicarmi con profondissimo impegno a
zazen
-88-
Faccio voto di venerazione per i buddha, i patriarchi ed
i maestri
Faccio voto di alienarmi la codardia e la ignavia
Faccio voto di proseguire integerrimo come un guerriero
Che il mio corpo, il mio spirito e la mia coscienza
siano segnati da questi voti come da marchi impressi con
ferro rovente.
-89-
2.
Inevitabilmente cado nell’errore. Quello che mi domando
è se esiste l’errore, o è solo un modo per incolparci di
non essere capace di fare o dire cose che reputiamo
lodevoli, altamente dignitose. L’essere umano è una
macchina complessa, un assemblamento armonioso di
diversi fattori, e come ogni sistema complicato spesso
va in crisi, si blocca, non fa quello che dovrebbe fare…
ma un sistema complesso (come quelli informatici) sono
progettati per determinate funzioni, mentre l’uomo non
ha uno scopo, un compito da assolvere… o mi sbaglio?
Comunque, ritornando al mio errore, mi confesso incapace
di balzare in avanti ed agguantare quel fazzoletto
bianco che è sinonimo di vera maturità. Essere adulti
non significa non sbagliare, bensì combattere per
evitare in futuro altri sbagli. Nel mio piccolo, questa
volontà mi manca, e la cosa è grave. Sono un uomo
qualunque che fa una vita qualunque, come posso ancora
cadere nella negligenza e nella manchevolezza? Non
dovrebbe essere tutto più facile? Forse, maggiore è la
responsabilità e maggiore è la volontà a rispettarla. Ma
un uomo che è sposato non ha una grande responsabilità?
Tutto è relativo, chi sei, cosa fai, come fai…
L’altro ieri ho fatto un voto, che comporta il seguire
dei valori e il non farsi depredare lo spirito dalle
-90-
manfrine della vita mondana. Oggi sono caduto
nell’abisso della mondanità, facendomi accalappiare dai
valori mondani così imperanti in questi anni di fine
millennio. Il mio capo ha deciso di darmi un telefonino,
contro il quale io mi sono sempre battuto, ancora adesso
ritengo a ragione. Non ho fatto nulla per convincerlo
che la spesa era inutile: cosa ne faccio al lavoro di un
telefonino? Al contrario sono subito corso a prenderlo e
per tutto ieri ed oggi ci ho giocato come un bambinetto.
Un anno di zen buttato nel cesso… e per di più tirando
lo sciacquone, visto che ho accettato di prendere un bel
centone al mese in nero da un cliente senza dire nulla
in ditta! Sono un milioneduecentomila all’anno, quasi
una quindicesima. Ho pensato che sarebbero stati soldi
buoni per pagare la quota associativa al dojo… come fare
l’elemosina con soldi rubati!
Tornando a quanto sopra: l’essere umano, complesso e
laborioso, non ha uno scopo, nel senso che nessuno lo ha
progettato per assolvere un preciso compito, anche se
alcune religioni sembrano affermare proprio il
contrario. Se l’essere umano non ha uno scopo, perché
esiste? La risposta è che non è necessario avere uno
scopo per esistere, anche se non vuol dire che non
sussista motivo per questa esistenza. Se ci siamo il
motivo c’è, non si scappa. Quello che manca è lo scopo
finale. Lo scopo finale va costruito più che ricercato,
-91-
creato più che perseguito. Lo scopo è vivere. E vivendo
si costruisce un incredibile tessuto di azioni che si
intrecciano con quelle di altri migliaia di esseri
(umani o no) venendo così a creare u ricamo tanto
complesso quanto armonioso, tanto fitto quanto colorato.
L’esistenza nell’universo è un tappeto dagli infiniti
fili e colori e ricami, che si vive in un sol giorno (la
vita di ogni creatura) e che esiste solo in quel giorno.
La vita è già una magnifica ricompensa, la migliore in
assoluto, l’unica opportunità di sperimentare noi stessi
e l’universo, l’unico momento che possiamo sentire e
percepire e vivere. Non esiste null’altro, non può
esistere… perché cercarlo? E se esistesse comunque non
sarebbe adesso, in questa vita, da questo mio corpo
sperimentabile. Per questo si può venerare il Buddha
(ottenendo benefici poiché inconsciamente si è spinti ad
una condotta morale elevata) ma non invocare il suo
aiuto: il Buddha non può aiutare nessuno.
-92-
3.
Mentre scrivevo le note del punto 2., improvvisamente
(le cose capitano sempre all’improvviso) mi è venuto in
ricordo un momento vissuto con gli amici, quando ero
piccolo, penso otto o nove anni. Sotto il portico di un
condominio di via Moncalvo, aspettavo, non so più se da
solo o meno, un amichetto che scendesse a giocare. Il
ricordo è confuso, e dunque capisco che quell’attimo di
vita è andato perso e ciò che ricordo probabilmente non
corrisponde alla verità. E ciò mi spaventa e mi fa
riflettere su come la nostra vita spesso si basi su
fondamenta mandaci. Noi siamo figli della memoria ed
agiamo in base a ciò che ricordiamo, e così come
tendiamo a dimenticare ciò che impariamo a scuola o come
la nostra memoria perda presto i flabili frammenti dei
sogni notturni, così il nostro passato si perde nel
corso del tempo e ciò che alla fine ricordiamo non è
detto che corrisponda alla realtà. Chi mai può
verificare i nostri ricordi? Così è la storia, penso,
quella che studiamo, quella che pensiamo ci appartenga.
Gli studiosi ricostruiscono lavorando su testi che a
volte poggiano le loro tesi e le loro ricostruzioni su
altri testi; un immenso palinsesto in continua modifica.
Già la storia delle antiche civiltà ruota su pochi punti
cardine, mentre il resto è precipitato nell’oblio e lo
-93-
si può riedificare grazie all’intuizione ed alla logica…
ma quanto è vero? Di tremila anno di cultura egizia, si
conoscono qualche nome di faraone, alcune cose che
fecero, una manciata di mionumenti, qualche papiro… in
realtà tantissime informazioni e manufatti, ma rispetto
a ciò che si produsse per tre millenni è solo una
manciata di qualche decennio. La nostra cultura è figlia
di ipotesi, di costruzioni artificiali, non possiamo
fare altro che affidarci al buon senso.
Ricordare il passato ha senso in quanto la memoria
storica è serbatoio di valori. Le radici formano un
popolo, così come formano un individuo. Dimenticare,
volutamente, chi siamo e da dove veniamo – storicamente
e culturalmente – è segno di follia mentale. L’identità
non è una pura astrazione, bensì una sintesi, o meglio
una stratificazione del passato storico. L’individuo si
definisce in quanto ha un passato e questo passato è la
sua memoria, il suo spirito, le sue nozioni che fanno
funzionare l’intelligenza. Ogni nostra azione, pensiero
e parola, ogni sentimento trova energia per
concretizzarsi nel passato – quello personale,
ovviamente. Cosa sarei io, adesso, senza trent’anni di
vita alle spalle? Ora, il problema che si pone è se la
coscienza e la conoscenza di questo passato siano
indispensabili ad un individuo per stabilire la sua
identità o se l’esperienza ottenuta agisca anche
-94-
inconsciamente e dunque si può vivere il momento
presente obliando di volta in volta il momento passato.
Individuo, identità, momento temporale, memoria,
coscienza e conoscenza, ecco termine che devono essere
analizzati e compresi per potere portare avanti questo
discorso (e siamo punto e a capo, visto che comunque è
solo grazie nozioni passate, a memorie ben stabilite che
possiamo intraprendere una tale analisi).
-95-
4.
Continua la lista delle mie negligenze, all’interno di
un periodo che ho voluto dedicare: un voto fatto che
faticosamente riesco a mantenere. Ho messo un
bigliettino vicino al piccolo altare del buddha nello
zendo, con scritta sopra una preghiera per il bambino
dell’Antonella. Il giorno dopo Antonella mi chiama al
lavoro, dicendomi che ha abortito spontaneamente. Lì per
lì non ho saputo cosa dire, a parte le solite frasi di
circostanza. Poi ho realizzato l’inutilità del voto, ma
adesso mi rendo conto che a maggior ragione devo tenervi
fede. Perché fare un voto, mantenerlo, quando si sa che
non sarà di giovamento a nessuno se non a noi stessi? Mi
sembra un gesto egoistico. Io so che i buddha non si
muoveranno per le mie preghiere, ma so anche che la
tenacia a tenere fede ad un voto, privandosi di
determinate cose e bisogni, può migliorarci e portarci
verso una più alta condotta morale. Quello che non
comprendo è come può aiutare una terza persona. E di che
cosa bisogna privarsi durante un voto? Dolci? Sesso?
Colazione? Doccia calda? O seguire i cinque precetti
(non mentire, non rubare, non uccidere, non tradire e
non bere alcolici)? Devo riprendermi dallo scivolone che
mi sta precipitando nel buio e nella mondanità. Sto
diventando gretto, squallido, consumista, misero. Ho
-96-
paura di me stesso e di questo mio atteggiamento,
accorgendomi per di più di non avere la forza per
controbatterlo. Credo che si tratti della società nella
quale vivo e della quale, molto probabilmente non posso
fare a meno. La città non è solo un agglomerato di
edifici e di persone, è pure la concentrazione dei
miasmi della civiltà; i lati peggiori ne vengono messi
in evidenza, ingigantiti e ben nutriti… da noi stesi!
Una persona deve vivere rispettando un’integrità di
comportamento e di pensiero: mente pura, parole, giuste,
azione corretta, niente paraculismi e furbizie… tante
belle parole e bei propositi che in una città come
Milano (faccio esempio della mia città – che amo, devo
dire!) è difficilissimo mantenere; non per debolezza di
intenti, per incapacità congenita o mancanza di
perseveranza, ma semplicemente perché la condotta di
vita che sei obbligato a tenere non te lo permette.
Bisogna essere sinceri: il lavoro opprimente ed
invadente, la mondanità elargita dai mezzi di
comunicazione, il dovere ed il diritto – così ci
insegnano – del guadagnare il più possibile ed in tutti
i modi, ci hanno portato a comportamenti maligni,
cinici, gelidi verso il prossimo. Parlo di me stesso, di
cui ho sicura esperienza. Intorno a me ho un alone che
mi isola dal mondo e tutto ciò che vedo non deve toccare
il mio cuore, primari obiettivi sono la carriera, la
-97-
macchina, il cellulare… è forse un essere umano, questo?
Eppure, avendo famiglia, non puoi sottrarti ai doveri
familiari. Sono confuso, eppure certo che tutto potrebbe
essere differente. Ecco perché ho deciso di seguire la
Via indicata dal Buddha. In essa sono sicuro di
recuperare quei valori necessari a rendere fiorita anche
la vita di città, a rendermi conto che quello che
apparentemente sembra un dovere è solo illusione e ciò
che conta è l’igiene mentale e spirituale, il benessere
interiore di chi ami ed il rispetto per chi ti vive
accanto.
-98-
5.
Questa notte, durante un sogno, mi è parso di provare
una piccola e breve esperienza di satori. So che si
tratta di un’illusione, di uno sfogo dell’inconscio,
della realizzazione di un desiderio; tuttavia non posso
fare a meno di soffermarmi sulla qualità del sogno e sul
suo significato. Come tutti i sogni, all’alba era un
frammento friabile e disperso, ma il ricordo di una
frase è rimasto, brillante e luminoso. Nel sogno
affermavo un’idea, non so più dove ed a chi, che suonava
verosimilmente così: La realtà è la vita, la vita è la realtà; è
un’esperienza che ha significato solo per l’individuo che la vive. Ora che
è sera, dopo una giornata nella quale la mia mente non
si è posata mai su questa frase, mi accingo ad
analizzarla ed a capire se contiene grani di verità.
Le parole chiavi sono: vita, realtà, esperienza,
individuo. La vita è l’arco di tempo di esistenza di
un’entità biologica o vegetale o micogena nel corso del
quale la suddetta esplica la propria funzionalità
attraverso le qualità di cui è dotata. Allargando il
concetto, si può dire che la vita è l'esistenza di
qualsiasi cosa in un lasso di tempo all’interno del
quale mantiene inalterate struttura, funzioni, processi
biochimici, o solo chimici. In questo casa tutto è vita:
la roccia, l’acqua, il fiore ed il cielo. Posso dire che
-99-
con vita si intende l’esistenza di creature appartenenti
ai regni animali, vegetali e micogeni. Credo, comunque,
che io intendessi con vita, l’esistenza di un essere
umano; tuttavia, ha senso parlare di tutti gli esseri
viventi, ovverosia appartenenti ai tre regni. La realtà
è la totalità delle cose esistenti, nulla vi è escluso.
L’esperienza è ciò che un essere vivente sperimenta,
l’insieme di situazioni ed accadimenti nel quale si
trova ad agire passivamente od attivamente. L’individuo
è l’illusione dei cinque aggregati.
La realtà è la vita, la vita è la realtà. Vita è realtà coincidono. La
vita di un essere, l’insieme degli accadimenti e delle
circostanze nell’arco del suo tempo sono anche la
realtà, la sua realtà. la Realtà assoluta, trascendente
l’individuo, non ha senso perché non può essere
sperimentata; la realtà sperimentata dell’individuo è la
sua vita.
E’ un’esperienza che ha significato solo per l’individuo che la vive. Se ciò
che sperimentiamo è la nostra vita, la nostra esperienza
è la nostra vita, allora esperienza, vita e realtà
indicano la stessa cosa. Chi è che sperimenta-vive nella
sua realtà? L’individuo. L’individuo attraverso i sei
sensi sperimenta la realtà che vive e forma la
coscienza, la coscienza rifletta la realtà e formula il
concetto e l’idea di vita.
-100-
In ultima analisi, realtà, vita, esperienza ed individuo
non differiscono fra di loro, sono la mente dello zen.
Ciò che io vedo è il mio sé, la mia mente, la mia vita,
la mia realtà. Soggetto ed oggetto non sono entità
separate, bensì una dualità imposta dalla nostra
coscienza discriminante.
-101-
6.
Sono rimasto sveglio per tre ore a letto, la notte
scorsa, impressionato dalle immagini di un film di
guerra, Salvate il soldato Ryan. Non sono state tento le scene
crude, quanto la consapevolezza della tragedia immane
che i soldati, uomini qualunque, hanno vissuto per conto
nostro. Morti e morti, odio e ferocia, tremenda paura e
fragilità… che ventaglio di sentimenti ha percorso
l’Europa di mezzo secolo fa. Solo mezzo secolo, e la
gente si odiava, si ammazzava, campi di sterminio,
bombardamenti, baionettate, la bomba atomica… i forni
crematori... E adesso, dove è finita quella guerra?
L’energia smisurata generata da milioni di corpi umani
che fine ha fatto? L’odio che provavano i nostri padri e
i nostri nonni è svanito nel nulla? In Germania, le
persone della mia età sono i nipoti degli uomini che
combatterono contro il mondo e vollero conquistarlo, che
bruciarono ebrei e se ne vantarono; il sangue di
discendenza è lo stesso, i geni sono gli stessi, le
persone sono le stesse. Cosa è cambiato? I maestri zen
che insegnavano durante l’espansione del Giappone
imperiale, con le strage che comportò, cosa pensarono?
Il loro zazen era lo stesso? Kodo Sawaki, Deshimaru…
cosa c’era nei loro cuori?
-102-
Siamo figli dell’era fascista, immancabilmente, quando
milioni di italiani – la maggior parte – inneggiava al
duce. Siamo tutti loro figli, qua in Italia, come in
Germania sono tutti figli dei razzisti impietosi che
bruciavano uomini, donne e bambini. Come risollevarci da
questo karma terribile che ci pesa sulle spalle? Sono
dunque anch’io colpevole perché mio nonno accettò il
fascismo e la sua alleanza con la Germania? O, forse,
ognuno è responsabile solo delle proprie azioni? Eppure,
non si può dimenticare, ma forse si deve. Tutto diverrà
polvere, i ricordi si perderanno per sempre con la
scomparsa dell’umanità ed un intero universo sparirà,
come se non fosse mai esistito.
Solo il presente, solo l’attimo fuggente che ci sfugge
dalle mani appena si cerca di afferrarlo, solo quello
conta. In quell’istante incalcolabile l’universo prende
le sue decisioni.
-103-
7.
Devo prendere una decisione. Entro domani. Questa notte
mi alzerò e mi affiderò a zazen. Schiarendo la mente,
sedando le ansie, forse sarò lucido per una obiettiva
scelta. Io so bene che quindici anni di allenamento è
una ricchezza che non è bene gettare, ma so anche che
questa conoscenza ha il sapore di una preparazione allo
zen. Sento che non ci può essere nessun passo migliore
se non quello di dedicarsi allo zen. Primo o poi viene
il momento per il guerriero di trasformarsi in
religioso, mantenendo quella disciplina e
quell’imperiosa forza che se sono prerogative essenziali
nella guerra non sono valori secondari nella religione;
zazen è una lotta continua.
Bisogna lottare per raggiungere uno scopo. Zazen non ha
scopi, solo sedersi; contro chi lottare? Contro la
debolezza della mente e della volontà e del corpo. E chi
combatte contro la mente e la volontà ed il corpo, se
mente, volontà e corpo sono tutto quello che possiedo?
Lo spirito. Lo spirito lotta, lo spirito di Buddha che
ho dentro di me, lo spirito di Buddha che sono senza
saperlo.
Anche qui, parole grosse. Spirito di Buddha. Ma chi è lo
spirito, chi è Buddha? Allora bisogna tornare indietro,
dimenticare queste parole ed affidarsi a zazen ed alle
-104-
antiche scritture. Sedersi in silenzio, immobile come
una montagna ed addestrare l’intelligenza nella lettura
dei sutra e dei testi dei grandi maestri, nient’altro
può servire per chiarificare la mente e scorgere il vero
obiettivo. Non so cosa sia lo spirito, non so cosa sia
Buddha. Ora devo eliminare queste incertezze,
allontanare le false credenze e le illusioni, niente
nirvana e reincarnazione, non pensare al karma, soltanto
sedersi appartato, risoluto, silenzioso, concentrato.
Mirare a se stessi, pulendo la coscienza.
Capita, nel girovagare per le librerie, che mi imbatta
in ridondanti testi sul buddhismo, sull’energia
interiore, sul potere della mente. sugli angeli e su
mille altri argomenti, resi fioriti e semplici e
digeribili come acqua e the, ma che sono ben lontani dal
vero rigore filosofico. La verità non è semplice e
comprensibile solo perché si è letto un testo infiorato.
La verità – il Dharma, tanto per intenderci – pretende
serietà ed impegno, costanza e volontà, e non è detto
che ciò deva poi essere discongiunto dalla benevolenza e
dall’altruismo, al contrario! Questi sentimenti
altruistici sono la conseguenza della seria ricerca del
Dharma, ne scaturiscono automaticamente.
-105-
8.
Continuerò a frequentare il tempio. Ieri sera, entrando
nello zendo e preparandomi allo zazen, ho percepito un
sentimento di gratitudine, come se un fiore nascesse in
me. Per quanto le circostanze della vita me lo
permetteranno, cercherò di frequentare il centro almeno
due volte la settimana (sicuramente una presenza alla
settimana è obbligatoria) ed ogni due mesi seguirò il
breve ritiro di due giorni. La mia presenza al Centro
non è casuale, tanto meno è il sintomo del desiderio
futile di seguire una moda. Ritengo che sia necessario,
in questa vita, capire cosa facciamo e perché lo
facciamo… e cosa ancora più importante sapere come fare
per vivere meglio. Per questo ho deciso di convertirmi
al buddhismo. Ed a questo punto è bene fare delle
precisazioni. Buddhismo, Buddha e buddhisti; nel nostro
Paese, in questi ultimi anni, stiamo assistendo ad una
vera e propria invasione di spiritualità orientale
(cosiddetta), ed in tutto questo il buddhismo (presunto
tale) ha una sua parte fondamentale. I templi tibetani,
i dojo zen, le aberrazioni di Osho proliferano oltremodo
nelle città, sui monti, in mezzo ai boschi, guidati da
sedicenti maestri del dharma (il Dharma con la "d“
maiuscola è un'a’tra cosa) da lama imbellettati nelle
loro belle vesti ocra, da pseudoguru che spandono perle
-106-
di saggezza riciclate da testi (autentici, questa volta)
spirituali di vecchia data. Del Dharma del Buddha…
nemmeno l’ombra, se non si cerca con attenzione. Quando
avvertii il desiderio di rispondere a quelle domande che
da tempo mi assillavano e che non avevo trovato (pur
sapendo che forse non esistono) nelle religioni nelle
quali investigai, conclusi che il buddhismo (che già da
tempo conoscevo, pur avendolo sempre tenuto distante)
poteva aiutarmi. Ben presto mi resi conto che si
trattava dell’unica religione universale, adatta a
qualunque essere umano, di qualunque cultura e razza
(sic!) e classe sociale e nazione. Compresi che la Via
indicata dal Buddha (la cui esistenza onoro) era la
migliore possibile, la confacente al meglio. I casi
della vita vollero (ma nulla accade per caso) che nel
cercare un luogo di cultura buddhista la mia scelta
cadde sul Centro che ora frequento. Ora mi rendo conto
che tutta la mia vita (ciò che ho fatto, detto e
pensato) mi ha condotto a questo Centro, che banalmente
ho scelto perché vicino a dove lavoro; e lavoro dove
lavoro perché sono stato in Egitto con mia moglie; ed in
Egitto vi sono andato come viaggio di nozze; e prima ho
sposato una ragazza conosciuta nel dojo di karate-do; e
così indietro nel tempo. Non è meraviglioso, tutto
questo? A coronare, posso affermare per certo che in
questo centro c’è il Dharma del Buddha, quello
-107-
autentico: Ne ho le prove, non perché ho cercato e
trovato il Dharma, ma per via di piccoli fatti
collaterali, di innocenti (apparentemente) indizi,
parole e gesti che mi hanno portato sulla giusta strada,
dalla quale non ho intenzione di allontanarmi. Se trovi
un tesoro, te ne accorgi, anche senza conoscerne
esattamente il valore… anche se non riesci a vederlo
bene questo tesoro – basta il riflesso, no?
A tempo debito, quando mi sentirò più maturo (passeranno
degli anni?) dedicherò qualche riga per elencare le
piccole prove che possiedo a suffragare la mia tesi
della sicura presenza del Dharma nel tempio di Ryusui
Zensen Roshi.
9.
Mi sono sempre sentito in colpa per la mia ferma
decisione di non devolvere nulla in beneficenza, anche
se a volte capita che dia poca pecunia ad un lavavetri o
per una causa che sento vicina. Tuttavia, in generale,
non appoggio nessuna iniziativa in maniera stabile. E’
forse una colpa? o, peggio, un peccato? Evitare di
aiutare le popolazioni che vivono in una situazione
civile, sanitaria e tecnologica inferiore alla nostra
-108-
(mi riferisco all’Italia) può essere considerata
un’azione poca meritoria? L’altro giorno, ascoltando le
vomitevoli notizie sullo scandalo della missione
Arcobaleno, ho avuto una riprova della bontà del mio
intento a non fare elemosine. Anche se non tutte le
missioni sono infette da scandali, rimane la verità che
la vera elemosina è agire con benevolenza e compassione
nella realtà sociale nella quale si vive, senza
sforzarsi di andare in chissà quale parte del mondo od a
versare somme solo per sentirsi in pace con se stessi.
Se la propria vita incrocia il destino del missionario,
senza che noi si abbia stravolto l’esistenza per
ottenere ciò, allora nulla in contrario… anzi! Quello
che tengo a puntualizzare è che decisioni che provochino
traumi nell’ambito familiare sono da evitare. Si può
essere caritatevoli anche con i propri cari e non
sentirsi sminuiti.
Voglio prendere l’esempio della vita religiosa; una vita
spesa per la religione, qualunque essa sia, quasi
sacrificata per essa… giusto? Affatto. E’ bene dare un
senso alle parole e ricomporre un vocabolario interiore
che tenga conto dell’esatto loro significato. Vivere
religiosamente la propria esistenza vuole dire ricercare
la nostra natura ed assolvere il nostro ruolo nella
società nella quale viviamo. Vuole dire cercare di
essere persone morali e mantenere l’integrità, evitando
-109-
paraculismo, ipocrisia, superbia, indifferenza. Vuole
dire diventare un “adulto”, responsabile totalmente
delle proprie azioni, che pensa ciò che dice cercando di
metterlo in atto. Vuole dire, innanzi tutto, cercare e
trovare un senso alle parole che si pronunciano ed un
senso nelle parole sentite; e da questa ricerca del
senso recondito, ricordarsi le azioni ed i pensieri che
hanno causato il proferire delle sopraddette parole, e
non ultimo le azioni ed i pensieri che da quelle parole
nasceranno, o sono nati. Una ricerca che copre l’intero
anno di un’esistenza, ma che vale ben la pena di
compiere. Su questo argomento mi prendo la briga di
tornare più avanti, anche perché ho deciso di definirlo
come questione da portare in sanzen.
-110-
10.
Il sacrificio dei diciotto uomini che hanno minato il
loro organismo per interrompere una reazione a catena
che avrebbe inquinato l’intero Giappone di
radioattività, il loro camminare lento dentro
insufficienti tute registrato da videocamere e trasmesso
al mondo, l’apprensione di una nazione ciecamente
fiduciosa nelle proprie capacità e nella propria
tecnologia, l’ammissione di colpa da parte dei più alti
dirigenti della società che gestiva il reattore
nucleare… sono questi gli eventi, i fatti della vita che
mi suggeriscono che nulla è ancora perso e che
nell’anima dell’uomo i semi del dovere e della
responsabilità germogliano continuamente. Il Giappone,
tranciato e stracciato dal consumismo occidentale, dal
capitalismo occidentale, dalla moda occidentale, dai
vuoti valori di fine millennio occidentali, preda della
tecnologia, alla disperata ricerca di sempre nuovi e più
disumani passatempi, ci ha donato nel momento più
tragico di questo fine secolo (la consapevolezza di una
catastrofe annunciata) un esempio di sacrificio
inimitabile. Il vecchio Giappone, fatto di lealtà, di
assoluta fedeltà al gruppo – leggi clan – cui si
appartiene, di totale accettazione della morte come
ultimo rimedio per mirare al trionfo… od all’onorevole
-111-
sconfitta, è risorto come la fenice araba. In realtà,
sotto le ceneri gelide e grigie
dell’industrializzazione, pagliuzze di brace non hanno
mai perso il loro calore, incendiandosi nel momento del
bisogno. Dove e quando, dirigenti prezzolati sarebbero
disposti ad ammettere pubblicamente l’errore e la
responsabilità della propria azienda per una cattiva
gestione che potenzialmente può spazzare migliaia di
vite umane? Dove e quando, volontari si offrirebbero,
anonimi, sapendo che il loro corpo un domani non sarà
più quello di adesso? In Italia, in questo paese che
pure amo, tutti sono pronti a scaricare il barile per
non rimanere infangati, ed il senso di responsabilità è
un dovere che conta meno della merda su un marciapiede.
Ci siamo dimenticati che cosa voglia dire essere
responsabili delle proprie azioni ed ammettere in
pubblico gli errori, tanto che vivendo in una società di
tale risma l’eventuale onesto che vorrebbe imitare
l’onestà dei giapponesi verrebbe deriso e preso per uno
scemo. Il suo esempio lodevole non avrebbe peso, al
contrario, lo si indicherebbe come modello di scemenza.
E’ così i nostri figli crescono, ed in loro non c’è più
spazio per l’etica del dovere, del lavoro, della
fedeltà. Ora sappiamo che il giapponese non ha
dimenticato cosa voglia dire essere un guerriero, il
sacrificio per il bene comune è un valore non alieno al
-112-
suo cuore. Bastano questi per indicare una primaria
razza guerriera. E noi? Siamo ridicoli e frignoni.
Quanti soldati manterrebbero il giuramento dato in caso
di guerra? Gli obiettori di coscienza (per lo più
fannulloni e mezze seghe) aumentano di anno in anno,
mammoni che piagnucolano di essere contrari alla
violenza. Ma quale violenza? Il soldato non è violento,
ma forte e deciso nel proprio dovere. La sua mente deve
essere chiara, il suo senso del dovere inossidabile, la
sua volontà a difendere il proprio paese (i propri
concittadini) non vacilla. Dove sono i nostri soldati?
-113-
11.
“Riesce a trovare il senso di quello che diciamo?”
La domanda me la porto addietro da due settimane – senza
risposta certa, se non una pletora di mezze idee alcune
senza coda, altre senza testa. Per questo ora mi sono
seduto a buttare giù queste righe per cercare di dare
forma ai pensieri che mi si agitano dentro. Certo, lo
zen dovrebbe essere l’acquietamento della mente, ma va
da sé che il sottoscritto è ben lontano dall’aver
raggiunto solo il primo gradino di questo risultato…
nemmeno l’ombra, insomma! Tuttavia, non va negato il
fatto che con una certa volontà e sforzo riesca a
riflettere seriamente su un unico prolema e con un poco
di esercizio riesco anche a sviscerarlo bene. Ecco,
dunque, che cerco di dare la risposta a lungo cercata,
preparando un discorso che presto o tardi dovrò
discutere in sanzen.
Mi ripeto la domanda: “Riesce a trovare un senso in
quello che diciamo?” La voglio analizzare, questa
domanda.
Riesce. Si rivolge alla mia persona, alla mia mente, alla
mia capacità analitica. Il verbo riuscire implica la
vittoria in una ricerca di qualcosa o di qualcuno. Vuole
dire che io debbo vincere la mia battaglia, e vuole
-114-
anche dire che io devo cercare qualcosa, altrimenti
quale la mia ragione d’essere nel Bodhimandala?
Trovare. La conferma della necessità della mia ricerca.
Sono nel bodhimandala per cercare qualcosa e debbo
trovarla, debbo riuscire; non ci sono altre attività se
non quella del cercare, e del riuscire a trovare.
Un senso in quello che diciamo. Questa frase va suddivisa.
Parto dalla fine.
Quello che diciamo. Nella segreteria, il maestro tiene dei
discorsi, spesso generici, a volte centrati
specificatamente sul buddhismo, ma sempre, sempre
inerenti il dharma. So questo non perché individuo il
dharma, bensì per una supposizione logica: il maestro –
colui che ha ricevuto il Sigillo della Trasmissione
della Mente – non parla tanto per aprire la bocca: il
suo è un insegnare lo zen, per chi ha le orecchie per
intendere. Quel dire, dunque, quel parlare, quei
dialoghi sporadici vanno afferrati al volo e seguiti con
serissima attenzione (l’attenzione di chi lavora di
precisione, un orologiaio, per intenderci.) Il fatto che
nella domanda il maestro ha posto l’attenzione a quello
di cui si parla nella segreteria (nel bodhimandala,
dovrei dire) vuol proprio dire che in quelle parola è
nascosto l’oggetto della mia ricerca, il tesoro del
buddhismo. Una perla? Per di più ha usato il plurale, il
che significa che non quello che dice lui è degno di
-115-
attenzione, ma anche le domande dei suoi allievi, le
risposte - sempre di questi ultimi.
Senso (o meglio: Un senso). Personalmente, credo che siamo al
nocciolo della questione. Il senso di quello che si
dice, del parlare tra maestro ed allievo (perché non è
mai dialogare tra il maestro e più allievi, ma è sempre
un mondo tra due individui, un rapporto (mondo) tra due
termini (maestro, allievo). In una serata ci possono
essere più mondo, ma non vanno presi come un dialogo tra
un termine da una parte, e più termini dall’altra – così
sarebbe un ragionare sbagliato.) Senso (guardo il
vocabolario – sommo bene): dal latino sensu, da sentire,
che è percepire. Seguono ben tredici accezioni. Le più
appropriate sono:
7. Criterio generale intuitivo, discretivo,
intellettivo.
8. Significato, concetto espresso da una parola, da una
frase.
12. Opinione, parere.
Credo che l’accezione più appropriata sia quella del
numero otto, laddove si psecifica che senso è il
significato espresso da una parola, o da una frase.
Tuttavia, per arrivare a questo bisogna usare un
criterio sia intuitivo, che discretivo, che intellettivo
e giungere infine ad un’opinione, un mio parere
personale.
-116-
Sopra, il risultato dell’analisi, ora le correzioni a
questa analisi. Il senso che debbo cercare, non è un
significato recondito, che ha valore in quanto è in
rapporto con le singole parole che compongono le frasi e
le frasi che compongono il discorso. Il senso è celato
al di fuori di qualsiasi contesto, pur tenendo conto che
il contesto va preso in considerazione. E’ come se si
trattasse di una metafora, dove se si parla del sole che
illumina gli esseri viventi, scaldandoli, non bisogna
soffermarsi sul significato rapportato alle singole
definizioni: sole (dunque luce, calore, vita), esseri
umani (pensieri, intelligenza, ciclo della vita e della
morte); bensì andare oltre, e capire che il sole è Dio,
la luce ed il calore la sua grazia, gli esseri umani
spiriti o meglio: anime. Ed anche questa metafora ha un
senso, ancora più recondito, ed è questo senso profondo
che bisogna far emergere. ne conseguo, in ultima
analisi, che non si può più, alla fine, parlare di
opinione personale, perché il significato più profondo,
il senso delle parole e dunque delle cose, trascende
qualunque parere per diventare inopinabile, verità
assoluta. Lo stesso dicasi per l’accezione di senso:
Criterio intuitivo, discretivo, intellettivo. Il
criterio di ricerca interpreta, di conseguenza è un
filtro e come tale ha lo scopo di far passare alcune
-117-
cose e lasciare indietro altre, ed alla fine non si sa
se è passato il giusto o viceversa.
Cosa posso trarre da queste sopra riportate analisi? Che
cosa è questo senso? Se lo cerco, interpreto e dunque
sbaglio. Dovrei inventare dei parametri, e sarebbero
sbagliati. Nulla allora, solo ascoltare e lasciare
decantare senza fare nulla se non zazen… e naturalmente
continuare con questi fogli di diario assoluto, che una
volta finiti sono dimenticati. Anche questa disgressione
che mi sto accingendo a terminare devo lasciare cadere,
per non esserne influenzato. Quale risposta allora? Non
cercare un senso, oppure andare per gradi, ovverosia
individuare il senso apparente, poi la metafora celata
dietro, poi il senso primo di questa metafora ed il
senso recondito del senso primo? E se non ci fosse
metafora? ma come si sviluppa un discorso del maestro?
Quasi impossibile seguirlo, tanto è un balzare da un
argomento ad un altro… eppure ci deve essere un
denominatore comune, perché non siamo macchine che
sparano numeri a caso, ma coscienze che seguono una
linea di condotta. Il primo livello di significato è
dato dalle singole frasi, e queste frasi assumono un
significato diverso all’interno della frase che le
utilizza. le frasi così formate hanno un senso prese
singolarmente, ma questi significati possono non essere
gli stessi se le frasi di uno stesso discorso sono messe
-118-
in rapporto tra di loro. Fra questi rapporti di frasi,
ne viene fuori che i significati delle singole parole
possono assumere sfumature differenti. Voglio fare uno
schema:
-119-
parol parol parolparol parolparol parol
frase
parolparolparol
frase frase frase
periodo periodo
DISCORSO
All’interno di un discorso, possono esserci quattro
livelli di significato, quattro sensi, per così dire; in
realtà il senso recondito, nel parlare del Bodhimandala,
è al di fuori di questi quattro livelli.
Il Dharma è il senso delle cose. E il senso in quello
che si dice, come nella domanda del maestro, è
un’indicazione per scovare il Dharma del Buddha. Non
rimane che ascoltare, riflettere, mettere da parte e
continuare zazen, oppure considerare ogni parola come un
koan. La domanda del maestro, in definitiva è un koan.
-120-
12.
Sanzen.
Martedì 12 ottobre 1999, una data che appositamente qui
segno per rammentare ora e per sempre l’esperienza del
mio primo sanzen (ovverosia dialogo a quattr’occhi con
un maestro illuminato – maestro, illuminato, ecco due
termini che per essere pronunciati esigono da parte del
proferitore… io… una minima conoscenza dello zen. Io non
possiedo questo tesoro, ma posso affidarmi al giudizio
di chi da tempo segue Ryusui Roshi e felicitarmi del
fatto di essere stato ammesso al Centro). Sanzen non è
un semplice scambio di belle parole, né una confessione
dal prete con assoluzione finale, tanto meno una seduta
dall’analista. Sanzen (nel mio attuale stato di
co(no)scienza) è la dialettica critica che il maestro
imposta affinché l’allievo (che ancora io non sono)
trovi con le proprie forze risposte al suo quesito. In
sanzen il maestro conduce il gioco, in quanto conosce il
gioco (è impregnato del dharma) e dunque quello che dice
è sinonimo di verità (dharma – Dharma).
Entrando in segreteria, il maestro stava scrivendo il
foglio giornaliero delle note. Mi sono seduto, iniziando
a leggere (per la ennesima volta) il primo capitolo
della sublime opera di Dogen Zenji. Nel mio spirito mi
auguravo che smettesse presto, dato che già in un’altra
-121-
occasione – arrivando in segreteria con l’intento di
chiedere sanzen – il maestro era impegnato alla macchina
da scrivere e proprio non me la sentii di disturbarlo.
Questa volta la fortuna è dalla mia parte (ma la fortuna
non esiste, come non esiste la Provvidenza, invenzioni
entrambe per togliersi di dosso la responsabilità delle
scelte e degli errori): il maestro ben presto smette di
scrivere ed apparentemente non sembra volere iniziare a
segnare un altro foglio. Tra l’altro, i suoi fogli
meriterebbero un commento a parte, tanto sono gli spunti
che se ne possono trarre per iniziare una seria
discussione su un qualunque aspetto dell’esistenza
(sociale politica, metafisica, filosofica, etc.) umana.
Torniamo alla segreteria. Faccio gassho e chiedo di fare
sanzen. Il maestro accetta, e di quello gliene sono
immediatamente grato. Si inizia.
La domanda che decido di porre al maestro – la questione
da discutere, insomma – riguarda una sua frase, già
argomento di un punto di questo diario. “Riesce a
trovare un senso in quello che diciamo?” Spiego al
maestro l’ansia che mi hanno procurato quelle parole e
cerco di dimostrare il mio sforzo per comprenderle e
farle “girare” nella mia vita. E’ difficile, col
maestro, riuscire a prolungare un discorso senza essere
interrotti… e questa interruzione è sempre la benvenuta.
Ogni sua parola contiene una verità, od è lo spunto per
-122-
la ricerca di una verità, altrimenti non si spiegherebbe
la Trasmissione della mente che ha ottenuto dal
Patriarca Deshimaru. Tuttavia, è bene chiarire subito
che il maestro, il roshi (come preferisco chiamarlo
quando non mi rivolgo direttamente a lui) usa esporre il
dharma parlando della realtà sociale nella quale
viviamo, ed i suoi esempi sono fatti di vita, di storia
che tutti noi che frequentiamo al centro hanno vissuto o
vivono. Non c’è nulla, nel suo insegnamento, che sia
anche solo lontanamente assimilabile al minestrone
profumato new age e filotibetano che in questi ultimi
anni si è riversato – per opera di - sugli italiani.
Noto che anche lo zen italiano ne ha subito l’influsso,
tanto che in questi ambienti che definisco senza
esagerare alterati , non si fa che parlare di nirvana,
angeli, trascendenza, reincarnazioni, e tutto scivola
irrimediabilmente verso la metafisica, le metafore
poetiche e tutte queste belle cose da sentire ma che in
effetti nulla hanno a che fare con la realtà nella quale
noi siamo immersi, anche nostro malgrado. In questi
giorni il Dalai Lama (che appositamente evito di
chiamare Sua Santità) è a Milano, per raccogliere fondi
per la causa tibetana (che comprendo) ma anche per
insegnare ai milanesi come riacquistare la pace
interiore, la serenità, qualunque sia il loro credo.
Siamo veramente lontanissimi con lo studio della Via. La
-123-
Via non è, per nessuna ragione, una panacea, né per
nevrotici o paranoici che siano, né tantomeno per
tossici o gente dello spettacolo che vuole mettersi in
mostra. Con il roshi questo non accade, e dunque ecco la
prova della sua reale illuminazione. Il roshi non parla
mai apertamente del dharma, i suoi discorsi non sono
un’elencazione dei principi buddhisti, od una
disgressione sulle dottrine del buddha (leggi: Buddha).
Il suo parlare – come già fatto notare poco sopra –
ruota attorno alla realtà sociale nella quale siamo
immersi, ed ognuno deve essere in grado di cercare il
senso delle cose (il Dharma, come in questo momento
della mia vita io lo intendo) con le proprie capacità.
L’insegnamento del roshi, al fine di questa ricerca, per
chi ha orecchi, è illuminante.
E sanzen? Quando ho esposto la mia incapacità di trovare
il senso delle parole, mancando in me la conoscenza del
senso, subito il roshi ha ribattuto specificando che pur
non conoscendo l’obiettivo della ricerca, lo scienziato
(faceva un esempio, ma è ovvio che si riferiva allo
studente dello zen) procede facendo ipotesi, e scartando
nel processo della ricerca quelle che non si possono più
ritenere validi. Così devo procedere. Costruire ipotesi,
eliminare quelle invalidate dai dati dell’esperienza, e
continuare fino ad arrivare alla verità, al Dharma. Lo
zen è illuminazione immediata, ma questo non esclude un
-124-
cammino graduale, fatto di piccole aggiunte, ognuna
delle quale è un corpuscolo di luce, una pagliuzza, un
tozzo di brace nell’oscurità della nostra (mia)
ignoranza.
Lo sanzen è terminato soffermandosi su una mia ultima
domanda, che inizialmente non mi era nemmeno passata per
la mente, ma che, data la piega che aveva preso la
discussione, mi sono sentita in dovere di fare:
“maestro, cosa fa lei per tutti quei giovani e meno
giovani che vengono presi in giro sul Dharma del
Buddha?” Il maestro non mi ha risposto subito, lasciando
“aperta” la domanda; il giorno dopo ne ha parlato sul un
suo foglio di note, chiarendo che lui si chiama fuori
(per l’età e per avere già molto dato) ma lascia
l’incarico ai suoi migliori allievi (i più preparati) di
iniziare una serie di conferenze, senza intenti di
crociate od acerrime discussioni. Starò a vedere. Nel
frattempo, continuo lo studio, vado avanti con zazen,
costruisco ipotesi, le verifico, quelle buone le porterò
in sanzen.
Per finire, alla luce, di questo sanzen, pongo termine
ai punti di questa seconda lettera dell’alfabeto beth,
ritenendo che sia tempo di iniziare un nuvo scalino per
innalzarmi ulteriormente da malkuth. Costruire ipotesi,
indagare fatti sociali, senza dimenticare la mia indole
artistica, la passione per la poesia ed il fantastico,
-125-
per colmare con l’immaginazione, l’intuizione ciò che la
ragione non riesce a comporre.
Non ho finito con questo punto, volendomi adesso
soffermare, seppur brevemente, sul senso delle parole.
Senso che non avrebbe senso se disconnesso con le azioni
ed i pensieri che hanno causate le parole in questione.
Pensieri, azioni e parole, è un trittico che viaggia in
continua rotazione, ogni parte non potendo mai essere
discongiunta dalle altre… e ciò vuole dire che cercare
il senso delle parole è anche la ricerca del senso delle
azione che si compiono e dei pensieri alla base di
entrambi (Parole ed azioni).
-126-
DALETH
1. Mito ed anima – 12 dicembre 1999
L’intervista ad Hillman, che ho debitamente
registrato, mi ha lasciato segni indelebili, in aggiunta
ad un desiderio di conoscere meglio l’autore e di
indagare più profondamente alcuni argomenti e concetti
che mi hanno sempre affascinato, quali il mito e l’anima
(da non confondersi con spirito). Due termini, questi
ultimi, legati a realtà ampie sia di indagare, sia da
comprendere; legate al cammino spirituale e culturale
dell’uomo. In questi anni, il degrado della vera ricerca
spirituale, sostituita da una massa di pseudofilosofie,
scuole esoteriche, libere interpretazioni delle
religioni classiche (il tutto elencabile sotto il titolo
di: new age) hanno allontanato la persona dalla vera
conoscenza del mito e dell’anima, ovverosia da una
giusta interpretazione dei significati dei vocaboli
menzionati. Che cosa è il mito? Che cosa è l’anima?
Dell’anima, il solo parlarne evoca il concetto di
dio, immortalità e vita ultraterrena (od extraterrena),
dunque, come aspirante buddhista, non mi sento pronto di
affrontare adesso un simile discorso, non questo
-127-
affermando che la mia ricerca del Dharma escluda la
volontà di trovare finalmente una soluzione – per quanto
personale – al problema: cosa è l’anima (posta la sua
esistenza)? Per quanto riguarda il mito, posso
permettermi di darne una spiegazione alla luce delle mie
attuali e scarse conoscenze. In passato ne ho perfino
parlato in un articolo sulle origini della fantascienza,
raggiungendo una conclusione che tuttora condivido.
Ritorno volentieri all’argomento, cercando così di
definire maggiormente la mia tesi e magari trovando
nuovi sviluppi.
Il vocabolario da quattro accezioni, tutte
indubbiamente rispondenti alla complessità del termine
mito e che nulla hanno a che vedere con l’uso
incongruente che oggi se ne fa. La parola deriva dal
geco mythos: parola, storia, narrazione; e già
l’etimologia ci aiuta a compiere un passo verso la
comprensione. Le quattro accezioni si possono leggere
su qualsiasi vocabolario (il mio è lo Zingarelli), a me
interessano le prime tre, che riformulerò in una mia
personale lettura:
1. Una lettura religiosa. Narrazione sacra
sull’origine della vita e del cosmo (cosmogonia)
attraverso le imprese di déi (o di un dio).
2. Una lettura eroica. Narrazione di imprese di eroi
cui seguirono fondazioni di civiltà.
-128-
3. Una lettura filosofica. Esposizione di un sistema
filosofico, o comunque astratto, attraverso
un’allegoria.
4. Una lettura sociologica. Immagine di un evento,
di un fenomeno sociale, o di un personaggio che in
determinati gruppi culturali ha svolto un determinante
ruolo pratico o ideologico, od entrambi.
Ciò che accomuna le quattro accezioni è l’idea del
racconto, attraverso il quale si narrano vicende per
spiegare lo stato attuale delle cose o il motivo del
perché delle cose. Il mito si può correlare anche ad
eventi o personaggi realmente esistiti, ma che hanno
acquisito nel corso del tempo una tale levatura da
sfuggire la realtà storica. Ma ciò non ha importanza, in
quanto è nella formulazione dello stesso mito, oramai
disgiuntasi dalla causa originale che lo ha formato, che
l’uomo cerca le risposte alle grandi domande della vita.
L’essere umano è un animale mitopoietico, ovverosia si
distingue dagli altri animali per il fatto che è sua
caratteristica creare miti. Dunque, non parlo di
intelligenza e sentimento per distanziare l’animale uomo
dagli altri animali presenti sul pianeta che ci ospita,
bensì della capacità innata di creare miti, ovverosia
narrazioni che stano a fondamento della civiltà. La
conseguenza maggiormente lampante è che la civiltà
dell’uomo trova origine non nella volontà di qualche
-129-
dio, ma nel mito. Il mito della creazione, così come è
spiegato nella genesi biblica, ne è un esempio, in
quanto pur non rispondendo alla possibilità di riscontri
scientifici è la spiegazione accettata da tutti i
cristiani, che su questa base hanno edificato la loro
civiltà. L’induismo, per spostarci in oriente, è
ricchissimo di miti, legati alle gesta di miriadi di
divinità, che nelle loro imprese hanno dato origine
all’uomo e all’attuale universo. Ma il mito è qualcosa
di ancora più sottile e penetrante, quando si riferisce
a determinati valori, come l’onore ed il coraggio,
conseguentemente specificandosi nel mito del samurai
(tanto per fare un esempio), indicante l’ideale di una
persona che sacrifica la sua vita per un ideale. Ecco,
il mito del samurai è quello che mi piace
particolarmente, perché meglio di altri mi spiega quella
perenne tensione dell’uomo alla ricerca di un qualcosa
che vada oltre l’immanente. Il mito del samurai è il
mito del trascendente.
Il samurai, nella mia esposizione, non è solo il
riferimento alla figura storica del medioevo giapponese,
ma anche l’immagine di un individuo ideale, di colui che
si batte – mettendo a repentaglio la propria esistenza –
per un ideale. Si potrebbe obiettare che il samurai era
un guerriero al soldo di un feudatario (Daimyo), verso
il quale palesava una sincera fedeltà. Quale ideale,
-130-
allora? In questo caso, dovrei introdurre il concetto di
ideale, ma è ancora presto. Piuttosto, vorrei porre
l’evidenza sul particolare che proprio nel servire il
Daimyo, il Samurai onorava l’ideale, perché l’ideale è
ciò che muove il samurai, che cerca un padrone per poter
meglio onorarlo (l’ideale). Di conseguenza, non si
tratta più di un semplice atto di sudditanza, giacché il
Samurai è conscio che esiste qualcosa che va oltre, ed è
questo qualcosa che lo spinge a sacrificare la vita.
Siamo in un contesto superiore, di completo valore
umano, al di spora di qualunque religione. L’uomo
samurai non si batte per gli déi, per Cristo o Buddha,
bensì per una forma idealistica che sfugge qualunque
interpretazione e che difficilmente può essere spiegata
su carta. E’, per l’appunto, il mito del samurai, nel
quale alcune persone cercano di trovare una ragione di
vita. E’ l’unico motivo che può spingere a praticare il
kendo, la via della spada (la spada è il simbolo del
samurai), che in questi tempi di valori azzerati e di
pseudomiti di celluloide ci può ricondurre ad essere un
vero uomo, un adulto, insomma un bodhisattva. Il
bodhisattva è colui che ricerca il mito in assoluto, il
mito dell’illuminazione, ma è disposto a sacrificare
questa ricerca per salvare un simile dalla miseria
dell’ignoranza… ed è proprio in questo sacrificio che
sta il supremo ideale, impossibile de definire a parole,
-131-
ma solo con i gesti, con l’azione, con zazen ed il
kendo.
Attenzione! Il mito non è favola, non è invenzione,
è una realtà ben precisa dentro di noi.
Postilla (molto breve)
Con Daleth, inizio a porre dei titoli alle note,
data la mia volontà di cercare percorsi nella mia
personale ricerca del Dharma.
-132-
2. Tempo di cambiamenti – 2 gennaio 2000
Preciso subito la ragione del titolo: dall’inizio
del nuovo anno, non frequenterò più il Tempio Zen dove
insegna il Maestro Ryusui. Leggendo le note indietro,
dove mi ponevo il dovere ed il voto di fare del Centro
Zen un costante punto di riferimento nella mia ricerca
del Dharma, questa decisione appare quasi inverosimile.
Posso solo dire che ciò che ci riserva il domani è
veramente imperscrutabile. Non sto parlando di destino,
concetto lontano dalle mie idee (per altro sicuramente
erronee) bensì degli effetti dei molteplici intrecci
della vita. Quegli stessi intrecci che mi hanno
inesorabilmente portato a prendere la difficile
decisione. Precisamente, il kendo è stato fondamentale.
Ma andiamo per ordine.
All’inizio del mese scorso, a seguito di una
crescente perdita di interesse nel karate, decisi di
interessarmi ad una alternativa. Lo zen non poteva
essere questa alternativa, dato che la sfera in cui
opera non comprende aspetti al contrario ricoperti dal
karate – in quanto arte marziale – e per l’ulteriore
motivo che da tempo ho sempre saputo essere incapace a
condurre una vita aliena ad una qualsiasi attività
fisica. Ritengo importantissimo dedicarmi ad una
attività fisica, non solo per gli evidenti benefici
-133-
sull’organismo, ma anche per sdebitarmi con mio fratello
Daniele. Essendo lui impossibilitato, per via della
grave malattia che lo assilla, impegnarsi in una
qualsiasi attività fisica, ho io il dovere assoluto di
praticarla per entrambi, un dovere cui non posso fare
meno. Se a questa attività fisica si aggiungono valori
quali l’onore, il rispetto, la sincerità, il coraggio…
allora siamo di fronte ad un’arte marziale. Il karate,
che ho praticato per quindici anni, mi ha formato il
carattere, in un certo senso; ma, ultimamente, ho
sentito che non era più per me, che in esso non sarei
mai riuscito a trovare ciò che cercavo. Che cosa? Non lo
so, anche se credo che lo zen abbia tirato fuori questa
mia delusione, evidenziandola. Infine, il kendo, verso
il quale già tempo addietro, circa sette od otto anni,
provai interesse. Così ho contattato un dojo, ho fatto
una lezione di prova, mi sono innamorato e di
conseguenza ho preso la decisione di dedicarmi ad esso,
per raggiungere i più alti risultati possibili. Mi sono
subito trovato in un ambiente umano, frequentato da
persone sincere, a cui non ero abituato (nel karate
oramai ci sono troppe tensioni, lotte per il potere, la
politica sta assumendo proporzioni allarmanti ed il
business è imperante). Come rinunciare a tutto ciò? Il
kendo è budo, la via del guerriero, il modo più
-134-
verosimile per avvicinarmi al mito del samurai, che ho
spiegato nella nota precedente, se non mi sbaglio.
Cosa centra tutto questo con il Tempio del maestro
Ryusui? Tutto è connesso, indissolubilmente. Purtroppo,
la quota associativa del Tempio è molto alta, tale da
non permettermi il sostentamento delle spese per il
kendo: l’hakama, e fra non molto una armatura completa.
E’ forse veniale tutto questo? Non credo. La mia ricerca
del Dharma non si estingue, al contrario: il kendo fonde
il budo con lo zen, inoltre ben presto inizierò a
cercare un altro Tempio zen, se pur con la
consapevolezza di non potere più trovare un grande
maestro come Ryusui Roshi. Ho scritto una lettera
indirizzata a Philip, il monaco che mi ha seguito nel
mio anno al Tempio, non per spiegare le ragioni del mio
abbandono, ma per ringraziare di quanto ha fatto per me.
Continuerò zazen nel piccolo zendo da me costruito in
cantina e proseguirò nella compilazione del commento del
Dhammapada, opera a cui tengo moltissimo.
-135-
3. Il miracolo della vita – 20 gennaio 2000
A distanza di quasi tre settimane riprendo il
diario. In questo arco di tempo ho avuto modo di
riflettere profondamente sulle scelte operate e sugli
esiti che potranno avere nella mia vita. Ammetto che
spesso mi colgono dei dubbi, ma la certezza di non avere
preso una strada sbagliata, la consapevolezza che le mie
qualità al meglio si manifesteranno attraverso il kendo,
mi spronano a continuare. Tuttavia, la vita non è solo
kendo e zen, anche se così mi piacerebbe fosse. la vita
è molte altre cose, talune di importanza fondamentale,
come quella che dà il titolo a questa nota. Il miracolo
della vita… quale miracolo? Il miracolo della creazione,
che la donna serba nel suo ventre, la capacità di creare
dal nulla un essere vivente. Si tratta di un atto
smisurato, oserei dire divino, e che, paradossalmente,
possiedono tutte le creature di questo pianeta, anche la
più umile ed apparentemente inutile. Come un ratto, come
un piccione, od uno scarafaggio, anche la donna è in
grado di costruire una forma vivente, partendo da poche…
anzi una cellula. Che altri commenti si possono fare?
Nessuno, al massimo la meraviglia di fronte al fatto di
una cellula che già in nuce contenga tutte le
caratteristiche fisiche del suddetto essere vivente.
Vorrei parlare anche delle attitudini psichiche, ma mi
-136-
addentrerei in un contesto non molto familiare, che non
necessariamente coinvolge la scienza della psicologia,
mentre indubbiamente rimanda a molte nozioni del
buddhismo. ma non è questo l’ambito più adatto. Io sono
qui, in semplicità ed umiltà, a parlare del figlio che
io e Barbara abbiamo deciso di avere e che già da
qualche tempo preferisce rimanere al di là di questa
vita. Uso un parlare forse troppo mistico, ma sono
convinto che più che creare un essere ex novo, noi si
dia la possibilità ad una forza trascendete di
manifestarsi su questa terra, introducendo in essa delle
nostre stesse qualità. E, forse, non si tratta di una
forza trascendente, bensì di un’energia quanto mai
appartenente a questa realtà, scaturita in maniera
karmica e che attende il momento giusto per rinascere.
Un’energia che forse è priva di volontà, di anima, di
identità, ma possiede una tendenza, delle qualità, una
certa intensità.
Comunque sia, sono qui solo per meditare sul
desiderio nostro di avere un figlio e sul fatto
incontestabile che da nove mesi i nostri sforzi sono
vani. Il caso è una sciocca invenzione per non pensare
alla responsabilità che dovremmo assumerci in ogni atto
della nostra vita, atti che sono le cause del nostro
destino. E’ possibile che abbia compiuto, o detto, o
pensato qualcosa che contrasti la nascita del nostro
-137-
bambino. Non si tratta di un discorso che nulla a che
vedere con il senso delle cose, perché se ci si ferma un
attimo ci si rende subito conto che noi e soltanto noi
siamo la causa del nostro destino. Lo costruiamo secondo
dopo secondo, ognuno con le nostre azioni, le nostre
parole ed i nostri pensieri, e questa moltitudine di
fili formano un’immensa rete, dove diventa assurdo
pretendere di spostare un filo, o di tagliarlo senza
compromettere quelli che gli sono vicini. Così è la
nostra vita, una rete di karmica, dove tutto ha un
valore pienamente concreto. Se io agisco e parlo male,
queste mia azioni saturano l’ambiente in cui vivo,
influenzando chi mi vive accanto (lavoro, famiglia,
amici) e generando reazioni che presto o tardi
ritorneranno a me. Nulla di trascendente, come si vede,
ma soltanto immanenza, incontestabile. Dunque, mi
chiedo, quale mia manifestazione sta generando un simile
ritardo? O le cause sono da ricercarsi in più profondi
strati del tempo? Bisogna solo avere fede, proseguire la
vita con calma ed energia, nella corretta visione delle
cose.
4. Zen e Kendo – 23 gennaio 2000
In questi ultimi giorni spesso mi sono chiesto cosa
mi ha condotto lontano dal karate, così lontano da
averlo definitivamente accantonato. Ma non dimenticato!
-138-
In quindici anni della mia vita, molte ore della
settimana le ho dedicate al karate, iniziando da ragazzo
(avevo diciassette anni) e finendo da uomo (come dovrei
definirmi adesso), accumulando in tal modo un discreto
bagaglio di sapere, oltre ad avere forgiato un buon
fisico. Tutto è andato perso? Oso dire di no. Ho già
scritto non molto tempo fa di questo, ma ci tengo a
ritornare sull’argomento. Credo di avere scorto la causa
ultima della mia drastica decisione, e voglio meditarci
sopra, argomentarci infine.
Ricordo che qualche anno fa, quando la mia storia
con Simona (breve, molto breve) giungeva al termine, ero
intenzionato ad iniziare la pratica del kendo, senza
abbandonare il karate. Mi scoraggiò il costo eccessivo,
cosicché continuai con la pratica del karate con ottimo
entusiasmo. Dal 1991 al 1995 visse i migliori anni da
karateka: ottima forma, frequentissimi allenamenti,
insegnamenti, stages. Pensavo, allora, che la mia strada
fosse quella, aprire una palestra, diventare istruttore
e poi maestro, e negli anni che vennero immediatamente
dopo alcune cose mi persuasero della bontà delle mie
intenzioni. Purtroppo non fui buon veggente. Nel 1997
iniziai il corso istruttore della FIKTA, e l’entusiasmo
non mi mancava. Gli ultimi mesi del 1998 mi videro
applicato seriamente… come dire, la lampadina che arde
il doppio del normale prima di spegnersi. Dal 1999 ebbi
-139-
l’improvviso calo di interesse, stranamente in
coincidenza con la mia frequentazione del tempio zen del
Maestro Ryusui. Non sono più riuscito a risollevarmi e
tutto questo deve avere un senso. Forse mi resi conto di
non aver ottenuto ciò che cercavo, forse l’ambiente era
talmente cambiato da non sentirmi più in armonia con
esso, forse lo zen mi aveva aperto un altro occhio,
forse l’infortunio di Barbara (senza la quale la mia
vita non sarebbe più la stessa) mi ave a messo di
malumore – il timore che il ginocchio malandato non le
avrebbe permesso di continuare la pratica – forse la
constatazione che tanti anni di sacrificio non mi
avevano gratificato di un grazie da parte
dell’associazione di goshin-do (ma credo che sia un
troppo pretendere), forse l’entusiasmo mi è morto
dentro, di morte naturale, come capita agli esseri
viventi … insomma, tanti motivi, ma forse solo uno ne è
la causa originale ed unica. Quale?
Il karate permette un’ottima educazione fisica.
Dovrei aggiungere anche un’ottima educazione etica, un
giusto modo di affrontare la realtà di tutti i giorni.
Ma non posso dirlo, perché mi sono accorto che non è
così. E’ questa la verità, e su questo aspetto mi ha
aperto gli occhi lo zen. Il karate è diventato un
fenomeno non separabile dalla federazione in seno alla
quale lo si pratica, e col tempo si sono innescati quei
-140-
meccanismi tanto tipici negli ambienti dove ci siano
interessi economici e politici (non la politica dei
partiti, bensì quella del potere). La FIKTA è
un’organizzazione a fini di lucro e per quanto sia
composta da ottimi karateka, scarseggiano gli “adulti”,
così come Uchiyama Roshi ha la compiacenza di chiamare i
bodhisattva. Ci sono solo uomini che vogliono mangiare
ed ingrassare e comandare, e si tanto ben mascherato
sotto la facciata del karate etico (quello del dojo kun,
tanto per intenderci) da arrivare a crederci essi
stessi. ma si ingannano, e discorsi sentiti io stesso
con le mie orecchie non mi danno che ragione. In questo
karate io non riconosco nessuno zen, nemmeno nella sua
più piccola parte, semmai lo zen ha parti. Potrebbe
esserci, ma le attuali condizioni delle organizzazioni
non lo permettono.
Nel corso dell’anno passato ho maturato questa
convinzione, avvallata anche dal tirocinio buddhista,
che mi ha portato a vedere le cose con occhio
differente, oserei dire più imparziale, in un tal modo
che spesso mi sento spesso fuori dal coro e dunque privo
di quei riferimenti che normalmente usiamo per definire
il giusto ed il non giusto, il bello ed il brutto, e
così via. E’ paradossale rendersi conto che noi
giudichiamo e valutiamo con quei parametri che la
società corrotta che vogliamo giudicare ci ha forniti, e
-141-
senza i quali ci sentiamo perduti. Io stesso, spesso, mi
sono sentito spaesato, ed solo grazie allo zazen ed alla
certezza delle verità del Dharma (l’insegnamento del
Buddha e dei Patriarchi a lui successivi) che ala fine
ho sempre ritrovato la giusta strada. Ultimamente, a
seguito del mio volontario abbandono del tempio (ma per
soli motivi economici, ci tengo a precisarlo) questa
capacità è venuta meno, costringendomi spesso al
silenzio piuttosto che dire fesserie o percorrere le
squallide strade delle idee preconfezionate che ci
vengono fornite a destra ed a manca. dalla settimana
entrante inizierò un nuovo tirocinio zen, dedicando più
tempo allo zazen ed alle letture di testi sul Dharma (e
riprendendo seriamente la stesura di queste note). E
così, il karate non ha nulla a che vedere con lo zen,
con l’etica, con la purezza d’animo, anche se conosco
karateka che si possono definire “adulti”, e non a caso
sono al di fuori del coro. Penso a Claudio, a Roberto e
sua moglie Laura, a Sopracciglione (non ricordo mai se
si chiama Massimo e Massimiliano); tuttavia con loro non
ho mai stretto un buon rapporto di amicizia (in effetti,
non ho mai ricevuto da parte loro proposte del genere.
Credo che il carattere chiuso faccia insorgere negli
altri la volontà di tenermi un po’ alla larga). Troppo
pochi, comunque, ed isolati affinché possano essere la
ragione del mio continuare la pratica. Non trovo più
-142-
ragione di praticare, a parte il fatto di tenermi in
forma… e non è ragione sufficiente. Senza contare il
fattaccio dell’estate scorsa, riportato in queste note,
durante lo stage di goshindo a Foligno. Un altro
macigno, forse quello definitivo.
Inutile continuare, ho già detto tutto. Delusione,
mancanza di gratificazione (indispensabile),
consapevolezza di un karate che si è alienato, o non ha
mai posseduto alcuno elemento di zen, dispersione
dell’amicizia (Bruno è cambiato, Michelone non viene
più, Michelino e Riccardino non gli ho mai sentiti
vicini), una federazione filopolitica e lucrosa, e – mi
duole dirlo – un maestro a volte troppo freddo con chi
ha dato tanto. Parlo del Maestro Shirai, indubbiamente
un grandissimo karateka, e forse anche un grande uomo
(per chi gli è vicino) ma troppo lontano da chi vorrebbe
almeno una volta sentirsi nei suoi pensieri. Tutto il
gruppo che pratica con lui, non è composto da suoi
allievi, ma solo da persone alle quale lui insegna
karate. Lo fa magistralmente, con uguale impegno e
sacrificio e dedizione da tantissimi anni, senza mai
stancarsi, spesso o quasi sempre trasmettendo insieme al
semplice insegnamento di una tecnica anche qualcosa
d’altro di più grande, che ha che fare con la vita di
tutti i giorni; ma è inutile negare il fatto che noi non
siamo suoi allievi. Nell'associazione di goshindo che ha
-143-
fondato, non si è forse circondato di persone della
FIKTA, tutte economicamente agiate? Il Maestro sa dove
pescare e cosa pescare. Non voglio criticarlo, la vita è
sua.
Al contrario, affacciandomi nel mondo del kendo ho
avuto impressioni differenti. Non voglio dire che le
persone siano migliore, perché è indubbio gli individui
si assomiglino tutti; pur tuttavia, devo ammettere che
nell’AIK, l’associazione dove mi sono inscritto, ed
anche la più vecchia in Italia, vige una filosofia
differente. Non c’è lucro, nemmeno uno spiraglio di
volontà di guadagnare sul kendo. Forse perché
l’associazione è piccola (il kendo è poco sviluppato in
Italia, non più di un migliaio di iscritti) e dunque
sarebbe assurdo pensare ad una carriera professionale… o
forse perché lo stesso kendo non si presta a simili
prese di posizioni. In Giappone so per certo che ci si
può dedicare alla carriera professionista del kendo solo
dal settimo dan. Interessante, vero? L’ambiente è
piccolo, tutti e dico tutti si conoscono, si gira da
dojo a dojo, ed il belo – se così so può dire – è che
non esiste un maestro di riferimento, giapponese o meno
che sia. So che una o due volte l’anno arrivano alcuni
maestri giapponesi, verso uno dei quali mi sembra di
aver compreso ci sia una specie di profondo rispetto,
tuttavia non esiste quella figura veneranda come nel
-144-
karate, nella fattispecie interpretato dal maestro
Shirai. Ci sono grandi possibilità di sviluppo e spero
nel contempo di inserirmi all’interno del gruppo che
dirige l’associazione. Ecco, forse è proprio questo ciò
che mi mancava, l’idea di appartenete attivamente ad un
gruppo, e non solo quella di vacca da mungere. Ma questo
non è tutto. Ora voglio dire due cose sullo zen ed il
kendo, che tra l’altro è anche il titolo che ho dato a
queste note.
Precedentemente ho detto che ho trovato la
possibilità di armonia tra il karate e lo zen. In
realtà, se mi devo attenere all’insegnamento del maestro
Ryusui, è profondamente sbagliato parlare di zen e… Lo
zen è religione, è il Dharma del Buddha, e come tale
deve proseguire solitario lunga la strada che porta
all’illuminazione. La questione che mi conduce a
ritenere importante accostare lo zen ad un’arte marziale
è il samadhi (zazen, per intenderci). Il samadhi
assoluto è sperimentabile solo in zazen, tuttavia,
quando ci si alza, si può portare nella vita quotidiana
quello che si chiama samadhi positivo. Come una pianta
dall’intenso profumo che ci circonda mentre siamo
seduti, i suoi fiori ci possono accompagnare
all’occhiello; così possiamo portare questo samadhi
positivo in altre attività, e di più rinforzarlo. Il
kendo può fare questo, è impregnato della filosofia zen,
-145-
al contrario dello karate che proviene da tradizioni
completamente differenti. L’atteggiamento, la
concentrazione, lo spirito, la mente, tutto è rivolto
all’annullamento dell’ego, a superare la coscienza
discriminante per entrare in armonia con tutto ciò che
ci circonda. Solo così si può fare un buon kendo. Ma,
naturalmente, non sono ancora così afferrato per
arrivare a trarre simili conclusioni. Rimanderò il tutto
a quando sono almeno un primo dan (ci arriverò? Sì!).
-146-
5. Scienza e nostalgia – 30 gennaio 2000
Spesso capita che si visitino luoghi non tanto per
l’interesse che possiedono (architettonico, culturale,
geografico, etc.) quanto per i ricordi che possono
evocare. Mi sto riferendo al Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano, che nella giornata di ieri ho
visitato con Barbara, dolce metà del mio cielo. In
effetti, non ero lì tanto per sapere qualcosa di
aeronautica o di acustica, quanto per tornare con la
memoria ad anni passati, quando ebbi la fortuna di
visitarlo con mio padre. la nostalgia è un potente
sentimento, tanto forte quanto più i ricordi sono legati
a momenti felici dell’infanzia. Uno di questi momenti fu
certamente quello che mi vide visitatore del Museo della
Scienza e della Tecnica. Così, ieri, ho ripercorso gli
stessi spazi, visto le stesse macchine, schiacciati gli
stessi bottoni; mi sono seduto su un pezzo di
artiglieria pesante (suscitando i rimproveri del
guardiano) dove so mi ero seduto da bimbo; ho passato la
mano sul metallo dei possenti treni a vapore ben sapendo
di averlo fatto anche quel giorno di più di vent’anni
prima. C’erano le stesse biciclette, le stesse
automobili, il seminterrato con la riproduzione di una
vecchia fonderia, tutto di pietra e metallo, ed il
pendolo che con le sue lente ed eterne oscillazioni
-147-
indica il ruotare del nostro pianeta. Dunque un viaggio
nella memoria, nient’altro, consapevole, tuttavia, che
io non ero più lo stesso e che nemmeno l’aria e gli
odori che respiravo erano gli stessi. per più di un
attimo ho considerato che nemmeno quelle stesse macchine
fossero in ultima analisi le stesse, perché
l’osservatore non era più lo stesso e la luce che le
colpiva non era la stessa di quel lontano oramai giorno.
Tornando a casa, ripensando ad ogni attimo
rivissuto, o vissuto ex novo, mi sono accorto di una
fugace intuizione che avrebbe potuto provocare in me il
pianto, essere causa di lacrime. Non si possono vedere due
volte le stesse cose. Ciò che vidi al museo quand’ero bimbo,
se pur a rigor di logica potrei affermare essere le
stesse che ho osservato ieri, se pur in termini di
ovvietà dovrei ammettere che il pezzo di artiglieria su
cui salii a nove anni è lo stesso su cui sono salito
ieri, in un’analisi al di là delle convenzioni mentali
cui siamo abituati risulterebbero essere perse per
sempre nel limbo del tempo passato. Una cosa non lo è di
per sé, a scapito di ciò che la circonda, non possiede
una natura ed un’essenza tale da poter dire: è ciò che è.
Una cosa è in stretto rapporto con l’ambiente nella
quale è inserita, assume significato in relazione con
l’osservatore, e l’elenco dei fattori potrebbe
continuare. Oggi guardo il portacenere che ho davanti
-148-
agli occhi, proprio adesso, ma domani altra luce lo
colpirà e pure io non potrò dire di essere lo stesso
(altro sangue, altro umore, altra aria respirata, molto
cellule saranno morte). Eppure, è nello stesso momento
impossibile negare trattarsi dello stesso portacenere.
Si viene così a costituire una sorta di contraddizione,
una dualità, dunque, che proprio lo zen tende ad
eliminare. Ecco un punto, dunque, su cui meditare a
lungo: come eliminare il paradosso del continuo
mutamento in opposizione alla stabilità? Se tutto è
stabile, nulla muta; se tutto muta, nulla è stabile.
Questo dilemma era conosciuto già ai tempi dei sommi
filosofi greci, e si potrebbe assimilare al paradosso
della freccia di Zenone. E’ ovvio che la freccia
colpisce il traguardo, ma la logica affermerebbe il
contrario. E’ ovvio e logico che il portacenere è lo
stesso, ma lo zen, il Buddha, mi dicono che non può
essere lo stesso.
-149-
6. Piccoli piaceri quotidiani – 6 febbraio 2000
La vita tende inesorabilmente a sfuggirci, ed i
nostri sforzi hanno il sapore della vanità, tesi come
sono a preservare ed accumulare cose e ricordi che alla
fine, immancabilmente, risulteranno per lo più inutili,
pesi dei quali sarebbe stato meglio in precedenza
liberarsi, come le zavorre che impediscono alla
mongolfiera di librarsi libera nei cieli azzurri di
maggio. Mettiamo da parte soldi, vendiamo il nostro
tempo per uno somma di denaro a fine mese, compriamo
nuovi vestiti quando notiamo che la moda è cambiata,
donando alla chiesa quelli vecchi o regalandoli quasi
vantandoci di questo nostro atto di bontà; e poi
l’autoradio, il computer, l’orologio subacqueo da mezzo
milione (magari sappiamo nuotare male o non del tutto),
il fuoristrada (mai guidato su uno sterrato). E così,
presi dalla mania del tanto e del più, ignoriamo sottili
ed assoluti piaceri del vivere quotidiano, dimentichiamo
che la vecchiaia è l’arte del ricordo e quando saremo
canuti e curvi ci risulteranno squallidi i rammenti
degli straordinari e i sabati al lavoro, dell’autoradio
con telecomando e CD, delle serate in discoteca a
spaccarci i timpani; vorremmo avere avuto più momenti
banali e quotidiani, ma ricchi di illuminazione, di
satori. Il sapore del caffè la mattina in inverno prima
-150-
del lavoro, la passeggiata lenta e pacata la domenica
per andare a messa, la birra con gli amici dopo un duro
allenamento; aiutare in cucina a pulire le verdure, in
assoluto silenzio o parlando di cose del tutto inutili;
le passeggiate nei boschi, così tanto per camminare,
fermandosi magari a raccogliere due o tre more; starsene
seduti sulla poltrona preferita a leggere il nostro
autore preferito. Ognuno ha i suoi momenti quotidiani, e
non sarebbe stolto rivalutarli, e cercare in essi la
giusta illuminazione, la nostra vera natura che in
questa società ipertecnologica abbiamo accuratamente
seppellita sotto strati di convenzioni e mode dettate
dalla televisione. Bisogna ricercarli ed immergersi in
essi, senza il timore di sprecare tempo… la nostra vita
si rispecchia in essi. Quando la nostra volontà langue,
quando ci rilassiamo e facciamo o diciamo cose cui non
prestiamo attenzione, allora la nostra vera natura
emerge, non vincolata e controllata. In quel momento di
totale libertà, noi dobbiamo ancor di più annullarci,
come in zazen, per scoprire noi stessi e raggiungere il
satori. Nello zen, può apparire ad un profano che si dia
troppa importanza a mestieri privi di valenza per così
dire “spirituale”, come setacciare la cenere per
togliere i mozziconi, o fare le pulizie nel tempio. Al
contrario, in questi momenti poveri e quotidiani,
possiamo rintracciare la nostra natura, come in zazen,
-151-
perché la nostra mente è concentrata solo sul
setacciare, solo sul pulire lo stipite: pulire,
respirare, null’altro. Non è meraviglioso? Lo stesso
discorso vale per i piccoli piaceri, come camminare nel
parco, le mani in tasca e null’altro per la testa,
beandosi del momento. E’ questo quello che ci manca, la
capacità e la voglia di bearsi del momento che si sta
vivendo, senza essere con la testa altrove, immerso in
pensieri che non hanno nulla a che fare con quel preciso
istante. Se si riuscisse a a raggiungere una simile
concentrazione-deconcentrazione, allora la natura di
buddha che è in noi non ci sarebbe sconosciuta.
-152-
7. Dio esiste? – 6 febbraio 2000
Normalmente non ritengo utile perdere tempo in
problemi pseudofilosofici la cui soluzione è più
effimera e falsa del problema stesso. Lo definisco
pseudofilosofico perché nella sua essenza è falso,
nonché fuorviante e del tutto inutile a risolvere
qualunque rovello e dubbio. Per lo più serve per
convincere noi stessi, e non sarebbe saggio servirci
della soluzione cui siamo giunti, a volte esagerando
nell’autocompiacimento, per cercare di tirare sulla
stessa carretta il nostro prossimo. Comunque, procediamo
e vediamo cosa ne viene fuori.
La domanda è subdola, impossibile negarlo, dato che
ha in sé due enunciazioni che ben dovremmo conoscere e
che invece ci sfuggono. Prima enunciazione: essa spiega
la natura dell’entità che noi sinteticamente definiamo
Dio. Seconda enunciazione: essa spiega il significato
dell’esistenza. Ora, per proferire la domanda “Dio
esiste?” noi dovremmo ben conoscere le due enunciazioni.
Così è? Non lo so per chi mi legge, ma personalmente non
ne ho la benché minima idea; ma posso fare uno sforzo.
Vediamo, con Dio posso identificare un essere (sob! che
cosa è un essere?) che sfugge il tempo e lo spazio pur
identificandosi in essi (pertanto è presente in ogni
luogo ed ogni tempo – naturalmente a patto che io sappia
-153-
ben definire tempo e spazio!). Vorrei andare oltre,
parlando di onnipotenza, ma è conveniente fermarsi e
cercare di dare un significato a spazio e tempo e al
termine – molto usato e poco compreso – “essere”. Che
cos’è un essere? Questa è una domanda veramente
fenomenale. Cosa vuole dire un essere, e, ancora più
intrigante, cosa vuole dire essere un essere e sentirsi
un essere?
Bene, abbiamo capito che prima bisogna dare valore
ai termini di base, poi, illuminati da tale sapienza,
arrivare al grande dilemma di Dio. Concentriamoci: Che
cosa è un essere? Prima, ovviamente, bisogna avere ben
stretti in mano i fondamenti del linguaggio (nella
fattispecie, quello italiano) per cui è lecito chiedersi
che cosa si intenda per “cosa”. Non domandiamo “Che
tempo è un essere” o “Che spazio è un essere” o “Che
sentimento è un essere”, bensì “Che cosa è un essere”.
Il problema è che ognuno di noi intende “cosa” in una
sua maniera particolare, come è giusto che sia, senza
bisogno di affidarsi al vocabolario, così come ad esso
non ci affidiamo per trovare risposta alla grande
domanda: Chi è Dio (posto che esista). Conseguentemente
tutto il percorso risulterebbe inquinato di
soggettività, e apparirebbe un comportamento ingenuo e
ridico quello di manifestare la mia soggettività
-154-
intendendola come una delle possibili risposte al
dilemma su Dio.
Posto quanto sopra, una mia soluzione la voglio lo
stesso dare, ché sono vanaglorioso. Che Dio esista o non
esista, non ha assolutamente nessuna importanza, perché
non sposterebbe di una virgola l’intera storia della
civiltà umana e di questo pianeta. Un conto è sapere di
Dio, un conto è credere di sapere di Dio. Bisogna
spostare di un livello tutto il discorso.
Sinteticamente: l’esistenza o meno di Dio non è
congiunta con la credenza o meno in lui. Le due cose non
vanno di pari passo, non sono in comunicazione; e
comunque, qualunque sia la nostra fede, o certezza che
dir si voglia, sarà sempre lontanissima della Verità
(posto che esista).
-155-
8. Hemingway – 7 febbraio 2000
Ci sono scrittori che hanno fatto della propria arte
un tutt’uno con la vita vissuta, tanto che se ne fatica
a trovarvi un distinguo; e farlo forse è un male. Ne
conosco pochissimi, e se dovessi fare un nome per
portarlo come esempio, credo che Hemingway sarebbe il
primo ad essere proferito. Hemingway, il grande
scrittore di questo secolo che ha saputo reinvenare il
romanzo. Proprio in questi giorni sto leggendo Isole nella
corrente, il romanzo postumo, in verità tre episodi
stretti attorno alla figura di un uomo che, come tutti i
protagonisti del grande scrittore, è un fallito e come
tale assolutamente un vero uomo. E su questo aspetto
della narrativa di hemingway mi vorrei soffermarvi.
Tutti i protagonisti di Hemingway, per quanto
apparentemente diversi, nel fisico, nel lavoro, nelle
amicizie, nelle morti, sono la manifestazione di uno
stesso individuo, che è l’ombra di Hemingway. Egli si
racconta di volta in volta, attraverso dialoghi,
scazzottature, battute di caccia, lunghe giornate di
pesca, agguati al nemico, episodi di battaglia, sbronze
colossali e amari – sempre amari – ricordi di una vita
vissuta e persa. Sembra quasi che Hemingway ci voglia
ricordare che nella vita si è sempre dei perdenti, che
ciò che ci rimane è un pugno di ricordi e la
-156-
consapevolezza che il domani sarà più amaro dello ieri.
Ma l’idea di fallito di Hemingway è sfuggente e riguarda
uomini e donna che apparentemente sono di successo, come
il pittore Hudson, mentre la loro esistenza si stempera
piano piano lungo continue sconfitte sentimentali,
perdite di cari ed amori. Quello che dobbiamo chiederci
è: perché Hemingway fu quello che fu, cosa lo portò al
suicidio, cosa lo indusse a ritenere la vita ed il mondo
qualcosa di amaro ed al contempo bellissimo, come un
improbabile e stupefacente fiore che nel momento di
essere toccato si sbriciola.
Il percorso, Hemingway lo dipana nei suoi libri,
pagina dopo pagina e tocca a noi riuscire a
ricostruirlo, per infine comporre il puzzle della sua
anima. Egli giunse all’inevitabile conclusione che la
vita non si può afferrare, ma tutt’al più è lei che ti
afferra e ti scuote, e che non si può usare, ma è lei
che ti usa. La fine è sempre ed una sola: la morte, ma
non di vecchiaia, bensì durante un’azione in cui si
crede e nella quale si è finiti per fuggire o
dimenticare per mancanza di altri scopi. Hudson non è un
patriota, non caccia il sommergibile tedesco per amor
del suo paese. Il suo scopo è più grandioso, titanico,
l’unico vero motivo che ognuno dovrebbe avere per fare
le cose: il senso della sfida, il pericolo ed il
coraggio di sfidare, il pesce spada, il leone, il
-157-
sommergibile tedesco, il fucile del nemico, l’immenso
mare, la vita stessa, la morte, che alla fine vincerà,
sempre, ovunque, comunque. Attenzione! Non siamo davanti
ad una visione pessimistica della vita, al contrario.
Hemingway amava la vita, amava il mondo ed i suoi
personaggi, i suoi meravigliosi e perdenti protagonisti
lo dimostrano: essi lottano con estremo amore per le
cause giuste che nulla hanno a che fare con loro se
stessi… ed è per questo che muoiono.
Ultimo, ma non ultimo, Hemingway, per quanto se ne
dica, sapeva scrivere. Se qualcuno volesse mai iniziare
la carriera dello scrittore – o perlomeno provare – gli
converrebbe leggere il grande vecchio.
-158-
9. Mike Oldfield&Kendo – 8 febbraio 2000
Naturalmente è sempre difficile riuscire ad essere
imparziali. I nostri giudizi invariabilmente sono emessi
su parametri personali, e non sempre sono modificabili o
assimilabili da altri. E questo si evidenzia ancor di
più quando l’oggetto della passione – dell’amore dovrei
dire – è insolito, o perlomeno poco comune. E’ bello,
bellissimo amare qualcosa che pochi conoscono, studiarla
e conoscerla a fondo, suscitando sempre la sorpresa se
non l’indifferenza nel prossimo. Ah, è meraviglioso ed
io godo di ciò, perché mi fa capire come spesso siamo
modellati dalle grandi correnti imposte dalla società.
Quando la cosa è semplice, di facile accesso,
immediatamente consumabile…bhe, state certi che sarà
appannaggio della massa; è sempre stato così e lo sarà
sempre. Al contrario, quando l’oggetto dei desideri,
dell’amore infrenabile, della più cieca passione è così
singolare, strano, apparentemente incomprensibile,
alieno, brutto, inutile… allora sono pochi i suoi
estimatori, una vera élite.
Così accade per il kendo, praticato da un migliaio
di persone in tutta Italia; così accade per
l’incommensurabile Oldfield, genio musicale, che forse
vanta maggiori estimatori della nobile arte marziale
giapponese. Il Kendo e la musica di Oldfield non hanno
-159-
nulla in comune, se non il fatto che li amo e che sono
due meraviglie che il mondo ha saputo offrirmi. Io credo
che vale la pena di combattere e vivere per loro, sì,
vale la pena. Perché ho la certezza che siano dei fiori
inestimabili, dei gioielli della nostra cultura e
sarebbe veramente sciocco perderli, veramente sciocco.
Differente è l’amore per la mia Barbara ed a scanso di
equivoci mi conviene prossimamente spendere tempo ed
elettricità per chiarire il tutto.
Molto bene, questa è una nota breve, dato che spesso
sulle cose più belle faccio fatica ad esprimermi. Credo
che il miglior modo di dir le cose sia non dirle
proprio. Al contrario, limitarsi ad agire, con il corpo
intero muoversi, come nel kendo, per manifestare la
propria vera natura e raggiungere il Dharma. Certo,
perché anche in Oldfield è presente il Dharma,
altrimenti perché l’universo ha sprecato tanto tempo e
fatica a diventare quello che è? Le due cose sono in
contrasto? Non credo proprio, il percorso che le lega
magari è elaborato, e con un poco do pazienza lo
dipaneremo.
-160-
10. L’albero – 21 febbraio 2000
Cosa vuole dire disintegrare una vita? Innanzi
tutto, vuole dire sapere cosa è una vita e dunque avere
bene saldo il concetto di vita, e non è una cosa facile.
se qualcuno dovesse domandarci cosa è la vita, non credo
riusciremmo a trovare così su due piedi una risposta
soddisfacente. Tutto questo per arrivare a confessare il
mio senso di colpa per avere consentito l’abbattimento
di un pino trentennale, una magnifica pianta di quasi
dieci metri… anzi un magnifico essere vivente. Ma per
continuare devo per forza di cosa cercare di esporre la
mia idea di vita, che cosa è, come si sviluppa e perché.
Cosa non facile, dunque e che credo non possa nemmeno
essere spiegata. Questa sapienza non risponde ai rigidi
canoni della scienza, bensì alla sensibilità dell’arte;
non è una fredda tabella matematica, piuttosto un
quadro, od una sinfonia, dove le pennellate e le note
vengono accostate e sovrapposto in armonia con l’indole
dello spirito.
La vita? tutto è vita, anche la più misera
particella di vita. Semplicemente, bisogna considerare
il tutto su piani differenti, definibili livelli di
coscienza. la vita è la coscienza nel suo manifestarsi,
partendo da uno stato di assoluto coma ed inerzia (la
pietra) fino a quello di coscienza infinita (Dio?).
-161-
Ecco, ho gettato in questo momento un’idea,
un’intuizione che è uno spunto sul quale lavorare in
futuro, il tutto nato dalla riflessione
sull’abbattimento del grande pino davanti a casa. Sì,
perché si è trattato di un assassinio, della distruzione
di una vita. Bisogna partire dal concetto che una pianta
è un essere vivente a tutti gli effetti e come tale
andrebbe rispettato. Ciò non vuol dire non cibarsi di
verdure e frutta, attenzione, vuole dire non
distruggere. la differenza è rilevante.
Nelle popolazioni indigene, nella cultura tribale
dalla civiltà occidentale considerata selvaggia, anche
la preda nella caccia è sacra ed in alcune culture si
chiede ad essa perdono e la si rispetta perché è fonte
di vita. L’animale non viene allevato, la sua indole
selvatica non è smorzata, i suoi istinti inibiti.
L’animale vive nel suo contesto, come l’indigeno, e
muore per nutrire un altro essere vivente, quasi come se
donasse se stesso. La stessa sacralità noi dovremmo
inserirla nella nostra vita quotidiana, nel curare anche
le piantine dell’orto e del giardino. Sono esseri
viventi che meritano il nostro rispetto e che con noi
condividono questo meraviglioso pianeta.
Per tornare alla pianta, non ho molto da aggiungere.
Vorrei solo esprimere il mio dispiacere per avere
lasciato commettere questo crimine ed ora mi domando che
-162-
fine abbia fatto lo “spirito” del pino. Essendo un
essere vivente, produce karma e di conseguenza
quell’energia deve essere andata da qualche parte: nel
prato, nelle mani del giardiniere, nella mia mente che
produce il sentimento di dispiacere, in chi guardava
dalla finestra di casa sua. ho pensato al significato
della parola “spirito” , alla fede ed al rigore
scientifico e mi sono accorto, in finale di esame, che
ancora adesso, malgrado il mio zazen e letture dei sutra
(che dovrei riprendere con maggiore ardore, studiandoli
attentamente) non sono ancora giunto ad una conclusione
definitiva. il dubbio mi tormenta l’anima, ed il dubbio
di avere permesso l’assassinio di un essere vivente è
ancora più forte.
-163-
11. I Piani di esistenza – 12 marzo 2000
In parole povere, tutto è vita, esistenza, essa è
come un’energia che pulsa e vibra in ogni particella di
materia dell’universo; maggiore è la vibrazione, più
complessa è la forma di vita. In base a ciò, ho buttato
giù un diagramma, dividendo le forme esistenziali in
sette piani o livelli. Credo sia possibile organizzare
tutto l’universo in questi sette piani, considerando che
ogni cosa è una forma di vita. Il passo successivo
consta nel ricercare le leggi che governano l’energia
vitale e nel comprenderne appieno la struttura.
L’energia vitale è il wakan tanka (per utilizzare la
mitologia dei nativi americani), altrimenti definibile
come il ki universale. Questa energia, come già dapprima
annunciato, pervade l’intero universo, ogni atomo ed
ogni interstizio tra gli atomi. Naturalmente, la mia è
sole un’intuizione, ma per una volta voglio seguire
questa intuizione fino in fondo e vedere dove mi porta.
In aggiunta, voglio cercare di armonizzarla con il
pensiero buddhista, e credo proprio sia possibile. In
questo caso, il wakan tanka è il Dharma, dunque non solo
energia, ma anche legge e senso delle cose; ma è ancora
presto per arrivare ad una simile conclusione.
-164-
12. Tempo di svolte – 21 marzo 2000
La nostra vita non è una semplice linea dritta che
collega la nascita e la morte, senza interruzioni, senza
curvature, senza sorprese. In parole povere, voglio dire
che mi sta capitando qualcosa di nuovo; dopo quasi
trentacinque anni, mi rendo che conto che provo
l’inguaribile desiderio di cambiare il corso della mia
vita. Nulla che abbia a che vedere con un drastico
ribaltamento di ciò che sono adesso e di ciò che adesso
possiedo; semplicemente la necessità – che è più che
desiderio – di introdurre delle novità.
Perché tutto questo? E perché proprio adesso e non
l’anno scorso, o cinque anni fa? Se devo analizzare la
situazione, allora mi tocca guardarmi alle spalle ed
iniziare da quando sono entrato per la prima volta nel
tempio del Maestro Ryusui, se non andando ancora più
indietro, ai tempi di frequentazione del gruppo Bahai di
Milano. Sarebbe da capire se esiste un filo conduttore o
se sono cose che capitano a caso, sotto lo stimolo
improvviso di desideri infrenabili. Forse dovrei
riguardare tutta la mia vita sotto una nuova ottica, e
già so che nel farlo potrei accorgermi che ciò che vedo
non sarà di mio gradimento. Di conseguenza, per evitare
il trauma di una simile ricerca – che presto o tardi
dovrò affrontare – sarebbe saggio cominciare da adesso,
-165-
dal desiderio di svolta insortami da pochi giorni,
proseguendo poi a ritroso nel tempo, fino a quando i
miei ricordi sapranno condurmi. Sarà una ricerca della
mia vera essenza, del mio sé, della mia natura
inequivocabile, unica, irriproducibile, qualcosa di
meraviglioso, come una nota melodiosa che vibra
nell’universo. Potrei incontrare difficoltà, se non
addirittura dei lati della mia personalità poco
piacevoli (e so che ci sono).
A metà aprile parteciperò ad un seminario di Reiki,
per l’apertura dei canali energetici. Nulla che abbia a
che vedere con la new age, dato che questa filosofia è
nata all’inizio del secolo in Giappone. Succesivamente,
se ne avrò la costanza, mi voglio dedicare allo shiatsu
e nel contempo continuare il mio studio del Dharma del
Buddha (lo zen, si intende), per conto mio, od in un
tempio qui a Milano. Certamente la rinuncia al tempio
del Maestro Ryusui ha pesato molto e mi ha lasciato
amareggiato, e spesso mi domando se la mia scelta sia
stata quella giusta: kendo o Buddha? In realtà non ho
rinunciato al Buddha ed al suo insegnamento, ma solo ad
un tempio la cui ammissione era vincolata al pagamento
di una retta troppo salata per i miei fondi.
Adesso basta, questa sera faccio fatica a scrivere,
forse per via del televisore acceso.
-166-
13. Reiki – 25 aprile 2000
Dall’inizio dell’anno ho notato un calo di stesure
di queste note, e ripongo la causa nell’abbandono del
tempio del maestro Ryusui. Il maestro era un continuo
stimolo ad analizzare la realtà ed a mettere sempre in
discussione le mie azioni, le mie parole ed il mio
pensiero. I suoi discorsi – lezioni, sermoni – erano
mere riletture della società in cui viviamo, salaci e
dure critiche a quelle piccole gesta e tradizioni ed
usanze e modi di dire che siamo abituati a seguire e che
sono invero motivo di perdizione (intesa questa come
allontanamento dalla verità del Buddha, il Dharma,
perfettamente comprensibile anche da chi non ha fatto
dell’insegnamento dell’Illuminato la sua via).
Ora sono solo, spesso mi accorgo di cedere alle
lusinghe della mondanità, ancora più spesso – e per
questo ringrazio tutti i Buddha, i Bodhisattva ed i
Patriarchi – sono conscio di come tutti noi viviamo in
una società basata su ipocrisie e vuote usanze. Io
stesso sono il primo a seguire queste leggi mondane, per
questo la mia consapevolezza è così lucida. Ciò che mi
manca è la forza di compiere il passo che mi separi
dalla mondanità. Quando sarò capace di compierlo?
-167-
Nel frattempo cercherò di dedicarmi con maggiore
impegno a questo diario, annotando qualunque cosa mi
passi per la mente.
E per non staccare, eccomi a dire quattro parole sul
seminario di Reiki (o reiki, con la prima lettera
minuscola, a seconda dell’importanza che gli si vuole
dare). E’ stata un’esperienza singolare, e credo di non
averla ancora metabolizzata, per via della mia mentalità
scettica e scientifica che è all’opera su uno o due
fatti. innanzi tutto, premetto che è stata dura, non per
il seminario in sé, quasi una cosa banale, quanto per
l’atteggiamento della mia Barbara, che non ha gradito –
giustamente o meno, non è mia competenza opinare sui
suoi metri di giudizio – gli orari piuttosto lunghi e la
mia assenza da casa per tutto il fine settimana.
Continuando, posso dire che si è trattato di un
seminario che avrebbe potuto benissimo essere contenuto
in una giornata, ci sono stati troppo tempi morti ed un
finale “angelico” che a mio parere nulla aveva a che
fare con il reiki. Ed ora passiamo ad una veloce
descrizione, in modo che tu che mi leggi ti possa fare
un’idea di che cosa sia _ o cosa si pensa che sia – il
reiki. (Un’altra premessa: intorno a questo reiki è
sorto un giro d’affari non indifferente, con la
conseguenza che tutto il movimento è inquinato dall’idea
di fare soldi).
-168-
Bene, tutto è iniziato con una informale
presentazione a cui è seguito un piccolo rituale quanto
mai ridicolo e piuttosto americano, durante il quale
ognuno di noi ha scritto il proprio nome su
un’etichetta, appiccicandola poi sul petto all’altezza
del cuore. Dato che eravamo in otto, non mi sembrava il
caso, anche perché ritengo ogni occasione ottima per
allenare la memoria e l’intelligenza.
Ci siamo seduti ad un tavolo ed il Master (così si
chiama nel reiki colui che può aprire il canali) ha
spiegato brevemente i chakra ed il reiki, due argomenti
che richiedevano più tempo e che io farò argomento
principale in una successiva nota. Adesso mi preme dare
una panoramica del seminario.
Finita la breve spiegazione, nella quale il Master
non ha ritenuto opportuno soffermarsi a parlare delle
origini del movimento reiki (comunque mi sono già
informato in proposito, scoprendo come al solito tante
belle incongruenze), abbiamo iniziato a simulare dei
trattamenti reiki fatti su un’altra persona, sia quello
completo che quello veloce. Successivamente il Master ci
ha donato una serie di piccoli cristalli (sette, quanti
i chakra) con i quali effettuare delle terapie (ne
abbiamo vista una, imparando velocemente le giuste
posizioni).
-169-
Soltanto nel tardo pomeriggio si è giunti al momento
della prima iniziazione. Nel reiki ci sono tre livelli,
l’ultimo dei quali è quello del Master, mentre nel primo
vengono fornite le chiavi per trasmettere il reiki
tramite le imposizioni delle mani. Le quattro
iniziazioni del primo livello corrispondono all’apertura
dei chakra delle mani, del settimo chakra e del chakra
del cuore, più un’iniziazione di carattere spirituale.
Il Master è stato parco di parole, per questo credo che
mi rivolgerò ad altri per avere maggiori informazioni.
Durante la prima iniziazione ho sperimentato un
fatto inconsueto, che ancora adesso sto cercando di
metabolizzare e razionalizzare (e non so fino a che
punto ciò sia giusto ed adeguato alla situazione).
Cercherò di spiegarlo brevemente. Un calore piacevole mi
ha pervaso il capo ed il petto ed una gioia
incontenibile ha preso possesso di me, tanto che mi sono
messo a ridere stupidamente. Non so dare spiegazioni, se
non avanzare l’ipotesi – timidamente – di
autosuggestione, anche se credo che convincersi di
sentire caldo (molto piacevole e confortante, lo ripeto)
e provare una gioia appagante e senza motivi siano
accadimenti troppo lontani dall’autosuggestione (non
avevo letto materiale informativo, nessuno me ne aveva
fatto cenno, non mi aspettavo nulla di tutto ciò… e
conservavo un’ombra – spessa – di scetticismo – che non
-170-
mi ha ancora abbandonato). Da giorni rifletto e medito,
ma non sono ancora giunto ad una conclusione che non sia
quella che mi suggerisce di non fermare la mente su quei
fatti, ma di continuare zazen e reiki, proseguire nel
mio personale percorso di ricerca... o meglio, formulare
definitivamente un personale percorso di ricerca.
Comunque, qualcosa è accaduto, ho compiuto un passo, o
sono pronto a compierlo. ma prima di avventarmi su
simili considerazioni, voglio continuare nel racconto,
mancando veramente poco al suo completamento.
Mentre ero in meditazione, dopo l’iniziazione – la
prima – una luce improvvisa è apparsa nel mio orizzonte
visivo (avevo gli occhi chiusi) ed un calore è stato
percepito dalla pelle nella zona del viso corrispettiva.
Non so cosa sia successo. per un attimo ho pensato che
fosse il sole (avevo le finestre sulla mia destra) ma
pioveva (almeno, prima di iniziare l’iniziazione) e le
finestre del locale sono a livello della strada, la via
è stretta ed era quasi sera. Che cosa è successo? Anche
in questo caso, meglio non pensarci su.
Che cosa altro dire, a parte la diarrea che mi ha
colto domenica (il secondo giorno) e la frequenza più
alta del solito di defecamento da una decina di giorni a
questa parte? Leggendo, ho scoperto che si tratta di un
periodo di autopurificazione… e se si tratta solamente
di un po’ di freddo preso al pancino? Ecco, la mia
-171-
mentalità scientifica all’opera. Basta, non voglio più
trarre conclusioni o cercare risposte, solo prendere per
accaduto ciò che è accaduto e cercare di migliorare la
mia vita.
Un’altra cosa. mi sta passando la voglia di mangiare
carne. Un altro effetto, dunque? Questo, per di più,
sarà difficile da far digerire alla mia Barbara!
Nel punto successivo ci sono dei commenti a “frasi
zen”, a coronamento della lettera daleth. Sono pronto a
passare ad he, in costante avvicinamento al sentiero che
mi condurrà alla sephira successiva.
-172-
14. Pensieri zen – 25 aprile 2000
I
Nascere è proprio come andare in barca. issate le
vele e muovete i remi. Sebbene siate voi a remare, la
barca vi ospita, e senza di essa nessuno potrebbe
galleggiare. ma voi procedete, ed il vostro navigare
conferisce alla barca la sua essenza. riflettete su
questo fatto.
In quel preciso istante non esiste nient’altro che il mondo della barca:
il cielo, l’acqua e la sponda fanno parte del mondo della barca, che non è
uguale ad un mondo che non sia quello della barca.
Quando navigate, l’insieme formato dal vostro corpo,
dalla vostra mente e da quello che vi circonda
costituisce l’intera attività della barca. Così la
nascita non è nient’altro che voi e voi non siete
nient’altro che la nascita.
Dogen Zenji
Commentare un pensiero di Dogen Zenji è un’impresa
che esula le competenze e la maturità di un allievo
-173-
quale sono io. meno di un allievo, dato che non ho
neppure avuto i tre rifugi; ma non importa. Commentare
il Patriarca dello zen soto vuole dire mettere da parte
il nostro sistema occidentale di critica e giudizio,
così basato sulla logica e sull’esatta scansione
temporale, per lasciare il posto non all’intuizione od
alla sensibilità, bensì alla volontà di unire la teoria
alla pratica, in una pasta omogenea che è la nostra
vita. Dogen Zenji parla sempre della nostra vita, non vi
è nulla di astratto o teorico, tutto ha una pura valenza
concreta, umana, carnale, oserei dire esistenziale.
In questo bellissimo pezzo, il Patriarca puntualizza
la limpida verità che nascita e vita e noi, in quanto
esseri viventi, siamo la stessa identica cosa; e giunge
a questa conclusione attraverso varie proposizioni
geniali nella loro semplicità. Nascere - – non vivere –
è come andare in barca, ci si siede, si impugnano i remi
e si voga verso l’immensità del mare. Questa nostra
azione conferisce l’essenza ala barca, perché suo scopo
è quello di consentire la navigazione. Il Patriarca
consiglia di riflettere su questo fatto. Riprendiamolo,
allora: ...il vostro navigare conferisce alla barca la sua essenza. Io
nasco, ovverosia entro nella barca e la spingo
all’esterno, intendendo con ciò che conferisco senso
alla mia nascita. E dunque, la nascita sono io ed io
sono la nascita.
-174-
Ancora prima di arrivare ad affermare esplicitamente
quanto appena detto, la prima proposizione del Patriarca
la suggerisce.
Quello che viene dopo è ancora più straordinario.
Barca, io, il mondo che mi circonda sono la stessa cosa,
e non solo un insieme di entità separate che
interagiscono. Bisogna liberarsi da una certa mentalità
dualistica e cercare di comprendere che il nostro sé non
è inscritto nell’individuo, ma corrisponde al mondo
intero di cui si fa esperienza. Esperienza è sé.
La vita è nascere e spingere la barca e remare e
comprendere che mare e cielo e terra e barca sono
manifestazioni di uno stesso organismo; comprendere che
nascere è vivere e vivere è nascere. Allora apparirà
chiaro che la nascita non è nient’altro che voi e voi non siete nient’altro
che la nascita.
-175-
II
Molto tempo fa Cartesio disse: “penso, dunque sono”.
Qui comincia la filosofia. ma se non state pensando, che
cosa succede? Qui comincia la pratica zen.
Maestro zen Seung Sahn
Lo zen non è una filosofia, a scapito di un pessimo
pregiudizio che sembra essersi così ben solidificato
nella mentalità degli occidentali. Spesso mi domando
come e quando un individuo viene a contatto con questa
pseudoverità e perché mai non si sforza di indagare e di
capire esattamente il senso delle cose che sente. la
nostra conoscenza – anche quella scolastica, si badi
bene – è basata essenzialmente sul sentito dire.
pazienza, ma qui sono come bastione a difesa dello zen e
della sua essenza prettamente religiosa.
La filosofia è un bene prezioso ed un tesoro
impareggiabile, ma non è religione. Almeno nel senso
occidentale dei due termini… ed è bene mantenere questa
accezione. Ora non voglio soffermarmi a parlare di cosa
sia o non sia la religione; mi basta porre l’attenzione
sulla proposizione del Maestro Seung Sahn.
-176-
Lo zen è pratica, zazen, vivere quotidianamente il
samadhi con il corpo intero, è non pensiero e non non-
pensiero. Il pensiero e la consapevolezza di pensare,
ovvero l’uso delle facoltà mentali e la capacita di
rendersi conto dell’uso e delle potenzialità di queste
facoltà, non determina l’individuo, non è autocoscienza.
In zazen, nel samadhi assoluto, non si pensa né si non-
pensa; semplicemente si sta seduti, null’altro. Eppure
la consapevolezza di se stessi è assoluta, pervade ogni
cellula e va oltre. In questo stato, la coscienza è
pulita, la menta libera, si è in comunione con il tempo
e lo spazio, di conseguenza con l’universo intero.
Quando si è in zazen, si vive intensamente l’attimo
presente, che è tutto il nostro universo. Allora, quel
singolo istante è identico ad un singolo istante
dell’eternità: per questo possiamo dire che il nostro
essere è eterno.
Quando si è in zazen, immobili, si occupa la parte
più piccola dello spazio, e per questo possiamo dire che
il nostro essere è infinito.
Il nostro essere è tempo, è spazio, è l’universo. E’
tutti gli esseri viventi, perché al pari di noi tutti
gli esseri viventi condividono spazio e tempo e dunque
ci condividono, e noi condividiamo noi.
E’ possibile non pensare? Il pensiero è una delle
attività della mente. Non bisogna cadere nella falsa
-177-
convinzione che il pensiero è una cattiva
predisposizione e che lo zen sia un mezzo per eliminare
il pensiero. Se non ci fosse la facoltà di pensare, i
grandi patriarchi non ci avrebbero lasciato i loro
scritti. Neppure il Buddha. Il pensiero è un gioiello,
ma in zazen non serve, così come non serve il non
pensiero. Bisogna sgombrare la mente, la coscienza, o
per meglio dire, bisogna evitare di utilizzarle... anzi,
non bisogna dar loro retta; allora si staccheranno da
noi come foglie secche. Questa non è filosofia, è zen in
pratica. E’ zazen.
-178-
III
“Che cosa andate a fare laggiù?”
“Lo saprò quando ci sarò arrivato.”
André Gide
Lo zen è dappertutto, e questa citazione ne è un
esempio inequivocabile. Che cosa è lo zen? Un grande
casino, verrebbe voglia di rispondere; oppure: non ne ho
la benché minima idea. Ricordo il monaco Corrado,
allievo del Maestro Ryusui, quando mi disse che dopo
trent’anni non aveva ancora capito nulla. Bellissimo!
“Che cosa andate a fare laggiù?” “Lo saprò quando ci
sarò arrivato.” Bellissimo! Perché fare zazen? Potremo
rispondere solo quando ci arriveremo. E quando ci
arriveremo non sarà più necessaria la risposta: saremo
lo zen, saremo Buddha, ed il Buddha non va né viene, né
cresce e né decresce.
Dobbiamo andare allo zen senza cercare qualcosa, uno
scopo superiore, una meta (l’illuminazione, od il
nirvana). Dobbiamo andarci con una domanda implicita:
“Che cosa vado a fare laggiù?” E la risposta ci deve
pervadere e spingere: “Lo saprò quando ci sarò
arrivato.”
-179-
Forse non ci arriveremo mai, o quando ci arriveremo
non ce ne accorgeremo; o forse ci siamo già.
L’importante non è pensare di ottenere qualcosa di
particolare. Shikantaza, solo stare seduti.
IV
Detesto sentirmi a casa
quando sono all’estero.
G.B. Show
Tanto vale non viaggiare, se si vuole ritrovare
ovunque la stessa atmosfera e le stesse abitudini di
casa nostra. E’ il turismo di massa, dove l’individuo si
sposta per andare in un posto identico. Dove, allora, la
sorpresa? lo straniamento?
Andare al di fuori del proprio paese è un desiderio
che nasce dalla spinta interiore di conoscere altre
tradizioni, altri costumi ed altre culture. nagare tutto
ciò per rifugiarsi in clonazioni dei nostri habitat è un
atteggiamento di totale chiusura mentale.
-180-
GIMEL
12 ottobre 1999
1.
Precedentemente ho parlato di senso delle cose, nella
fattispecie riferito alle parole, alle azioni ed ai
pensieri. Proprio da queste tre manifestazioni
dell’essere, che sono le uniche in ultima analisi,
voglio iniziare la riflessione che mi ha spinto ad
iniziare questa nuova lettera. Precedentemente ho anche
scritto del mio sanzen, che proprio sul senso delle
parole verteva, arrivando personalmente alla conclusione
(nella mia riflessione scritta, non in sanzen, dove il
maestro mi ha lasciato una domanda aperta ed un compito
non indifferente: quello di costruire ipotesi per poi
disfarle – dato che, vista la ricerca, è impossibile
trovare subito la verità) di come sia necessario
accostare, o meglio armonizzare la ricerca del senso
delle parole a quella del senso delle azioni e dei
pensieri. Ora voglio soffermarmi sul significato del
termine senso: cosa è il senso? Posso dire quello che
intuisco, ovverosia che si tratta del Dharma. Il Dharma
-181-
va individuato nel nostro esprimere noi stessi, e dato
che il mondo è la rappresentazione che di esso ce ne
facciamo, appunto attraverso pensieri, parole ed azioni,
ne conviene che qui si sta parlando del Dharma come il
senso delle cose. Come trovare questo Dharma, se non
attraverso le tre manifestazioni? Il maestro di Dogen
Zenji, Nyozai, disse di lasciare cadere corpo e mente,
ma bisogna notare che corpo e mente sono parole, azioni
e pensieri, che lasciati cadere rivelano il Dharma. Ma è
pure vero che zazen, lo strumento principe per rilevare
il Dharma, è azione, perché è fare qualcosa, stare
seduti, quieti ed immobili, è anche pensiero, perché
essi non si sopprimono né si incrementano e dunque il
loro scorrere nella mente non è annullato, ed è parola,
non solo durante il salmodiare dei sutra e dei precetti,
ma per via che gli stessi pensieri, quando non
immaginativi, sono parole silenziose. Allora, si arriva
ad una contraddizione, che sarebbe non altro che la mia
incapacità di andare oltre questo gradino.
1. Il senso delle azioni, dei pensieri e delle parole
è il Dharma
2. Lasciando cadere corpo e mente si afferra il
Dharma, si è il Dharma
3. Zazen è lo strumento per arrivare al Dharma. Zazen
è il Dharma
4. Zazen è azione, pensieri e parole.
-182-
5 Con azioni, pensieri e parole si afferra il Dharma,
si è il Dharma.
E’ un cerchio, un serpente che si morde la coda, dove
non parto da nessuna parte per non arrivare in nessun
luogo. Posso dire, un po’ amareggiato, che questa mia
prima ipotesi è incompleta… monca. In verità, mi sono
lanciato in disgressioni partendo da basi non studiate,
non costruite con il ragionamento. Esponendo l’ipotesi,
mi sono basato su assiomi, che adesso devo riprendere
ed analizzare per capire quale intuizione mi abbia
portato a loro.
Pensieri, parole, azioni. Ancora prima delle Quattro
Eccellenti Affermazioni, sono i cardini del nostro
essere, perché ci esprimono e rappresentano gli
strumenti di azione sulla realtà che percepiamo da una
parte e di percezione della stessa realtà dall’altra.
Percepire attraverso i sensi, sia passivamente che
attivamente, è un’azione, la cui conseguenza può essere
un pensiero, od una parola di commento. Attraverso i
sensi (azione) percepiamo la realtà e di essa ce ne
facciamo un’idea. Ma l’azione è anche agire attivamente,
oserei dire aggressivamente (ma non con uso di violenza)
onde ottenere che nella realtà che percepiamo noi ci si
-183-
muova, o che questa realtà la si modifichi. Questa è
l’azione
Azione. Percepire attraverso i sensi. Utilizzare
attivamente i sensi. Agire sulla realtà attraverso il
nostro corpo fisico. Muoversi nella realtà con il nostro
corpo fisico. L’azione sono le nostre opere, ciò che
creiamo, ciò che facciamo, che modifichiamo: il lavoro,
la creazione artistica (ma anche artigianale), l’amore
fisico, lo sport, l’arte marziale. Tutto ciò che implica
manifestare se stessi attraverso il proprio corpo fisico
o tramite un manufatto creato con il proprio corpo
fisico.
Parole. Fondamentalmente, parlare è un’azione, ma qui
si intende come la manifestazione del pensiero (anche
l’azione lo è), o meglio il proferir parola inteso come
rapporto con una o più persone. Parlando si comunica,
nel modo migliore, il proprio essere all’esterno, si
esprimono opinioni, si fanno complimento o rimproveri…
insomma, si interagisce e si agisce sulla realtà,
creando effetti. Con la parola si comunica un’idea,
un’opinione, una filosofia, un insegnamento. Il Buddha,
Il Cristo, insegnarono con le parole, ammaestrarono
uomini e donne con il dono della favella, con il vibrare
delle corde vocali. La parola è il linguaggio, ed il
linguaggio traduce la percezione della realtà. Per certa
filosofia, la verità è insita nelle proposizioni ed il
-184-
linguaggio non è solo la chiave di lettura della realtà,
ma la realtà stessa. Io non condivido simili posizioni,
ma riconosco nel linguaggio un’importanza fondamentale.
Anche gli animali (in special modo i mammiferi)
possiedono un linguaggio, atto a comunicare stati
d’animo. Ecco, forse questa ultima definizione è forse
la migliore: Il linguaggio comunica stati d’animo. E con stato
d’animo si possono intendere tutte le manifestazioni
possibili del nostro essere.
Pensieri. L’ho messo per ultimo, quando in ultima
analisi andrebbe posto come fondamento. Azioni e parole
nascono sempre da un pensare. Non sempre, ragionandoci
sopra. L'istinto non è un pensiero, eppure da esso
scaturiscono sia azioni che pensieri. Cosa dunque è un
pensiero? E’ l’attività della mente, che lavorando sulle
percezioni elabora idee.
Bene. Noi siamo pensieri parole ed azioni, e ci
presentiamo agli altri in queste tre manifestazioni.
Trovare il senso di esse, vuole dire carpirne il
significato ultimo, e non solo la causa che le ha
generate. Questo in primo luogo. In secondo luogo,
assumendo che le tre manifestazioni rappresentano da una
parte il nostro essere nel mondo ed il nostro essere al
mondo, e dall’altra il mondo al nostro essere (attraverso
le azioni ed i pensieri) ne consegue che ciò che
facciamo, pensiamo e diciamo è rispondente alla mondo, è
-185-
la realtà. Scoprire dunque il senso di pensieri, parole
ed azioni, è trovare il senso delle cose. Ora, cosa può
essere il senso delle cose? Il loro significato, perché
esistono, come esistono, lo scopo del loro esistere? Il
senso delle cose è il Dharma, ma cosa è il Dharma, senza
cadere nel vizioso: Il Dharma è il senso delle cose?
Perché le cose sono quelle che sono, e perché si dice
quello che si dice, ecco cosa è il Dharma.
2.
La storia dell’Italia repubblicana del secondo dopo
guerra è cosa preziosa, tanto che mi rammarico nel
constatare che malamente e poco viene trattata nelle
scuole medie inferiori e superiori. Solitamente bisogna
giungere all’università, nella facoltà apposita, per
inserirsi nel giusto corso di specializzazione e
finalmente indagare su quello che è accaduto a questa
nostra bella (povera) Italia. Il problema sorge quando
si considerano i testi che sono la vera materia di
studio, affermando con ciò che storia avvenuta e storia
scritta (ed analizzata) non sempre è detto che
coincidano. Il libro che si studia non è la realtà
-186-
accaduta, non è quel particolare passato, bensì una sua
interpretazione, per quanto obiettiva ma solamente
un’interpretazione. Precedentemente – giusto appunto nel
punto precedente – dicevo come i tre modi di
manifestarsi corrispondessero alla realtà delle cose, ma
ora ben mi accorgo che non tenevo conto del fattore
interpretazione. La realtà la si interpreta, e dunque la
sua essenza ci sfugge, innegabilmente fino a che agiamo,
pensiamo e parliamo. La realtà – diciamo storica, per
rimanere in tema – è composta da fatti, ovverosia
fenomeni. Anche noi siamo un fenomeno. I fenomeni si
percepiscono attraverso i sensi e si analizzano con la
mente, dando vita a pensieri; ma non è detto che le mie
percezioni, dunque la mia mente, siano quel particolare
fenomeno percepito: è una sua rappresentazione. Fra noi
ed i fenomeni, esiste una rappresentazione – quella,
appunto, dei fenomeni. La storia è composta da fenomeni.
Ora, una storia passata e finita, non può nemmeno essere
più percepita… come dunque rappresentarla? Gli storici,
che si accingono a lavorare di intelletto su accadimenti
storici avvenuti secoli prima della loro nascita,
lavorano, bene che vada, su rappresentazioni di altri,
con la conseguenza che le loro conclusioni sono quanto
mai ipotetiche, per quanto possibilmente verosimili. Se
ne conclude che la materia di studio – nel caso di un
corso di storia – non è un particolare periodo storico,
-187-
per esempio il famoso e non abbastanza conosciuto
sessantotto, bensì il particolare testo scolastico di
riferimento. Si studiano le idee dello studioso, quando
si dovrebbero cercare i resoconti dei nudi fatti,
conoscere il contesto sociale e culturale ed abbozzare
una tesi (che invariabilmente risulterà opinabile).
Tutto questo per sottolineare la mia attuale (proprio
di queste note) propensione a considerare impossibile
uno studio obiettivo della storia. Ed estendendo
l’orizzonte, l’impossibilità di una rappresentazione
della realtà scevra da una qualsiasi interpretazione.
Osservare senza interpretare vuole dire fare in modo che
la coscienza discriminante, che funziona istintivamente,
non entri in gioco, e per non farla entrare in gioco
bisogna evitare di dare importanza ai sensi. Tutto nasce
dai sensi (e non dimentichiamo il sesto, la mente
pensante, la fabbrica di pensieri – i cosiddetti oggetti
mentali), che stimolati dalla realtà esterna, composta
dagli oggetti dei sensi, producono le relative
coscienze.
A riguardo, concludo, s’impone una lunga riflessione.
-188-
3.
Zazen è sinonimo di samadhi, ovverosia di quello stato
del nostro essere in cui la coscienza non discrimina, i
pensieri sorgono e muoiono senza nostro intervento; in
definitiva, l’attimo protratto nel quale sia ha la
possibilità di percepire non attraverso i sei sensi.
Zazen è attività e lavoro fondamentale nel buddhismo
zen, da cui ne consegue che il fiore così ottenuto va
portato con sé nella quotidianità della vita. In zazen
si ottiene, o meglio si è samadhi assoluto, si è
infiniti ed eterni, non perché si viva per sempre e si
permea con il proprio essere tutto lo spazio, bensì
perché quel singolo istante e quel singolo spazio che ci
vedono impegnati in zazen, immersi attivamente nel
samadhi, sono identici con i singoli istanti e spazi
dell’eternità e dell’infinito. Quando non si è in zazen,
quando si vive la quotidianità, tuttavia, non bisogna
pensare che il frutto di zazen non si possa assaporare.
Il samadhi positivo è quel frutto, che dobbiamo portarci
addietro, costantemente, per vivere completamente il
nostro buddhismo. Così facendo, anche la nostra vita di
tutti giorni, che erroneamente considereremo banale ed
inutile, diventa un’occasione per raggiungere il satori.
A fronte di quanto sopra, è indispensabile allineare il
-189-
quotidiano e zazen, o meglio integrare il quotidiano con
zazen. A parole, ma nei fatti, come fare?
La società nella quale vivo, ad una mia prima
considerazione, non permette una vita in armonia con
l’ottuplice sentiero, essendo continuamente le
tentazioni a portata di mano. Nel lavoro, negli svaghi,
ma anche nella vita familiare, le occasione per
lasciarsi andare alla mondanità, per allontanarsi dai
valori e cadere nei vizi, per invaghirsi della
disonestà, del tradimento e del paraculismo ci
circondano, con la conclusione che è molto facile essere
preda di esse. Molto meglio la vita monastica. Ebbene,
Ryusui Roshi non mi ha dato ragione, sottolineando che
non è per colpa mia se non riesco ad alienarmi le
tentazioni, ma per via di una incapacità insita nel mio
essere uomo; incapacità, tra l’altro, che può e deve
essere prima limitata ed infine eliminata. Per giungere
a questo risultato, bisogna iniziare ad integrare nella
quotidianità il piccolo samadhi positivo, molto
lentamente, con grande pazienza, modificando gli
atteggiamenti ed allineando il comportamento a zazen.
Come ebbe modo di dirmi il monaco Philip, bisogna
evitare di atteggiarsi a comportamenti che creino un
intrinseco contrasto con il nostro zazen. Dunque,
iniziare da questo piccolo passo, per costruire piano
piano la mia vita buddhistica. Non solo buddhistica, in
-190-
verità, ma totale, assoluta, la vita che vivo ogni
giorno in ogni istante della mia esistenza.
-191-
4.
La proliferazione dei mezzi di informazione sembra
avere causato nel corso degli anni una quanto mai
allarmante disinformazione, propagandasi questa in ogni
ricettacolo della nostra società. Il fenomeno non sembra
essere solo causato dal mondo della televisione, anche
se lo ritengo il maggiormente responsabile, ma si
trovano fonti di cattiva informazione anche nei libri,
sui giornali, e dunque non sarebbe sbagliato ritenere
che anche internet ne sia invasa. Tuttavia, il mondo
della televisione ne è il maggior colpevole, anche per
il fatto che interi settori della società si affidano ad
esso per manifestare il proprio pensiero. Un esempio,
l’altro giorno, mentre cenando mi sorbivo il solito
programma vinci un sacco di soldi se sai un sacco di
cose, le più disparate possibili, sintomo di erudizione
frammentaria, appunto definibile televisiva, senza,
immagino, il giusto approfondimento. Il presentatore -
tra l’altro, faccio notare di come avesse espresso, su
una risposta di un giocatore, la sua deficienza in
merito all’autore di Tenera è la notte – nell’elencare le
risposte non dette, si fermò a spiegare di come il
nirvana fosse nel buddhismo l’ideale alter ego del
cristiano paradiso. Si può immaginare quale idea sul
buddhismo ne possono trarre gli spettatori ignari della
-192-
struttura dottrinaria del movimento religioso iniziato
con l’insegnamento dell’illuminato. Il presentatore,
certo Jerry (Jerri, o Gerri) Scotti, ex parlamentare, è
stato nei giorni scorsi presente agli insegnamenti sulla
“felicità” del Dalai Lama, avvenimento che ha preso i
connotati di manifestazione politica nonché di
spettacolo.
Da quanto sopra scritto, mi piace giungere alla
conclusione che la popolazione italiana, quella
televisiva e comunque incapace di frapporre un filtro
critico fra se stessi e la (dis)informazione dilagante,
si sia infarcita di conoscenze frammentarie, per di più
inesatte. Tutti noi siamo vittime ed al contempo
colpevoli di questo male. Ed a farne le spese è la
stessa vera conoscenza, quella vera, importante per
comprendere il mondo e se stessi, venduta a basso
prezzo, smerciata a lotti, solo nelle parti di buona
degustazione e che può essere frutto di guadagno…
insomma, un business. Lo stesso buddhismo, difficile
religione e sistema filosofico – in assoluto sublime e
non adatta tutti, giustamente – sta subendo in questi
ultimi anni del millennio una mercificazione aberrante,
grazie all’opera pessima di tantissimi sedicenti maestri
del dharma (volutamente lo scrivo al minuscolo) che
hanno iniziato a fare circolare una propria
interpretazione del sublime insegnamento
-193-
dell’Illuminato. ho come l’impressione che si sia voluto
rendere il buddhismo una religione, o meglio un
movimento spirituale adatto a tutti, stravolgendone così
la sua vera essenza. Ché il buddhismo non è per tutti ed
esige responsabilità e profonda serietà e severità.
Trattasi di un cammino verso l’acquisizione della gnosi
e della libertà, per diventare infine uomini emancipati,
ma non per questo alieni alle problematiche della
società nella quale si conduce la propria esistenza.
-194-
5.
E’ bene che spenda tempo e carta per un problema
“umano” che spesso è facile constatare nei rapporti
lavorativi all’interno delle aziende. Nella fattispecie,
mi riferisco al modo con il quale vengono considerate le
donne sposate in procinto di iniziare una gravidanza.
Parlo pere esperienza, ovverosia per esser stato
testimone di fatti. Credo che simili situazioni, penose
e squallide aggiungo nel definirle, si sviluppino in
tutte le aziende, e quello che stupisce è la
constatazione che spesse volte simili atteggiamenti sono
ostentati da delle donne. Dunque, l’esempio che voglio
portare è quello di una mia collega, Antonella, donna
riservata e tranquilla, ma non per questo stupida o
debole, che a causa di così invidiose qualità è spesso
oggetto di maldicenze non solo nascenti dai “capi” ma
bensì dalle stesse sue – e mie – colleghe. In effetti,
provo rimorso e vergogna per non essere capace di
tagliarmi definitivamente fuori dal circolo vizioso
delle mie colleghe (lavoro solo con donne) prendendo una
posizione decisa ed onesta – sincera, insomma – per
dedicarmi esclusivamente al lavoro e lasciare a chi
altro non è in grado di fare il pettegolezzo,
intervenendo solo se interpellato e sempre dicendo la
verità e difendendo gli oppressi. Spero sinceramente che
-195-
l’educazione buddhistica che mi sto impartendo mi porti
col tempo a diventare un vero “adulto”, intendendo con
questo termine il Bodhisattva. Tornando alla mia cara
collega Antonella, sposata da pochi mesi e desiderosa di
una gravidanza, devo riferire l’episodio che mi vide
uditore involontario di maldicenze fra il “capo”, certo
Bacci – che tutti noi chiamiamo dottore ben sapendo che
laurea non ottenne – ed un consulente esterno, sua
grande amico e confidente, un vecchio di settant’anni in
fase avanzata di rincoglionimento. I due Vecchi
appartenenti al gota della Ducoil Chimica (preciso:
trattasi del nome della mia azienda) parlicchiavano, con
pompa di grandi illuminati, commentando lo stato civile
dell’Antonella, così poco adatto ad una persona
seriamente intenzionata alla disponibilità verso
l’azienda, arrivando infine alla conclusione che su
quella persona non si poteva fare affidamento, dato che
con un bambino da accudire non avrebbe potuto offrire il
suo massimo per l’azienda. In tutto quel discorso,
indegno di un essere vivente che vuole definirsi umano,
si adombrava l’idea che una donna sposata con figli sia
una perdita per l’azienda, e dunque alla fin fine non
faccia che rubare lo stipendio.
Bacci e Cribio, i nomi questi dei due coglioni flosci,
uomini (?) soggetti ad una mentalità retrograda e
vetusta, totalmente priva del rispetto per il prossimo
-196-
in generale e per la donna in particolare. A gente di
tale risma, come replica a discorsi così deprimenti, di
argomenti validi ed intelligenti – se il loro intelletto
limitato riuscirebbe a comprendere – ce ne sarebbero da
portare; ma si correrebbe il rischio di essere
fraintesi, alienati dalle strategie aziendali e dunque
per sempre dimentichi di eventuali aumenti di livelli e
di paghe, e dato che tutti dobbiamo vivere e cercare di
migliorare il tenore di vita della famiglia nella quale
viviamo, non possiamo fare altro che tacere ed
abbozzare. Io, personalmente, evito sempre di parlare
con Bacci di argomenti che anche solo alla lontana
sfiorino l’aspetto umano e squisitamente intimo delle
mie colleghe, e quando proprio non riesco a sfuggire
sempre, e dico sempre, difendo le colleghe, anche le più
stronze, perché mio padre mi insegnò che esercitare il
mestiere della spia, professionalmente o meno – è fare
opera cattiva. In aggiunta, voglio ricordare a queste
persone – e simili – che anche loro, in quanto esseri
umani (purtroppo) sono nati da donna, e che pure le loro
mogli (le opinioni delle quali non posso che trovare
inaffidabili, considerati i gusti che le hanno spinte ha
maritarsi con certa gente) hanno messo al mondo dei
figli. Aggiungo, altresì, che la condizione della donna
che è madre, è condizione sublime; che la donna nel
mentre crea nel suo corpo la vita, è un miracolo per gli
-197-
occhi ed i cuori di tutti; che la figura della madre –
in special modo per noi maschietti – è determinante
nello sviluppo e rimane sempre un punto di riferimento.
Ancora, voglio dire a questi signori che le aziende ed
il mondo del lavoro in generale sono parte integrante
della società, e considerata che la società è formata da
cellule familiare e su queste cellule base la propria
sussistenza, bisogna ringraziare le donne che creano
esseri umani, perché operano il bene per la società.
Certo, poi c’è l’educazione, ma questo è un altro
discorso che esce dall’attuale contesto.
Tanto che siamo in tema, voglio finire questo punto
esponendo il “bell’ambiente” lavorativo all’interno del
quale devo passare circa nove ore al giorno – esclusi il
sabato e la domenica, grazie al cielo. Non sono qui a
sparlare male della gente, ma dato che la situazione è
quella e che la debbo sopportare in continuazione, mi
piace metterla nera su bianco, giusto per ricordarmene
in futuro, caso mai la memoria del vecchio che sarò
perde acqua. Non so (non sono psicologo) se è per via
dell’ambiente piccolo, ma fra noi colleghi della Ducoil
Chimica, ci si mette dell’impegno per sputtanarsi a
vicenda. Il sottoscritto cerca con le proprie debole
volontà di fuggire a questo gioco al massacro, e quando
è irretito dalle circostanze fa di tutto per rimanere i
silenzio o deviare il discorso sullo scherzo. Non così è
-198-
per le mie colleghe, sempre pronte a sparlare dietro a
chi manca – con il quale, la volta precedente o nella
prossima occasione, lo si fa confidente di altre
maldicenze – in una continua girandola che non ha fine.
Quello che è peggio, ciò che più di ogni altra cosa mi
urta e verso la quale non avrò mai sentimenti di
perdono, è quella perversa volontà grazie alla quale
talune delle mie colleghe – nella fattispecie due –
spesso confidano al capo(decaz) i loro malumori nei
riguardi di quelle due o tre persone (sempre le stesse).
Così, si ha la consapevolezza che qualcuno primo o poi
parlerà male di te con la direzione. Questo vuol dire
professare il mestiere della spia; professione che non
fa per me. Siamo una piccola comunità, un mondo in
miniatura, dove tutti siamo capitati per fabbisogno e
non per amore degli uni verso gli altri, cosicché
sarebbe bene sopportare, fare del nostro meglio per
tornare a casa da chi si ama vivi e sani (anche
mentalmente). Adesso, in queste righe, io esprimo il
proposito di non tradire, né sputtanare, né ingannare
qualsivoglia persona, per qualunque fine; perché non
esiste fine degno che si possa raggiungere con il
raggiro. Anche questo vuole dire cercare di essere un
bodhisattva.
-199-
6.
Argomenti e fatti di vita da riportare in questo
diario sono tanti, forse troppi. Ritenevo,
nell’intraprendere questo esercizio, di occuparmi dei
più salienti – come dire: di quelli che si possono
definire punti di svolta – ma da diverso tempo mi sono
accorto dell’impossibilità di separare un fatto
dall’altro, legati come sono da un unico filo
conduttore. Ecco, dunque, la ricerca che conta: quella
del misterioso filo conduttore, misterioso solo per la
mia velata mente, ancora incapace di osservare con
chiarezza la realtà fenomenica e di trarne insegnamento.
A gettare maggior confusione, ma solo apparentemente, si
aggiunge la da poco iniziata lettura della Critica della
ragion pura (dagli esperti chiamata la prima Critica) del
sommo Kant. Anche ad un profano quale son’io non sfugge
la profondità smisurata del suo pensiero. Ora, tornando
a quanto più sopra detto, cerchiamo di trarre dalla
massa un fatto singolare stimolante la mia riflessione,
che non dovrà e non vorrà essere vana ed inutile. Spesso
mi ripeto che queste note – questo diario, appunto
Assoluto – è materiale che verrà ad essere di giovamento
sia a me, in un prossimo futuro, che a mio figlio (uso
una forma singolare, non negando la possibilità di un
desiderio ad averne degli altri – “averne”, quale brutto
-200-
verbo, come se qualcuno lo si possa avere, cioè
possedere!). Bene, di cosa parlare? Almeno due
argomenti: l’ultimo sanzen (il secondo) nel quale con il
monaco Ryusui (il Maestro – sarà bene d’ora in poi usare
la maiuscola) ho discusso di cosa sia la responsabilità;
l’ultimo stage di goshin-do, intorno al quale ho
interiorizzato certezze e problematiche nuove. Un punto
alla volta, dunque. Iniziamo con sanzen.
Nella sua fase di conclusione, il Maestro mi ha
chiesto di dire un’ultima cosa, ed il sottoscritto ha
espresso, dopo un attimo di riflessione, la sua
concezione dello zen, e cioè che trattasi di una Via
difficile che esige dallo studente il senso di
responsabilità. Responsabilità non è un termine da
prendere alla leggera, come al contrario sembra
insegnare a tutti noi la società nella quale viviamo,
identificando in essa in primo luogo quella italiana.
Responsabilità vuole dire non solo essere assolutamente
consapevole delle proprie azioni, parole e pensieri, ma
assumerne gli effetti, totalmente, accusando il colpo se
ciò lo comporta. E’ facile, in una società come la
nostra, ricca di relazioni interpersonali (a volte –
spesso direi – rese d’obbligo da varie esigenze) di
occasioni (negli acquisti – il mercato, e la pubblicità,
a seguire… anzi, in primis) di informazione, di
divertimenti (quasi sempre proposti con massicci
-201-
martellamenti)… di mode, insomma, per lo più, ma anche
per chi sa dove cercare e guardare di ricche possibilità
per arricchirsi (in senso culturale, naturalmente); è
facile, dunque, cadere in errori e causare con il
proprio karma (azioni, parole e pensieri) frutti marci
che andranno a cadere col loro carico virulento nella
cesta del prossimo. Ne consegue che ci rimangono due
alternative: assumersi le responsabilità di quanto
operato, oppure negare e nascondersi. la seconda non è
mai scelta degna di un vero adulto; e non mi sto
riferendo al bodhisattva della tradizione buddhista, no
di certo, bensì a qualunque essere umano che desidera
dichiararsi tale. Per il sottoscritto, che ha deciso da
tempo di seguire lo Studio della Via, vi è una ragione
in più per dare un senso al concetto di responsabilità e
per assumersi in toto la responsabilità delle proprie
azione. Considerando, in aggiunta, che la responsabilità
la sia ha verso qualcosa o qualcuno, ovverosia verso un
principio, un organo statale, un ente morale, una
persona (l’amico, la moglie, l’amata, il figlio – va da
sé che parlo anche di “la figlia” – l’insegnante o il
Maestro), ecco che doppiamente devo stare attento alla
mia condotta, orale ovvio, che deve essere rigorosa. Da
una parte mia moglie, Barbara, che mai smetterò di
ringraziare per l’amore che nel suo cuore porta nei miei
confronti, verso la quale ho l’obbligo di comportamenti
-202-
degni, leali e fedeli, di azioni di amore, e di una
condotta generale della mia vita avente lei come
riferimento: per fare un esempio, nel guidare per
lavoro, devo fare attenzione, perché se causassi un
incidente che mi procurerebbe la morte, lei rimarrebbe
sola (anche se, grazie alla sua forza, una vita nuova se
la ricostruisce – pur tuttavia soffrirebbe)… e se
procurassi la morte di qualcun altro le conseguenze
sulla nostra famiglia sarebbero terribili. Gli esempi si
allungherebbero, riempendo questa pagina. Per di più, se
la provvidenza (la nomina incautamente, non sapendole
dare un significato appropriato e probabilmente non
credendoci) ci assiste, fra poco avremo un figlio, che
subito, immantinente diverrà un altro riferimento, una
nuova responsabilità. Dall’altra parte, la Via del
Buddha, il Dharma che studio da un anno a questa parte.
Esige una grande responsabilità, per il semplice motivo
che risulterebbe un’assurdità il mio diligente sutudio
se non fosse accompagnato da una altrettanto diligente
condotta di vita, la quale altro non è che l’Ottuplice
Sentiero. Addentrandomi nella riflessioni, noto che la
quarta verità delle Eccellenti Affermazioni, se presa
sul serio (ed altro non può essere se si desidera
studiare la Via) si può mettere come base di partenza
per una vita matura. Ecco, in ultima analisi, fatta
rientrare la dottrina del Risvegliato nell’ambito della
-203-
vita quotidiana: semplicemente soffermandosi
sull’importanza della responsabilità e sulla doverosa
coscienziosità nell’applicarla.
Per quel che riguarda il goshin karate do, la
disciplina marziale costruita dal Maestro Shirai (e non
inventata, dato che racchiude elementi di differenti
scuole di karate, magistralmente congegnati in un
tutt’uno di sorprendente semplicità ed efficacia) il
discorso parrebbe più complesso che nel riscontro di una
prima analisi. Per il fatto che debbo introdurre la
figura di mia moglie, quanto mai inseparabile dal mio
vivere il karate. Barbara ed io ci siamo conosciuti in
palestra, il nostro amore è sbocciato in altri lidi, ma
il karate ha saputi cementare la nostra unione. Ora, a
seguito del suo infortunio al ginocchio, che non le
permette di esprimere a pieno le sue qualità di atleta,
Barbara sembra stia perdendo interesse, e più di una
volta mi ha espresso l’intenzione di abbandonare gli
allenamenti. Consigli non ne posso dare, conosco la
donna e so che non ci presterebbe ascolto più di tanto,
giustamente: il consiglio di una persona che non vive la
situazione in questione serve a ben poco, non è
obiettivo, per intenderci. Io stesso, come
precedentemente annotato, a seguito dell’incontro con lo
zen, non trovo nel karate quello stesso stimolo di
qualche anno fa. Ho scoperto che nel karate cercavo
-204-
qualcosa che mai avrei potuto trovarvi, mentre nello zen
mi si aprono ampie prospettive. Tuttavia, se
abbandonassi l’allenamento, mia moglie mi seguirebbe,
anche se la sua decisione di abbandono non fosse
completamente matura. E’ per questo, e non altro motivo,
che tardo a prendere una decisione, che, comunque, deve
essere decisa entro la fine dell’anno. In aggiunta, e
non ultimo motivo, in palestra (dovrei dire dojo) non si
respira più quell’aria di amicizia come qualche anno fa.
Bruno conduce una vita sempre più lontana dai nostri
(miei e di Barbara) canoni; Michele è sempre più
assente, preso come è dal lavoro; Michelino fa lo scemo
(come dice Barbara) con caterina, una ragazza
finlandese; Riccardo ha sempre mantenuto quella patina
di distacco utile a non formare una vera amicizia, e,
comunque, da qualche tempo sembra fare coppia con
Michelino. Nicoletta e Rosanna non vengono più da tempo,
con la conseguenza che Barbara si sente isolata, sola,
anche se non ha mai voluto confessarmelo; e, se si
prende in considerazione il fatto che nei suoi riguardi
– primo, perché è una donna (per di più piccola di
statura, e, secondo, è infortunata al ginocchio – tutti
applicano le tecniche mollemente, facendola inferocire,
la sua insoddisfazione appare ancora più evidente. Io
cerco di starle vicino, ma non sempre riesco, e quando
il dolore al ginocchio le torna a causa di una
-205-
particolare tecnica, o la sua tenacia non basta a farle
raggiungere il risultato sperato in barba ai limiti
imposti dal ginocchio, allora si chiude in un silenzio
per me angosciante, dal quale esce dopo qualche giorno.
In questi periodi io dovrei starle vicino, parlarle, ma
ne sono incapace, oppure non indovino il momento giusto,
con la conseguenza di peggiorare tutto; non mi rimane
che, come ultima risorsa, di comportarmi al meglio delle
mie possibilità, educato, premuroso, gentile.
Il karate, se è stato formativo per me, se nella mia
vita ha saputo donarmi il sapore giusto e la mentalità
adeguata per affrontare le cose, presumo che lo stesso
sia accaduto con mia moglie. Per questo, oltre al fatto
che abbisogno di più tempo, devo seguire la sua
decisione, di continuare o meno nella pratica dell’arte
marziale. Devo ammettere, comunque, per finire questa
nota, che presto dovrò affrontare il problema con lei,
spiegandogli come il karate non mi appaghi più (se non
nella sua esclusiva efficacia di allenamento fisico) e
che il tempo così guadagnato possa servirmi per
dedicarmi finalmente alla scrittura; inoltre, i soldi
altrimenti devoluti alla federazione ed alla palestra,
potranno servirmi per pagare il servizio di analisi dei
testi dell’agenzia letteraria. Fra non molto sarà pronta
la raccolta della Foresta di Laft, e data la fiducia che
ho in quei racconti, non trovo inutile e dispersivo
-206-
affrontare la spesa, considerando anche l’improbabile e
lontana possibilità che i miei racconti ricevano una
seria attenzione.
-207-
7.
Ho assistito al terzo kusen del Maestro Ryusui. Il
kusen è quel momento, durante zazen, nel quale il
Maestro, rimanendo in zazen, espone quello che si
potrebbe definire un sermone, ovverosia un suo discorso
sul dharma. Dei precedenti non ho fatto cenno in questo
diario, benché la loro importanza non fosse indifferente
al mio sviluppo di persona dedita alla realizzazione
dell’insegnamento dell’Illuminato; al contrario,
dell’ultimo mi interessa riportarne un sunto, più che
altro perché il Maestro ha parlato di alcuni aspetti
dell’essere buddhisti che rispecchiano alcune
riflessioni che feci settimane addietro. Nella
fattispecie, mi sto riferendo ad un periodo di tempo
(qualche giorno, invero) che passai a chiedermi se era
il momento o meno di chiedere di ricevere i precetti,
per la ragione che non ritenevo – e non ritengo –
coerente con le mie intenzioni continuare a frequentare
il Centro come semplice associato. La conclusione fu che
lasciai perdere, ritenendo più opportuno parlare con il
maestro di tutto ciò quando la mia comprensione del
buddhismo fosse cresciuta di qualche granello. E’
successo che nell’ultimo kusen, il Maestro ha parlato di
come i precetti (ottenuti con un piccolo ed
apparentemente insignificante rituale) siano importanti
-208-
come punto di riferimento per chi segue e studia
l’insegnamento dell’Illuminato; i precetti ci ricordano
in ogni momento che abbiamo assunto una ben precisa
responsabilità e ci possono venire in soccorso quando il
nostro essere onesti, seri e leali può venire contestato
e messo in discussione – ovverosia quando stiamo per
commettere una colpa – dallo sviluppo di una determinata
situazione. Bene, le parole del Maestro hanno in maniera
definitiva tranciato la mia indecisione, costringendomi
a riesaminare la mia posizione al Centro. Il Centro è un
Tempio buddhista zen, chi in esso vi insegna è un
maestro illuminato che ha ricevuto la Trasmissione da un
maestro illuminato, e precisamente dal Patriarca Dogen,
e che frequentarlo non significa soltanto andarci per
fare zazen ed ascoltare quando capita i discorsi di
Ryusui Roshi, bensì impegnarsi doverosamente nella
pratica del Buddha-Dharma; il che vuol dire assumersi
delle responsabilità. Ed io queste responsabilità me le
voglio assumere. E’ per questo che ho preso la
decisione, tornando a casa l’altra sera, dopo zazen ed
avere ascoltato il kusen, di chiedere al più presto i
precetti. Esporrò le conclusioni delle mie riflessioni a
riguardo, ed ascolterò il parere del Maestro,
consapevole dell’autorevolezza del suo insegnamento.
Non si tratta, credo, di fanatismo, il mio, né di una
vampata, quello che si può definire una passione
-209-
passeggera destinata ad esaurirsi come la fiamma
scaturita dalla paglia, vistosa all’inizio per finire in
cenere fredda. La mia è una ferma volontà a proseguire
lo studio del Dharma, fin dove le mie forze saranno in
grado di portarmi, impegnandomi nello zazen, nella
comprensione e nella pratica quotidiana, non
dimenticando di accompagnare a queste attività una
costante e profonda riflessione sulle mie parole, i miei
pensieri e le mie azioni.
-210-
8.
Babbo natale esiste. In un certo senso. Quale, questo
senso? Vengo ora a descriverlo, perché mi pare di avere
scorto una verità, o presunta tale (con queste note vi
indagherò sopra), illuminante a dir poco, sul tema
dell’identità di un essere umano (o dovrei dire
vivente?). Bene, iniziamo dal principio, introducendo
l’argomento in modo che tutto possa apparire con
chiarezza. Poi si vedrà che l’analisi è più breve del
fatto, ed il fatto di questa introduzione che sto
allungando oltremodo… ma, si sa, il cappello ha la sua
importanza.
L’altro giorno, in ufficio, si stava parlando di
quando da bambini, avessimo scoperto la non esistenza di
Babbo Natale (per conto nostro o su informazione dei
nostri genitori o chi altro). Alla fine del discorso,
non durato molto per la verità, me ne sono uscito con
un’affermazione che ha sollevato l’ilarità delle mie
colleghe, per altro giustificata, anche se ad una più
attenta analisi la mia battuta (doveva essere così nella
mia intenzione) risulti più profonda di quanto
sospettato. Ed è appunto in questa sede che mi accingo a
dimostrare che la mia battuta può essere utilizzata come
spunto per interessanti riflessioni.
-211-
Ciò che proposi come battuta alle mie colleghe – ma
già dopo averla detta iniziai a crederci sul serio – è:
nel momento che si portano i doni sotto l’albero, a natale, si diventa Babbo
Natale, dunque, siamo tutti Babbo Natale, e la sua esistenza è così
confermata. Ciò che intendevo dire è in attinenza, come
appunto anticipato sopra, con il problema dell’identità.
Noi siamo ciò che pensiamo di essere, ovvero noi in
quanto esseri viventi e la nostra identità coincidono.
Ciò che si manifesta agli altri tramite il mio corpo
(espressioni facciali, parole, azioni) è la mia identità
in azione, ciò che io sono, ma anche ciò che io penso di
essere. nel momento che mi accingo a fare un dono,
sapendo di agire come un virtuale Babbo Natale, io
divento tale, lo sono a tutti gli effetti,
indipendentemente dal mio passato storico,
indipendentemente dal fatto (veritiero) di essere
Nataniele Paghini. Voglio collegare l’argomento a quanto
afferma il Maestro Deshimaru, nel dire che quando siamo
in zazen (altrimenti definibile samadhi), siamo
illuminati. Zazen ed illuminazione, quando la pratica è
potente ed assidua, coincidono. Allo stesso modo, quando
la pratica di essere Babbo Natale è profonda, quando la
nostra concentrazione è potente come quella in zazen,
allora coincidiamo con il concetto di Babbo Natale. Ma
parlare di concetto è sbagliato. Si può considerare
zazen un concetto? No: zazen è una condizione
-212-
dell’essere vivente, la condizione sua più pura,
fondamentale, all’origine di ogni sentimenti, pensiero e
coscienza. All’inizio c’è zazen. babbo Natale è un
concetto, un’idea di un uomo che elargisce doni con
gioia, similmente all’idea del bodhisattva. Nel momento
che siamo in zazen, siamo dei bodhisattva (nel suo
significato allegorico, ovverosia di termine che
rappresenta un insieme di virtù ed intenti. Similmente,
se consideriamo Babbo Natale non come nome proprio di
una persona, ma come termine simboleggiante un insieme
di virtù positive e di atteggiamenti altruistici, allora
ci si può identificare in esso, anzi, si può essere
incarnazione di tale logos nel quando il momento e lo
spazio coincidono con la nostra volontà natalizia.
Dunque qui sto parlando di spirito natalizio, che non è
un qualcosa che esiste indipendentemente da noi, ma che
si può definire come la predisposizione a fare una certa
cosa in una determinata maniera per un ben preciso fine.
Ed ecco, concludendo, il Babbo Natale realmente
esistente in tutti noi.
-213-
9.
C’è qualcosa di nuovo nell’aria. E’ un modo di dire,
no? Ma questa volta, nell’utilizzarlo, avrei dovuto
aggiungere… e non è bello. mi sto riferendo alla
trasmissione televisivo cui ho assistito, in parte (ero
ospite di amici), ier sera. Uno spettacolo del sabato
sera, come vanno di moda da anni ed anni, per menti
incapaci di cercare altrove più seri e costruttivi
impegni, dove due squadre si combattono a colpi di
giochi idioti. E’ risaputo che fa milioni di spettatori,
e, giustamente considerato, che in Italia non posso
esistere milioni di idioti, ne conviene che molti
spettatori sia siano lasciati intrappolare, o, come nel
mio caso, sgomenti ed increduli, assistano per rendersi
conto di quanto basso sia il livello non solo della
televisione italiana, ma anche della cultura in
generale. Personalmente, voglio evitare in futuro ogni
contatto con simili riviste televisive, per mantenere
una corretta igiene mentale.
Di cosa trattava il programma? Bene, le due squadre in
competizione erano formate da, una parte gli
eterosessuali, dall’altra gli omosessuali; i componenti
erano solo maschi, mentre il pubblico, che votava alla
fine di ogni gioco era formato da donne, di ogni età (ed
estrazione sociale, credo). Solo qualche anno fa, una
-214-
simile trovata sarebbe stata ritenuta impensabile,
mentre con i tempi che corrono risulta sempre più
naturale ritenere normale la trasgressione… perché
l’omosessualità, per quanto se ne dica, è una
trasgressione. Si tende a far notare che l’omosessualità
è antica come la civiltà umana, e probabilmente è vero;
che nell’antica civiltà greca era d’uso che gli uomini
amassero e frequentassero dei giovani di pari sesso
(forse gli stessi grandi pensatori che hanno fondato il
ragionar occidentale si abbandonavano a questo vizio);
che anche in alcuni animali (mammiferi) si possono
sviluppare atteggiamenti omosessuali. Insomma, è normale
e non può essere contestata. Anzi, stiamo arrivando ad
un punto tale che mostrarsi contrario all’omosessualità
vuole dire fare atto di intolleranza… essere razzisti,
insomma. A ragione di ciò, onde non apparire troppo
bigotto, mi voglio soffermare ad affrontare il problema
e studiare la questione per evidenziare la presunta
normalità o meno dell’oggetto di questa nota e per
dimostrare se il mio atteggiamento è da bigotto o da
persona impensierita giustamente dalle tendenze di
questi ultimi mesi. Aggiungendo, che in tutto il mondo
si sta verificando una nuova presa di posizione nei
riguardi degli omosessuali: inserimento di nuove leggi,
facilitazioni burocratiche, riconoscimenti ed altro
ancora.
-215-
Bene. Partiamo dal basso. Cosa è l’omosessualità?
Varie spiegazioni ci possono essere a riguardo. Iniziamo
dalla più semplice: il rapporto carnale fra due
appartenenti dello stesso sesso di una specie animale, e
dunque il coito tra maschio e maschio, o femmina e
femmina. Questo in natura, dove il coito, ovverosia la
penetrazione, non viene raggiunta, ma simulata negli
atteggiamenti della copula. In natura questo avviene fra
quelle specie animali dal complesso sistema sociale,
cioè che vivono in gruppi dove sussistono diverse
gerarchie. Gli scienziati concludono che accade per
stabilizzare il gruppo. Lo scopo, dunque, è quello di
uno stabilizzatore sociale, avvenente tuttavia tra
animali che, a differenza dell’uomo, non hanno
sviluppato una cultura stratificata, nel senso che
cresce nel corso delle generazioni, con tutto quello che
ne consegue: arte, tradizioni, scienza, religione,
eccetera. In oltre, è bene specificare che fra i
suddetti gruppi di animali (delfini, scimmie, giraffe,
per fare alcuni esempi) la pratica dell’omosessualità
non è un agire fine a se stesso, solo per trarre
piacere, godimento, bensì una sorta di valvola tendente
a mantenere l’armonia nel gruppo. In aggiunta, non sono
stati riscontrati casi di omosessualità fra due
individui dove l’uno è un adulto e l’altro un piccolo, e
quest’ultimo non coscienziente. L’omosessualità è
-216-
pratica fra individui consapevoli del loro agire e
disposti nel fare questo; in più, è probabile che la
pratica serva a preparare il maschio all’accoppiamento
vero e proprio, oppure a sfogare il proprio stimolo
sessuale quando la femmina ancora non è in stagione
d’amore.
Nell’ambito della civiltà umana, non si può dire
altrettanto. L’omosessualità è pratica come un vizio fin
e a se stesso, onde raggiungere l’appagamento di un
desiderio che non trova riscontro di utilità in seno
alla società. E’ vero che, si dice, fin dalla nascita,
ovvero al momento della discriminazione (tredici,
quattordici anni) l’individuo diviene consapevole della
propria omosessualità; ma un conto è permettere che
questa omosessualità venga esternata senza ritegno, un
conto è viverla nel proprio io, con riservatezza. La
religione cattolica la considera un peccato; io, non
essendo cristiano, non posso dirmi d’accordo su questo
giudizio, tuttavia non posso ritenere l’omosessualità un
aspetto normale dell’essere umano, e dunque ritengo
indispensabile che l’omosessuale si atteggi a contegni
riservati. Naturalmente, ben sono consapevole del fatto
che qui non bisogna parlare solo dell’aspetto puramente
fisico, ma anche del sentimento d’amore che attornia e
compenetra l’atto sessuale. Chiaramente, se fra due
omosessuali, l’intesa è anche sentimentale oltre che
-217-
sessuale, allora non mi pongo in contrasto; ma rimane la
mia ferma idea che comunque il rapporto va se non
celato, per lo meno non ostentato. Intendo: vivere
l’omosessualità non come una colpa, bensì come un
propensione personale che nulla deve avere a che vedere
con la società nella quale si vive. In aggiunta, ricordo
che la pederastia, forse non confondibile con
l’omosessualità, è comunque un atteggiamento deviato che
deriva dall’omosessualità.
Una società è formata dal nucleo famigliare nel suo
elemento più piccolo. La famiglia permette la crescita
ed il mantenimento della società, attraverso l’unione di
uomo e donna generante una nuova vita (o più di una).
Nel suo svilupparsi, questa nuovo essere senziente deve
avere due figure accanto, fondamentali: quella paterna e
quella materna. Nel caso uno delle due mancasse, è per
via di incidenti accidentali o meno, e comunque è bene
sostituirla, onde assicurare una giusta crescita.
Inoltre, la famiglia è la prima scuola di educazione;
per questo cedo che sia bene dei coniugi il vivere in
armonia ed il cercare di ampliare in modo costruttivo le
proprie conoscenze; ed inoltre credo nella validità del
matrimonio. Insomma, sono un tradizionalista, e non vedo
come due omosessuali possano costituire una famiglia, né
tantomeno ritengo indispensabile che vengano formate
leggi a favore degli omosessuali. Nessuna acredine nei
-218-
loro confronti, semplicemente, essendo una
predisposizione congenita, è bene che rimanga tale,
senza trasformarla in istituzione. Permettere la nascita
e la buona crescita di un essere vivente, ecco uno degli
scopi dell’uomo… come può riuscire a fare ciò un
omosessuale?
-219-
10.
Nel primo capitolo dello Shobogenzo, il Patriarca
Dogen esordisce dicendo: Quando tutte le cose diventano il Buddha
Dharma…, continuando con lo specificare cosa succede
nel momento che ciò accade. Ora, pur non conoscendo e
non avendo consapevolezza del Dharma del Buddha, penso
di poter soffermarmi sull’implicazione della
proposizione del Patriarca; perché, ad una stretta
analisi, il linguaggio esprime più di quel che si evince
ad una prima approssimata lettura. L’aggettivo quando ed
il verbo diventare sono il perno del discorso che voglio
affrontare; ma prima di iniziare, è opportuno che
indaghi su una porzione della frase, ovverosia tutte le
cose.
Sicuramente, la traduzione italiana non può riprodurre
il significato profondo del giapponese utilizzato dal
Patriarca Dogen, tenuto conto anche del fatto che un
lemma trova nelle radici etimologiche la sua vera
essenza, e, dunque, una traduzione non può mai attingere
a questa eredità, riproponendo per intero il valore che
l’autore volle infondere nel suo scritto. Ciò
nonostante, si può accostare al significato ignorato
quello che noi riteniamo il più opportuno possibile, in
base alla nostra esperienza ed alla nostra conoscenza.
Nel caso della frase: tutte le cose, il sottoscritto ritiene
-220-
considerarla come riferimento alla Totalità, o
nominabile nel sistema buddhista come: Buddhatathata.
Proseguendo, posso ora arrivare al significato
dell’intera proposizione, che risulterebbe: quando la
Totalità diviene il Buddha Dharma. Ciò significa che la
Totalità non è sempre, in eterno, il Buddha Dharma, nel
senso che il Dharma, quale scopo dello zen, non è sempre
presente nelle cose. Il Dharma, in conclusione, non è un
elemento della realtà sensibile, bensì – e qui azzardo
un’ipotesi – una qualità delle cose non sempre
manifesta.
Quando si manifesta il Dharma, e perché si manifesta?
Rispondere a questi dilemmi presuppone la conoscenza di
cosa sia il Dharma, risultato che si può raggiungere
solo con l’illuminazione improvvisa, il satori, frutto
di serissimo e profondissimo zazen (leggi samadhi) e di
coscienziosa vita vissuta lungo la Via. Io, non avendo
né la conoscenza trascendentale (nemmeno in una sua pur
piccola porzione) né un’esperienza di vita buddhistica
(quanto mai difficile da perseguire), mi limito a fare
ipotesi, costruire concetti personali da verificare di
giorno in giorno, scartando quelli non più sostenibili.
Arrivando così alla conclusione – di questa nota –
dell’esposizione di una mia personale interpretazione
del Dharma. L’importante, in ciò, è avere sempre
presente che si tratta di una posizione temporanea, da
-221-
verificare e presumibilmente errata… ma necessaria per
continuare nel cammino.
Definizione del Dharma.
Riferendosi non al dharma (gli elementi della realtà –
altro argomento affrontabile e da affrontare), e nemmeno
all’insegnamento orale del Buddha; bensì al suo
significato più intrinseco, corrispondente a quel Dharma
la cui ricerca deve essere precipua in un Dharmacarin
(definizione data dal Maestro Prajnananda). Questo
Dharma è il Dharma. Definizione: Il senso delle cose. Con
cose intendendo la Totalità, e con senso (termine il cui
esatto significato mi assilla da tempo) esattamente il
Dharma, ovverosia il significato delle cose rapportate a
esse stesse, in una relazione che è interdipendente.
Continuando, la Totalità, essendo composta da cose
(elementi) in rapporto continuo fra di esse, ha il
significato che hanno le cose, e le cose hanno il
significato che se ne deduce dal loro rapporto con le
altre cose che compongono la Totalità. Ora si giunge ad
un dilemma della filosofia di ogni tempo, che si scinde
in due problemi: 1.le cose hanno un’essenza a priori?;
2.questa essenza è conoscibile?
11.
Da questa nota, è mio intenzione abbandonare –
temporaneamente, si intende – le disquisizione oltremodo
-222-
tese alle argomentazioni teoretiche, cosa che ho fatto
finora, trascurando di conseguenza l’aspetto pratico e
perciò più importante: la vita, concreta, quella della
quotidianità. Concludendo questa breve premessa, mi
piace sapere di avere raggiunto definitivamente questa
certezza, ovverosia che il troppo parlare di concetti
non legati alla realtà (come, al contrario, dovrebbe
essere il Dharma) conduce lontano dallo Studio della
Via.
Bene, iniziamo; a caso, la prima cosa che mi viene in
mente. Giusto l’altro giorno, al telegiornale della sera
di Canale 5 – quello dell’opposizione, così considerato
dalle persone avvinte dai pregiudizi e con i paraocchi –
mi capita di vedere un servizio altrimenti inutile su un
singolare episodio avvenuto durante una partita di
calcio. Precisando, una telecamera aveva filmato una
scena nella quale fra due giocatori erano intercorsi dei
probabili sproloqui (niente sonoro) con un epilogo che
vedeva uno dei due sputare in faccia all’altro. Qualche
giorno dopo, una speciale commissione, basandosi sul
filmato, aveva giudicato lo “sputacchino” reo di colpa e
passibile di espulsione. Il servizio di canale 5
concludendo facendo notare che era il secondo episodio
di incorrettezza che, ripreso dalla televisione, veniva
sottoposto alla commissione sportiva, e si chiedeva dove
avrebbe potuto portare questa possibile rivoluzione. A
-223-
riguardo, vorrei esprimere il mio giudizio, dato che
ravviso in germe nella faccenda lo sviluppo di
situazioni del tutto non auspicabili. Inizio col
precisare che il campo di calcio, essendo un’arena di
combattimento in primis, ovverosia un luogo dove più
persone si affrontano in vista della vittoria. Ci sono
due gladiatori, si affrontano, ad armi pari, ed
ovviamente, trattandosi di un gioco rude, gli animi si
surriscaldano, il fisico si affatica, i muscoli dolgono,
la mente non sempre può rispondere lucidamente; la
conseguenza può essere un gesto inconsulto, una perdita
di controllo, un’esplosione di rabbia, ed il tutto è
giustificabile all’interno della situazione, nell’arena,
quale realtà virtuale. L’arbitro esiste per limitare
questi episodi – inevitabili, voglio precisare – e ciò
che osserva ed esamina deve essere da lui e soltanto da
lui giudicato, all’interno della durata ufficiale dello
scontro. Quello che è successo ha ribaltato la sacralità
del combattimento, l’ha messa in secondo piano. Qualcuno
è andato a ripescare in un secondo momento, e quando i
giochi erano orami finiti, ha punito un gesto del tutto
comprensibile (all’interno della realtà dell’arena, lo
ripeto). Il dramma, il pericolo, è insito nel fatto che
d’ora in poi si esamineranno con scrupolo da inquisitore
tutti i filmati, e le telecamere – ergo l’addetto che la
manovra - seguiranno ossessivamente ogni gesto degli
-224-
atleti, obbligandoli a contenere emozione che è
necessario sfogare per il giusto andamento della
partita. Certo, sono d’accordo che è necessario
contenere gli sfoghi e mostrare un comportamento
dignitoso, anche per via degli spettatori – specie
quelli giovani – ma il nocciolo del problema sta proprio
in quest’aspetto: agli spettatori è consentito di vedere
troppo… e troppo da vicino. La televisione è diventata
imperante, nonché mandataria e conservatrice della
verità, perché la verità è ciò non che noi vediamo, ma
che la televisione ci fa vedere. Per questo motivo non
condivido il giudizio della commissione, temendo in
futuro un’intromissione delle telecamere in ogni angolo
della nostra esistenza: al lavoro, nella vita pubblica,
in strada, tanto che si dovrà stare attenti ad ogni
gesto. Libertà negata.
-225-
12.
Punto di svolta decisivo nella mia vita. Nulla a che
vedere con l’aspetto sentimentale, che grazie al cielo
(modo di dire, estraneo a qualunque credo religioso)
mantiene il suo aspetto florido. Ciò a cui mi riferisco
è la decisione definitiva di abbandonare il karate… per
il kendo. In realtà, un dubbio nel fondo della coscienza
rimane, ecco dunque il motivo di questa nota: indagare
su questo dubbio e scoprire se ha un senso ragionevole o
se si tratta solamente di un frutto del timore… Timore
di cosa? Di perdere qualcosa che ho costruito lungo
l’arco di quindici anni e che di conseguenze deve avere
avuto un’influenza sul corso della mia vita. Ho iniziato
a praticare karate-do all’età di diciassette anni,
essenzialmente per acquistare fiducia e sicurezza in me
stesso, in un secondo momento per dedicarmi ad
un’attività sportiva che tenesse impegnato ed allenato
il fisico. Ben presto mi sono sentito quasi morbosamente
attratto da questa arte marziale, tanto che sempre era
in primo piano nelle mie decisioni. Programmai la mia
vita sul karate: mai saltare una lezione, rinunciare a
lavori che impedissero per problemi vari l’allenamento…
perfino rifiutai l’invito a cena di una ragazza (a casa
sua) per non perdere una lezione del Maestro. Cosa dire?
Ancora adesso faccio fatica nel carpire la ragione del
-226-
mio attaccamento, ma forse si tratta solo della
consapevolezza che esiste qualcosa al di sopra di tutti
noi (non mi riferisco a Dio, al Cielo od altri concetti
puramente religiosi), o per meglio dire al di là di noi,
come l’onore, il dovere, la lealtà, qualcosa da servire,
per il quale sacrificarsi. In effetti, c’è una piccola
verità in ciò che ho appena scritto, ed è la verità del
trascendente, di ciò che non può essere spiegato a
parole, bensì con i gesti, configurati in particolare
azioni. Oltre l’apparente, e per motivare l’apparente,
per conferirgli dignità, bisogna cercare valori
definitivi ed assoluti, non necessariamente di carattere
religioso. Allora, sotto questa ottica, i valori
religiosi e quelli puramente laici (come l’onore del
guerriero) tendendo entrambi a farci vivere una vita
dignitosa che si elevi dallo stato animale verso uno
stato spirituale. Entra in gioco il dovere morale, nel
senso kantiano del termine, dunque indiscutibile e
solamente attuabile.
Ritornando al discorso iniziale, ecco che il mi
dedicarsi assiduamente al karate-do era ed è una ricerca
del trascendente, un offrirsi a quei valori che la
società consumistica di questi ultimi decenni non è
capace né di offrire né tanto meno di mostrarne la
ricerca. Ora, con la drastica decisione di abbandonare
il karate-do per il kendo, potrei perdere di vista la
-227-
ricerca di questi valori assoluti? Non credo,
semplicemente non solo perché anche il kendo è una porta
aperta (per chi sa aprirla) sui valori sopra menzionati,
ma anche in ragione dello zazen, a cui mi dedico con
tutta la sincerità e concentrazione di cui sono capace.
Il filo non è andato perso, la strada è sempre ben
segnata innanzi a me, tocca solo a me disporre della
forza per continuare. Tuttavia, il dubbio sulla scelta
permane. Permane la paura di perdere molto, ovverosia
una cultura accumulata in quindici anni, che
immancabilmente mi ha portato ad essere quello che sono.
Mi domando, il kendo, lo zen, saranno in grado di
donarmi tanto? Non so rispondere, solo il tempo saprà
darmi una risposta. Ulteriormente, un altrro timore è
dato dalla consapevolezza che la mia scelta imposterà
anche una scelta forzata da parte di Barbara. So –
avendomelo lei detto – che è stanca di continuare la
pratica (il ginocchio?); ma questa mia decisione non
potrà che obbligarla a fare altrettanto. Ne abbiamo hioà
parlato, e lei mi ha detto che si tratta di una
questione che devo affrontare – in ultima analisi – da
solo.
-228-
HE
1. Nuova impronta – 11 maggio 2000
La vita non è statica, e quando lo è (per volontà
nostra, è bene precisare) diventa al pari di uno stagno
e presto comincia a maleodorare. Al contrario,
rinnovando gli elementi che la formano, purificando le
situazioni, introducendo nuovi contesti, si ha il
piacere di vivere, perché tutto diventa una scoperta, un
viaggio che non può mai finire. Così, cercando di
assimilare quanto appena detto, non posso che essere
contento di avere lasciato il karate per il kendo, di
avere iniziato lo studio del Reiki e di continuare
ascrivere poesie (ogni poesia è un universo,
un’avventura) di essere ancora indaffarato nella ricerca
di un tempio zen e di meditare una capatina ad un tempio
tibetano vicino a casa. Da qui il titolo: Nuova
impronta. Sì, giacché i miei piedi hanno cambiato forma,
le piante non lasciano più i soliti segni sulla sabbia…
eppur sono sempre miei, questi piedi! Non è fantastico?
Ma cerchiamo di venire al dunque. L’attivazione Reiki mi
ha aperto nuove prospettive, ora intravedo un universo
smisuratamente più vasto ed intuisco che potrò
-229-
sperimentare esperienze che mi conoscenza, saggezza e
pace. Il tutto, senza rinunciare alla mia quotidianità,
e ciò rende il tutto ancora più meravigliosamente.
Reiki, in connubio con lo zen, mi fa comprendere come
sia sempre più necessario staccarsi dalla mondanità,
dalle abitudini, dai sentito dire, dai pregiudizi, tutti
schemi mentali presi in prestito e facili da usare, ché
in tal modo non si spremono troppo le meningi. Questo è
un punto che non smetterò mai di ripetere, fino alla
nausea se necessario.
Reiki, dunque. Cosa è successo dall’ultima volta?
Qualche cosina interessante e da non prendere alla
leggera. Innanzi tutto la purificazione dei cosiddetti
ventun giorni, nei quali ho defecato in abbondanza e mi
sono dedicato ad autotrattamenti. Il risultato? A
portata di mano, impresso nel mio corpo di carne e
sangue. Ad aprile, prima dell’attivazione, ho fatto una
visita specialistica per liberare l’orecchio (mentre
scrivo mi viene in mente una sera di luglio del ’94, ero
andato a trovare mia madre al mare – Camogli,
precisamente – e si stava guardando un film in
televisione: “Gli eroi di Telemark”. Domenica, ricordo,
prima del film avevamo giocato a carte. A volte ho
sprazzi di vita vissuta, ricordi che fioriscono con
tutto il loro carico emotivo; ma ancora non riesco a
trovare collegamenti tra quei ricordi e l’attimo
-230-
presente). Ritorniamo all’orecchio. nella visita è
risultata una perforazione all’orecchio, di vecchia
data, più cicatrici di altre perforazioni, il tutto in
un insieme di cattive condizioni. il dottore mi
prescrive la solita cura (precedentemente avevo fatto
un’altra visita, e prima ancora, di diversi anni, lo
stesso disturbo mi si era presentato varie volte). Alla
fine, il dottore si raccomanda che io ritorni per una
visita più accurata per verificare bene l’entità della
perforazione. Ci sono tornato questa mattina, e con
sorpresa il dottore ha scoperto che la membrana del
timpano si sta autorigenerando. Ora è un foglio roseo
sottile e delicato… ma c’è, quando non avrebbe dovuto
esserci. Il Reiki è estraneo a questo? Non lo so, e non
voglio indagare. Così come non voglio indagare su come
sia passato da sera a mattina il mal di stomaco alla mia
Barbara dopo un trattamento Reiki. Nuove impronte,
appunto. Nuove impronte.
-231-
2. La vera realtà – 11 giugno 2000
Esattamente un mese di silenzio e riflessione. Il tempo
è statico, pura illusione: è la nostra psiche che
accelera o rallenta ai ritmi delle emozioni e delle
passioni. E migliaia di cose accadono senza che noi si
riesca a trovare una ragione ovvia… ma è solo per nostra
incapacità. Invero, per ogni cosa c’è un motivo
d’essere, e noi abbiamo il dovere e l’obbligo di
scoprirlo. Per questo, e non altro, sono qui a narrare
di un percorso che mi si è ripresentato in questi ultimi
giorni e dei miei tormenti decisionali.
Prima di arrivare al dunque, mi preme sottolineare come
sia oramai difficile per noi cittadine della società del
consumo e della brevità, riuscire a soffermarsi su
questioni di interesse etico, sociale e filosofico. Mi
spiego meglio. I giornali, sia cartacei che televisivi –
l’informazione, insomma – forniscono non solo il dato di
fatto, ma anche la sua interpretazione, a tal punto che
lentamente ci stiamo dimenticando l’importanza della
riflessione e dei tempi – mai brevi – necessari per
effettuarla. Il mondo che abbiamo creato non ci vuole
indaffarati in simi le sciocchezze, così abbiamo
delegato altri a farlo per noi. Ho l’inquietante
impressione che la società nella quale siamo nati e
-232-
viviamo – e nutriamo – si divide in tre strati: la
massa, di cui io stesso ed il mio amore facciamo parte;
la casta che nutre cibo preconfezionato e precucinato la
massa; e un èlite di liberi pensatori, di filosofi e
sapienti… insomma, di seriosi studiosi a cui poco
importa della massa e che conducono le proprie ricerche
ad esclusivo beneficio dei confratelli. Avete bisogno
che vi spieghi il tutto in dettaglio? (arriverò mai al
dunque, in questo foglio?)
La massa siamo tutti, chi più, chi meno. Chi vive
integralmente nella massa, chi soltanto quegli attimi in
cui - a volte suo malgrado – è costretto a nutrirsi del
cibo della massa. A me interessa l’homo massa. Egli è
imboccato, non pensa, non legge, non riflette, segue le
tradizioni senza chiedersi come e perché siano nate, si
affida ai pregiudizi, evita di prendere decisioni
personalmente, guarda programmi insulsi alla televisione
che non procurano mai educazione ed istruzione. Costui
non vuole fare fatica, solo divertirsi e raggiungere il
benessere, e per questo lavora e lavora, ed il suo
cervello si atrofizza, non importa se è un genio
dell’informatica o cos’altro. L’homo massa non è più
capace di rompere i veli di maya e di domandarsi dove
siamo e cosa cavolo stiamo facendo… e, specialmente,
perché.
-233-
La casta dei produttori di cibo è la più patetica. Anche
loro sono come l’homo massa, loro stessi lo sono in fin
dei conti, ma hanno raggiunto il gradino superiore (o
forse sarebbe meglio dire inferiore) ed oltre a nutrirsi
del cibo precotto lo producono. Sono loro che ci danno
le notizie e la loro interpretazione, dispongono i fatti
come gli pare, rigirano la frittata per tornaconto
personale (questi sono i politici) a volte spostano
impiegati ed operai come pedoni su una scacchiera.
Quando arrivi la sera a casa e ti siedi per cenare, sono
dietro la televisione che ti aspettano con i loro
programmi per deficienti, ti fanno l’occhiolino, ti
dicono che sei bravo, ti mostrano corpi bellissimi che
nessun essere normale riuscirebbe ad avere e mantenere
all’interno di una normale esistenza. Possono essere
utili, i giornalisti (alcuni, pochi per la verità) ma
devi saperli ascoltare.
All’interno di questi due gruppi, per fortuna di tutti
(ma nessuno forse se ne rende conto) esistono personaggi
formidabili, anime nobili ed umili, difficili da
individuare, ma che possono donare molto e con le quali
conviene condividere degli interessi, o conviene
ascoltarle, magari leggerle. Non si può dire chi siano,
ma solo che ci sono e che ognuno di noi può individuare…
e magari proprio uno di noi che si sente
-234-
fondamentalmente una cacca, potenzialmente è uno di
questi bodhisattva.
L’èlite è il gruppo più pericoloso… ed inutile.
Qualunque cosa facca, la fa per se stessa. Il suo lavoro
non esce dal gruppo e non si sa bene a cosa possa
servire. All’umanità no di certo. Sono tanti, troppi… ma
bisogna tenerli, perché ognuno ha il diritto di vivere
la propria vita come più gli aggrada.
Tutto questo ha un senso? Indubbiamente.
Il senso è la vera realtà che si nasconde dietro la
facciata che noi non solo abbiamo eretto, ma ci
spacchiamo il culo per mantenere. Possiamo vederla,
studiarla, viverla? Quale è la sua vera natura? Esiste
solo un modo per raggiungerla: zazen e profonda
obiettività innanzi a tutti i casi della vita.
-235-
3. Una nuova visione della vita… ma sempre la stessa –
13 giugno 2000
La vita ha un suo aspetto positivo: non è mai la stessa,
è un caleidoscopio mutevole che ci presenta combinazioni
di colori sempre differenti… e che il più delle volte ci
sorprendono. Come fare ad affrontarli ed interpretarli
correttamente? Da dove partire onde ottenere le giuste
chiavi di lettura? Affidarsi alla fede religiosa, alla
scienza o a qualcosa d’altro?
Esperienza e sperimentazione, questa è la mia risposta.
Costruire dei modelli di riferimento che le circostanze
di volta in volta ci costringeranno a modificare e
perfino cambiare radicalmente, fino a quando non
troveremo un’armonia tra il nostro essere e la realtà
che ci circonda, fino a quando il modello che costruiamo
e che deve rappresentarci il mondo circostante non
soddisfa il nostro essere, la nostra interiorità ed
esteriorità; insomma, la nostra totalità. Ma così
facendo, non si rischia di approdare a modelli negativi,
depravati, oppressivi verso il nostro prossimo? Ci vuole
qualcosa a priori. Potrebbe essere la coscienza. Eppure
essa può risultare inquinata, tale da ritenerla
inaffidabile, tale da farci supporre che il suo stato di
partenza è pur sempre una conseguenza, un effetto di una
causa antecedente. Esiste qualcosa a priori, percepibile
-236-
od intuibile, con la quale disporre le fondamenta di una
ricerca della verità?
L’anima. L’anima è un concetto, e ci si cede per un atto
di fede. Qui non la nego e non l’affermo, semplicemente
specifico l’impossibilità di percepirla come dato
d’esperienza. L’anima è un concetto a posteriori, e non
può rappresentare la base del nostro modello. Bisogna
cercare altrove. In noi stessi, senza una meta precisa,
soltanto non soffermandosi sui pensieri, sulla
coscienza, sui sensi, cercando di andare oltre il
concetto di Io, di Ego. Questo è zazen. Con zazen si
intuisce, profondamente ed indubitabilmente la vacuità…
e da qui inizia la nobile via che conduce alla divinità.
Il percorso è lungo, ma di semplice esposizione. Non
corrisponde all’illuminazione (la folgorante e totale
comprensione del Dharma), non significa essere dei santi
o degli angeli in terra; solo si comprende meglio la
giusta relazione tra noi e l’universo. Io ho iniziato
questo viaggio, ho percorso la strada, sono arrivato ad
una meta che è il vero inizio, e voglio rendere
partecipe chi legge quello che ho scoperto. Preciso la
soggettività dell’esperienza, ma non posso negare la sua
validità e la verità incontrata. Chiunque poteva
giungere a conclusioni differenti dalle mie, pur
tuttavia egualmente nobili e giuste, diritte scale vero
l’Oceano della Divinità. La nostra mente terrena non è
-237-
in grado di afferrare la complicanza dei molteplici
fattori che contribuiscono a formare un essere
senziente, ed umano nella fattispecie. Il Buddha ha dato
un’indicazione, sublime essa, ma solo un tassello che
inserito in un disegno più vasto. Esiste qualcuno – o,
per meglio dire, è esistito – che ci ha fornito le
coordinate giuste ed i parametri adeguati per comporre
l’intero mosaico. Ne scaturirebbe un’opera d’arte
superlativa, al completamento della quale tutti gli
uomini e donne, di qualunque religione e ceto sociale,
sono invitati ad intervenire.
Questa lettera sacra – HE – è finita.
Questa Sfera Mistica, MALKUTH, è stata completata.
-238-
Catechismo cattolico
Sono sempre stato contrario nel volereintrodurre nella vita educativa di Miriam dellospazio riservato al catechismo cattolico e alrelativo insegnamento dei fondamenti dellareligione cristiana. Così come non ho maiapprovato integralmente l’ora di religionecattolica inserita nel programma scolasticodella scuola primaria; preferendo che venissesostituita da una più opportuna lezione dimitolologia, considernado il mito – Mito, piùpropriamente – uno dei costituenti della psicheumana.
Pur rimanendo di quet’idea, che in unmomento succesivo spero di poter sviluppare espiegare, credo che nei riguardi del catechismocattolico, così come viene insegnato all’internodegli istituti religiosi, quali le parrocchie,sia opportuno un differente approccio. Enonostante io e Barbara non siamo due praticantie, parlando di me stesso, nemmeno un credente –essendo attirato da una visione buddhista dellarealtà,se pur con forti influssi politesisti – ègiusto che Miriam inizi un percorso in tal senso(riferito al catechismo).
Il perché va individuato nel mio pormirispetto al Mito (d’ora in poi “mito”) e allasua concezione. E alla necessità che un bambinonon solo venga avviato verso una concezione
-239-
mitica della realtà, ma anche che sia invogliatoa sviluppare un proprio immaginario poetico,personale se pur rifacendosi a modelli giàesistenti. Questo perché l’essere umano è unanimale mitopoietico, ossia che è propensoall’affabulazione, alla creazione di raccontiche spieghino e raccontino la propria origine,alla narrazione della realtà prima ancora chealla sua analisi e spiegazione.
Ciò che ci differenzia dalle altre specieviventi di questo nostro meraviglioso pianeta(“nostro” per modo di dire), non ètantol’intelligenza o l’autocoscineza 8probabilmenteposseduta anche da qualche altra specie), bensìla qualità della mitopoiesi. Infatti, se pur sistudiano i linguaggi e i comportamenti socialidi specie volute,se pur ci siano indizi diautocoscienza e intelligenza evoluta inquestespecie superiori, di una cosa si può esserecerti: l’essere umano è l’unico che crearacconti, che narra attraverso parole e disegni,che comunichi stati emozionali attraverso segniche non siano prettamenti utilitaristici per lasopravvivenza della specie. Insomma, l’essereumano
Il motivo che sta alla base di ciò fa partedi quel gruppo di misteri che da sempreattanagliano la ricerca spiritusle e non, ecomunque non è mio desiderio parlarne ora.Piuttosto, mi preme sottolineare che un bambino
-240-
non può ricevere immediatamente una spiegazionescientifica e totalmente non poetica del mondo edi come abbia avuto origne la vita. E’necessario introdurlo al mondo, introdurlo einiziarlo alla vita attraverso il mito,attraverso il racconto mitico e fiabesco per laprecisione, non volendo con ciò asserire che ciòche viene enunciato nei racconti religiosi sullacreazione sia falso. Ma non è neppure vero!Diciamo, piuttosto, che verità e falsità nonsono pertinenti al mito. E dunque allareligione.
Ecco spiegato, a grandi linee, il mio parerefavorevole all’insegnamento del catechismo, nonsolo, ma anche a una pratica religiosa(affiancata dalla rimarcazione che tutti i mitihanno uguale valore, se pure ognuno deve trovarecollocazione nella configurazione culturalenella quale si è sviluppato nel corso deltempo). Per questo è necessario che Miriam, cosìcome greta quando i tempi saranno maturi, inizia sviluppare la visione mitica della realtà, unasorta di fermento poetico che non dovrà maiabbandonarla nel corso della sua vita, anche see quando non riterrà più opportuno seguire ilcristianesimo (così come è capitato a me).
Ci vuole un mito fondante, che sia consono ein armonia con la società e la civiltà nellaquale si vive. Almeno ciò nei promi sviluppidella crescita.
-241-
2. Capitolo I del Sutra del Loto
Si tratta di una sorta di introduzione atutto il Sutra, ed assistiamo all’apparire didue fra i maggiori protagonisti oltre al Buddhastesso, e cioè Maitreya e Manjushri. Inoltre,alcuni insegnamenti vi sono già esposti - informa rudimentale - ma comprensibile ed utileper delle riflessioni iniziali sul valore ed ilsignificato dell’intero Sutra.
Siamo sul picco del Monte Gridhrakuta, che avolte viene tradotto in occidente come Piccodell’Avvoltoio, nei pressi della città diRajagriha, la capitale del Magadha, un regnodell’India nord orientale. A tale proposito,vorrei aprire una parentesi storica edincorniciare brevemente un periodo nei quali dueculture vennero in contatto, favorendo ilpassaggio di nozioni e sapere.
Nel corso dei cinque secoli successivi allamorte del Buddha, il suo pensiero prese adiffondersi in tutta l’India, ed in seguitomigrò grazie all’opera missionaria di coraggiosimonaci verso l’est asiatico. Tuttavia, ciò chemi preme ora, è sottolineare il contatto tra laciviltà indiana e quella greca dell’imperoBactriano che avvenne nei due secoli antecedentila nascita del Cristo. La storia degli imperiindogreci è di fondamentale importanza percapire come il pensiero buddista sia penetrato
-243-
nel mondo ellenistico dapprima e poisuccessivamente in tutta quell’areamediorientale ricchissima di fermenti religiosiche è la mesopotania e la regione iraniana. Neicinque secoli che vanno dal Buddha al Cristo,abbiamo lo sviluppo e la diffusione delzoroastrismo (deformazione occidentale dizarathustrimo) nell’Iran, ed ancora adesso glistudiosi cercano di trovare collegamenti perprovare che il Mitra zoroastriano ed il Maitreyabuddista non sono che la palesazione culturaledi uno stesso modello simbolico-religioso.
Mitra è una divinità indoiranica, collegataal sole, che aiuta Varuna, dio massimo vedico,nella lotta contro i demoni e nel soprassedereall’universo intero. Stesso ruolo presiede nelzoroastrismo, affiancando Ahura Mazda nellalotta contro il principio del male, Arimane.Sicuramente è stato assimilato dal buddhismo, amio parere, e trasformato nel bodhisattvaMaitreya, il Buddha futuro, ovverosia Bahaullahstesso.
Il culto di Mitra fu molto popolare fral’aristocrazia e l’esercito romano, e nei primisecoli della nostra era fu l’unico serioconcorrente del cristianesimo. Il fatto cheabbia perso il confronto è da imputare al suaesotericità (segretezza), al suo essereesclusivamente per alcune classi sociali ed aessere precluso per le donne. Tuttavia il suo
-244-
aspetto solare fu assorbito dalla figura diCristo salvifico ed angelico, e tutto lognosticismo cristiano che si sviluppò moltoprobabilmente subisce ampie influenze dalmitrismo. Ricordiamo che il culto di Mitradall’Iran si diffuse fino in Gran Bretagna,ricalcando più o meno l’area di influenzaceltica, come se il mitrismo rispondesse adesigenze spirituali connesse con la cultura deicelti. Sono semi lasciati cadere nei solchidella storia e che col passare dei secoli sisono sviluppate in nuove piante e verzure.
Con questo ho voluto solo ricordare che lereligioni sono mene monolitiche di quanto sivoglia immaginare e che hanno subito influenzefra di loro tali da modificarne completamente lefondamenta originarie. Lo stesso islam subìinfluenze manichee sotto gli Omayyadi, quandol’impero persiano venne conquistato dagli arabi,e tutte le dottrine ebree del giorno delgiudizio e degli angeli (che ritroveremo nelcristianesimo e nell’islam) sono di direttaderivazione zoroastriana.
Nel suo ultimo periodo di vita “ufficiale”Mitra assunse la connotazione di portatore diluce del Dio Unico. L’esoterismo e lognosticismo occidentali si sono nutriti diquesta interpretazione solare e presumibilmenteanche il misticismo islamico ne assorbì lanozione. Bahaullah, cresciuto nella cultura
-245-
islamica sciita pregna di messianicità, fuidentificato da suo figlio cpme lamanifestazione di Dio, così come i raggiluminosi sono la manifestazione del sole.
Ritornando al Sutra del Loto, diamo unaccenno su cosa accade. Una immensa folla dimonaci e monache, laici e laiche, bodhisattva,divinità, arhat, esseri mitologici, draghi,creature non umani e quanto di più stupefacentel’immaginazione può produrre è riunita attornoal Buddha Sakyamuni, il quale, assiso nellaposizione del loto, è immerso nel samadhi1.All'improvviso, il Buddha emana un raggio diluce purissima dalla fronte (esattamente fra idue occhi) e si appresta a risvegliarsi dalsamadhi. A questo punto, il bodhisattva Maitreyainterroga il bodhisattva Manjushri, chiedendoglispiegazione di quanto sta accandendo. Il tutto èraccontato con dovozie di particolari e connarrazione ricca di iperboli e di ripetizioniche possono stancare il lettore occidentale. Inrealtà, nella letteratura buddhista,inizialmente nata oralmente e tramandatasi contale modalità, la ripetizioni di medidesimi
1 Samadhi: difficilmente traducibile in italiano, indicauna situazione psicologica di assoluta quiete interiore e di introspezione spirituale. In questo stadio, l'essere annulla se stesso e si ricongiunge con l'assoluto. Entra in armonia con la Totalità.
-246-
contenuti in uno stessa narrazione garantivaun'appropriata memorizzazione. Nella domandaposta da Maitreya e nella risposta data daManjushri troviamo esposte due importantiverità.
1. I tre veicoli di insegnamento del Buddha2. La ciclicità dell'insegnamento del BuddhaManjusrhi spiega che il Buddha, di "ritorno"
dal samadhi si sta accingendo ad esporre lalegge fondamentale dell'universo, ovverosia laLegge del Loto. Lo stesso sutra ha questo nome ela dottrina sviluppatasi in seguito trasformaquesto scritto nella manifestazione tangibiledella stessa legge, tanto che possiamoannoverarlo tra le scritture sacre pereccellenza. In una visione bahai, si puòaffermare che il Sutra del Loto è una delleinfinite forme del Libro Primigenio, il qualedall'eternità è presso la Divinità.
Ma analizziamo bene i due punti soprabrevemente elencati.
1. Cosa si intende con veicolo? E' unametodologia di insegnamento attraverso la qualeil Buddha cerca di aprire la mente dei suoiallievi onde risvegliarli alla realtà assoluta,che è una sola. Tuttavia, come Egli si accorgepresto, gli individui sono fortemente legatialle passioni ed al proporio Io, preda dellabrama e dell'ignoranza; di conseguenza larivelazione della legge suprema risulterebbe
-247-
perfino dannosa. Ecco che il Buddha inventadifferenti veicoli, ad incastro, per condurrelentamente gli uomini al risveglio ed allacomprensione totali. Il sutra elenca treveicoli: i) Veicolo degli arhat (gli ascoltatoridella voce, i primi allievi del buddha i qualiudirono di persona i suoi isegnamenti). Questo èil Theravada, o Buddhismo degli anziani, legatoa concezioni ancora primitive ma giàracchiudenti in essa i semi di tutti i futuriprogressi. Come dici Abudlbaha, il seme ha giàin sè la quesrcia che sarà, e csì il buddhismoprimitivo porta in grembo più grandi e cosmicheconcezioni. A questo veicolo facciamo risalirel'insegnamente delle Quattro Nobili Verità - cherimangono una fondamenta del buddhismo - e laconceaione transitoria del nirvana comeestinzione. ii)Veicolo dei Pratyekabuddha. Conil termine pratyekabuddha si usa indicare chiraggiunge l'illuminazione con i propri mezzi,senza concorrere ad aiutare l'universo nella suacostante evoluzione. Naturalmente, il Sutra delLoto è molto esplicito nell'insegnare che con ipropri mezzi ed in via solitaria non èassolutamente possibile raggiungere il satori,tuttavia, come spiegato precedentemente, adalcuni individuo può servire appartarsi insolitudine per superare una certa fase delproprio cammino ed approdare poi all'ultimoveicolo. La legge della concatenazione dei
-248-
dodici anelli (sulla quale meditano i buddhasolitari) è il concetto base di questo veicolo.Basilare anch'esso, ma solo in vista di una piùampia concezione dell'insegnamento buddhista.iii) Veicolo dei Bodhisattva. L'ultimo veicoloed il più completo. Non è molto chiaro, ma aduna prima analisi il Sutra sembrerebbe indicarequesto ultimo come il veicolo unico e principe,quello vero. Potrebbe anche essere, tuttavia,che sia solo uno dei possibili veicoli senzarappresentare la verità assoluta, che in quantotale non è possibile concepire se non attraversointerfacce temporanee. Qui si ha l'introduzionedella figura del bodhisattva, che è fondamentalenel buddhismo Mahayana. Il bodhisattva è coluiche rimanda la propria illuminazione totale, ilproprio diventare buddha fino a quando tutti gliesseri viventi di tutti i mondi saranno salvati.Qui sorge un paradosso. Anche il BuddhaSakyamuni è stato un bodhisattva ed ha fattop ilvoto di salvare tutti gli esseri... come alloraè divenuto Buddha? La risposta va trovata incapitoli successivi, dove viene svelata la veranatura di Sakyamuni.
Bodhisattva. Entra in campo a pieni terminiil concetto di amore altruistico e di beneelargito senza aspettativa di nessunaricompensa. L'insegnamento è che qualunque cosa,sia buona o malvagia crea karma e dunquerinascita; pertanto le azioni pie vanno compiute
-249-
con assoluto distacco e fini a se stesse. Solocosì il saggio può raggiungere la divinità edaiutare gli altri a farlo. La sua praticareligiosa si basa su sei virtù:
1) Fare dono di sé. Offrire se stessi e leproprie azioni, ma anche donare cose materialiin quanto vista come pratica che diminuisce ilsenso di attaccamento. L'accentramento di beniconduce ad un forte attaccamento alla vitaterrena, con la conseguenza che il mondospirituale, prerogativo alla divinità, sfugge.L'huqullah, per intenderci, ha sia da una partel'utilità di poter sostenere la Causa, edall'altra la possibilità offertaci didistaccarci dall'attacamento ai soldi. ma ancheil dono della propria esistenza, in casiestremi, è vista come una virtù santificatadalla Divinità.
2) Disciplina. L'osservanza dei precettibasilari, quali: non uccidere, non rubare, nonmentire, non indulgere in azioni e pensieri chepossano addolorare il prossimo, e molti altri.Nella fede bahai significa attenersi alle virtùche sono elencate nel Kitab i Aqdas.
3) Pazienza. In ogni istante ed in ogniaspetto della propria esistenza bisognasforzarsi di essere paziente e tollerante. Amaggior ragione nella ricerca della buddhità.Sono due qualità che possono permettere diosservare le cose con maggiore lucidità e di
-250-
prendere decisioni più ponderate. Esserepaziente vuole anche dire non lamentarsi.
4) Costanza. La pratica religosa non solonecessita di pazienza, ma anche di assiduità, dicostanza e sforzo. Ogni giorno sforzarsi direcitare la preghiera obbligatoria, di leggeremattina e sera i versetti sacri. Sono un inizio,ma se manteniamo questa condotta i fiorisbocceranno nel nostro cuore.
5) Meditazione. Potrebbe essere anche zazen,o preghiera. La pratica religiosa pereccellenza, cardine e fondamento di qualunquefede.
6) Saggezza. Argomento ostico da affrontare.Il termine sanscrito è Prajna e non basterebbeun volume per sercare solo di affrontare laquestione in termini generali.
Esaurito una prima esposizione dei treveicoli, venimao al secondo punto, profondamentebahai. La ciclicità del Sutra del Loto.
Come il racconto di manjushri ci fa inutire,ciclicamente il Sutra viene esposto da un buddhaed attraverso di esso la suprema legge vieneannunciata. Sutra e Legge coincidono, ed isingoli segni che manifestano visivamente ilSutra sono il corpo del buddha.Buddha=Legge=Sutra. Si prefigura lo scenario cheverrà meglio chiarito nel capitolo XVI.
-251-
Per qaule motivo viene esposto ad intervallicosmici il Sutra? Quando la legge inizia adeclinare e si entra nel periodo di mappo(declino assoluto della legge) appare un buddhaad insegnare la suprema legge per salvare tuttigli esseri viventi.
E' chiaro che il secondo punto è in buonasintonia con quanto insegna la fede bahai. E,tenendo conto che il Buddha sakyamuni fu unamanifestazione divina, ogni conseguenza logicatende a conclusioni bahai. Ma non bisognacorrere.
Chi narra è Manjushri, il quale narra di unevento simile a quello che staaccadendo, ma chevide lo svolgimento interminabili eoni addietro.Egli, terminando il racconto, dice che sia luiche Maytreia erano allora presenti, ma con nomidifferenti. Reincarnazione, rinascita? No, e mispiego.
Quando Masnjushri era il bodhisattva Mioko,il Buddha Nichigatsu-tomyo rivolse a lui leseguenti parole:
"Tu sei l'occhio del Mondo,in te ognuno può credere ed avere fede.Tu puoi onorare e sostenere il Dharma,la Legge che io espongotu solo puoi testimoniarla."
-252-
Parole forti, che indicano una primarietà diManjushri, il quale ha tre valenze, una mitica,una spirituale e l'altra umana.
1.Valenza mitica di Manjushri. E' larappresentazione della virtù per eccellenza: lasaggezza, intesa quale prajna e non conoscenzadi nozioni. La prajna è la conoscenza deldivino, che dischiude i cancelli del cuore eapre la nostra mente-anima alle dolci brezze chespirano dai giardini di Baha. Si ottine soltantoattraverso la pratica religiosa della preghiera-meditazione, della pazienza, del dono di sé, edell'osservanza dei precetti religiosi o decretidivini.
2. Valenza spirituale. Manjushri è lo Spirito Santo. Ovverosia l’emanazione energeticadivina, prana, archeus che dir si voglia. Se consideriamo la realtà divina come un sole, allora Manjushri è l’insieme dei raggi solari, la luce che innonda l’universo e che tutto pervade. O, ricollegandosi ad una parabola successiva tratta dallo stesso Sutra, è l’acqua del dharma che bagna ogni cosa.
3. Valenza umana. In questo caso è la manifestazione concreta e fruibile dai sensi, ovverosia vedibile everificabile, sperimentabiledella divinità.
In quest’analisi, ho voluto leggere il Sutradel Loto in un’ottica religiosa monoteistica,
-253-
inquewsto caso quella Baha, che ritengo essere l’unica religione basata sulla Rivelazione che meglio di chiunque altra sia in grado di affrontare le problematiche sociali, cultirali epsicologiche del mondo in cui viviamo. Ma questo, forse, sarà l’argomento di una prossima discussione.
Milano, 12 novembre 2008
-254-
3. La questione di Abramo
Sia gloria a Dio.Ed Abramo ricevette l’ordine di sacrificare
suo figlio al cospetto di Dio. Egli chiese,perché ciò? Onde provare la tua fede, gli disseDio.
Io penso che la prova sia stata duplice. E’possibile veramente credere che l’Oceano diVerità per un attimo solo abbia voluto il sanguedi quell’innocente? Ed è possibile che luiignorasse il fatto che una suo Profeta maiavrebbe potuto dubitare di Lui? Dove, allora, lanecessità del sacrificio? Quale lo scopo?
Dio non mise alla prova Abramo, in veritàEgli fece in modo che Abramo mettesse alla provaDio, iniziando non solo lo spirito, ma anche lamente alla verità universale. Per far ciò chieseall’uomo di sacrificargli il figlio, la cosa piùpreziosa che avesse al mondo. Abramo, allora,nella sua perplessità presumibilmente seguìquesto ragionamento: Questo Dio è arrivato danulla, si è proclamato come l’unico dio, haannunciato il mio obbligo a pregarlo e adessochiede come prova della mia fedeltà a lui lavita di mio figlio. Giammai dovrei fare unasimile cosa, foss’anche egli l’unico dioesistente; tuttavia, voglio metterlo alla prova:se egli non ferma il mio pugnale, allora lomaledirò e nessuna generazione a seguire si
-255-
ricorderà di lui; se lo ferma, allora il miocuore sarà per sempre suo, e il cuore sei mieifigli e dei figli dei miei figli.
Dio voleva dimostrare ad Abramo di esserepace ed amore, e per riuscire in ciò condusseAbramo sulla soglia del più grande atto diamore: il sacrificio della propria stirpe; nonper vedere se Abramo portasse a termine il rito,bensì per fermarlo sul momento culminante emanifestare la clemenza divina: Io non hobisogno della morte di tuo figlio, Abramo, perconoscere la tua fede in me, ma tu doveviconoscere la mia clemenza per amarmi.
Dal canto suo, Abramo aveva bisogno dellaconferma che quel dio fosse Dio, affinchépotesse essere da quel momento e in poi il diod’Israele.
Ho voluto dare un’interpretazione diversadel famoso passo biblico e, in effetti, sipotrebbe benissimo spostare l’accentomaggiormente sul pensiero di Asbramo, sulla suadecisione di sacrificare il figlio per metterealla prova Dio. Magari insinuando che Dio nellasua onnipotenza non sospettasse questo pensierodi Abramo.
Come molti altri passi della Bibbia, leinterpretazioni sono molteplici.
Milano, 13 novembre 2008
-256-
4. Natale
Scrivo queste note a un passo dallefestività natalizie.
Credete ancora in babbo natale, carebambine, convinzione che sia io che vostra madreabbiamo promulgato in seno alla nostra famiglia,consapevoli forse della bellezza di questo mito.Chiaramente, veràà un giorno nel qualescoprirete che non esiste nella realtàquotidiana, quella che tutti noi viviamo nolentio volenti, Babbo Natale. Non esiste nemmeno unpaese dove egli viva insieme ai suoi amici elfie folletti, tutto preso durante l’anno acostruire giochi.
Spesso, mi domando perché sia più facile farpassare per vero un mito come quello di B.N.piuttosto che parlare di Dio, di Gesù e diinsegnare all’interno della famiglia lareligione o la preghiera. Personalmente ritengoentrambi dei miti, e come tali non possonoessere etichettati con Vero o Falso, perché ilmito appartiene a un’altra categoriaconcettuale. Anzi, non è affatto una categoria,non almeno nel senso kantiano2 del termine. Delmito non si può dire che esista o meno,solamente che opera attivamente all’internodella nostra anima (pertanto, bisogna postulare
2 Kantiano: riferito al filosofo Kant, il cui pensiero ha
rivoluzionato il modo di intendere la conoscenza delle cose.
-258-
l’anima come ente reale per concepire il mitocome operatore fattivo – ma detto in questitermini ammetto che perda molto di poeticità).
Essendo un mito, Babbo Natale esiste neinostri cuori, nel nostro amore, ed è per questoche io e la mamma vi abbiamo parlato di luiancor prima che di Dio. Essendo una figuramitica scollegata da strutture religiosecomplesse (anche se la sua origine sembra esserelegata a San Nicola) il suo valore è piùsemplice e immediatamente intuibile da unbambino. Babbo Natale è colui che porta i doninel giorno della gioia e del radunarsi infamiglia. E’ un momento di pace, di serenità, dicalore consumato nell’intimità della sferafamiliare. E lo spirito natalizio incarnato dalB.N. non è gravato da chissà quali sentimentialtruistici o caritatevoli; è un piccolo spiritoche si occupa di piccole gioie, quotidiane eprivate.
Avrete il modo e il motivo, crescendo, diampliare il vostro orizzonte etico. Per adesso,babbo natale assolve egregiamente il modesto manon insignificante compito di rendere il vostroNatale un giorno speciale ed unico.
Milano, 14 novembre 2008
-259-
5. Giustizia e non vendetta
In questi giorni, i media (e mi riferiscoprecipuamente ai notiziari televisivi) hannoparlato spesso del processo imminenete agliimprenditori ritenuti responsabili dell’incendioalla famosa acciaieria Falk. Precisamente,ritenuti responsabili delle morte causatedall’incendio, in quanto sembrerebbe che lemisure di sicurezza e quelle antincendio nonfossero le più idoneo, ovvero fossero scarse enon verificate secondo un piano programmaticoben preciso, come vuole la normativa.
Comunque sia, sarà il dibattimentoprocessuale a far emergere la verità, o meglio,come sempre quando si tratta dei tribunali, avràla meglio ,a versione dei fatti che verààenunciata con maggiore coerenza e rappresentanzadi prove affidabili.
In merito non mi pronuncio, in quanto nonconosco bene i fatti e anche a conoscerli bene –attraverso i mezzi di informazione, ovviamente –non sarebbe mai sufficiente. L’esperienza mi hainseganto che quasi mai, se non proprio mai,l’esposizione dei fatti attraverso i mezzi diinformazione (mass media possiamo definirli) siarappresentativa di ciò che realmente è accaduto.Ritengo che i fatti, chiamiamoli pure i fenomeniche accadono nel mondo, non possono mai essereriferiti nella loro integrità. Già il
-260-
raccontarli, per parola o scritto o anche permezzo visivo, ne altera l’autenticità. Ma questoè un altro discorso che magari affronterò piùavanti.
Ciò di cui vorrei parlarvi, ora, è delladifferenza che sussiste tra giustizia evendetta, ifferenza che oggigiorno parrebbeessere venuta meno. E lo faccio in riferimento,appunto, a ciò che le televisioni fanno vederesulla faccenda della Falk, che poi il vero nomesarebbe Tyssen; ma questo è un particolareininfluente. Influente, al contrario, sono leinterviste ai familiari delle vittime.
Nessuno puà mai capire fino in fondo ildolore di una persona quando perde un faro, ameno che tu non sia una persona similmentelegata a quel caro; e per quanto tutti nellavita affrontiamo presto o tardi la perdita dipersone amate, ciò non basta e non aiuta acomprendere e ad essere partecipe del dolorealtrui. Dunque non mi soffermo qui a giudicare isentimenti di sofferenza dei genitori e dellemoglie e dei fratelli degli operai mortinell’inendio dell’acciaieria. Piuttosto vogliomettere l’accento sulle parole e i commenti diqueste persone all’indomani dell’accusaformalizzata ad alcuni imprenditori dell Tyssen,accusa di omicidio colposo e concorso inomicidio. Accusa pesante, terrificante in ambitolavorativo. Accusa accolta dai parenti con quasi
-261-
esultanza, gioia, esasperata soddisfazione;emozioni che innegabilmente lasciano trasparirei sentimenti di vendetta. Pià che giustizia èfatta, qui si tratta di vendetta è fatta, perchéla giustizia non deve punire chi a priori èconsiderato colpevole, e nemmeno ascoltare levoci colme d’angoscia e di dolore dei parenti.La giustizia deve essere talmente al di sopradelle parti che un giudice non dovrebbe esseresfiorato da coinvolgimenti emotivi, anche se ciòè impossibile, perché abbiamo un’anima e questaanima è una vera benedizione del divini. Ciònonostante, la giustizia deve essere lontanadalla vednetta, ed è per questo che i parentinon possono far parte del procedimentioprocessuale e ancor di meno dovrebbero essereintervistati onmde dar loro la possibilità diesultare o inveire o chiedere a voce altagiustizia, perché no, quella che chiedono non ègiustizia ma vendetta. Ed è comprensibile, ègiustificabile, è umano che la chiedano. E’giusto che sia così e non potrebbe esserealtrimenti.
Quello che dico è che non si tratta di unatteggiamento bello. E con bello, intendo Bello,perché il bello non è solo nelle forme, nellemovenzee nella musica, bensì anche nel modo diparlare, di pensare, di esprimersi, di estarnarei propri sentimenti. E dunque può essere belloanche il dolore, anche il pianto e la sofferenza
-262-
se vissuti nella propria anima senza lanecessità di sbandierarli al mondo televisivointero, quasi pervasi da questa necessitàindotta di protagonismo, di visibilità. Come sefosse più importante la visibilità del propriodolore, della propria sete di giustizia-vendettache il dolore stesso, che la giustizia stessa.Come se fosse un diritto che la verità emergadagli atti processuali, un diritto dei parentiavere giustizia, avere questa sorta disoddisfazione, come se dopo ci si sentissemeglio, come se fosse un sostegno a sopportaremeglio il dolore della perdita dei cari.
E così, il sapere delle persone in prigione,come la legge vuole che avvenga se ritenuteresponabili, potrà confortare gli animiaddolarati? Ridurre la peerdita, o meglio lamorte di una persona a un medro peso dabilancia, per pareggiare i conti nella nostranima? Soffro due pesi, ma se quello vienecondannato allora soffritò solo un peso perchéeuqll’uomo in progione vale un peso.
Non è un diritto dei familiari averegiustizia. Non è una pretesa che possonoaccampare. Per quanto il dolore della perditasia enorme, si tratta di un dovere dello stato,innanzi tutto. Lo Stato ha il dovere di faregiustizia, questa è la verità. E il dovere èsempre più forte del diritto.
-263-
Il dovere è l’assunzione di responsabilitàverso qualcosa o qualcuno, una persona, unasituazione o un principio. Il dovere è rendersiconto che ci sono imperativi morali, che inquanto esseri umani non possiamo condurreun’esistenza volutamente ignari del nostroprossimo. Il dovere è sapere essere coerenti conla parola detta e con la parola data.
E’ dovere dello Stato fare luce sugliaccadimenti ed era dovere degli eventualiresponsabili fare in modo che i sistemi diemergenza in caso di incendio funzionasserocorrettamente.
Milano, 18 novembre 2008
-264-
6. Medicine alternative
Tempo addietro ebbi una serie di discussionicon alcuni miei colleghi, inerentil’accertabilità e l’affidabilità di alcunemedicine cosiddette alternative. Non si riuscìad arrivare ad una conclusione largamentecondivisa, ognuno rimanendo sulle proprieposizioni, per una serie di ragioni, più o menosensate. Vi accorgerete, affrontando lerelazioni interpersonali, che spesso se nonsempre è quasi impossibile fare cambiare idea aqualcuno, così come lo è cambiare la propria.L’umiltà di ammettere un proprio errore, ocomunque di rivedere una propria idea o tesi èun valore poco conosciuto e ancor menopraticato. E’ vero che Pound mirabilmente disseche se un uomo non si batte per una propriaidea, allora o quell’idea non vale nulla oquell’uomo non vale nulla; ma ciò non significaevitare a priori e sempre di rivedere unapropria posizione anche dopo un’estenuantebattaglia che ci ha visto perdenti.
Ci sono molte cose che non conosco, altreche conosco poco, alcune che conosco in manieraaccettabile e pochissime che conosco bene. Manon mi difetta il senso critico e il vizio dianalizzare bene le questioni, da più punti divista possibili, grazie all’amore per lafilosofia, al tempo che ho speso per studiarla
-265-
al di fuori dei percorsi accademici, alleletture che continuamente faccio. E non è unatteggiamento mentale in contrasto con quanto viho spiegato nel primo di questi pensamenti (sulmito fondante necessario per lo sviluppo dellapsiche-anima) perché ritengo oramai da qualcheanno che poetica della vita e visionescientifica della vita possono coesisterepacificamente in quanto la nostra anima è ilfrutto di una realtà mitica che noiglorifichiamo nel nostro intimo, che alimenta lapsiche la quale non potrebbe trovaremanifestazione se non attraverso la mente(l’operatività di una parte del cervello) e ilmondo diciamo “materiale” (che comprende ilnostro corpo, ovviamente); il quale mondo puòessere investigato solamente dagli strumentimessi a punto dalla scienza in così tanti secolidi duro lavoro.
Anche questo è un argomento sul quale vorreitornare successivamente, in altro momento. Orami preme ritornare alla questione delle medicinealternative, alla discussione avuto con i mieicolleghi che per quanto tecnici di laboratoriorimangono fermi in posizioni del tutto estraneea una sana prassi scientifica.
Se il nostro organismo risponde a leggi benprecise (molte delle quali ancora da scoprire èvero, ma pur sapendo in anticipo che una leggedella natura non può che rispondere a criteri
-266-
matematici e logici) che sono state formulate (oscoperte, anche qui altra discussione da aprire)secondo criteri metodologici condivisi da tuttala comunità scientifica, come è possibileintervenire medicamente su tale organismoattraverso interventi che non tengano conto diqueste leggi? Non solo, come tenere conto dimedicine che si basano su assunti assiomatici edogmatici, a volte vecchi di secoli se non dimillenni, che non possono essere verificati davalide e ripetibili sperimentazioni dilaboratorio?
L’omeopatia ne è un esemplare esempio. Nonstarò qui a soffermarmi in un trattato didivulgazione omeopatica, lasciando a voi ilpiacere di andare a cercare informazioni, se loriterrete opportuno, preferendo evidenziarel’aspetto del tutto pseudoscientifico di unabranca della medicina i cui cultori vogliono farpassare per scienza tout court. Senzaconsiderare il largissimo consenso che trova trala popolazione o tra la gente che dir si voglia.E’ incredibile come nella nostra societàoccidentale così ricca di opportunità direperire informazioni e notizie su pressochétutto, ancora ci siano vastissime sacche diignoranza scientifica. Anzi, di ignoranza diragionamento. A volte mi viene da pensare chesia più opportuno parlare di sacche di buonsenso perse in un mare di ignoranza. Che poi non
-267-
è giusto, perché molte persone che conosco lequali fanno ricorso alle prescrizione di mediciomeopatici, non posso certo definirle ignoranti,anzi. Sembrerebbe che costoro abbiano necessitàdi credere in qualcosa che trascenda la scienzae la realtà, un loro mito, una sorta direligione, tuttavia non rendendosi conto che lareligione si fonda su un mito che deve essereconsiderato come realtà mitica dell’anima, edunque non solo non investigabile dalla scienza,ma neppure usabile come strumento di scienza.Questo è il punto fondamentale.
Eppure la psiche può influenzare la nostramente, il nostro umore, talora, forse, anche lanostra salute. Le emozioni e i sentimenti, sepur riconducibili a fenomeni biochimici, cipermettono di gioire, meravigliarci, amare esoffrire; pertanto non devono essere abbandonatinelle mani fredde della scienza, ma allevati omeglio riscattati all’interno di una narrazione,di un mito. Ma che non è, ripeto ancora unavolta, qualcosa di cui si possa dire è vero o èfalso, esiste o meno, è verificabile ofalsificabile. Il metodo della falsificabilitàdeve essere un felice strumento per demarcare lascienza dalla pseudoscienza; l’arte – dunque ilmito e la religione – non sono pseudoscienza, malo diventano se con essi si vuole proporre unostrumento alternativo per analizzare come è
-268-
fatta la realtà e quali sono le sue dinamiche eleggi.
Ecco, dunque, che partendo da un discorsointorno alle medicine alternative sono arrivatoa definire i contorni di una più ampia einteressante discussione: come e perché nonconfondere l’arte con la scienza. E come eperché uno spirito ricco di arte e di scienza, ocomunque felicemente sensibile su entrambi icampi. Sia uno spirito Bello.
Milano, 20 novembre 2008
-269-
7. I tarocchi
Ho iniziato lo studio dei tarocchi dagiovane, più o meno in concomitanza con le mieprime letture di magia cerimoniale e diesoterismo occidentale. Non ricordo esattamentequando nacque in me questa passione, più o menomentre frequentavo le scuole medie e sono sicuroche i primi testi li lessi mentre frequentavo laterza media.; ma cosa mi abbia spinto verso taledirezione non lo so, ameno che non mi rifacciaalla teoria del daimon.
Unitamente allo studio della magiacerimoniale, che alcuni chiamano ancheoccultismo o scienza occulta, mi dedicai anchealle prime letture sul buddismo, e per moltianni questi due interessi sono proseguitiparallelamente. Ultimamente, almeno mentrescrivo queste note, ho perso ogni interesse perle scienze occulte, mentre proseguo sempre nellostudio del buddismo.
Tornando ai tarocchi, nel corso degli annisono riuscito a comprendere e realizzare chesarebbe stato un errore continuare a vederli conun’ottica di studioso di essoterismo. Per quantonel secolo XIX siano stati spesso affiancatiallo studio della Qabalah (una forma esotericadel giudaismo, anche e si tratta di unadefinizione molto ambigua), mi sono accorto chehanno un profondo valore psicologico e mitico, e
-270-
mi hanno aiutato in tal senso le letture di Junge Jodorowsky. E specialmente quest’ultimo èstata la guida che mi ha aiutato ad ampliare lavisione dei tarocchi quale compendio archetipicodell’essere umano.
Pertanto ci tengo precisare che i tarocchi,se da una parte possono ancora (e lo sono,purtroppo) usati ascopi divinatori, dall’altraparte sono dei mezzi terapeutici di valoresquisitamente psicologico. Le figure delle lame(o carte o arcani che dir si voglia) sonomiraboli simboli che se osservati con occhipoetici ci possono aiutare a fare luce sullanostra anima. Io stesso li uso a questo scopo enon vengono mai meno alla loro natura.
L’eesere umano è essenzialmente un animalemitopoietico, come avrò modo di dire spessevolte in questi pensamenti, e i tarocchi siprestano ottimamente ad evidenziare e stimolarequesta qualità; infatti una giusta e sincera edemozionante lettura delle carte si potrà daresolo se si sarà in grado di comporre unanarrazione partendo dalle lame uscite durante iltiraggio.
E più sarà complesso e ricco il racconto,maggiore sarà la possibilità che si possaapprofondire la nostra anima.
Io vi consiglio lo studio dei Tarocchi,possibilmente di quelli marsigliesi nellavariante proposta dallo stesso Jodorowsky.
-271-
8. Mio padre
Voi non avete conosciuto mio padre, ilvostro nonno paterno, e non so ancora adessodirmi se sia stato un ben o un male. In realtà,non so ancora adesso quale sia il mio verosentimento verso di lui, anche perché non ho maiaffrontato criticamente questo argomento. Trannequalche sporadica riflessione, dopo la sua mortenon ho avuto la forza per propormi di rivedere edi capire l’importanza e l’influenza dellafigura di mio padre nella mia vita. Non ne homai parlato e quando leggerete queste righe èprobabile che voi sarete le prime persone asentire le mie confessioni.
L’ambiguità del rapporto con mio padre nascein un momento preciso e continua tuttora, inquanto vado quasi costantemente a trovarlo alcimitero e tengo appesa al muro del mio studiouna sua foto (precedentemente appesa addiritturain camera da letto). I ricordi di porzioni dellamia vita dove lui è presente vengono spessorivisitati dalla mia coscienza, a volte con unforte senso di nostalgia e malinconia, a voltecon una certa perplessità, spesso concompassione. Mai con rabbia, anche se cisarebbero valide ragioni affinché ciò avvenisse.
Compassione e perdono; e comprensione.Questi i tre sentimenti principali che provoverso mio padre. Compassione per le sue
-273-
sofferenze. Perdono per il suo comportamento.Comprensione come giustificazione di ciò chefece e disse.
Negli ultimi anni, se non mesi della suavita, quando il tumore oramai lo aveva invaso,era cambiato, forse ritornando alla sua veranatura che per molto tempo era stata deturpata efuorviata da quel giorno fatidico. Il giorno chei dottori finalmente sentenziarono la lorodiagnosi sulla malattia di mio fratello Daniele.
Ci sono giornate, inserite e sommerse nelnostro passato, che spiccano per un particolareche non potrà mai abbandonarci; una forteemozione, solitamente, legata a immagini oeventi, momenti di forti sensazioni, circostanzeche nel bene come nel male avranno la qualità dicambiarci la vita, oppure di modificarlasostanzialmente. Simili giornate sono come punticardinali, mattoni fondanti, e per chi amaritornare spesso nei propri ricordi, sono tesorida custodire con parsimonia, sia che portinoalla luce sofferenze, sia che faccianoriaffiorare piacevoli sensazioni.
Quella fu una di queste giornate. Avevo pocopiù di dieci anni e mi accingevo ad iniziare lescuole medie, l’adolescenza si stava affacciandoe l’infanzia arretrava, rimanendo nel limbodorato dell’età fanciullesca. Ricordochiaramente mio padre seduto sul bordo del lettoche piangeva e io impacciato nel tentativo di
-274-
consolarlo. Solo ora capisco quanto inutilefosse e solo ora, padre come lui, comprendoquanto enorme e schiacciante possa essere statoil dolore.
Da quel giorno, lentamente, o forserepentinamente, non so, perché ora mi sfuggel’arco di tempo entro il quale casa mia sitrasformò in un luogo invivibile per me.Invivibile per chiunque. Mio padre diventavasempre più nervoso, irascibile e mentre ioentravo nell’adolescenza il clima in casa sifece teso, mio padre litigava continuamente conmia madre, urlava, bestemmiava, la insultava permotivi sempre e comunque banali. Quando uscivodi casa mi vergognavo nell’incontrare i vicini,perché supponevo che tutti sentissero le urla ele bestemmie di mio padre. E da sempre sonosicuro che la principale ragione della miaadolescenza solitaria e introversa e del miototale chiudersi sia stata il comportamento dimio padre. E pensando a mio fratello William,giusto riparlandone l’altro giorno con miamadre, del suo periodo negativo alle scuoleelementari ed anche del successivo bassorendimento scolastico alle medie e allesuperiori (tanto che non ebbe il desiderio diportarle al termine) come non posso orariportare tutto ciò al comportamento mio padre ealle nefaste conseguenze di due bambini increscita evolutiva?
-275-
Il periodo delle mie medie fu sicuramente ilpiù terribile, poi non so se feci l’abitudine oaltro, ma sicuramente le cose non tornarono piùa posto, come si suol dire. Non nego chesuccessivamente, specialmente quando terminai lascuola, non nego che ci furono deimiglioramenti, ma è certo che il bel periododella mia infanzia non è mai più tornato. E daciò deduco che William, che l’infanzia l’havissuta nell’inferno, non ne abbia una bella daricordare.
Ma ciò non vuol dire che noi tre fratellinon ci siamo aiutati a vicenda, e che non siamostati uniti. Girammo l’Europa insieme, quandoancora Daniele poteva guidare e camminare esuccessivamente io e William uscivamo insieme,specialmente per andare al cinema. E con lamalattia di mio padre, con il tumore che locolse a sessant’anni, ebbi modo di vedere miamadre con occhi differenti, così come vidi miopadre non più con cuore astioso.
E’ difficile spiegare che malgrado tutto, hosempre amato mio padre e che forse l’ho perfinoperdonato e che ora tengo una sua fotografia eprego nei giorni del suo compleanno e della suamorte. E qui non nego nemmeno di pensare che iltumore venne come punizione, o meglio, comemalvagia fioritura del cattivo karmaaccumulatosi negli ultimi anni. Non unapunizione divina, giacché non credo che la
-276-
realtà divina si occupi di giudicare esentenziare intorno alle faccende umane;piuttosto un’autocondanna, un giudizio che miopadre si è dato da solo, con il suocomportamento. E questo riguarda tutti noi,bambine mie. Siamo i giudici di noi stessi, eciò che facciamo ricadrà su di noi, inbenevolenza o in disgrazie.
Non voglio più aggiungere nulla, per ora,sapendo che sicuramente ritorneròsull’argomento, in questo mio rileggermi ilpassato.
Milano, 30 novembre 2008
-277-
Prolegomeni successivi
Tempo addietro presi a modello l’Albero della
Qabalah, per ordinare la mia crescita spirituale
all’interno di una narrazione diaristica. Col tempo
l’entusiasmo si smorzò ed io fui preso da altre
incombenze e passioni. Terminai il primo volume –
coincidente con la sfera mistica di Malkuth – in
prossimità della mia conversione alla Fede Baha’i, dato
che ritenevo che quell’atto di immersione religiosa
potesse significare un importante passo di crescita e
maturità interiore.
In realtà le cose sono andate diversamente, ed ora
mi trovo ad iniziare questo nuovo volume del Diario
Assoluto subito dopo la mia rinuncia alla Fede sopra
menzionata. E’ passato quasi un anno, nel quale la mia
vita ha subito scossoni e raddrizzamenti. Ora,
presumibilmente, credo di essermi incanalato nella
direzione giusta… che è non avere nessuna direzione
giusta, bensì assaporare il mondo col cuore e vivere
l’attimo con gioiosità.
Questa nuova sfera mistica – detta Yesod (ed un
giorno disserterò un poco sull’Albero) – nasce e si
sviluppa in un incrocio di accadimenti che non mi
possono lasciare indifferente… tutt’altro! Li vorrei
elencare, giusto per far comprendere a me stesso che la
-278-
vita è costellata di segni che è bene non ignorare ed a
maggior ragione trascurare.
Non sono elencati in ordine di importanza, dato che
l’ultimo è il fiore più bello del mio giardino. Qui non
si tratta di organizzare delle classifiche; si tratta,
piuttosto, di saper valutare la portata di ogni singolo
avvenimento ed il valore della loro coincidenza.
Una nota prima di proseguire. L’anno di sosta fra
una sfera mistica e l’altra mi ha visto impegnato a
compilare una sorta di diario di autoanalisi, una sorta
di percorso terapeutico basato sui principi rivelati nel
libro “La profezia di Celestino”, fra i quali quello
sulla fondamentale importanza delle coincidenze. Jung
parlava di sincronicità, ma non sono qui a fare una tesi
sullo sviluppo della psicologia. Ciò che conta è che
quel libro, per coincidenza (!), ha scatenato una serie
di eventi che mi ha condotto all’apertura di questa
nuova serie di riflessioni.
Ma voglio tornare ai tre accadimenti.
1- Rinuncia della Fede baha’i
2- Lettura del libro “Il codice dell’anima” di
Hillman
3- Il bambino che Barbara sta crescendo dentro di sé
-279-
Ne devo parlare adesso? Ne faccio argomento di
capitoli successivi? Non lo so. Adesso preferisco
rimanere in questo prologo come un piccolo poeta sui
sentieri di un placido giardino, magari sul ponticello
di pietra ad ascoltare il canto dell’acqua che fluisce.
La vita non è solo un dono… anzi non è proprio un
dono. la vita è l’unica realtà, è la verità
indubitabile, è la ragione che spiega l’universo. Non il
contrario. La vita esisteva prima dell’universo, ne era
il mito, l’archetipo formativo. Tutto questo, per
annunciare un cambio di registro che lascia sorpreso –
piacevolmente debbo ammettere – il mio spirito
razionale.
Voglio terminare dicendomi che questa nuova sfera
mistica mi induce a ripropormi differentemente
all’interno del nuovo volume del diario. Non più le
lettere dell’alfabeto ebraico, bensì il nome delle varie
fasi di crescita dell’adepto delle arti esoteriche ed
occulte: neophita, zelatore, practicus, etc.
Non posso che augurarti buon lavoro, Nataniele.
N.B.
-280-
Prima di iniziare ho piacere nel raggruppare quelle
poche riflessioni accumulate in questo anno di pausa tra
una sfera mistica e l’altra.
-281-
Introito all’altare della Sfera Mistica
Fiori di acqua e luce – 22 giugno 2000
Una nuova raccolta di poesie, per lodare e
commemorare l’importante svolta della mia vita. Ma quale
svolta?
Una svolta che comporta nuovi impegni, una maggiore
responsabilità, una riqualificazione del mio
comportamento, un sistema di riferimento che esige una
continua ricerca della verità.
Il 13 giugno, in un negozio di tappeti orientali,
alla presenza di due credenti, ho dichiarato di volere
essere ammesso nella comunità baha’i. La mia vita non
può più essere quella di prima, pur rimanendo
esattamente quello di prima. Quello che è accaduto, è
una rivalutazione. Consapevole del ruolo dell’uomo e
dello scopo della Rivelazione, non posso più guardare il
mondo con gli stessi occhi. Ecco che urge l’impegno di
ridisegnare la mia filosofia e di pormi dei progetti che
implichino la ricerca della verità. Essa, la ricerca, è
un dovere morale dell’uomo, che non può semplicemente
accettare una fede o un credo senza avere lottato e
studiato; ed anche dopo, non si deve rilassare ed
-282-
abbandonare nella culla delle sacre scritture, ma
rimboccarsi le mani ed esplorare i vastissimi
possedimenti degli insegnamenti, per trovare sempre
nuovi percorsi.
Personalmente, sono interessato ad una rilettura dei
sutra buddhisti primitivi nella luce degli scritti
baha’i, e ad una nuova interpretazione del Dharma così
come è studiato nello Zen. Voglio portare gli
insegnamenti del Buddha nella luce di Baha’u’ullah,
collocando il Perfetto Risvegliato fra i Messaggeri
Divini la cui filosofia è ancora valida nella società
odierna.
-283-
Forse non si cresce mai – 4 luglio 2000
Nella vita non si impara mai nulla, tanto meno si ha
la possibilità di crescere, o modificare il proprio
carattere, e men che meno di migliorare, nello spirito,
nel carattere, nella moralità. Si nasce e si diventa
quello che si è, assolutamente senza scostarsi. Se si ha
l’impressione di cambiare, allora si è preda di
un’illusione; in realtà quello che succede è solo un
allineamento con la nostra vera identità. Prima si era
mendaci, artefatti, sbagliati, con lo studio, la
ricerca, la meditazione ci avviciniamo al nostro io, ci
identifichiamo con esso, diventiamo esso e finalmente
nasciamo per quello che veramente siamo. Dunque, non
cambia nulla, solamente ci si avvicina o ci si allontana
dalla propria identità.
L’identità è il nostro Io. Quando nasciamo, esso è
ben preciso e nitido, ma noi non lo conosciamo, lo
ignoriamo e se il nostro karma è favorevole, forse
abbiamo la possibilità di iniziare una ricerca di esso;
prima di avere di lui una intuizione, in seguito di
iniziare una questua, meticolosa o superficiale. La
nostra vita è tutta qui, capire che abbiamo un Io, e
cercare di allineare la nostra vita su di esso.
-284-
Ma questo Io, mi chiedo, ha un valore morale, dei
parametri caratteriali, insomma qualità, positive o
negative che siano? Se non lo conosciamo, come facciamo
a cercarlo? E se fosse una pura illusione? Ed il karma,
in che misura rientra nella relazione Io e corpo?
Bisogna ristrutturare tutto. Allora, esiste il sé,
del quale nessuno sa niente. Esso è già quando nasciamo,
ma non è l’anima. Il Sé è la nostra vera natura, la
natura autentica, quello che siamo e che dobbiamo
riscoprire, perché la società lo ricopre di illusioni.
Poi abbiamo l’ego, che è frutto del karma. L’ego è
quello che siamo in apparenza, la forma, ciò che vediamo
a prima vista in un nostro simile, così come in un
animale, od in una pianta. Anche l’universo ha un ego,
ma è molto più difficile distinguerlo dal suo Sé.
Il Sé è l’essenza, l’Ego la forma. Il karma è
l’effetto delle nostre azioni, la nostra manifestazione
nella realtà concreta, immanente. Ciò che diciamo,
pensiamo e facciamo (le opere con il corpo) modifica la
realtà, in modo minimo o massimo. E’ il karma. Il karma
dei nostri genitori ha parzialmente effetto su di noi,
conseguentemente è giusto dire che una parte di loro
rinasce in noi, e non solo geneticamente. Il nostro
karma lavora sul nostro Ego, ma non sul Sé, che è già
quello che è.
-285-
L’anima è la natura divina, è una bolla spirituale
collegata al nostro Ego (corpo è Ego) che si forma al
momento della nascita e cresce fino alla morte del corpo
fisico. In quel momento avviene un trapasso. La
coscienza (il residuo della nostra esperienza) trapassa
nell’anima, ed inizia una nuova vita.
In realtà, le cose non avvengono così. Io non so
come avvengono. Baha’u’llah ha le idee chiare, come suo
figlio e diversi altri illuminati. Io ho solo due
possibilità: o affidarmi alle parole del Messaggero, o
iniziare una ricerca seguendo le sue indicazioni, ma
basandomi soltanto sulle mie forze. La seconda è quella
che preferisco. Certo, ogni tanto potrei chiedere un
conforto alla Divinità, il Gloriosissimo, ma non voglio
fare affidamento su di lui: mi ha dato abbastanza forza
per arrangiarmi da solo.
-286-
Nitsche ha sbagliato tutto – 5 settembre 2000
Sono passati alcuni mesi, per me un arco di tempo di
riflessione. Una parte di questo diario è dedicata allo
studio delle dieci illuminazioni, dato che ho intravisto
nel lavoro di Redfield del buon materiale di lavoro.
Adesso sono qui per parlare di Nitsche, il pensatore
e filosofo tedesco. Sto leggendo il suo “La volontà di
potenza” e mi sono accorto che il grande filosofo parte
da presupposti completamente sbagliati. Per questo tutto
quello che ne segue è errato; tuttavia non si può negare
a Nitsche il merito di avere scardinato l’ipocrisia
della civiltà occidentale, la falsa morale che ci sta
corrodendo da dentro. Ma sbaglia nel considerare il
nichilismo come la conseguenza di due millenni di
cristianesimo, come l’effetto, il contraccolpo di un
atteggiamento umano lontano dalla legge dell’andare al
di là del bene e del male. Nitsche considera l’intera
morale un’invenzione della civiltà corrotta cresciuta
nel cristianesimo, e come tale non corrispondente alla
realtà, non vera, e dunque superabile. Nitsche parla di
ceti bassi e medi che innalzandosi hanno causato
deturpazione e a lungo andare il nichilismo.
E’ vero, il nichilismo, l’esaurimento nervoso e
psicologico, la caduta dei valori, sono una diretta e
forte conseguenza di secoli di morale imposta e non
-287-
sentita nel profondo. Questa verniciatura ha portato
alla commedia, ovverosia alla recita di palinsesti in
cui nessuno crede.
Per descrivere bene questa situazione di lassismo,
Nitsche pone una similitudine con il buddhismo.
Chiaramente, Nitsche non sa nulla del vero buddhismo;
evidentemente ai suoi tempi gli studi degli insegnamenti
del Buddha erano a livelli bassissimi.
Non solo, Nitsche, come qualunque altro pensatore
occidentale, di ieri e di adesso, confonde l’occidente
con l’intero mondo. L’occidente che ci culla è un’isola
di felicità, una porzione minima che ben poco ha in
comune con il resto del mondo. Esistono civiltà e
culture che non contemplano sistemi di pensieri simile
al nostro e dove i parametri morali ed etici sono
dissimili, a volte alieni. Per questo, in vero, non
esiste un nichilismo, se non nella civiltà occidentale.
Noi parliamo, consideriamo, analizziamo, ponderiamo e
forgiamo complesse teorie sociali e filosofiche… ma che
ne sappiamo del Butan? O cosa pensano gli aborigeni
australiani del comunismo, di Dio e della pensione?
Fortunatamente non esiste solo l’occidente, e non lo
dico perché non mi piace viverci… anzi, non saprei come
farne a meno! Lo dico perché le nostre previsione
risultano invariabilmente errate. Scommetto che Orwell,
che tanto temeva il comunismo, nemmeno gli passò per
-288-
l’anticamera del cervello che l’Europa sarebbe stata
sommersa da un’ondata di migranti nordafricani.
Un saluto.
-289-
Frammenti di illuminazioni – 11 settembre 2000
Spesso capita, fenomeno ignorato e sottovalutato –
d’altronde viviamo in una società consumistica dove le
rivelazioni dell’istinto non sono considerate, e,
dall’altra parte, tutti si gettano sulle apparizione
miracolose che sono solo allucinazioni di massa – magari
ascoltando della musica, o guardando un bel panorama, o
leggendo un libro, di sentire improvvisamente una
profonda chiarezza attorno ad un argomento che ci
angustiava. In verità, queste meraviglie accadono nella
congiunzione di due sensazioni, di due esercitazioni dei
nostri sistemi sensoriali (nel senso buddhista del
termine, s’intende); quando cioè si riflette
sull’argomento in questione nel mentre si ascolta una
particolare musica o ci si trova immersi nella natura
incontaminata. Insomma, le condizioni possono essere
molteplici, e differenti da individuo ad individuo. Ma
il risultato è identico: l’improvvisa illuminazione.
Certo, bisogna essere sinceri, ed affermare che sono
illuminazioni d’importanza secondaria, e che spesso si
perdono nel tempo e nella coscienza (od incoscienza?).
Capita che cammini, ed improvvisamente comprendi la
frase criptica di un maestro, o il significato delle
stelle, o più banalmente le profonde implicazioni di
-290-
un’affermazione apparentemente senza senso, o di una
semplicità che ha del quotidiano.
Oggi, mentre mi sedevo, improvvisamente ho capito
per quale ragione è stato Ryusui Roshi ad ereditare il
Dharma dal maestro Deshimaru. Semplicemente, ha
sviluppato un suo zen, molto particolare, oserei dire
geniale. Chi pratica zen sembra essere fatto con lo
stampino, un sacco di citazioni in testa, il sorriso
ebete in faccia, la testa rapata… le solite cose,
insomma. Ryusui Roshi è diverso, non cita, non ha la
testa rapata e ride solo quando bisogna ridere. Parla
del Dharma senza parlare del Dharma. Ecco per quale
ragione a lui Deshimaru Roshi ha consegnato il Sigillo.
-291-
PARTE PRIMA
La verità non è istituzionabile (30/04/01)
Per alcuni mesi ho creduto, o meglio cercato di credere che la verità possa essere espressa all’interno di una istituzione. Naturalmente mi sto riferendo alla verità metafisica, o trascendentale… alla verità che spieghi l’universo non nella sua modalità (per questo abbiamo la scienza) bensì nella sua essenza (posto che abbia un’essenza) nella sua ragione prima ed ultima di esistere. Ho creduto di ravvisare ciò nella Fede Baha’i, ma ora, dopo attenta analisi, mi accorgo che i motivi erano ben altri.
Bisogna sempre essere sinceri con se stessi, per
quanto questo possa essere causa di sofferenza e
disagio. In questo caso, l’esame riflessivo che mi sono
imposto a rilevato la causa principe della mia
conversione alla fede suddetta. La ricerca della verità,
purtroppo non ha nulla a che fare, dato che rimango
legato (e lo sono rimasto nella mia breve vita di
baha’i) alla visione buddhista dell’universo. Il motivo
era semplicemente quello di rompere la tradizione
cattolica, di slegarsi dai falsi ed ipocriti costumi
della società italiana. In particolare, mi riferisco al
-292-
battesimo, perché è da quando abbiamo deciso di cercare
un figlio, che mi angustio sul fatto del battesimo.
Il battesmo è un rituale oramai svuotato della sua
sacralità, imposto ad un incosciente da persone che per
la maggiore non credono nel dio cristiano, o ci credono
solo per costume. Personalmente, andare all’altare con
mio figlio tra le braccia di mia moglie, affermare di
credere in dio padre ed in suo figlio sono gestualità e
verbosità senza senso. Tuttavia, sono ben consapevole
degli ostacoli cui posso andare incontro annunciando
questo mio pensiero. Già una volta mia moglie mi ha
fatto notare che la tribù dei bambini potrebbe isolare
nostro figlio, se non fosse battezzato. Io non credo che
ciò possa accadere, anche se sono consapevole che la
possibilità esiste. Ciò che pavento maggiormente, è
l’incomprensione della mamma di Barbara, così
apparentemente legata alle tradizioni. ma, in ultima
analisi, che senso fare battezzare un bimbo da genitori
che non credono nella fede cristiana e cattolica in
particolare?
Ecco, mosso dalle riflessioni sopra riportate, fui
spinto a convertirmi alla Fede Baha’i. Successivamente,
i malintesi nati con Barbara e non per ultimo la mia
idiosincrasia per le istituzioni religiose e idee
personali non collimanti con la rivelazione di
Baha’u’llah mi hanno spinto a rigettare la fede.
-293-
Ora vivo in una situazione quasi angosciante. Certo,
formalmente rimango un bahai, ed è questo che dirò al
prete quando Barbara mi costringerà ad andarci a
parlare. In ciò sarò fermo di proposito.
La religione, per tornare al titolo di questa
riflessione, cosa mai è se non l’approccio della nostra
anima all’anima del mondo? Se non la risposta che ognuno
si dà ai dilemmi che l’animo umano si pone da millenni?
Ognuno ha la sua risposta, ed omologarla e rinchiuderla
in un’istituzione con le sue regole ed organi è
deprimente e squallido; non solo, è quanto mai
antiproducente, perché limita la sensibilità e la
creatività dell’individuo. La rivelazione può essere uno
specchio della verità, e forse un dio, o il dio unico,
ha parlato all’uomo per trasmettergli la sua verità, ma
ciò non toglie che piegare la propria mente ed il
proprio spirito ad un insieme di conoscenze sia una
sorta di impastoiamento della creatività umana… e la
creatività è la qualità che fa dell’essere umano un
essere speciale.
Io non nego la veridicità della Fede Baha’i,
tantomeno la sua validità sociale. Semplicemente, la mia
visione religiosa è una visione mitica e poetica, che
necessità dell’assoluta libertà di inventare nuove
configurazione di simboli e miti, di iniziare nuove
mitopoiesi. Postulata l’esistenza di Dio e la sua
-294-
Rivelazione, rimane fatto ineludibile la sua assoluta
libertà di pensiero, che tende all’indipendenza da credi
preconfezionati.
-295-
L’anima che è noi (03/05/01)
Non bisogna negare l’anima.
Bisogna imparare a ragionare evitando di utilizzare
gli strumenti cognitivi modellati dalla civiltà
occidentale, e mi riferisco alle meccaniche logico-
verballi, al raziocinio. E’ tempo che l’uomo guardi se
stesso – e di conseguenza il mondo – con gli occhi del
bambino, con la meraviglia del bambino. Mi voglio
spiegare ulteriormente.
Per secoli, dalla rivoluzione rinascimentale,
l’occidente ha posto barriere tra la fantasia,
l’immaginazione da una parte e la logica (sinonimo di
verità) dall’altra. La religione è diventata questione
di fede dogmatica ed una valvola di sfogo per sedare le
angosce per ciò che il raziocinio non spiega. Abbiamo
definito i miti come favole e leggende e costruito la
nostra storia su basi prettamente causali e matematica
(siamo il prodotto, anzi, il risultato di azioni e dna e
fattori ambientali). Tutto ciò che comportava il mondo
dell’immaginazione è stato alienato nel suo limbo, come
diversivo ed evasione. Il mito è diventato evasione – ed
io mi riferisco al mito non nell’accezione postmoderna
tanto cara alla società consumistica, dove non è che la
rappresentazione del modello ideale di vita. Io parlo
-296-
del mito come lo intendevano gli antichi greci… e come
lo intendono ancora adesso gli aborigeni australiani. Il
mito come serbatoio del nostro essere uomo. Come origine
dell’uomo.
L’anima va ripescata da questo serbatoio, e mondata
dai preconcetti scientifici e religiosi (e qui mi
riferisco alle fedi di ceppo abramico). Non ci servono
prove scientifiche, per ciò, perché non v’è nulla da
verificare. Ricominciamo a guardare il mondo con occhio
infantile, per scoprire la meraviglia, ed essere come
quegli esploratori medioevali, come i mercanti sulla
vita della seta che tornando dai paesi dell’oriente
parlavano di tetti d’oro, uccelli giganti e donne dalle
innumerevoli mammelle. Riprendiamoci i miti che abbiamo
cacciato, e riconquistiamo gli déi. Jung diceva che gli
déi sono diventati malattie. Io dico che abbiamo ucciso
gli déi ed essi sono ritornati sottoforma di malattie
(mentali), vizi peccati. Ridiamo l’anima al mondo.
Abbiamo un’anima, non concepibile razionalmente,
essa proviene dai miti, dagli archetipi, ed essa è la
nostra vera natura. Essa ci rappresenta e si esterna
attraverso le emozioni ed i sentimenti. La sua è
un’esistenza prettamente artistica, creatrice e di
improvvisazione; nostro compito è ridarle dimensione,
scoprire il suo ruolo nel mondo e vivere la vita come
un’avventura, come una sperimentazione teatrale.
-297-
Il mito dell’anima… non è affascinante, questa
frase? L’anima, questa entità astratta, incorporea,
questa illusione. Ma cosa è un’illusione? Non esiste
l’illusione, tutto è verità, tutto si concretizza in noi
e dato che noi il risultato dei nostri pensieri, delle
nostre azioni, dei nostri sentimenti… non è sciocco
ridurre le illusioni, le chimere, i sogni a mere
fantasticherie? No! Esse sono il pane dell’anima. Di
più, esse sono le parole dell’anima, il suo parlare, il
suo dire, il suo essere.
Il mito dell’anima. Parliamone, allora,
proclamiamone l’esistenza, facciamone un novello
vangelo… ma no! Non esiste la rivelazione, non esiste un
dio creatore staccato dalla sua creazione. Gli dèi sono
i canali energetici dell’universo, sono nati con lui e
moriranno con lui. L’universo è più meraviglioso di
quanto scienza e religione rivelata ci insegnino, non è
solo la conseguenza del big bang, non è solo la
creazione di dio… è la manifestazione del mito. E’
l’espressione, il parlare dell’anima universale, la sua
continua improvvisazione, è il percorso del mito nelle
leggi fisiche. E la nostra anima è uno specchio, od una
figlia, od una goccia di quest’anima universale, di
questo Grande Spirito, di questo Brahaman… ma
attenzione! Non è un dio creatore e legislatore,
separato dalla sua creazione. E’ la creazione stessa,
-298-
così come noi siamo la nostra anima che si manifesta,
siamo l’anima stessa che inventa ed interpreta il suo
mito.
L’anima è un’immagine archetipica, come tale non ha
una collocazione precisa, non ha proprio collocazione.
Non esiste una dimensione dell’anima, se non quella del
mito. Dobbiamo sforzarci di pensare diversamente, di
ideare nuovi approcci al mitico che è in noi… anzi, dirò
di più, nuovi approcci all’esistenza in genere. La vita
è un’esplorazione del meraviglioso, cerchiamo di essere
come gli esploratori medioevali. Come gli studiosi
medioevali, che immaginavano animali chemerici e
catalogavano con criteri irrazionali.
Il mondo ha bisogno di occhi da bambino. ha bisogno
di ingenuità.
-299-
La sacralità della vita (07/05/01)
Barbara ha comprato un libro divulgativo sulla
gestazione e tutto ciò che è legato a ciò in ambito
emotivo, affettivo, alimentare ed altro ancora. C’è un
disegno - un quadro illustrativo – che mi ha colpito
notevolmente. Sono rappresentate le varie fasi di
sviluppo del bambino (infans, è chiamato nel testo),
dallo stato embrionale, a quello fetale fino al momento
del parto. Ho scoperto che a otto settimane, la creature
ha già un abbozzo di arti, la testa, il taglio degli
occhi e naso e bocca comunicanti. Il suo cuore batte (è
la prima cosa che accade, e questo dovrebbe indurci a
riportare l’attenzione sul significato del termine
cuore), il suo cervello inizia a formarsi, ad occupare
spazio. La differenza tra stadio embrionale e quello
fetale deriva dalla convinzione che il feto è
interamente sviluppato in tutti i suoi organi, e nel
proseguire della gravidanza non fa altro che aumentare
di grandezza. E’ sicuramente così… ma definire
l’embrione non come una forma di vita da rispettare e
proteggere per via della sua incompletezza è
abominevole. Il fatto che è possibile condurre un aborto
fino a quando sussiste lo stadio embrionale è un'azione
omicida. Fin dal momento del concepimento, il bambino è
-300-
completo nel suo corredo cromosomico, l’anima è scesa
nell’utero materno, la vita ha avuto inizio. L’idea di
strappare quel corpicino di pochi centimetri – se non
millimetri – dal grembo di Barbara e gettarlo nella
spazzatura, o congelarlo, o rinchiuderlo in un barattolo
sotto spirito in attesa di essere studiato, o destinato
all’incenerimento… mi ributta, mi disgusta, mi deprime.
D’altra parte, capisco l’importanza dell’aborto legale
come tentativo di controllare ed amministrare
un’operazione che avrebbe continuato ad essere
perpetrata nella clandestinità. Ci tengo solo a
puntualizzare un concetto rigoroso: la sacralità della
vita. Abbiamo perso questa nozione, così come abbiamo
perso la nozione della responsabilità, e del sacrificio.
La civiltà occidentale sta lentamente sostituendo
antichi valori con falsi miti che nella loro sfolgorante
falsità ci abbagliano e ci attirano, nessuno escluso.
In natura la vita è sacra, anche se in una
prospettiva difficile da comprendere dalla nostra mente
oramai aliena a ragionare per termini che non siano
logico-utilitaristi-edonisti. In natura, una creatura
anormale o debole non sopravvive al parto, e ciò è
necessario per la sopravvivenza della specie. Noi
abbiamo eliminato la selezione, nel rispetto di etiche
che negli ultimi secoli si sono via via sviluppate. Ciò
non vuol dire che la vita non è sacra in natura, mentre
-301-
lo è nella società umana evoluta. E’ vero il contrario.
Cercherò di spiegarmi, mostrando come potrebbe essere la
vita di una piccola società umana che abbia rinunciato
ai benefici della civiltà occidentale e ritornata al
contatto pieno con la natura.
La gravidanza viene seguita e protetta, l’infante
nasce, è allattato, custodito, allevato. Se è debole,
troppo, o anormale, egli morirà, la sua anima ritorna
nei lidi uranici in attesa di ridiscendere. I genitori,
che hanno amato il loro figlio, rimettono quel corpo nel
ciclo della natura in modo che la vita non si
interrompa. La sofferenza genuina è integrata nella
spiritualità verso la natura. Un ‘uomo è colpito dal
cancro, viene accudito, amato, col tempo egli aspetta la
morte con serenità e la comunità rende dolce il suo
trapasso: un’altra anima torna indietro, un altro corpo
viene cremato e le ceneri rimesse alla natura. La vita
non si interrompe. Se un bambino esce a giocare, solo
per acquisire responsabilità ed esperienza, e dopo un
grave incidente muore, ancora una volta un’altra anima
che va ed un altro corpo donato all’eterno ciclo della
vita. Tutto ciò non estingue il dolore, la sofferenza,
l’amore, la passione, le cure mediche… tutt’altro!
Questi sentimenti assumono il loro vero significato.
Esiste il senso di responsabilità.
-302-
La civiltà occidentale ha la miocentesi per
eliminare immediatamente le eventuali anomalie,
dimenticando la responsabilità dei genitori verso la
creatura che hanno concepito anomala, dimenticando il
mito (mito come vocabolo positivo, ricco di significato
educativo) dell’anima che avendo scelto dove nascere per
adempire il suo scopo ha il diritto di nascere a meno
che non sorgano impedimenti naturali; ha l'aborto per le
gravidanze indesiderate o non programmate, dimenticando
che la vita non la si programma, non è cosa
indesiderata, ma un evento sacro in quanto riflette la
manifestazione delle energie dell’universo, del volere
degli déi; impone subdolamente il monitoraggio dei
nostri figli con telefonini, controlli a vista sempre
più oppressivi, eliminazione quasi totale dei momenti di
svago indipendenti (nei bambini), dimenticando che il
rischio, l’incidente sono parte della vita
indispensabile e che cercare in tutti i modi di
prevenirli morbosamente porta ad uno sconvolgimento del
significato stesso di vita e di vivere.
Noi siamo creature poetiche, sentimentali, preda di
emozioni. E’ la nostra natura, pertanto è bene non fare
nulla - o comunque non troppo – nel tentativo di
eliminare quei sentimenti spiacevoli in favore di quelli
piacevoli. Alimentare la felicità, la gioia, l’amore e
cercare di sopprimere il dolore, l’angoscia, la
-303-
tristezza è un tentativo maldestro, primo perché l’amore
ha ragione di esistere in presenza dell’odio, e così via
con gli altri; e, secondo, come notiamo si è scambiata
la felicità di vivere con l’accumulo di denaro e beni,
causando una perdita dei valori sacri della vita. In
realtà, amore, gioia, piacere non sono in antagonismo
con odio, angoscia e dolore… tutti quanti hanno la
stessa importanza nel gioco della vita ed assumono
qualità negative o positive a seconda di come noi
assumiamo atteggiamenti nei confronti della vita. Tutto
può essere solo amore, ma non cercando di sopprimere
l’odio, bensì vivendo nel rispetto del prossimo; o può
essere solo piacere cercando di non confondere il
piacere solo con il benessere fisico ed economico.
-304-
Ritorno al divino (22/06/01)
Ritenevo di avere raggiunto un risultato, in merito
alle mie esigenze spirituali; evidentemente ancora non
sono in grado di comprendere appieno questo aspetto
della mia personalità… o della mia anima, dovrei dire
(ma cosa sia anima, personalità e carattere è un
argomento talmente vasto e basilare che sarò costretto
ad affrontare prossimamente). Ripercorrendo a ritroso i
miei passi, mi sono ritrovato ben presto di fronte al
mistero della divinità, che si rispecchia – od è
rispecchiato – dal mistero della vita (checché ne dicano
gli scienziati, la vita rimane comunque un mistero,
almeno nella sua forma causale, se non modale).
Ovverosia – giusto per essere chiaro con un eventuale
remoto lettore - ho rivalutato la mia decisione di
abbandonare la fede baha’i.
Se qualcuno dovesse osservare ed analizzare le mie
decisione sulla religiosità come elemento della mia
esistenza – che definirei breve e poco profonda –
chiaramente si farebbe del sottoscritto un’idea poco
positiva, e sicuramente con conclusioni non di certo a
favore di una coerenza di comportamento che dovrebbe
distinguermi (così ho sempre sognato). Non esiste
coerenza nel mio rapportarmi alla religiosità. Ora
-305-
rinuncia, ora mi dedico con fervore, ora annuncio un
ferreo scetticismo, ora analizzo il fenomeno, etc.
Potrei dire di non avere le idee chiare a proposito
delle mie esigenze spirituali… se la spiritualità fosse
solo un gusto, come quello di un certo tipo di pietanza,
od un capriccio sulla falsariga dei capricci
adolescenziali od anche sì adulti (e inculcati e di
seguito stimolati dall’opulenza della società
consumistica che manteniamo). Al contrario, credo che
questa atteggiamento sia indicatore di uno spirito
genuino di ricerca e di una mente scevra da
condizionamenti ed influenze esterne.
Dubitare, cambiare idea, angosciarsi intorno ad una
questione spirituale – nonché filosofica – è azione
degna e rispettosa. L’anima è in movimento, è alla
ricerca del suo centro di gravità (aggiungerei
permanente, citando la nota canzone di Battiato).
Definirei la mia vicenda con la spiritualità un spirale
che lentamente mi condurrà alla fonte divina, ma che
esige un percorso circolare e ciclico forse ampio quanto
la mia vita. Poco importa, fino a quando saprò con
certezza che è la mia libertà mentale ad assicurarmi
questo ciclico cambiamento di idea.
Non ultimo, mi sento in dovere di aggiungere, a
conclusione di questo brevissimo intervento, l’annuncio
-306-
della gravidanza di Barbara (ed adesso siamo al quarto
mese), mi vede costretto ad imporre un regime etico alla
mia esistenza… e qui si apre una nuova discussione.
Ora, è tempo di dormire. Sono le ventiquattro, ed il
colpo di tosse di Barbara a letto, è un invito a
staccare per andare a coricarmi. Buonanotte..
-307-
L’intelligenza dell’evoluzione (18 luglio ’01)
Nella vita, spesso capitano delle piccole
illuminazioni. Sono attimi fugaci che il più delle volte
si dimenticano, soffocati dalle molteplici esigenze
della quotidianità e del vivere sociale. E’ un peccato,
dato che possono riguardare verità importanti, o
faccende sentimentali, o meccaniche sociali… ed altro
ancora. Io me ne ricordo qualcuna, specialmente un
lontano giorno del millenovecentonovanta, durante una
lezione di karate-do. La tecnica era gyaku-tsuki, e
nell’eseguirla improvvisamente compresi come avrei
dovuto farla per renderla più efficace… ma non solo.
Compresi l’importanza della tecnica nell’ambito del
karate-do.
Questo è un esempio di poco conto, ed i microsatori
sono fratture luminose che coprono tutto l’agire ed il
sapere umano. Ritengo che solo attraverso e grazie a
questi istanti gli scienziati gettino le fondamenta
delle loro scoperte. Così come poeti ed artisti e
musicisti si rifacciano ai microsatori nel forgiare le
loro opere, come se fossero spunti miracolosi.
Cosa ne decreti il sorgere, sinceramente mi sfugge.
Ci vorrebbe, appunto, un microsatori! Scherzi a parte,
questa nota non è per studiare il fenomeno, bensì per
-308-
riportare la riflessione nata da una folgorazione, pochi
giorni addietro.
Un documentario. Il ghepardo, la sua struttura
muscolare ed ossea, la sua nicchia ecologica, la sua
evoluzione, il suo manto… Andiamo per ordine.
Scientificamente, si sa, è accertato che la natura
progredisca secondo il meccanismo dell’evoluzione: nel
regno animale, le specie migliorano per competere sul
territorio. Il miglioramento è, in sinetsi, una modifica
strutturale che tende all’efficienza massima. Nella
fattispecie del ghepardo, l’evoluzione ha beneficiato
questo felide cacciatore di alcune peculiarità, quali la
capacità di raggiungere altissime velocità (100/110 km
orari/ ed un manto maculato per mimetizzarsi nella
savana. In realtà, altri animali hanno sviluppato una
mimetizzazione migliore, ma è proprio osservando il
ghepardo che il satori mi ha visitato. Dunque, sia il
ghepardo.
Asserire il meccanismo dell’evoluzione, vuole dire
accettare che una data specie si sia modifcata nel corso
di millenni. Nel caso del ghepardo, vuole dire affermare
che il manto del ghepardo, nella specie dalla quale
deriva, era differente, probabilmente non maculato. La
maculazione successiva, è la risposra ad un'esigenza di
adattamento. La tecnica di predazione dell’animale
-309-
esigeva una mimetizzazione particolare. Poteva
essere uniforme, come nel caso del leone, ma sarebbe
reisultata inadeguata relativamente alla grande
velocità; infatti, un proiettile lanciato a d alta
velocità risulterebbe visibilissimo, se di colore
uniforme. Ma provate ad immaginarvelo a chiazze, tale
che nella velocità si venga a provare un effetto quasi
labirintico, dove i contorni sfuggono.
Fino a qui, tutto logico e facile... Ma, e c’è
sempre un ma, come è potuto accadere una cosa del
genere, per quale ragione l’evoluzione del ghepardo è
risultata differente da altri predatori che condividono
con lui lo stesso territorio (la savana)? E’
l’evoluzione intelligenze, è la consapevolezza
dell’universo. SeA=A eB=B,alloraA B
Questo è quello ci insegna la logica. Quando A si
avvicina il più possibile a B, significa che
l’evoluzione ha spinto il manto del ghepardo a duplicare
non tanto il colore della savana, quanto il contrasto
dei colori nella savana: chiaro dell’erba e scuri delle
ombre, in modo tale che nella corsa accade quanto ho
spiegato sopra. Affinché ciò avvenga, tuttavia, mi pare
indispensabile che un sistema di controllo esterno al
ghepardo ed alla savana faccia in modo che la
conformazione pigmentata del manto assuma le giuste ed
-310-
adeguata combinazioni. Altrimenti vorrebbe dire che il
ghepardo consapevolmente si è adattato nel corso dei
millenni. Ciò, ovviamente, è impossibile. Cosa, allora,
rende possibile la mimetizzazione, quale meccanismo
esterno all’evoluzione opera in modo che il manto
assimili le cromature della savana?
Io penso ad un’evoluzione intelligente
dell’universo, ma non virata verso la manifestazione di
una divinità superna tipica delle grandi religioni
monoteistiche. L’evoluzione intelligente è uno degli
aspetti, o meglio, delle qualità dell’assoluto
transfenomenico che è oltre il fenomenico e l’apparente.
La ricerca di questo transfenomenico è la fondamenta
dell’esistenza di un essere senziente.
-311-
No global, Sì global (20 agosto ‘01)
C’è chi si domanda se i fatti di Genova entreranno
nella storia, quella studiata perlomeno, e c’è chi li
interpreta come sintomi del malessere delle generazioni
giovani nate nelle società industriali del nostro
pianeta. A simili quesiti, difficilmente potrei avere
delle risposte, ma sicuramente ritengo che attorno ai
tumulti genovesi scatenatesi in concomitanza del vertice
G8 si siano sviluppate correnti di pensiero le più
disparate, alcune delle quali - quelle vicine alla
sinistra giovanile e combattiva ed in genere ad un certo
tipo di gioventù che riconosce nella sinistra la
tenutaria della cultura e della libertà di pensiero -
rasentanti la paranoia. Mi riferisco, nella fattispecie,
al parto oramai omologato (sic!) Di chi ritiene
responsabile il governo dell’accaduto, avanzando perfino
l’accusa che sia stata attuata una strategia apposita
per reprimere la contestazione antiglobal. Non solo, ma
è oramai consuetudine di tutti i sinistroidi accusare
il governo di destrofilia, addirittura andando a
paragonarlo con il Cile degli anni settanta. Ahimè, il
luogo comune è diventato imperante è la capacità di
ragionare con le propria testa è divenuta un’attività
assai rara.
-312-
A Genova, sicuramente le forze dell’ordine sono
state “esuberanti”, ma altrettanto i gruppi armati
contestatori hanno esagerato nella loro protesta. Dato
che non stiamo vivendo una situazione di guerra civile
(ringraziando il cielo), rimane ovvio che scagliare
pietre ed inveire fisicamente contro le forze
dell’ordine è un atto perseguibile penalmente e del
tutto incivile. Senza contare il fatto che giorni prima
del vertice, i portavoce ufficiali degli antiglobal
hanno dichiarato che avrebbero oltrepassato le zone
messe off limit dalle forze dell’ordine.
Cosa pensare? Una cosa sola: i responsabili, da ambo
le parti, vanno puniti, così come vanno redarguiti i
giornali ed i telegiornali che si sono trafelati per
dare informazioni a volte molto fazione.
Tornando alla questione generica degli antiglobal,
che contestano ai grandi paesi industrializzati la loro
presunta presa di potere sul mondo intero. Il discorso è
molto più ampio, e profondo. E’ chiaro che ognuno ha il
diritto di esprimere la propria opinione, ed è dovere di
uno stato democratico garantire questa libertà... Ed è
proprio perché suggellata da questa libertà che pure la
mia opinione sugli antiglobal ha il diritto di esistere
ed essere messa su carta (o su file, chiaramente). Quale
questa opinione?
-313-
Gli antiglobal non hanno avanzato soluzioni
attendibili per permettere ai paesi poveri di
affacciarsi sull’economia mondiale... Anzi, non hanno
avanzato nessuna soluzione. Il fatto che l’economia sia
governata dai grandi paesi è un dato di fatto, una
realtà dalla quale bisogna partire per prendere
provvedimenti... Ma mi sembra di capire che i paesi
poveri sono disponibilissimi ad entrare in questa
economia, e nessun loro rappresentante ha sfilato
assieme agli antiglobal. Nei paesi poveri si soffre la
fame, e, nello stato attuale delle cose, solo i grandi
paesi possono intervenire per garantire la loro
sopravvivenza. La globalizxzazione, per quanto
effettivamente sia una bruttura umana, rimane l’unica
soluzione per garantire la sopravvivenza dell’intero
pianeta. Naturalmente, una globalizzazione guidata che
lentamente porti al suo interno tutti i paesi del mondo,
garantendo ad ognuno l’identità culturale. D’altronde,
se si vuole creare una confederazione mondiale di tutti
gli stati, per abolire le guerre e la fame, non vedo
come non si possa accettare la globalizzaazione, dato
che dovrebbe esserci una sola economia. Ciò che è da
evitare, è la presa di posizione dei grandi paesi e
l’allineamento dei paesi poveri e minori sui parametri
imposti e per taluno sinceramente impossibili da
rispettare.
-314-
Il peso della tradizione (20 agosto ‘01)
E’ interessante sapere che, malgrado ci vantiamo
delle nostre specifiche mentali rispetto alle altre
specie, siamo impastoiati a superstizioni mentali che
nel regno della natura risulterebbero controproducenti
per l’equilibrio e la continuità. Mi riferisco alle
tradizioni ed al forte legame che proviamo verso esse.
Chiaramente, mi preme far sapere che non sono
contrario alle tradizioni, essendo un fondamento della
società umana e consentendo la salvaguardia di valori e
conoscenze importanti per la nostra identità. Tuttavia,
questo è condivisibile solo per quelle tradizioni che
noi sentiamo vive in noi e che reputiamo fondamentali
per la nostra esistenza o per certi aspetti della nostra
esistenza. Ad esempio, il kendo poggia le sue fondamenta
sulla tradizione, e per quanto si sia evoluto nel corso
dei secoli, rimane una disciplina che non può esistere
senza il peso della tradizione del Budo e del samurai.
Ci sono valori che non possono essere esentati dalla
pratica del kendo, e questi valori possono essere solo
recuperati e mantenuti vivi nella tradizione.
Al contrario, quelle tradizioni che ci risultano
vuote e non in armonia con la nostra anima - anche se
per altri sono valide e rapportabili ottimamente al
proprio status vivendi - sono solo debilitanti e
-315-
nocive... Almeno per me, che non sopporto l’ipocrisia e
la pochezza mentale e la superficialità nell'appropriare
determinate tematiche spirituali. Ora mi sto riferendo
al battesimo, al battesimo della bambina che la mia
amatissima Barbara accudisce nel suo ventre.
Io sono contrario, mentre Barbara, per motivi che
razionalmente non posso obiettare più di tanto, ritiene
doveroso officiare per la bambina. Non è questione di
credere o meno, afferma lei, ma di offrire alla bambina
una condizione che non la alieni dal resto dei bambini.
Si sa, i bambini formano un gruppo e se qualcuno
manifesta atteggiamenti o passati vissuti differenti
allora viene messo da parte, isolato. In realtà, questo
è un mito, dato che i bambini sono ancora troppo
immaturi e non dotati di analisi per capire la
differenza fra essere battezzati o meno. Per di più, la
società italiana si sta arricchendo di nuove etnie, tali
da garantire un’adeguata integrazione di tutti. In
aggiunta, e non ultimo, io sono un bahai, e come tale,
come credente nella figura di Bahaullah quale Maestro di
questa era umana non posso concepire il battesimo,
perché non credo ci sia un peccato originale da mondare.
Essere bahi, non sopportare le ipocrisie e la
pochezza mentale, seguire una tradizione oramai svuotata
dai suoi significati più profondi solo per conformarsi
ad uno stilema di vita sociale è del tutto
-316-
insopportabile. Sono sincero, non credo che Barbara lo
voglia fare per la serenità della bambina, almeno non
consciamente. Intendo che probabilmente abbia timore di
discostarsi dalle tradizioni. E’ normale, è un fatto
culturale. Abrogare una tradizione oramai obsoleta è
molto faticoso ed è normale che solo pochi abbiano la
forza... Anzi, no, la costanza e la fermezza mentale ed
il coraggio di affrontare le critiche della moltitudine.
In realtà, Barbara è molto forte, e dunque, amandola, io
mi sforzo di credere che lei lo faccia sinceramente per
la bambina e che questa non sia una scusa per
mascherare una sua paura congenita.
Ho intenzione, pur avendo accettato a malincuore il
battesimo della bimba (per la quiete familiare) di non
salire sull’altare o, pur salendo, di non recitare
nessuna formula.
-317-
PARTE SECONDA
Pietra filosofale (25 novembre 2001)
Quale è lo scopo della vita? Non si tratta di
essere a conoscenza di verità trascendentali, divine
o metafisiche che dir si voglia; tanto meno
ammettere che ci sia un disegno che trascendi la
nostra esistenza quotidiana. Semplicemente, dobbiamo
costruire questo scopo, nella certezza che una vita
non va mai sprecata... o per lo meno non andrebbe
sprecata. Forse la vita non è un dono, inteso questo
come qualcosa che ci viene dato da una realtà
divina, trascendente la nostra. Ma sicuramente
dobbiamo trasformarla in dono. Dobbiamo renderla
talmente preziosa per un motivo banalissimo: è
l’unica occasione che ci si presenta per manifestare
la nostra anima, la nostra identità, o per meglio
dire: il nostro sé. Ed a maggior ragione, dobbiamo
garantire a tutti gli esseri viventi questo diritto,
universale esso; il diritto di nascere, vivere
secondo la propria natura e tentare di realizzare i
sogni che per tutta la vita portiamo nel nostro
cuore, sia il cuore di un uomo, sia il cuore di un
animale.
-318-
Nel rinascimento e nel tardo rinascimento (ed
anche successivamente, durante l’illuminismo, la
cosiddetta epoca della ragione), alcuni uomini
cercavano la Pietra Filosofale. Materialmente si
trattava di trasformare il piombo in oro,
spiritualmente era la ricerca del divino per
ottenere la Grande Opera, traguardo non dissimile da
quelli di certe filosofie orientali. La Grande Opera
è la trasformazione dell’anima umana in anima
divina, trascendere questo piano materiale per
guadagnare una realtà superiore, beata,
infinitamente meravigliosa. Ciò che consente questo
è la Pietra Filosofale, tesoro ricavabile attraverso
dettagliate e criptiche pratiche alchemiche-magiche.
Io credo sia venuto il momenti di reinterpretare il
concetto di Pietra Filosofale.
Al di là di qualunque credo religioso, di ogni
sistema filosofico, del risultato probante delle
scienze, l’universo è la manifestazione della
volontà della vita, e come tale è sacro, perché
sacra è la vita. Nel rispetto del vivente e della
sua unica possibilità (la vita) di realizzare la
propria natura, il dovere di tutti noi è il porsi
dinanzi alle cose, animate o meno, come un monaco
zen riverisce il cuscino di ruvida tela sul quale
praticherà se stesso (zazen). Il diritto alla vita,
-319-
o meglio all’esistenza, da tributare a tutte le cose
è il primo dovere dell’essere umano. Dunque, tutto
ciò che nasce è un tesoro prezioso da custodire, è
la manifestazione pura della forza della vita, è lo
steso universo che moltiplica se stesso. E’ una
pietra filosofale, perché ogni cosa nuova è una
qualità che si aggiunge alla perfezione
dell’universo e ne partecipa dei benefici.
Ieri sera, alle otto e diciotto, è nata mia
figlia. La perla preziosa è venuta al mondo nove
mesi fa, ed è cresciuta custodita, protetta, nutrita
dal corpo di Barbara; da Barbara stessa. Due esseri
hanno diviso spazio, tempo, cose ed energie per nove
mesi.
Io e Barbara, nella nostra volontà gioiosa e
nell’amore delizioso di avere un figlio, carne nata
dalla carne, spirito imbevuto di spirito, abbiamo
offerto le circostanze (coi nostri corpi e
sentimenti e desideri e sogni ed emozioni) affinché
una nuova vita prendesse forma, affinché la matrice
dell’universo si moltiplicasse nuovamente in un
nuovo essere. Io non so da dove venga Miriam, se la
sua anima, posta che l’abbia, sia eterna, o perirà
con il suo corpo, e non voglio saperlo. Io so che
qui ed ora lei vive, che attraverso lei le energie
-320-
del mondo ci parlano e ci comunicano la volontà
degli déi. E’ la Pietra Filosofale della mia vita,
quella attraverso la quale trasformerò il piombo che
mi ha inquinato in oro che mi delizierà.
Tutto questo è una metafora, è un racconto
mitico. L’uomo è essenzialmente un animale
mitopoietico, un affabulatore. La narrazione
favolosa è lo strumento principe per spiegare gli
arcani dell’universo, non è necessario che dietro le
parole ci siano verità trascendenti, perché le
parole stesse sono le verità. Immanenti verità.
Ora, il mio impegno nella vita acquisisce un
nuovo valore, un più alto significato, un sublime
scopo. Non sto parlando di annullarmi nel servizio
tributato a Miriam. Al contrario sto parlando di
realizzarmi con maggiore tenacia per essere un
adeguato punto di riferimento, un faro nella notte
per la barca che Miriam dovrà costruirsi.
La sua vita le appartiene. Io non ne dispongo i
fili, probabilmente non ne conosco nemmeno i
termini. Io sono solo il custode di questa creatura
meravigliosa, e dovrò adoperarmi affinché la strada
le sia spianata innanzi. Costruirò un molo per lei,
le indicherò i cieli sereni ed i mari calmi per
poter salpare... E sarò come un marinaio con teso
l’orecchio per eventuali grida di aiuto. Allora
-321-
partirò, perché sui figli non si hanno diritti, ma
solo doveri, e questa cosa deve essere una gioia non
una tribolazione.
La felicità è circoscritta nel donarsi
passionalmente alle persone ed alle cose che si ami.
Oltre ciò, c’è solo l’illusione.
-322-
I Ricordi ed i sogni (7 dicembre 2001)
Oggi, mentre leggevo delle poesie di Borges, uno
dei miei poeti preferiti ed uno dei miei maestri
spirituali e letterari, mi è capitato un verso che
mi ha colpito, inducendomi una sorta di micro
illuminazione. Il verso recita: “E’ inutile ridirmi
che il ricordo/Di ieri e un sogno sono la stessa
cosa.” (Inutil repetirme que el recuerdo/De ayer y
un sueno son la misma cosa). Il ricordo di ieri ed un sogno
sono la stessa cosa. Trovo questa frase meravigliosa,
sublime, ma, con mio dolore, mi avverte che è il
frutto di un ragionamento poetico e dunque non da
tutti comprensibile. Ed è proprio questo aspetto che
mi ha fatto riflettere e non tanto la rivelazione
che il ricordo di un fatto accaduto ieri ha nella
sostanza e nell’essenza lo stesso valore del sogno
di questa notte. Io stesso ho animo di poeta e mi è
congeniale il ragionare da poeta. Ma se dovessi
proporre la stessa meditazione a chi non è
predisposto ecco sorgere un’incomprensione.
Tutto questo a cosa ci conduce? Le
incomprensioni e l’incapacità, che spesso si nota,
di stabilire un dialogo su argomenti comuni si basa
proprio sulla qualità del ragionamento, dove con
qualità non intendo attribuire un valore positivo o
-323-
negativo, bensì differenziare le modalità del
ragionamento, dovute a caratteristiche personali
intrinseche, a fattori educativi, culturali,
ambientali e sociali. Ne conviene, allora, che
improvvise folgorazioni, specialmente nel campo
artistico, possono risultare banali, o squallide, o
deprimenti, astruse per taluni, meravigliose ed
innovative per altri, normali per altri ancora.
Quello che bisogna capire è, allora, se esiste una
modalità di ragionamento che è qualitativamente
migliore di altre, o se l’illuminazione è u fatto
relativo e dunque anche la verità corrispondente
solo un fattore temporaneo e riguardante solo un
determinato insieme di individui (di menti, dovrei
dire).
Lo stesso zen, che si preoccupa di realizzare il
Dharma, non è una prassi adatta a tutti, e se pur
fra coloro che non vogliono seguirla ci sono menti
capaci almeno di capirla e giudicarla, altri ne
saranno completamente disturbati, anche se gli
stessi si dedicano con sincerità e devozione ad
altre scuole buddhiste. Dove è la verità? Se tutto
è relativo, anche il Dharma (il senso delle cose) è
un concetto prettamente umano e dunque suscettibile
di modifica, di cessazione?
-324-
Personalmente, ho sempre lottato per trovare una
strada che mi conducesse all’esatta comprensione
della totalità dell’universo, ma mi sono sempre
trovato a fare i conti con aspetti che non accettavo
e che non potevo fare miei, pena un forte senso di
insoddisfazione. Nelle parole del Buddha, termine
col quale si nomina Siddharta Gautama, mi è sempre
parso di recepire perle di incommensurabile
saggezza. Purtroppo non sono mai riuscito a trovare
una corrispondente scuola di insegnamento buddhista
che mi aiutasse nella pratica. L’unica, è risultata
una via che esigeva uno sborso di denaro troppo
alto, o forse troppo alto per la mia volontà di dare
(ma non vivo solo, e dunque devo tenere conto anche
delle considerazioni di Barbara). Ora, che sono in
corrispondenza con un monaco della scuola Honmon,
spero di aver trovato chi potrà darmi utili
ammaestramenti.
-325-
Dialoghi interreligiosi (30 dicembre 2001)
Negli ultimi anni si è sempre più assistito ad
una proliferazione di congressi e dibattiti aventi
come denominatore comune lo scambio interreligioso,
sia organizzati da strutture dipendenti dall’ONU,
sia da organismi statali, regionali o comunali, sia
da istituzioni private, il tutto nella forsennata
ricerca di un dialogo aperto e pacifico fra le varie
confessioni (non tutte, ovviamente, solo le
maggiori) come se i mali del mondo dipendessero da
una cattiva relazione fra queste e, dunque, la
soluzione può solo ritrovarsi nella loro reciproca
armonia. Nulla di più ipocrita ed illusorio.
Ipocrita, perché non solo le confessioni religiose
sono sempre rappresentate con ampie lacune, ma
specialmente per l’incontestabile fatto che la
religione non è la causa del malessere mondiale e
che fondamentalmente un dialogo di reciproca
comprensione si baserebbe su presupposti
inconciliabili con il medesimo atto di fede verso
una confessione piuttosto che un’altra. Illusorio
come conseguenza, in quanto i suddetti dibattiti
servono, al massimo, agli studiosi. Ma vorrei
spiegarmi meglio.
-326-
Partiamo dall’incomunicabilità di fondo. Vi
sono confessioni teiste e confessioni ateiste, e qui
vediamo già come un dialogo, se vi può essere, è
utili solo a studiosi, mentre il singolo credente,
per quanto si sforzi di tollerare colui che ha fede
in sistemi differenti non potrà mai accettarne i
dettami. Rimane sempre un’incomunicabilità di fondo,
perché un buddhista, pur se indifferente a discorsi
teologici e metafisici, non può accettare il dogma
di un dio eterno ed onnipotente che ordina lo stato
delle cose a proprio piacimento, così come un fedele
nella missione salvifica del Cristo non potrà mai
accettare la presenza di un Buddha che proclama la
pace del Nirvana senza l’ausilio di Dio. E se a
questo livello non vi può essere dialogo, quale lo
scopo di questi meeting? Qualcuno dice che bisogna
comprendersi a vicenda per superare le intolleranze
religiose. E’ vero che esistono le intolleranze, ma
spesso queste nascono da pregiudizi che affondano le
loro radici nella cultura e nella società di
appartenenza; senza contare il fatto che la
popolazione religiosa è per la maggior parte dei
casi ignorante sia della propria religione sia
dell’esistenza e dei risultati finali dei dibattiti
interreligiosi.
-327-
Prendiamo delle religioni monoteiste di maggiore
rilevanza mondiale: cristianesimo, islamismo e
giudaismo. Si basano su principi che solo a prima
vista attingono a patrimoni comuni. In realtà, lo
stesso Dio ha ruoli e scopi completamente differenti
passando dall’una all’altra fede, ed i fedeli in
fondo al loro cuore non possono che considerare con
pietà i loro “cugini”, ben sapendo che basano la
loro fede su un errore. Come può mai un cristiano
ammettere che Maometto è stato un profeta voluto dal
suo stesso Dio? E come potrà mai un giudaico
ammettere che Gesù sia il vero Messia? Non c’è
possibilità. Allora, ridomandiamoci lo scopo dei
suddetti dibattiti, e ririspondiamoci: per
comprendere come nasce l’intolleranza religiosa e
combatterla. Si sbaglia tutto, allora, se lo scopo è
solo questo.
La religione non è causa di malessere, non è
causa di intolleranza, non è causa di guerre o
quant’altro. La religione è solo un sintomo, è un
effetto. Le vere ragioni stanno a tergo, molto a
monte e riguardano la psiche profonda dell’essere
umano, il suo interfacciarsi con la realtà delle
cose, la volontà di potere e dominio, l’istinto di
conservazione. La religione è solo un gioco
attraverso io quale manifestare la libido della
-328-
quale ognuno di noi ne è ricolmo. A motivo di ciò,
il dialogo fra religioni non dovrebbe proprio
esserci, in modo tale che la fede sia una costa
inscritta nella sfera più intima dell’essere umano
ed utile al fabbisogno della sua anima e della sua
mente. Personalmente, della religione professata dal
mio prossimo non mi importa nulla, a patto che esso
non ne faccia uso per manipolare la sua libido ed
imporla al mondo. Questo sarebbe, ed è, il vero
pericolo.
E’ la cultura che va studiata ed affrontata, in
quanto la religione - fino a quando non riusciremo
ad inscriverla nella nostra sfera intima - è una
delle sue tante sfaccettature. La cultura e la
psiche umana, per l’esattezza sono i due punti che
necessitano di profonda analisi.
La civiltà umana dovrebbe spostare il proprio
asse verso una comunità rigorosamente laica,
governata da pochi organismi aperti a tutti e
trasparenti nello loro operare, indipendenti da
qualunque credenza religiosa. La religione rimane un
fatto individuale, liberamente esprimibile anche
attraverso associazioni e chiese, ma pur sempre
lontano dal mondo della politica. La morale, che
ognuno deve coltivare nel suo piccolo orto,
giustamente può essere alimentata dalla religione,
-329-
ma è più facile che una buona etica fiorisca in uno
stato laico, democratico e libero piuttosto che in
una teocrazia basta su cidici vecchi di secoli, se
non millenni.
A dar peso al mio pensiero, vorrei fare un
paragone, forse azzardato, forse banale, ma quanto
mai utile per comprendere come stanno realmente le
cose. Calcio (il gioco del pallone, intendo).
Vediamo bene come negli stadi, le persone offuscate
dall’ignoranza si picchino in nome di un legame
sentimentale-morboso verso una squadra di calcio.
Ovviamente, un interista non picchia un milanista
solo per motivi calcistici, o perché appartiene ad
una squadra avversaria (tutte le squadre lo sono). I
motivi sono altri e ben più profondi, che a
tutt'oggi mi sfugge riuscire a metterli su carta. Ma
è quanto mai chiaro che hanno a che fare con la
nostra natura di esseri umani, che è la stessa per
tutti gli esseri umani del mondo. E così come io, in
quanto essere umano adulto e maturo, non posso farmi
influenzare nel giudicare il mio prossimo e nel
relazionarmi con esso, dal calcio, così debbo
evitare che la religione si frapponga fra me ed i
miei giudizi sugli altri. Il problema, e lo ripeto,
sorge quando la religione è assurta a sistema di
-330-
Una nuova vita, una antichissima vita (31
dicembre 2001)
Quando è nata Miriam? Sembrerebbe una domanda
retorica, o, a più ragione, sciocca. Io non credo,
rispondo infischiandomi della banalità, che la mia
bambina sia nata nel momento stesso della sua uscita
dal ventre di Barbara. Si è trattato solo di una
formalità, per quanto dolora per Barbara,
un’esperienza che mamma e figlia in primo luogo, ed
io dietro loro, hanno sperimentato e vissuto
intensamente. Tuttavia, Miriam era già viva, era già
una essere vivente, era già nell’universo e ne
beneficiava. E così un giorno prima di venire alla
luce, un mese, tre mesim nove mesi prima. Nel
momento in cui il mio spermatozzo a fecondato
l’ovulo, è forse quello il momento della nascita? O
forse sarebbe più adeguato ammettere che lei era già
nata nel momento preciso nel quale io e Barbara
abbiamo preso la decisione di avere un figlio? O
forse prima ancora, o forse, più presumibilmente,
non è mai nata essendo Miriam, così come tutti noi,
una forma della forza vitale che impregna l’intero
universo. In tal caso, Miriam è antichissima, ed in
tal modo lo siamo tutti. Ciò che risulta di nuovo è
solo la forma, la struttuta temporanea, la
-332-
concrezione della forza vitale, un nodo di luce,
un’onda nell’immenso mare che nace e muore.
La mia bambina è un’essere vivente che io e
Barbara abbiamo richiamato sulla terra col nostro
amore, o meglio è la forza della vita dell’universo
che abbiamo concentrato in noi e plasmato con le
nostre matrici. Eppure, un’identità indipendente da
noi e dall’universo e dall’ambiente Miriam possiede.
E’ l’anima, che non è un fatto metafisico e
trascendentale, bensì il mito che si incarna, un
accordo che prende vita e vibra, una pagluizza di
luce che riverbera nelle tenebre. E’ un mistero che
non va investigato, ma solo vissuto con tutta
l’intensità possibile.
La vita è la vera natura dell’universo, e come
tale essa è pura e rappresenta l’idealizzazione
della perfezione, anzi è la perfezione fatta carne e
terra e cielo. Tutta la verità possibile è a nostra
portata, non dobbiamo fare altro che aprire gli
occhi, la mente ed il cuore all’evidenza
dell’universo ed alla forza della vita e considerare
sacro tutto ciò che vive, animato od inanimato che
sia.
E’ stupido ritenere che vi siano cose belle e
cose brutte, che vi sia il male ed il bene, che vi
sia Dio o non vi sia Dio, che si nasce e si muore.
-333-
In realtà, ogni istante ha il sapore e l’essenza
dell’eternità ed ogni luogo è tutti i luoghi
contemporaneamente e che tutto ciò che accade è puro
e giusto e necessario. E’ la nostra ignoranza che
offuscandoci frappone fra noi ed il resto il velo
del giudizio e del pregiudizio. In tal modo noi non
sentiamo più l’universo, ma lo giudichiamo, non lo
viviamo bensì lo osserviamo da lontano. I nostri
bisogni - da quelli indispensabili a quelli ritenuti
indispensabili a quelli superflui - ci impongono di
operare al mondo e questo operare ci obbliga a
giudicare tutto e tutti. E col giudizio perdiamo
l’innocenza e l’immanenza delle cose.
Dobbiamo tornare bambini per sentire la forza
della vita che scorre in noi, dobbiamo abbandonare
la nostra mente e vedere cosa alberga nel nostro
corpo oltre il nostro corpo.
-334-
Sovralimentazione e squilibrio dell’ecosistema
(14 gennaio 2002)
Alle volte - anzi, sempre - è necessario
chiedersi quali siano gli effetti della nostra
alimentazione. Mi riferisco, nella fattispecie, ai
cittadini della cosidetta civiltà occidentale, che
il luogo comune vuole riunisca tutti i paesi
industrializzati (se poi industrializzazione
corrisponde a civiltà è tutto da verificare) che
statisticamente consumano la maggior parte delle
risorse alimentari del mondo. In realtà, non voglio
ricalcare il dire di tutte quelle organizzazioni che
vedono nei paesi occidentali (USA in testa) la causa
dello squilibrio dell’ecosistema terrestre,
semplicemente capire e mostrare quale sia la vera
causa.
Che noi abitanti dei paesi induistrializzati
abbiamo un’alimentazione superiore al necessario è
fuori discussione, ma bisogna anche comprendere per
quale ragione esistono i paese occidentali. E
bisogna anche, con coraggio, dire che i paesi
“poveri” (secondo i parametri di noi occidentali)
non sono ancora arrivati a realizzare l’importanza
del mantenimento dell’ecosistema. In effetti, i
paesi industrializzati, che per primi hanno
-335-
inquinato e sconvolto la terra, ora sono anche i
primi ( quasi sempre) ha sviluppare progetti per la
salvaguardia del bene del pianeta. Al contrario, i
paesi in via di sviluppo “rodono” e sfruttano le
risorse senza adeguati criteri, e solo l’intervento
esterno li spinge a tenere conto dell’impatto
ambientale. Ciò vale, mi pare, per tutti i paesi non
europei e non facenti parte del G8, l’organizzazione
che riunisce gli Stati maggiormente
industrializzati.
In realtà, il discorso non è così semplice. La
verità, come al solito, è dove meno la si suppone.
Il fatto è che i paesi occidentali hanno ideato un
modello a loro immagine, modello che il resto del
mondo vuole imitare, con le conseguenze che si
vedono. La cultura europea è questo modello, e come
tutti noi possiamo constatare quasi tutti i paesi
mondiali cercano di conformarsene; tuttavia, il
passato storico non è lo stesso per tutti, con la
conseguenza di fratture ed incapacità di affrontare
quello che comporta una simile strada. La cultura
europea, non è solo figlia della filosofia greca e
della religione cristiana, è anche il prodotto
dell’illuminismo e della rivoluzioone industriale.
Avendo vissuti questi eventi, la società europea ha
sviluppato le giuste strutture di pensiero le più
-336-
idonee utili ad affrontare tutto il disastro che
l’industrializzazione ha prodotto. Ovviamente, tra
dire ed il fare c’è di mezzo il mare, ovverosia la
volontà esiste, ma il potere dell’economia spesso e
volentieri inibisce molti pregetti. Tuttavia, se
esiste la volontà, presto o tardi questa visionme
avrrà la meglio.
Ma cosa c’entra tutto questo con la
sovralimentazione? Il preambolo mi è servito per
mettere a fuoco un punto che mi è molto caro: il
problema siamo noi, esseri umani, figli della più
grande rivoluzione della nostra storia: la
rivoluzione agricola. Il passaggio dalla società di
raccoglitori-cacciatori alla società agricola segnò,
anzi innescò una trasformazione di tale portata che
le conseguenze le stiamo vivendo tuttora.
L’agricoltura e l’allevamento introdussero una nuova
mentalità: produrre nutrimento per soddisfare la
richiesta della tribù. Maggiore era la richiesta,
maggiore lo sfruttamento agricolo, maggiore il
divario fra coloro che avevano tanto e coloro che
avevano poco. A povertà è una conseguenza della
politica di sovraproduzione, dove lo scopo non è più
quello di soddisfare le esigenze, bensì quello di
creare nuove esigenze per soddisfare la produzione
di beni. Abbiamo, così, una situazione ribaltata,
-337-
esattamente opposta alla filosofia della natura,
dove il numero di esseri viventi è in relazione alle
disponibilità della madre terra. L’uomo, spinge la
disponiblità della terra per soddisfare un numero
sempre maggiore di esseri umani.
Naturalmente, non voglio affermare che la
comunità umana sia un male che infesti iol mondo,
solamente che questo pensiero (nato dalle
possibilità date dall’agricoltura) ha causato le
condizioni sociali che ora noi conosciamo, nonché le
malsane idee occidentali sulla morte, la giovinezza,
al vecchiaia e la malattia. Sarewbbe necessario
ritornare ad una forma di vita il più vicino
possibile alla sussistenza, ovverosia alla
produzione di beni limitati alle esigenze,
risparmiando tempo per l’educazione dello spirito e
la ricerca della propria natura originaria.
In natura, non esiste povertà o ricchezza. Gli
animali godono dei frutti della terra, predano solo
per la stretta sopravvivenza, non producono per
soddisfare il meccanismo in se stesso. I predatori
hanno il loro territorio di caccia, che difendono,
ma non appartiene a loro, e spesso animali predatori
differenti condividono lo stesso terittorio. In
realtà, l’idea di un territorio è umana e forse
andrebbe coniato un altro termine.
-338-
L’occidente, per tornare al dioscorso iniziale ,
essendo una struttura che produce in sovrabbondanza
e dunque deve stimolare al consumo, ha creato una
frattura, attinge alle risorse di tutto il mondo,
contribuendo in tal modo all’esistenza dei paesi
“poveri”. Tuttavia, l’occidente, vivendo questa
situazione paradossale che a parer mio è integrante
dell’evoluzione sociale umana, ha gli strumenti per
trovare una soluzione ed andare oltre. Io sono
sempre stato ottimista e ritengo che l’umanità possa
costruire un meraviglioso mondo sociale.
-339-
Il tradimento di Pietro (24 gennaio 2002)
Il Nuovo Testamento, sia che vogliamo
considerare quello ortodosso, sia che preferiamo una
visione più ampia che comprenda anche i cosiddetti
apocrifi, è un testo sublime, aldilà di ogni
implicazione religiosa. Anzi, se escludiamo queste,
allora potremo leggerlo con occhi nuovi.
Mi viene in mente, ora, le parole di un giovane
kendoka che pratica nel dojo; così giovane che ogni
appunto sarebbe ingiusto ed inopportuno. Il ragazzo
mi pare sia propenso allo zen ed a negare i dogmi
cristiani, il che non è un male, se non fosse che
cià porta sempre ad una posizione acida nei
confronti del Nuovo Testamento e dei fatti ivi
riportati. E’, questa, una posizione tipica di chi
per una ragione od un’altra non vuole pensarsi
cristiano. Purtroppo, spesso si confonde la Chiesa e
più in generale gli organi religiosi, con la Verità
e con la figura del Cristo, uomo e maestro
straordinario.
Pietro, discepolo, tradisce tre volte il suo
maestro, negando a chi lo ndica di esserne allievo.
In realtà, e voglio essere succinto, non è un atto
di tradimento, bensì un gesto di grande coraggio.
Pietro, nega la propria fede nel Cristo, per
-340-
guadagnarsi la vita, dunque antepone la passione per
la carne e la terra, all’amore per lo spirito. Ma se
così non fosse, la sua vita finirebbe in un attimo
ed il messaggio del suo maestro morirebbe con lui.
Ecco, allora, che Pietro nega la sua amicizia e la
sua fede nel maestro, per garantire al verbo del
maestro di sopravvivere e diffondersi.
L’attaccamento alla vita non è un peccato, non è
una colpa e la passione che si prova per questa
carne, per la terra ed i sensi, il cielo e le
foreste, è un vero e proprio dono che abbiamo il
dovere ed il diritto di difendere, proteggere e
nutrire. Amare Cristo, per Pietro voleva dire
negarlo per affermare la vita terrena; ma , essendo
il Cristo la quinteessenza della vita, essendo egli
lo spirito fatto carne e la carne fatto spirito,
ecco che Pietro non tradisce, ma afferma ed proclama
la sua umanità e l’umanità del suo maestro.
-341-
9.Il perché del filosofare
Ho sempre provato una forte attrazione perla filosofia, sia occidentale che orientale (equesta dicotomia, che è presente in molti altriaspetti dello scibile umano, andrebbeanalizzata, dato che sembrerebbe la culturaumana sostanzialmente divisa in occidentale oorientale - ma, in realtà, la questione va postain altri termini, come farò più avanti); anchese per quanto concerne quella orientale, il miointeresse verteva maggiormente se non totalmentesulle varie forme di spiritualità religiosa(specificando va detto, che nella tradizioneculturale indiana, giusto per fare un esempio, èquasi impossibile porre in atto una scissionetra filosofia e religione). Fin da giovane misono dedicato alla lettura della filosofia, piùche al filosofare vero e proprio, probabilmenteperché non ero ancora abbastanza maturo peraffrontare determinati argomenti con glistrumenti filosofici. Strumenti i quali,preciso, solo in questi ultimi giorni ho avutomodo di sperimentarne la vera natura.
Per tutti questi anni ho candidamenteignorato, o meglio travisato il vero scopo dellafilosofia. Non solo, mi era anche sfuggita lavera importanza della filosofia e la necessitàdi una sua costante preservazione. Avevo semprecaldeggiato lo studio della filosofia fin dalle
-342-
medie, inserendola, più o meno intensamente, intutti gli indirizzi scolastici delle mediesuperiori, consapevole che il suo studio avrebbeofferto agli studenti strumenti utili perragionare con la propria testa. In aggiunta aciò, che continuo a proclamare basilare chevenga attuato, mi piace ora affermare che lafilosofia è l’arte del pensare liberamente, e ilfilosofare è il pensare al di fuori di dottrinee sistemi ritenuti veritieri a priori.
Escludendo la scienza empirica, che analizzae studia la realtà dei fenomeni attraverso lesperimentazioni, le congetture e il tentativo didimostrarle; escludendo le scienze matematiche,che pur studiando enti astratti può vantare diessere una delle poche discipline dove vi sonoteoremi dimostrati validi da qui all’eternità(all’interno di sistemi ben definiti e coerentinel tempo, altrimenti le stesse leggimatematiche dovrebbero cambiare, adattandosi ainuovi sistemi – e comunque non cambierebbe ilsenso del discorso), la filosofia è quella“scienza” che mette in dubbio tutte le altreverità acquisite (appunto escludendo quellematematiche, quelle logiche e quellescientifiche sperimentalmente dimostrate), in uncontinuo e mai finibile lavori di revisionecritica.
La filosofia è appunto una revisione criticadelle conoscenze acquisite e una critica
-343-
continua della realtà, in una perseverantetensione verso la verità, consapevole che non ènella metà la sapienza, la gnosi, bensì nelcammino. La sapienza da amare, da produrre,della quale colmarsi, pertanto, non sarà mai laverità, perché è solo un ideale che ci sprona,bensì il continuo lavoro di critica.
Le stese scienze empiriche e matematiche, sepur vantandosi di possedere certezzeinconfutabili, possono essere sottoposte arevisione critica da parte della filosofia neiloro metodi di approccio alla realtà.
La mia conclusione, peraltro facilmentesupponibile da ciò che sopra ho scritto, è chechi intenda filosofare non può avere una fededel tipo religiosa o spirituale, o meglio nonpuò credere in un sistema dottrinario cheammetta delle verità a priori e non confutabili.Tutto deve essere sottoposto a critica, pertantoanche i dogmi e le credenze religiose. Pertanto,aggiungo ancora, la teologia, il cui nucleo èuna struttura assiomatica di verità nonscientifiche, non deve essere considerata comefilosofia.
Che poi anche l’asserto che non possonoesistere strutture di verità a priori, del tipodi quelle delle religioni rivelate, sia essostesso non una verità assiomatica e dunquesottoponibile a critica, certo non ci esime dalcontinuare per la nostra strada del filosofare,
-344-
perché se pur non esistono verità assolute disicuro l’unico modo per accertarsi che vi sianoo meno verità assiomatica è la critica stessa,la quale non è un’assunzione di veritàassiomatica, bensì solo uno strumento e dunquenon suscettibile di essere considerato unastruttura di verità. Insomma, non bisognaconfondere il cucchiaio con la medicina, comericordava il maestro zen che frequentai unadecina di anni fa.
Mi farebbe molto piacere, bambine (ma non losarete più nel leggere queste note) che voiconsiderereste l’opportunità di imparare un pocodi filosofia e di apprendere gli strumenti delfilosofare, per non dar per scontato nulla esottoporre tutto a una costante e salutarecritica, voi stesse comprese, così come io hoiniziato a fare ultimamente.
Milano, 3 dicembre 2008
-345-
10. Cristo storico e Cristo mitico
Ho terminato di leggere un interessanteraccolta di apocrifi neotestamentari.Considerato che in questi ultimi anni,probabilmente a seguito del fortunato romanzo diDan Brown, Il Codice da Vinci, sembra essercifra i lettori un interesse per rinato per lafigura di cristo (interesse foraggiato e osereidire pasturato con furbizia dalle caseeditrici), ho dovuto agire con oculatezza peracquistare un testo serio, dove le traduzionidei testi siano state eseguite da studiosi seri.Spesso, i saggi in circolazione che vantanoclamorose scoperte o sensazionali nuoveinterpretazioni sono scritti dozzinali ad operadi giornalisti o sedicenti esperti; pertanto sirischia di comprare un libro senza alcunaattendibilità.
Fortunatamente mi è capitato un ottimotesto, ad opera di uno dei più seri studiosiitaliani, Marcello Crateri, il quale mi hapermesso di addentrarmi nell’affascinante mondodegli apocrifi neotestamentari, che sono unaiuto indispensabile per capire come la figuradel Cristo sia stata nel tempo interpretata ereinterpretata a seconda delle vigenti correntidi pensiero o per soddisfare le esigenzefolkloristiche del popolo. Ed è proprio partendodalla figura di Cristo che voglio iniziare
-346-
questa discussione; anzi, si tratta proprio diiniziare e finire intorno a Gesù, perché mi èoramai lampante la verità che oramai non abbiamopiù la possibilità di sapere chi effettivamentefu e cosa disse.
Mi spiego, perché le mie parole potrebberoessere oggetto di fraintendimenti, e quando siopera un’indagine filosofica (e più avanti, inaltri pensamenti, vedremo come sia diventato nonpiù posticipabile da parte mia l’intraprenderedelle indagini filosofiche intorno alla realtà),quando si opera un’indagine filosofiche,appunto, è importante, anzi fondamentale evitarefraintendimenti – anche se va detto che infilosofia i fraintendimenti sono abbastanzacomuni. Pertanto, espongo il mio pensare conestrema chiarezza, iniziando da questoenunciato: Cristo è una figura mitica. Ed ora cercheròdi spiegare come sono giunto a questaconclusione.
Tutti i vangeli, sia quelli canonici chenon, rappresentano la testimonianza più direttadella vita e delle opere di Gesù; ma non nelsenso che chi li ha compilati ha assistitodirettamente alla predicazione del Cristo,piuttosto che non esistono altri testi scrittiappositamente per testimoniarla. Tuttavia, lamaggior parte, quelli canonici (che va detto perinciso non furono scelti da un’appositacommissione ecclesiastica, bensì adattati in
-347-
quanto erano quelli maggiormente diffusi)possono essere considerati come una sorta dipalinsesti. Infatti è probabile che siano statiscritti e riscritti, ogni volta apportandomodificazioni o aggiunte, a tal punto che oramaipossiamo affermare con certezza che non esiste più lapossibilità di conoscere la figura storica di Cristo. Pertanto,la figura che ci è pervenuta è unastratificazione mitica avvenuta nel corso deisecoli, a cui hanno partecipato non solo leriscritture dei vangeli (e ricordiamoci che gliapocrifi non sono elementi alieni dellatradizione cristiana, e di quella cattolica inparticolare, anzi) bensì anche tutto l’insiemepopolare e clericale dell’idea di cosa fu ed èGesù.
Gli stessi vangeli canonici subisconol’influenza del momento storico nel quale furonoscritti, e questo si può dire specialmente delvangelo di Giovanni, che presenta analogiasorprendenti con l’apocrifo di Tommaso, dichiara ispirazione gnostica. Il Gesù di questidue vangeli sembrerebbe essere un maestro disapienza gnostica, il che è impossibile dato chedurante la sua missione lo gnosticismo non eraancora stato formulato. Ma ciò non vuol dire chenon vi siano elementi ricavati da un testoanteriore comune ai due, del quale si parlaspesso. E sarebbe una scoperta sensazionale unsuo ritrovamento.
-348-
Personalmente, ritengo che i vangeli chemeglio di altri potrebbero offrire unatestimonianza abbastanza veritiera della vita diGesù, siano quelli degli Ebrei, ovverosia testinati in senso alle primissime comunità dicristiani, i quali erano per l’appunto degliebrei. Gli studiosi definiscono questo vangelomolto simile a quello di Matteo. Tuttavia non èrimasta alcuna traccia,
I canonici, al contrario, hanno lasciato unaprofonda traccia di se stessi, al tal punto chedata la loro somiglianza e la loro bellezzafurono senza decisione da parte delle autoritàscelti come testi di riferimento dalla Chiesa.Perché, va detto, nella Chiesa dei primi secoli,non esistevano ancora dei vangeli ufficiali e lastessa Chiesa si rifaceva a quelli esistenti.
Comunque sia, rimane sempre valida, almenonel mio sistema personale di pensieri, che lafigura di Cristo sia mitica, che egli stesso siaun mito, e con ciò non voglio affermare che nonsia esistito e nemmeno voglio dire che il mitoche è sia un’invenzione, o qualcosa di falso efuorviante. Il mito è una necessità dell’anima,e come tale, in mancanza di esso, l’anima necostruisce uno. Anzi, precisando, l’anima – madovrei dire l’essere umano – tende a mitizzare omiticizzare gli avvenimenti. Tutti gliavvenimenti. E più la distanza temporaledall’avvenimento è maggiore e più –
-349-
proporzionalmente alla carica emotiva delsuddetto – maggiore sarà la sua mitizzazione.Ma, tornado alla figura di Cristo, vorrei quiriportare due mie interrogazioni che mi posidurante la lettura del testo di cui all’iniziodi queste righe, e che annotai sui margini delsuddetto.
Se cristo col tempo ha assunto unafigurazione mitica così come era pretesadall’immaginario collettivo, ovverosia dallapropensione mitica della nostra psiche, è giustorivalutare tale figurazione con l’aiuto degliapocrifi, oppure gli stessi apocrifi offronoun’ulteriore figurazione mitica?
E’ possibile che stiamo vivendo un periododi cambiamento mitico, nel senso che la nostrapsiche abbisogna di nuovi racconti, pertantoecco la rinata fortuna degli apocrifineotestamentari? Forse l’attuale figurazionemitica di Cristo non soddisfa più la nostrapsiche, il nostro immaginario, ed ecco pertantoil tentativo di ricostruirla o modificarla?
Ancora una cosa, riguardo il vangelo diTommaso. Il fatto che, se da una parte èaccostabile ai sinottici, e specialmente aquello di Giovanni, mentre dall’altra se nediscosta esplicitamente, può significare duecose: i) o a differenza dei canonici è piùvicino alla verosimiglianza dell’insegnamentostorico di cristo, o ii) rimane legato alle
-350-
concezioni gnostiche del tempo in cui vennescritto, mentre i canonici se ne discostanoperché era volontà dei loro compilatorioriginale indicare la strada per una nuovareligione, o per una religione basata sudottrine differenti dallo gnosticismo.
Milano, 9 dicembre 2008
11. Il problema della laicità
Ho avuto modo di leggere un breve dibattitofra due pensatori, sulla tema della laicità, chein questi ultimi tempi qui in Italia rappresentaun problema a quanto pare spinoso. Più volte hofatto notare a chi con i quali discetto difilosofia – in appositi forum – che oggigiornosi ha un’accezione errata di laicità; infatti, èuso riferirsi alla laicità come se fosse laforma mentis di un non credente, o ateo che dirsi voglia, e, pertanto, viene definito comelaico colui che è ateo. Il che si tratta diun’asserzione errata e che stravolge il verosenso della laicità ed dell’essere laico. Laico,propriamente, è colui che aldilà della propriacredenza religiosa ritiene opportuno che in unoStato l’insieme della normativa che lo regge nonsia non solo influenzata, ma nemmeno alimentatada istituzioni o apparati religiosi. Per fare un
-351-
esempio a tema, facendo riferimento allasituazione del nostro Paese, l’attitudine laicaafferma che la Chiesa non deve intervenire nellavita dello Stato, limitando il suo campo allasola sfera intima e spirituale del singoloindividuo. E’ chiaro, che a differenza di moltialtri Paesi occidentali, L’Italia soffra di unasituazione differente, avendo nel suo seno unvero e proprio stato teocratico il quale, inbase a precisi accordi diplomatici ha da sempreavuto sia formalmente che ufficiosamente lalibertà di intervenire – a volte pesantemente –nella vita politica italiana (e sarebbe da direanche “sulla” vita politica).
Comunque sia, dato per scontati i dati soprariportati, mi preme soffermarmi sul dibattito dicui feci cenno, perché mi pare che gliinteressati arrivino a conclusioni feconde diargomenti. Per la precisione, a seguito di unarticolo di Claudio Magris sulla laicità – nelquale ripropone dei concetti abbastanza banali,ed altri non condivisibili. Ad esempio, affermaanche che laicità è sapere distinguere ciò che èdimostrabile razionalmente da ciò che è inveceoggetto di fede. Questo non mi pare compitodella mentalità laica, perché il laico deve solofare in modo che le questioni religioserimangano in una sfera privata, direi quasifamiliare e affettiva, sia che abbia la capacitàdi distinguere il razionale dalla fede che non.
-352-
Inoltre, la sua affermazione porta allaconclusione che la fede poggia su basiirrazionali; ma dovrebbe specificare che sitratta di fede religiosa, perché il sentimentodella fede, o meglio dire l’atteggiamentofideistico è presente in molti altri ambiti,compreso quello scientifico (anche se forse piùche di fede bisognerebbe parlare di fiducia).
Dunque, stando a Magris, ciò che è oggettodi fede non può essere dimostrato razionalmente,il che significa che esistono oggetti mentaliche sfuggono l’indagine razionale; ma se sonooggetti della mente, e dunque enti puri, comepossono non essere indagati razionalmente, datoche tutto ciò che è mentale, e dunque forma dipensiero, è analizzabile razionalmente? Sipotrebbe ritenere, pertanto, che non è affattovero che la struttura della mente siaesclusivamente razionale. Esistono ambitiirrazionali, ma che sono reali, dunque oggettodi conoscenza. La conclusione è che c’è unaconoscenza non razionale.
Secondariamente, ma non d’importanza bensìcome proseguo della discussione, se l’oggettodella fede non è un ente mentale, bensì unqualcosa che possiede presenza nel reale,ovverosia un ente facente parte della totalitàdell’universo, assumendo il ragionamento diMagris ne conviene che vi sono oggetti chepossono essere conosciuti soltanto tramite
-353-
analisi non razionale. Insomma, l’irrazionale harealtà, al pari del razionale. E questa è unadicotomia ed anche una visione duplice dellarealtà delle cose.
Magris conclude il suo interventopolemizzando con il senato accademico in meritoal rifiuto o all’impedimento esercitato sulPontefice, quando avrebbe dovuto intervenire conun proprio discorso all’apertura dell’annoaccademico. A parte il riportare malamente ifatti – ma tutti i mass media sembrano averlofatto, in quanto al Pontefice non fu impeditonulla e la segreteria del Vaticano decise diannullare l’intervento – la conclusione cuiarriva, per la quale si tratta di intolleranza,trova giustificazione – sempre che si tratti diintolleranza – proprio nelle parole precedentidello stesso Magris, dove si dice che èpercepibile una pressione e un’ingerenza dellaChiesa negli affari dello stato italiano;ingerenza che giustificherebbe la presa diposizione del senato accademico.
Ma, tornando al discorso principale, ora mipreme analizzare la risposta data da Severino eapparsa sullo stesso quotidiano un paio disettimane dopo. Severino è il massimo filosofoitaliano, o perlomeno quello maggiormenteconosciuto. Sto studiando il suo pensiero cheritengo degno di approfondimento, ma anche dicritica, in quanto pare proprio rifarsi al
-354-
sistema filosofico di Parmenide, il quale vennegià criticato sia da Platone che da Aristotile.
L’intero intervento è veramente ricco dispunti, Severino sa come trasmettere con paroletempli pensieri profondi. Inoltre mi è parso dinotare perfino una certa provocazione nel suointervento, come a voler stimolare uno studio,una discussione per trovare nuovi percorsi dipensiero.
Voglio riportare alcuni stralci del suoarticolo, perché subito all’inizio vi sonoproposizioni meritevoli di discussione.
Questa capacità non è cosa da poco (si riferisceall’affermazione di Magris, laddove si dice lalaicità è la capacità di distinguere ciò che èdimostrabile razionalmente da ciò che oggetto difede). Presuppone che si sappia che cosa sia “dimostrazionerazionale” e che cosa sia “fede”. Questa capacità segna niente dimeno che la nascita della filosofia, la presa di distanza dellafilosofia dal mito, cioè dalla fede.
Queste parole aprono un vero e propriobaratro ragionativo, nel quale ho trovato sommopiacere buttarmici. Severino prende unaposizione drastica, assimilando o forse facendouna uguaglianza tra fede e mito, e,contemporaneamente, asserendo che la filosofia èuna disciplina che si basa su metodiche diindagine puramente razionali. D’altronde, è bene
-355-
ricordare che il tutto il novecento filosofico èstato caratterizzato da un desiderio diriportare la filosofia – e lasciarcela – entro irecinti della razionalità e della logica. Ilfatto che la filosofia, nel suo nascere siastata – anche – un impulso a frapporre unadistanza ideologica tra la ragione e il pensierointorno al mondo e il mito – considerato comeuna narrazione intorno al mondo priva dicontenuti di veridicità, può spingerci aritenere che già dai tempi di Talete esuccessivamente di Parmenide ci fosse laconsapevolezza – anche se a livello basso – diuna scienza che si basasse su scoperte e teoriecomprovabili razionalmente, ovverosia a rigor dilogica (nel mio sistema di pensiero, logica erazionalità non possono essere disgiunti).Tuttavia, non penso che a quei tempi ci fossequella consapevolezza e non penso nemmeno che cifosse la capacità di discernere la scienza dalmito, dato che proprio il mito entrava a farparte di teorie filosofiche (vedi Platone). E,comunque, spesso le teorie che parevano essereimpostati sulla rigorosa logica, o su lucidededuzioni e postulati, in realtà si è scopertonon essere così (ad esempio i postulati diEuclide) tanto da indurre a ritenere che gliantichi pensatori seguissero percorsi diragionamento diversi dai nostri.
-356-
Non mi sembra di poter condividerel’affermazione di Severino, il mito impregnavafortemente l’esistenza degli antichi, a talpunto che fare parte delle dinamiche mentali, ecomunque anche si così non era, adesso non siamoin grado di capire dai soli scritti in cheambito esatto si sviluppava il loro pensiero.
Più avanti, Severino contesta conargomentazione ineccepibile, un’affermazione diMagris, fra le tante, presenti nel suo articolo:Laicità significa tolleranza, dubbio rivolto anche alle propriecertezze. E’ gioco forza per Severino fare notareche se il dubbio deve essere rivolto anche allecertezze, allora anche quest’affermazione chepropone una certezza (la tolleranza dellalaicità) debba essere messa in dubbio; e seviene messa in dubbio, la laicità diventa puroscetticismo su tutti i fronti e senza un minimodi certezza, una base solida, diventa una formafilosofica inaccettabile. Al contrario, se nonla mette in dubbio, allora c’è una certezza chenon può venire messa in dubbio, e per megliospiegare c’è un sapere che non può venire messoin dubbio, pertanto la definizione di laicitàdeve essere rivista. Insomma, un bel paradosso,nato esclusivamente da un’infelice espressionedi Magris, che, leggendo attentamente la suaaffermazione, pare anche accostare la tolleranzaal dubbio. Tolleranza significa mettere indubbio le proprie certezze. Ma tolleranza non
-357-
significa accettare anche le certezzedell’altro, nella consapevolezza che possonoesistere più certezze contemporaneamente, piùverità contemporaneamente?
A me pare che il grave errore di Magris, secosì mi posso esprimere, consiste nel volerportare la definizione di laicità oltre iconfini della delimitazione dei poteri e dellesfere di influenza dello Stato e dell’autoritàreligiosa. Questa porta invariabilmente aequivoci e malintesi. Al contrario, la laicitàdeve essere mantenuta nel suo campo dicompetenza, esclusivamente laddove esista unatrito – se così si può dire – tra Stato eistituzione religiosa. Soltanto in similicircostanze bisogna parlare di filosofialaicista, o laica che dir si voglia, da attuare,sempre che l’idea di uno Stato indipendente dadettami religiosi sia accettata e propagata(idea che comporta immancabilmente una revisionedella stessa concezione di religione). Maladdove non esiste un simile problema, è perfinoinutile parlare di laicità.
Nel finale di articolo, Severino prende inesame l’ultima cartuccia di Magris a favoredella sua visione di laicità, citandodirettamente colui che ritiene essere stato ilprimo a proporre l’idea di laicità. Mi riferiscoa Gesù il Cristo e alla sua famosa sentenza
-358-
evangelica, riscontrabile in Matteo 22, 21. madi questo ne parlerò in successivo pensamento.
Milano, 15 dicembre 2008
-359-
13. Due scritti di karate
Sfogliando – si fa per dire – dei vecchi files, mi
sono imbattuto in alcuni miei scritti, delle tesine
composte durante la frequenza del corso istruttori di
karate. Si parla di ben undici o dodici anni fa, quando
era mio interesse dedicarmi al karate anima e corpo.
Cosa che feci, comunque, e che iniziai a fare molti anni
prima, nel millenovecentottantaquattro. Il corso della
vita, successivamente, prese pieghe differenti e
inaspettate, da lì a un anno abbandonai il karate a
favore del kendo, con grande soddisfazione e ottimi
risultati. Eppure anche quella strada lasciai ed ora, se
debbo essere sincero, non so esattamente quale contrada
stia percorrendo.
Comunque, ora mi permetto di farvi leggere queste
due tesine, ché se pure l’argomento vi è ignoto,
apparendo inoltre di scarsa attrattiva, nondimeno vi si
possono ravvisare barlumi di una mia filosofia di vita,
o almeno i rudimenti o l’intaglio grezzo di un sistema
che forse stavo iniziando a costruire, interrompendolo
per occuparmi di altro. Ed è proprio questo il punto
centrale attorno al quale ruota la mia riflessione: come
posso far rientrare in un unico sistema di pensiero la
molteplicità delle mie esperienze e delle mie letture?
-360-
Ora, però, mettiamo da parte questo dilemma e
godiamoci le mie prodezze ragionative attorno a due
elementi chiavi dell’insegnamento (non solo dell’arte
marziale): come mantenere alto e costante l’interesse
degli allievi (ma si può dire anche “allievi”), e come
valutare il livello di apprendimento degli stessi.
-361-
STIMOLARE L’ALLIEVO NELLA PRATICA DEL
KARATE-DO
Premessa
Questa breve tesi vuole proporre un modello, non di
insegnamento, dato che all’autore manca l’esperienza
necessaria per definirsi tale. Si tratta di uno studio
su come aiutare gli allievi nel trovare e rinnovare con
la pratica del karate-do gli stimoli necessari a non
abbandonare la disciplina.
Per qualche tempo ho insegnato in varie palestrecome aiuto istruttore, confrontandomi sia con cinturebianche, che con cinture colorate e nere. Ne ho ricavatoun nucleo di esperienza e nozioni che mi è servito comebase e sul quale ho costruito questo studio.
Dopo anni di presenza nella federazione, ho maturato
l’idea che la continuità omogenea del sapere del karate-
do può essere garantita da uno zoccolo duro di
praticanti, fedeli ad un insegnamento, ad una
tradizione; ma per favorire l’allargamento di tale
sapere, bisogna fin dall’inizio incentivare l’allievo
nella pratica, evitando così quel fenomeno di riciclo
nella massa dei praticanti, che è, tra l’altro, la linfa
economica della federazione. Se questo significa una
-362-
perdita della qualità, è un discorso che cercherò di
affrontare più avanti.
1 Note personali sul karate-do
Mi è impossibile iniziare a buttare le fondamenta di
un modello di stimolazione senza dimostrare, almeno a me
stesso, di possedere le basi cognitive del karate-do,
il che vuol dire se io conosco il significato del
karate-do; non della parola in se stessa, che è solo un
fatto etimologico (importante ma non vitale), bensì
della disciplina che prende questo nome.
E’ un argomento che esaurirebbe le pagine che
seguono senza proporre una risposta soddisfacente, né
tanto meno aggiungerei valore a quello che molti
studiosi hanno detto in passato. Tuttavia si pone una
questione forse non da tutti affrontata e sicuramente
sottovalutata o ritenuta ingenua. La questione riguarda
la classificazione del karate-do come esperienza non
trasmissibile all’interno dell’insegnamento.
All’inizio c’è il gioco, un’azione che va eseguita
all’interno di un sistema prestabilito e secondo
determinate regole che non bisogna trasgredire per non
incorrere in pene relative alla gravità della mancanza
(volontaria o meno). Da questa breve definizione
parrebbe che ogni cosa è un gioco, dagli scacchi al
-363-
lavoro, dallo sport all’universo. Giocare, nella più
alta concezione del verbo, vuole dire vivere.
Quando praticavo karate da cintura bianca, ascoltavo
le cinture più elevate parlare negli spogliatoi, del
maestro, dei suoi mitici allievi, dei kata. Imparai per
sentito dire che il karate è una disciplina. Più tardi,
ritenni necessario acquisire anche conoscenze teoriche,
così comprai gli ottimii testi di Nakayama, e qualcun
altro di mediocre fattura che preferisco non citare.
Ebbi la conferma delle voci di spogliatoio: il karate-do
è una disciplina.
La società in cui viviamo è un insieme di sotto
insiemi ben definiti (la famiglia, la scuola, la
palestra, il lavoro) dove per la maggior parte delle
volte si utilizzano vocaboli particolari senza darne il
giusto significato, presumendo che tutti ne conoscano le
accezioni. Così avviene per il termine disciplina: tutto
lo usano, ma nessuno spiega cosa intende dire. Ho
guardato il vocabolario, e ne deduco che disciplina può
essere: 1) complesso di norme che regolano la vita di
una società religiosa, scolastica, militare, dove
l’osservanza di tali norme è senza riserve. 2) Dominio
della propria natura e del proprio istinto; capacità di
dominare se stessi. 3) Impegno assiduo, dedizione con
sacrificio. 4) Materia di insegnamento e di studio. 5)
Educazione, direzione, guida ed ammaestramento.
-364-
Etimologicamente, disciplina deriva dal latino discere,
“imparare”. Successivamente ho riflettuto, arrivando a
definire disciplina una sfera di conoscenza appresa
attraverso regole precise ed irrinunciabili, con sforzo,
sacrificio e pratica.
Il karate-do, visto sotto questa luce è una
disciplina. Per il sacrificio richiesto, per le regole
che lo strutturano, per l’atteggiamento dovuto. Anche il
gioco è disciplina; dunque karate-do è gioco nella sua
massima accezione, e dato che il gioco è una
riproduzione della vita, il karate-do è uno specchio
della vita, e la sua costante pratica può condurre ad
avere un approccio alla vita più sereno, ed al contempo
combattivo, più realistico, ed al contempo fantasioso.
2 L’essenza del karate-do
A parlare di argomento, potrei apparire sfacciato.
In verità io non parlerò dell’essenza del karate-do,
perché non la conosco, e nessuno può insegnarmela, ne
adesso ne mai.
Gli antichi greci, ai quali l’occidente deve
l’attuale modello di pensiero, ritenevano che l’essenza
di ogni cosa fosse la sua vera realtà, un nucleo di
verità indivisibile, puro, irraggiungibile dai sensi.
-365-
L’essenza non poteva essere percepita, ma congetturata.
Di conseguenza non può essere insegnata, bensì sentita
come meta di un cammino solitario.
Senza arrivare a filosofeggiare, inutile e
dispersivo in questa sede, mi limito a supporre che
anche il karate-do abbia un’essenza, che corrisponda
alla sue vera natura e attraverso la cui conoscenza si
arrivi a comprendere il perché del karate-do. E dato che
il karate-do è una disciplina, questa essenza non è un
frutto che tutti possono agguantare ed assaggiare; è una
pietra filosofale che si realizza attraverso un percorso
faticoso e costante. Alla maturazione ci si arriva da
soli, grazie agli insegnamenti del proprio maestro, che
nella propria bravura può insegnare i mezzi e le regole
per raggiungere l’essenza, ma non l’essenza stessa, che
è esperienza personale non trasmissibile.
Io posso insegnare ingegneria genetica. Ho appreso
la materia da studiosi che prima di me hanno fatto
importanti scoperte. Queste scoperte sono ora un dato
conoscitivo, una nozione che io trasmetto ai miei
allievi, che avranno i mezzi per operare senza avere
faticato per raggiungerli. E’ come un muro, ogni mattone
è una scoperta, e chi sta in cima gode il panorama senza
avere contribuito a costruire quel muro.
Nel karate-do le cose non funzionano nella stessa
maniera. Fin dalla nascita del bushido, passando per le
-366-
varie epoche storiche giapponesi, si sono susseguiti una
serie di grandi maestri, ognuno responsabile di
innovazioni nelle arti marziali. Evitando di dilungarmi
in una descrizione storica dei processi che hanno
originato il karate-do, mi soffermo sulle figure del
secolo scorso. i loro studi hanno condotto al karate che
conosciamo oggi. Attualmente, grandi maestri come Kase e
Shirai sono una fucina di saggezza ed esperienze
notevoli, il loro livello è quasi commovente per un
praticante quale lo sono io. Tuttavia, l’esperienza di
questi maestri, la sapienza da loro accumulata, non è
stato possibile trasmetterla ai loro allievi. Einstein
ha realizzato la teoria alle fondamenta dell’universo
conoscibile, tutti i fisici la conoscono e la sanno
realizzare. Ma quello che ha realizzato Kase è suo
soltanto, il risultato di una vita di sacrificio, e
morirà con lui. A noi rimarrà un fulgido esempio ed un
modello di pratica.
Il karate-do nasce e muore nel cuore di ogni
praticante. Chi si accinge al karate-do deve riscoprirlo
da solo, e risultati che saprà raggiungere saranno un
frutto del suo lavoro, cresciuti e maturati in lui,
incomunicabili. La palpabile sensazione di crescita
interiore che si prova dopo anni di pratica, ciò che si
ricava da questa sensazione – idee, riflessioni,
miglioramenti – rimarranno confinati in noi stessi.
-367-
Potremo manifestarli nello svolgimento delle tecniche,
nel modo di esprimersi a parole o a gesti, ma l'essenza,
il nucleo, il calore che proviamo nell’eseguire un kata
particolarmente felice saranno soltanto nostri.
Ecco perché il karate-do è disciplina. Disciplina di
mente, disciplina di corpo, disciplina di spirito.
Disciplina, un termine che oggi giorno sembra languire e
che andrebbe riscoperto. Il karate-do permette di
scoprirne gli innumerevoli vantaggi.
3 Cosa insegnare
Considerate le conclusioni sopra riportate, potrebbe
risultare problematico insegnare. Tutt’altro; senza
bisogno di comunicare questi pensieri all’allievo
principiante, ancora inesperto dei percorsi mentali del
karate-do, devo fargli percepire la mia ricchezza
interiore; dalle mie tecniche deve trapelare
l’esperienza che mi ha maturato nel tempo e mi ha
condotto al mio particolare stile di karte-do.
Come praticante, spesso mi chiedo per quale ragione
il mio karate è così, a prescindere dai miei errori e
dalle mie capacità, dal mio maestro e dai miei compagni.
Il mio stile predilige alcune tecniche, alcuni kata;
cosa mi ha portato a ciò? E, ancora più importante,
-368-
quali sono i risultati interiori di questo stile? Posso
migliorare, e nel qual caso come debbo fare?
Questo bagaglio di esperienze, se utilizzato nella
giusta maniera, conduce ad idee ben precise, a prese di
posizioni che sono il fondamento della pratica, anche se
suscettibili di miglioramento. Ciò che devo insegnare al
mio allievo, dunque, a prescindere dal programma tecnico
(un problema della federazione) è come insegnare una
determinata tecnica. Io dovrò rammentare ciò che mi ha
condotto a maturare la tecnica, in quali circostanze
l’ho applicata al meglio, dove non è utile, e
trasmettere tutto ciò all’allievo.
Quando osservo il Maestro Shirai eseguire una
tecnica apparentemente semplice come oi zuki (non si
smetterà mai di ricavare da questo colpo) non posso fare
a meno di pensare che ci sono dietro quarant’anni di
pratica, di riflessioni, di miglioramenti, di scoperte.
Tutto quello che il Maestro ha passato nellì migliorare
oi zuki non potrà mai comunicarmelo, ma io percepisco la
sua ricchezza, lo sforzo di raggiungere ka perfezione,
tutto l’universo che c’è al di là della semplice
tecnica, e questo per me è il suo insegnamento, il
massimo dello stimolo.
Io non sarò mai come il Maestro, tuttavia spero che
i miei allievi percepiranno ciò nell’osservazione di una
mia tecnica: la vita che c’è dietro, il tempo trascorso.
-369-
Si dice che la rosa che il fiore che osserviamo, per
quanto brutto e trascurabile, è il risultato di milioni
di anni. Una tecnica, per quanto eseguita non alla
perfezione, è il risultato di anni di pratica (che ha
senso solo se coadiuvata da spirito di ricerca).
4 Stimolazione
Sarò breve in questo paragrafo, limitandomi ad un
elenco. Altro non posso dire.
Se insegnerò è per una scelta personale, per amore
della conoscenza ed affinché altri se ne impadroniscano.
E’ un atto altruistico, e come tale richiede umiltà e
sacrificio. Forse col tempo mi riconoscerò non idoneo,
ma adesso voglio farmi una proposta.
Il gruppo che si viene a formare va cementato. Mi
devo proporre con serietà, facendo trasparire la mia
preparazione e la mia qualifica. Devo fare scoprire agli
allievi la ricchezza del karate-do, l’utilità della sua
pratica. Naturalmente chi non è predisposto non
comprenderà; dove il terreno è buono questi piccoli semi
cresceranno, e con essi il karate in Italia.
E’ pure un discorso economico, perché non credo alle
attività senza fine di lucro. Tuttavia, se l’allievo
-370-
capisce che il dojo non è solo fonte di guadagno, se
riesco a convincerlo che il karate-do è una continua
riscoperta del valore delle stesse tecniche, allora
questo sarà sicuramente uno stimolo sufficiente. Fargli
uscire il karate che è in lui, fargli assaporare il
valore di una tradizione .
LA VALUTAZIONE
Tesi di Nataniele Paghini
1. Premessa
Prima di analizzare gli scopi della valutazione
applicata all’attività dell’insegnamento del karate-do,
è bene soffermarsi brevemente sulla struttura operativa
della valutazione; una piccola introduzione per avere in
mano la chiave d’accesso a questo complesso argomento.
L’intelligenza è la facoltà mentale in base alla
quale delle informazioni recepite attraverso i sensi
dalla realtà circostante, sono elaborate ed utilizzate
per raggiungere un determinato scopo. Questa è una
definizione basilare, che non tiene conto dell’uso
astratto del pensiero, tanto per fare un esempio,
tuttavia è quella che meglio d’ogni altra ci serve in
-371-
quanto comporta un atto di valutazione, vale a dire il
dato appena assimilato è sottoposto ad un esame, conscio
od inconscio, per verificarne il potenziale d’utilizzo
in base alle proprie esigenze ed alla propria
esperienza. Si ha, infine, la scelta.
La valutazione, dunque, è un modo operativo
continuamente attivo e presente nella nostra vita
quotidiana, precede ogni decisione ed ogni giudizio, e
per quanto obiettiva può essere si basa comunque sulle
proprie esperienze e conoscenze. Nell’osservazione non
esiste una verità assoluta, in quanto l’atto di
osservare è una relazione che presuppone due termini:
l’osservante (attivo) e l’osservato (passivo), dove ad
uno stesso oggetto passivo possono corrispondere più
soggetti attivi, ognuno con il proprio bagaglio di
esperienze e conoscenze. E’ per questa ragione che
l’insegnamento del karate-do è una cosa serissima:
l’istruttore deve tendere alla massima imparzialità,
raggiungibile solo accumulando sensatamente conoscenze e
d’esperienze; nel caso la sua esperienza sia minima,
deve supplire con una profonda nozione del karate, che
ci tengo a precisare non coincide con l’erudizione, per
quanto accurata sia.
E’ bene precisare che la valutazione non è un atto
di pensiero sterile, il più delle volte automatico e
comunque scontato e dunque accettato come tale. La
-372-
valutazione è a tutti gli effetti un processo razionale
produttivo, che può condurre ad una decisione, una
confutazione, una critica, che si traducono in maggiore
conoscenza ed esperienza; è anche un processo formativo,
in quanto forma e qualifica le capacità cognitive
dell’individuo. Chiaramente deve anche essere un
processo di autovalutazione del sistema valutativo
utilizzato.
Per concludere, vorrei differenziare la valutazione
dal pregiudizio, e dal giudizio affrettato. La
valutazione è un processo attivo, un ragionamento voluto
e cercato. Il pregiudizio è una sentenza preesistente
nella società in cui si vive o nel gruppo sociale in cui
si opera (l’ambiente del lavoro, della palestra,
dell’amicizia) assimilata senza attuare la verifica
della sua validità. Il giudizio affrettato è un basarsi
con errata fiducia sull’istinto dettato dall’esperienza.
Certo, una grande esperienza porta a prendere decisione
in un batter d’occhio, e determinate situazioni
obbligano questa drasticità; nell’insegnamento questo
non dovrebbe accadere, perché la varietà psicologica e
culturale degli allievi può coprire un gamma maggiore
della più vasta esperienza.
La valutazione insegna che bisogna sempre
attuare delle verifiche del proprio modello
valutativo: la società umana è sottoposta a
-373-
continui mutamenti, nell’arte, nella religione,
nella filosofia e nella politica, nei costumi e
nei gusti, tali da obbligarci ad una continua
riconfigurazione dei parametri valutativi.
2. L’insegnamento
La valutazione del modello d’insegnamento adottato trova senso nel rispetto degli allievi e del karate inteso come disciplina mentale e non semplice moto fisico ed agitazione di braccia e gambe. Bisogna ricordare che l’allievo è una persona che, il più delle volte, paga per ricevere un’istruzione e per scoprire un mondo che potrebbe rivelarsi con sua gradevole sorpresa più ricco di quanto possa immaginarsi.
Questa autovalutazione si attua attraverso
diverse fasi di verifica e rimoludazione,
necessarie se si tiene conto che 1) l’allievo
reagisce differentemente in relazione alla
propria volontà e capacità di apprendimento, 2)
l’allievo migliora nel corso del tempo ed
abbisogna di nozioni più accurate, 3)
l’insegnante è a sua volta un allievo, dunque
sono validi anche per lui i punti 1 e 2. Siamo
davanti ad un ciclo perpetuo, una catena
circolare composta da quattro anelli: a)
formulazione del modello, b) riconfigurazione in
-374-
itinere, c) valutazione del modello, d)
validazione finale.
Questa catena è preceduta da una vera e propria
presa di coscienza dell’istruttore stesso.
Esaminiamo i cinque punti dettagliatamente.
Presa di coscienza
L’istruttore deve considerare il proprio spessore
culturale in materia di karate ed il proprio grado di
apprendimento del karate. Ciò che io so è sufficiente?
Cosa ho imparato e come? Qual è l’argomento preferito?
Posso migliorare il mio apprendimento?
Quest’esame avviene tramite un’autovalutazione
obiettiva dell’istruttore che si giudica come allievo e
nella valutazione finale del proprio modello di
insegnamento.
La presa di coscienza deve essere sempre costante
nell’istruttore.
a. Formulazione
Il modello di insegnamento non è il
programma. Quest’ultimo è lo scheletro, la
struttura fissa che riprende le direttive della
federazione in seno alla quale si opera. Per chi
opera al di fuori di una qualunque federazione
-375-
(il karate-do trascende per definizione il
concetto di federazione) è fondamentale basarsi
su una grande esperienza nell'insegnamento,
acquisita personalmente od indirettamente.
Il modello d’insegnamento non è tanto cosa
insegnare, bensì come, e come impostare questo come. Il
primo passo sarà una valutazione iniziale dell’allievo
alla fine della prima lezione, una valutazione a priori
che risulterà ovviamente essere incompleta e pertanto
aggiornabile nel corso della stagione. In base alle
caratteristiche evidenziate si formula il modello, che
comporta da parte dell’istruttore: i) un’idea ben
precisa sulla materia insegnata, ii) un piano
metodologico strettamente rapportato alla natura
dell’allievo, iii) un programma sequenziale e
progressivo dei contenuti della materia, iv)
un’organizzazione del contesto in cui si opera (rapporto
con l’allievo al di fuori del dojo), v) un sentimento di
viva partecipazione da parte dell’istruttore, punto
fondamentale per coinvolgere l’allievo.
b. Riconfigurazione
In questa fase si ha la ristrutturazione
dell’insegnamento. E’ un momento periodico in
cui l’istruttore deve verificare che il modello
-376-
approntato sia coerente con le attitudini e le
aspettative dell’allievo. Ciò che è da evitare è
uno slittamento tra l’insegnamento e
l’apprendimento, il cui effetto è un girare a
vuoto dell’istruttore e dell’allievo, ognuno
chiuso in una spirale che non conduce ad un
sensibile miglioramento. L’istruttore non
dovrebbe sentirsi staccato dall’allievo, né
provare indifferenza per l’argomento trattato
perché da lui già sperimentato e compreso (cosa
impossibile nel karate, dove ogni stadio
successivo obbliga un riesame di quanto
imparato) bensì sentirsi parte di uno stesso
insieme. E’ come una relazione i cui termini si
influenzano a vicenda.
Per concludere mi permetto una considerazione, forse
azzardata per la mia immaturità nel karate, ma
particolarmente sentita. Il dojo ha senso se lavorano
contemporaneamente un maestro ed uno o più allievi;
trova realizzazione in quella che si può definire
trasmissione di conoscenza.
La riconfigurazione del modello di insegnamento è
una fase dell’autovalutazione generale che si ripresenta
-377-
ogni volta che venga a mancare sintonia tra istruttore
ed allievo.
c. Valutazione del modello
La prima vera valutazione del modello
d’insegnamento avviene dopo un arco di tempo
prestabilito. Ad esempio, alla prima sessione di
esami per passaggio di cinture, l’istruttore può
verificare la validità del modello che ha
approntato. Questa non si basa sulla percentuale
di allievi che hanno conseguito la cintura,
perché il karate è essenzialmente un’arte,
estranea a statistiche e calcoli di probabilità.
Piuttosto, l’istruttore baserà l’autovalutazione
su quegli allievi che più a fatica di altri
raggiungono il meglio delle proprie prestazioni.
Se l’istruttore forma da un allievo di
prestazioni non elevate un buon karateka (nello
spirito, nel kime, nella costanza piuttosto che
nella forma) ne consegue un giovamento per
l’intero gruppo di allenamento, che si troverà
più compatto.
-378-
L’istruttore è libero di comunicare in
maniera differente secondo l’allievo cui si
rivolge per una correzione od un elogio od una
dimostrazione, tuttavia scopo principale è di
cementare il gruppo di allenamento, tenere
presente una virtuale linea di tendenza senza
troppo discostarsi da essa. Se alcuni allievi la
superano in meglio, ecco che l’istruttore dovrà
sforzarsi di spingere gli altri sulle loro orme,
ricordando ai “primi della classe” che si è tali
grazie anche a chi non emerge.
d.Validazione finale
L’ultima fase serve a legittimare il modello
d’insegnamento, a dargli valore ufficiale onde
considerarlo un intervento formativo
sull’allievo da utilizzarsi come modello futuro,
e dunque ripetibile nel tempo.
Questa validazione non avviene una volta
soltanto, non ha scadenze precise, è piuttosto
un momento che l’insegnante deve sentire nascere
in sé, quando avverte che il proprio intervento
-379-
forma l’allievo come l’ipotesi iniziale aveva
previsto o come le potenzialità dell’allievo
promettono; quando il concetto tradizionale del
karate è compreso e praticato, anche solo come
tentativo; quando nell’allievo scaturisce la
volontà di raggiungere l’obiettivo che
l’istruttore gli ha fatto scorgere.
La validazione, dunque, è un momento
fondamentale nella vita professionale
dell’insegnante. Egli può confermarsi un buon
istruttore, ed avere la certezza di trasmettere
al meglio la conoscenza insita nel karate-do.
Precedentemente, abbiamo parlato di quattro
fasi attraverso le quali l’insegnamento trova il
proprio modello ideale in relazione a
determinati allievi, l’ultima delle quali è la
validazione. Ora vediamo, schematicamente, le
analisi sulle quali si fonda il processo di
validazione.
- L’analisi dell’efficacia. L’insegnamento è
stato efficace? Ha trasmesso la vera essenza del
-380-
karate? L’allievo è ora in grado do praticare
ciò che ha imparato?
- L’analisi della coerenza. L’insegnamento
ha proposto nozioni coerenti fra di loro?
L’allievo ha riscontrato controsensi interni
nella conoscenza acquisita?
- L’analisi della pertinenza.
L’insegnamento ha proposto nozioni pertinenti
con l’argomento trattato? Sono state proposte
nozioni che nulla hanno a che fare con gli
argomenti del karate?
- L’analisi della trasferibilità.
L’insegnamento ha trasferito all’allievo
integralmente e con chiarezza le nozioni
espresse dall’istruttore?
- L’analisi dell’accessibilità.
L’esposizione della materia trattata è stata
tale da consentirne l’accessibilità per
chiunque?
Se queste cinque analisi hanno un esito
positivo, allora il modello formativo ottiene la
-381-
validazione, l’insegnante ha la certezza della
propria professionalità e la propria competenza
è trasferibile in altre situazioni e
sperimentabile in occasioni differenti.
Conclusione
Se lo scopo della valutazione di un modello
di insegnamento è ora chiaro, conviene
considerare attentamente quali sono i soggetti
che operino la valutazione.
- L’istruttore. E’ il primo responsabile del
cammino degli allievi verso la maturità. Ne
consegue il dovere di verificare continuamente
la validità del proprio insegnamento.
- I colleghi. Per comparare il modello con
il proprio e trarne conclusioni edificanti o
proporre critiche costruttive.
- Gli allievi. Ho dei dubbi sull’autorità
degli allievi a confrontarsi con la valutazione
di un modello d’insegnamento. Non nego la
democraticità di questa azione, dato che ognuno
di noi ha la libertà di formulari giudizi su
-382-
cose che entrano a far parte della propria vita,
tuttavia la conoscenza degli allievi nella
maggior parte dei casi non ha lo spessore di
quella dello istruttore (mi riferisco ad un
istruttore qualificato ed esperto). Su quali
basi, allora, operano una valutazione
sull’operato del loro maestro?
Poniamo il caso che l’allievo sia stato
formato nella scienza della valutazione. Ne
comprende i modelli e le finalità, la logica e
la meccanica… ma la sua cultura di karateka è
legata all’arco di tempo di pratica, anche se ha
costruito basi conoscitive e filologiche sulla
storia del karate.
Essendo il karate, prima di tutto un’arte,
la pratica è l’unica via per comprenderne
appieno i reconditi significati. Può esistere un
ottimo karateka ignorante delle origine
dell’arte che pratica (anche se lo stimolo a
conoscerle è inevitabile) ma è impossibile che
uno studioso, per quanto esperto, a digiuno
dell’arte ne capisca qualcosa.
-383-
Gli allievi (lo sono anch’io) devono
sforzarsi di seguire l’insegnamento e di trovare
in esso quelle tracce utili alle peculiarità di
ognuno. Da parte dell’allievo ci vuole
l’intelligenza di capire che l’apprendimento è
attivo, e che dunque bisogna cercare e scovare
nelle parole e nei gesti del maestro le verità
che possono innalzare il livello. Ciò non toglie
il fatto che l’istruttore deve comunque e sempre
autovalutarsi seguendo le regole finora esposte.
-384-
14. La filosofia degli antichi greci
Ho iniziato da qualche giorno la lettura diun libro di Severino, quello che si può ritenerecome uno dei maggiori, o dei più conosciuti (ledue cose non sempre coincidono) filosofiitaliani. Comunque sia, devo ammettere che lasua prosa è limpida e il suo stile conciso,quasi illuminante. Si tratta di una storia dellafilosofia antica, pertanto quella nata in Greciae nelle sue colonie (termine infelice, loammetto), intorno al sesto secolo avanti cristo.In realtà avevo già letto una bella storia dellafilosofia, quella di Bertrand Russell, uno deimaggiori filosofi inglesi del secolo scorso;inoltre ultimamente avevo scaricato diversomateriale molto interessante e dettagliato suifilosofi che normalmente vengono definiti comepresocratici. Ho abbastanza materiale percrearmi una buona base conoscitiva della primafilosofia europea, delle sue radici e dei suoiprimi movimenti.
Il libro di Severino mi serve a cercare ditrovare un filo conduttore che attraversil’intera storia della filosofia occidentale –partendo appunto dai greci antichi – per evitaredi perdermi nelle singole storie dei filosofi, avolte decisamente complesse e profonde. E quinascono i primi problemi; ovviamente, aggiungo,perché a questo mondo è assai difficoltoso
-385-
riuscire a percorrere una strada senza incapparein quale rottura fastidiosa del fondo stradale,oppure in un’improvvisa bella vista che ci rubalo sguardo e il cuore. In questo caso, è ilrendersi conto che Severino non esponeun’imparziale storia della filosofia, bensìdipana un racconto, una storia avventurosa dovei filosofi sono dei coraggiosi avventurieri allaricerca di un prezioso tesoro. Un tesoro cheprobabilmente nemmeno loro stessi sanno cosasia, anche se Severino sembra intuirlo eprobabilmente immaginare che anche i filosofigià sapessero cose che solo secolo dopo sonodiventate di conoscenza comune nella filosofiacorrente. Quello che voglio dire è che mi pareche Severino stia rileggendo l’intera storiadella filosofia a suo modo, o meglio la impostasecondo il proprio modello di pensiero, ilproprio sistema filosofico, la propria ideafondante. E facendo quest’operazione,raccontando una storia, affabulando i lettoriinserendo i filosofi in un percorso giàstabilito, come se ci fosse già a prescinderedalle loro scoperte e dalle loro intenzioni, nonfa altro che ritornare a quel mito cheall’inizioa del suo libro sembrerebbecondannare, in quanto antitesi dello spiritofilosofico. Perché secondo Severino, il mito,pur sempre importante e fondamentale perl’essere umano, non potrà mai essere il racconto
-386-
della Verità, in quanto non la ricerca usando laragione, ponendosi domande, mettendo in dubbio,cercando di osservare la realtà per capirne ifondamenti con l’aiuto della sola mente. Il mitoè una non verità, è un complesso narrativo chevuole spiegare all’uomo il senso delle cose, macome struttura stabilita e immutabile. Gli dèisi accettano per come sono e non li si indaga,il mito lo si accetta, lo si assorbe in sé erimane quello per sempre, immutabile. Il mito è,dunque, un vedere le cose con un’idea giàstabilita che appartiene più alla poesia che nonalla ragione. La nascita della filosofia segnail distacco dal mito, perché i filosofi greci,per primi, negano il mito e si mettono incammino con le proprie gambe alla ricerca deiprincipi che governano il mondo, domandandosicosa sia la totalità delle cose, che fondamentiabbia, quale leggi la governano.
E’ chiaro che si tratta di una rivoluzione ecertamente io non ho le capacità e le conoscenzeper negare l’importanza fondamentale di questoevento. Tuttavia, mi permetto di far notare cheSeverino, negando il mito, lo reintroduce nelsuo racconto, perché lui rivede la nascita e ildipanarsi della storia della filosofia alla lucedi una idea maturata riflettendo su venticinquesecoli di filosofia; perché ritiene che queiprimi filosofi già cercassero un qualcosa il cuiconcetto è nato molto dopo ed è venuto
-387-
evolvendosi e maturando in due millenni; perchédescrivendo la nascita della filosofia comeevento di rottura col mito, non fa cheimmaginare e proporre una fondazione miticadella filosofia; perché se la storia non hasceneggiatura o linee guida se non viste aposteriori, mentre nel suo dipanarsi è unacollezione di eventi le cui relazioni fra lorosono dettate dalle stesse leggi che governano ilgioco di life, allora raccontarla intessendolaattorno alla ricerca di uno stesso elemento,come se tutti i filosofi sapessero a prioriquale fosse l’elemento da cercare, significamitizzarla.
Quando si vive e si lavora all’interno di unmovimento di pensiero oramai consolidatosi, e sivuole ricercarne l’origine persa agli albori deltempo, collocandola nei pressi della vita diuomini la cui intenzione probabilmente non eraquella di creare una simile corrente dipensiero, allora significa effettuare unafondazione mitica.
Quando gli appartenenti ad un genereletterario ricercano degli eventuali precursori,non fanno che fondare un mito, perché non eranell’intenzione di qui cosiddetti precursoricreare quello specifico genere letterario enemmeno ci avevano pensato.
Ma io non ho lo stesso approccio diSeverino, nei riguardi del mito, non
-388-
considerandolo uno stadio del pensiero superatoe superabile. Il mito, e il libro stesso diSeverino lo conferma, è la manifestazione oforse la ragione d’essere della qualitàprincipale dell’essere umano: la mitopoiesi.Ovverosia il desiderio irrefrenabile diraccontare storie e di vedere ogni cosa comefacente porte di un racconto. Noi vogliamoaffabulare ogni cosa e soltanto trasformando ilmondo in un racconto, in una vera e propriafiaba possiamo soddisfare la nostra anima esentirci esseri umani. Ad esempio, anche unlibro meraviglioso come Il racconto dell’antenato diDawkins si dispiega come un racconto e usa lostratagemma di una scaletta narrativa perspiegare l’evoluzione, inserendola in unpercorso mitico, perché vista con gli occhidelle attuali conoscenze e comunque vista noncome avvicendamenti dovuti a causeinterdipendenti ma involontarie, bensì come attidi volontà dei geni per sopravvivere. Anchel’evoluzione, o meglio la nostra idea dievoluzione, è un mito. E qui, prima dicontinuare è meglio spiegare che c’è differenzatra un qualcosa e la sua idea. Che l’evoluzionesia la giusta teoria per spiegare il diveniredegli esseri viventi, è fuori dubbio; ma questateoria non è il terrirotia, ma una sua mappa. Ilterritorio non è la mappa non si è evoluto ecostruito nel corso del tempo seguendo lo scopo
-389-
preimpostato di fornire materiale per una mappa.La mappa è un racconto del territorio, è laforma mitica del territorio.
La conclusione è che il mito puòcorrispondere alla Verità, come nel casodell’evoluzione; oppure può essere solo unracconto per trovare la nostra origine, ol’origine di tutto, come nel caso dellafilosofia di Severino. Perché noi in quantoesseri umani culturali, abbiamo origine nelmito. La nostra psiche è nata nel mito ed è ilmito che offre una spiegazione di cosa noi siamoora. Di cosa siamo come entità psichiche eculturali, s’intende.
Proseguendo la lettura del libro suddetto –e per farvi capire che non ho giudizi negativisu Severino, sappiate che comprerò tutta lacollana della storia della filosofia, anche seil mio mito è diverso da quello che Severinodipana nelle sue opere – ho notato come i grecidi Severino avessero raggiunto identiche – oquasi – conclusioni sul senso delle cose diquelle raggiunte in India con alcune scuole dibuddismo e in Cina con il taoismo. E da notare èlo steso periodo storico, più o meno, ovvero dalsesto al quarto secolo avanti cristo, come sel’umanità fosse stata attraversata da un nuovovento, come una sorta di risveglio collettivo. Manche questo è mito.
-390-
Tornerò successivamente sui parallelismi trala filosofia dei presocratici e quella buddistae taoista.
Milano, 18 dicembre 2008
-391-
15 Nidanasamiuttam
Nei miei vecchi files, Ho recuperato altri miei
commentari inerenti dei testi classici di buddismo.
Ricordo bene che sono contenuti in un meraviglioso libro
che chiesi a barbara come regalo di natale e che lessi
con estremo interesse mentale, riempiendolo di appunti.
A questi tempi, l’interesse che nutrivo per il buddismo
era molto vivo e genuino, dettato da una sincera voglia
di approfondirne le dottrine. Ora, riesaminando quel
periodo, credo che possa iscriverlo nella mia costante e
febbrile ricerca di un centro di gravità permanente,
così come canta Battiato nell’omonima canzone; ed è per
la stessa ragione che successivamente mi sono convertito
alla fede bahai, ritornando poi al buddismo 8ma di
differente scuola), poi ancora alla fede bahai e infine
alla filosofia, forse l’unico vero strumento di
indagine. Nel frattempo dedicandomi alla poesia,
all’arte, alla scrittura, ala fiaba, in un percorso
ciclico che sinceramente mi lascia sconcertato.
Ecco i vecchi file, di cui sopra:
-392-
COMMENTO AD ALCUNI CAPITOLI DEL
NIDANA-SAMYUTTAM
1^stesura: dicembre 2001-gennaio 2002, Milano
Introduzione
Il Nidana-Samyuttam fa parte del Samyutta-Nikaya, una grossa
raccolta di discorsi del Buddha ordinati in sezioni,
libri o sottosezioni, capitoli e, per finire, paragrafi.
Il sutra in questione è il primo libro della sezione
delle condizioni (Nidana-vagga). Bisogna anche dire che
la grande raccolta del Samyutta-Nikaya è inserita nel
vastissimo canone Theravada, ed è redatto in lingua
pali. Noi, come seguaci del Mahayana (e come tali
interessati alle verità esposte in successi sutra)
abbiamo il dovere di studiare i testi del buddhismo
delle origini, utili a fornire i giusti lumi per
chiarificare gli insegnamenti che il Signore Buddha
espose con dovizia di parabole e simbolismi negli ultimi
grandi sutra, ed in particolare nel Sutra del Loto.
E’ quanto mai chiaro che tutta la dottrina del buddhismo
primitivo, a torto nominato Hinayana (Piccolo Veicolo)
-393-
pur nella sua limitata visione delle cose, è
indispensabile per comprendere appieno la profondità del
Dharma del Buddha; per questa ragione è sempre bene
iniziare lo studio didattico del buddhismo con i testi
in pali del canone Theravada (Anziani). E qui è
necessaria una nota di chiarimento.
L’Hinayana, come scuola, in realtà non esiste, essendo
questo appellativo stato coniato dagli esponenti del
nascente movimento Mahayana per designare tutte le
dottrine insegnate precedentemente. Io preferisco usare
il termine di “buddhismo primitivo, o delle origini”. Il
Theravada non è che l’unica scuola rimasta oggigiorno
del buddhismo primitivo. Questo buddhismo è l’insieme
degli insegnamenti che il Buddha espose nella prima fase
della sua trasmissione del Dharma, in relazione alle
esigenze ed alle capacità di comprensione dei primi
seguaci. Successivamente, sul finire della sua esistenza
terrena, l’Onorato del Mondo espose la vera dottrina, il
vero Dharma, nella forma del Mahayana, che vuol dire
appunto Grande Veicolo, in quanto le sue concezioni sono
di portata universale. Questi insegnamenti, tuttavia,
non vennero trasmessi immediatamente, ma tramandati
oralmente da discepolo a discepolo fino a quando la
cultura non fu pronta per accettarli.
Così vuole la tradizione. Nella realtà, presumibilmente,
alcuni monaci iniziarono a maturare una visione più
-394-
ampia dettata da particolari dettagli della dottrina del
Buddha, ponendo in tal modo le basi del Mahayana e
successivamente scrivendo i sutra quali il Prajnaparamita
e il Saddharmapundarika. Dunque, si potrebbero concludere,
il Mahayana non ha nulla a che vedere con l’originario
insegnamento del Buddha. Non è esattamente così:
possiamo tranquillamente affermare che il Dharma del
Buddha letteralmente inspirò i monaci spiritualmente più
evoluti, illuminandoli e mostrando loro il nuovo
veicolo, che essi non idearono affatto, in quanto esso
era già archetipicamente presente. Il Buddha, bisogna
ricordare, essendo un “assoluto”, trascende spazio e
tempo ed il suo insegnamento è vivo e presente in ogni
istante e luogo dell’universo. Ciò vuol dire che il
Buddha insegnò, insieme alle dottrine studiate dal
Theravada, anche il Mahayana, seminò baccelli di puro
Dharma che germinarono secoli dopo, quando le
circostanze furono idonee a stabilire un adeguato
ambiente di crescita. In tutti coloro che la ricerca del
Nirvana risultava limitata, le pianticelle crebbero nel
profondo dell’inconscio, fiorirono bagnate dalla rugiada
delle parole del Buddha e maturarono alla luce calda
della prajna nuovi frutti: i bodhisattva. Costoro
“riscoprirono” gli ultimi insegnamenti del Buddha,
“riscrissero” i sutra ed esposero al mondo l’univo
-395-
veicolo possibile per realizzare il Dharma qui ed ora:
il Veicolo del Buddha.
Tutto ciò raggiunse il suo parossismo nel Sutra del
Cuore e nel Sutra del Loto, sommi insegnamenti che
trasmettono il vero Dharma del Buddha.
Detto ciò, ritorniamo al Nidana-Samyuttam. Per calcolare
l’impatto di forze subatomiche è necessario utilizzare
formule matematiche molto complesse che, tuttavia,
necessitano da parte dello studioso la conoscenza delle
regole principali, quali quelle dell’addizione, del
prodotto, della divisione, eccetera. Similmente, per
immergerci nel sublime campo del Mahayana e potere
gioire nel leggere e recitare il Sutra del Loto,
dobbiamo essere ferrati nei principi basilari del
buddhismo, che proprio si trovano nella loro integrità
nel canone pali.
Nel Nidana-Samyuttan viene esposta la genesi condizionata,
la catena di condizioni che legano la nostra esistenze
ad un imperituro ciclo di rinascite. Come vedremo, la
genesi condizionata è legata alle Quattro Nobili Verità
ed è la soluzione per capire come l’ignoranza sia
basilarmente la causa del nostro vivere dolorosamente.
Ancora una volta, ci tengo a precisare che non sempre è
un bene interpretare la rinascita come reincarnazione di
un principio individuale da un corpo ad un altro
-396-
attraverso una sequenza temporale di esistenze.
Rinascita è anche nascere ogni giorno immersi
nell’illusione e nell’ignoranza.
1. Buddha-Vagga
In questo capitolo il Buddha espone la genesi
condizionata, imputando ad essa la causa dell’origine
del dolore, che come si è visto nell’esegesi del Sutra
della messa in moto della Ruota della Legge è una della
Quattro Nobili Verità; ne conviene, allora, che questo
capitolo del Nidana-Samyuttam ne è una sorta di
corollario.
La genesi condizionata è conosciuta anche come i dodici
nidana, ovverosia i dodici anelli perché la genesi viene
vista come una sorta di catena ciclica. Preferisco il
termine di “genesi condizionata”, addicendosi
maggiormente all’idea che volle presentare il Buddha.
Nel suo stile estremamente conciso e privo di fronzoli,
il Buddha ci elenca immediatamente quelle che si
potrebbero definire come delle stazioni nel cammino
dell’evolversi dell’essere umano, in ognuno delle quali
si manifesta ed opera una determinata qualità o virtù
(non nel suo senso etico) effetto di una causa
-397-
precedente, che a sua volta è l’effetto di un’ulteriore
causa antecedente.
La prima stazione è l’ignoranza, che come si è già visto
nel Sutra della messa in moto della Ruota della Legge, è una delle
cause dell’origine del dolore. In generale, nel
buddhismo di ogni scuola, l’ignoranza è vista proprio
come il fondamento negativo, la madre dell’illusione e
della brama, quanto di peggio un essere umano possa
dimostrare. Naturalmente, non si tratta di una
deficienza di erudizione, anzi! che nel buddhismo – e
specialmente nella tradizione zen – la saggezza (prajna)
scaturisce da un’assidua pratica meditativa e non da uno
zelante studio dei sutra. Sempre nel capitolo che stiamo
esaminando, il Buddha spiega stazione per stazione, e
nella fattispecie dell’ignoranza, parla di nescienza
delle Quattro Nobili Verità. Ignorando la presenza del
dolore nella vita, la sua origine, la sua cessazione
possibile e il mezzo che conduce a questa cessazione,
l’essere senziente causa la nascita dell’ignoranza come
stato di non-conoscenza e produttrice della genesi
condizionata. Come si vede, siamo sempre all’interno di
una stessa vita, e non già in un moltiplicarsi di
reincarnazioni; ignorando la storia del dolore nella
vita di tutti noi, in questa stessa esistenza noi
produciamo una catena di impurità che conducono ad un
ritorno ciclico delle stesse stazioni, un circolo
-398-
vizioso che ci incatena ad una forma di pensiero ed a un
modus operandi del tutto insufficienti a realizzare in
sé l’universo-dharma, che altro non è che il Dharma del
Buddha, o natura del Buddha, che tutti noi possediamo da
sempre.
La natura di Buddha, ovverosia quello stato nel quale
siamo un tutt’uno con l’universo e tempo e spazio
vengono annullati, è lo stato naturale e spontaneo di
ogni cosa esistente, animata o meno. Tuttavia, gli
esseri animati, dotati di coscienza e pensiero, emozioni
e sentimenti, vivono in turbinio di passioni – il ché
non è cosa negativa – che spesso conducono la loro mente
lontana da una giusta visione dell’universo. Questa
visione errata produce concezioni, opinioni, ipotesi che
vengono tramandate di generazione in generazione,
allargando ed aumentando le basi per lo sviluppo
dell’ignoranza. Nel momento in cui, la verità del dolore
(con i suoi tre sigilli, come spiegato sopra) viene
realizzata, allora l’ignoranza si dissolve e diviene
possibile iniziare il cammino verso la buddhità. Il
problema sono le tendenze, rappresentabili come la forza
di inerzia delle nostre azioni, e pensieri e parole.
Fino al cessare di questa forza, la nostra vita non può
che seguire i vecchi schemi e metodologie di pensiero,
appunto in quanto influenzate dal nostro agire passato.
Possiamo chiamare queste legge, la legge del karma. Lo
-399-
spazio che sussiste fra le tendenze che non possiamo che
seguire e la libertà assoluta di reagire agli eventi a
nostro piacimento rappresenta il nostro grado di karma,
o meglio: la forza del karma. Più piccolo è lo spazio
fra il libero arbitrio ed il destino maggiore è la
potenza del karma e dunque la pesantezza delle azioni
passate. Maggiore è lo spazio di azione, minore
l’influenza del karma. Quando lo spazio sarà uguale
all’infinito, vorrà dire che ci saremo affrancati dalla
legge del karma, avendo scatenato la natura di Buddha
che è in noi.
Dobbiamo immaginare uno scultore che ideata un’immagine
cerca di ricavarla da un blocco di pietra, scalpellando
le parti superflue. maggiore è la sua bravura, maggiore
sarà la possibilità che la statua risulti identica alla
sua immagine. Così, l’immagine è la natura di Buddha che
noi grazie agli esercizi percepiamo di avere. La nostra
capacità di colpire è il grado del nostro karma, e la
statua che ne risulta è il nostro gradi di
illuminazione. Dovremo scolpire molte statue per
migliorarci, e non è detto che in questa vita ci si
riesca.
La seconda stazione, che sorge in dipendenza
dell’ignoranza, sono i sankhara. Il termine è di
difficile traduzione, indicando le predisposizioni che
-400-
nascono a causa dello stato di ignoranza e che imprimono
un corso all’esistenza non ancora individualizzata.
Chiaramente, qua si intendono le azioni della vita
passata che predispongono i sankhara, ma noi possiamo
immaginarli come fattori ereditari, ambientali ed
educativi, nonché come il daimon idealizzato dallo
psicologo jungiano Hillman. Conviene ora fare una piega
all’esterno per parlare del daimon e di come esso possa
essere considerato come un sankhara.
Hillman, nel suo libro Il codice dell’anima, cerca di
riproporre una psicologia distante da una fredda scienza
che vede l’essere umano come una pura e schematica somma
di fattori, tali che quel fattore più questo fattore più
altri n fattori produce l’essere umano e la sua
individualità, al pari di una semplice operazione
matematica. Hillman rifiuta una simile conclusione, e
vuole dimostrare che l’individualità umana ha un
nocciolo incontaminato che è l’anima, la quale viene al
mondo custodita e influenzata dal daimon.
16 L’educazione dei figli
Mi soffermo su questo argomento, pervalutare il mio modo di essere padre ededucatore. Pur ammettendo che ritengo il ruolodel padre privo di lineamenti ben definiti, a
-401-
differenza delle generazioni precedenti, rimaneinvariato il suo ruolo – così come quello dellamadre – di educatore. Ora, cosa significhieducare è compito arduo da definire, così come ècompito arduo quello di metterlo in pratica; sepure risulta fondamentale il farlo.
E’ chiaro che per essere educatori bisognasia credere nel proprio ruolo e nella suaimportanza, sia avere dei modelli diriferimento, ovvero dei valori superiori, delleIdee cui tendere per poi riflettere taletensione verso i propri figli. Risultaconseguente che educare significa trasmettere ivalori cui si crede, pertanto è precipuamentenecessario possedere dei valori.
Da dove arrivano questi valori che noidobbiamo trasmettere ai nostri figli? sono ivalori della nostra società, oppure quelli aloro volta ricevuti dai nostri genitori (equesti ultimi due coincidono?)? Oppure liricaviamo dalle esperienza di vita vissuta? Sonolegati al nostro modo di vivere e pensare? Credosia un po’ di tutto ciò, ma credo più di ognialtra cosa che i valori rispecchino il nostromodo di vivere e di pensare e di rapportarci congli altri. Ecco, allora, che per essereeducatori, per prima cosa dobbiamo tenere – comesi suol dire – una retta e decente condotta divita. Tenere, così come si tiene la rotta, unavolta fissata, malgrado le tempeste o la calma
-402-
piatta, perché la meta è davanti a noi, abbiamofissato la rotta tramite le costellazioni,sappiamo che là in fondo è la fine del viaggio eche è nel viaggio che ci forgeremo. I valori nonsono la meta, ma il viaggio stesso, sono tuttociò che si fa per tenere la rotta, sono laconseguenza della ferma volontà di raggiungerela meta. La quale sarà sempre oltre l’orizzonte,quale ideale puro e irrealizzabile, appuntoperché non è nella sua natura venire realizzato,concretizzato, messo in pratica, bensì è nellasua natura ispirare i marinari e i naviganti,dar loro la forza e la costanza di proseguire ilviaggio; il quale a volte avrà degli improvvisiscartamenti, scogli da evitare, pericoli daaffrontare, ampi giri da effettuare, isole earcipelaghi da circumnavigare o attraversare,che i nostri valori muteranno, perché avremoperso l’orizzonte della meta. Ma solo per untempo limitato, perché soltanto guardando lecostellazioni alla fine dell’impedimento odell’evento fuorviante ritroveremo la rottagiusta per proseguire il viaggio.
Ci sarebbe, dunque, da capire cosa sianoqueste costellazioni che ci aiutano a tenere larotta, che ci indicano la strada per quegliideali verso i quali attueremo un cammino cheforgerà i nostri valori. Sono le stessecostellazioni per tutti o cambiano? Sonoarchetipi o le acquisiamo? Conducono solo verso
-403-
16. COMMENTO AL DHARMACAKRAPRAVARTANASUTRA
1^stesura, dicembre 2001
Introduzione
La traduzione esatta del titolo del sutra è: Sutra della
messa in moto della Ruota della Legge. Già da qui si
possono trarre ampi spunti di riflessione e discussione,
infatti questo sutra può ben essere considerato il
resoconto del primo discorso del Buddha nell’
esposizione della dottrina che sarà a fondamento del suo
insegnamento. Da quel momento si ha, nella tradizione
buddhista un po’ di tutte le scuole, la prima messa in
moto della Ruota della Legge, che segna l’introduzione
nel mondo del Dharma del Buddha.
Il Dharma del Buddha è una nozione dai significati tanto
ampi quanto sfuggenti, e se inizialmente era atto ad
identificare in una discussione fra monaci o in
un’esposizione o commento di parole dell’Illuminato lo
stesso insegnamento del Buddha, successivamente ha
inglobato nelle sue molteplici accezioni anche quelle di
-405-
“senso delle cose”, “legge universale”, “il fattore più
piccolo dell’esistenza causale dato di conoscere”, e
molto altro ancora. In questo sutra, il termine
mantiene il suo significato primitivo, dato che non è
ancora nata la filosofia mahayana con tutto l’apparato
speculativo di respiro cosmico che me segue. Ciò non
vuol dire, tuttavia, che non si possa leggere il sutra
in questione tenendo a mente una nozione più universale
di Dharma.
L’importanza del sutra, comunque, è data
dall’esposizione che il Buddha fa in pubblico delle
Quattro Nobili Verità, dette anche Eccellenti
Asserzioni, che risultano essere il fondamento del suo
insegnamento. Il Buddha, avendo realizzato il risveglio
(bodhii), si presta a trasmettere questo meraviglioso
tesoro a chi è disposto ad ascoltarlo. La tradizione
vuole che al momento del Risveglio, il Buddha,
comprendendo che nessuno avrebbe mai potuto seguire una
così difficile Via, decidesse di ritirarsi nella foresta
a meditare in silenzio per il resto della sua esistenza.
Solo l’intervento di Indra (una divinità induista,
precisamente vedica) convinse il Buddha ad insegnare il
Dharma, salvando così tutti gli esseri senzienti, anzi,
l’intero universo. Sicuramente si tratta di
un’integrazione tardiva per compiacere e forse attirare
i fedeli induisti; è certo, comunque, che l’iconografia
-406-
buddhista ha attinto a piene mani in quella induista, la
quale, come religione, ha nel corso dei secoli assorbito
il buddhismo, relegando il Buddha storico a
manifestazione (avatar) di Vishnu.
-407-
La Prima Asserzione
Dolore
La vita è dolore (duhkha). Il Buddha parla che è
doloroso non ottenere ciò che si vuole, è doloroso
perdere ciò che si ama, vivere con ciò che si odia, la
malattia, la morte. Sembrerebbe che la vita stessa sia
dolorosa. Alla fine, conclude ricordando che i cinque
skandhaii sono dolore.
Una visione a prima vista tremendamente pessimista della
vita, che poggia la sua base sulla realtà del dolore,
sulla sua continua azione nei confronti di tutti gli
esseri. Il Buddha, va detto subito, non è un filosofo,
non è un uomo dedito alla speculazione; egli è un medico
che mosso da compassione individua una malattia, ne
indaga le cause, realizza che esiste un rimedio e lo
mostra a tutti, in un atto di donazione completa di se
stesso. Ciò che richiede in cambio è solo attenzione,
volontà, generosità, disciplina, concentrazione e
perseveranza. Ne consegue che non bisogna studiare ed
analizzare le Quattro Eccellenti Asserzioni alla stregua
di una qualsiasi teoria filosofica, bensì farle proprie
con l’intero corpo, realizzarle nella vita di tutti i
giorni.
Il dolore di cui si fa cenno, che è un sintomo, non è un
veleno che ci uccide. E’ la cartina tornasole della
-408-
nostra esistenzialità. Noi siamo “esistenti”, e siamo
“personalità” e dunque viviamo in quanto soffriamo, e
tutta la nostra vita si costruisce sulla sofferenza. Di
questa sofferenza dobbiamo prenderne atto con
consapevolezza, questo ci dice il Buddha, anzi ci esorta
a farlo. Dobbiamo vivere il dolore per capire quanto
importante esso sia per l’evoluzione non solo dell’uomo
in quanto homo sapiens, ma di tutte le specie viventi,
del mondo e dell’intero universo. Nel mondo della
natura, la sopravvivenza della specie è legata alla
lotta del più forte che sopprime il più debole, del più
forte che scampa il predatore, del più forte che
trasmette il suo seme,
-409-
del più forte che resiste alle calamità; dolore che
forgia, che costruisce, che modella. Dunque, dire che
tutto è dolore, vuol dire che questo posto in cui
viviamo è vivo con noi ed in noi, pur essendo
condizionato ed impermanente. Lo stesso Bodhisattva, in
eterno procinto di realizzare la natura buddhica,
rimanda l’agognata meta per rituffarsi nel dolore della
vita e salvare tutti gli esseri, quasi consapevole che
solo provando dolore può sperimentare l’ebrezza
dell’avvicinamento alla buddhità.
Nel dettaglio, il Buddha si riferisce al dolore
dell’essere umano che pur essendo un costrutto di
aggregati si illude di avere una natura propria, una
essenza e ne rimane legato moltiplicando in tal modo il
dolore. Qui bisogna introdurre tre termini: Sankhara
(condizionato), Anatta (non sussistente) e Anytia
(impermanente) relativamente ai cinque skandha. L’essere
umano, dice il Buddha, per quanto ci è dato sapere
tramite l’osservazione dei sensi (ed altri dati non ci
possono essere forniti al di fuori della sfera di azione
dei sei sensi) è un costrutto, un sistema operante
grazie all’armonia di cinque aggregati: il corpo
materiale, organico; le sensazioni (udito, vista, tatto,
gusto, olfatto e pensiero); le ideazioni, che susseguono
alle sensazioni (ascolto un rumore - la sensazione - lo
identifico successivamente come musica di pianoforte -
410
ideazione o percezione); tendenza comportamentale,
ovverosia la nostra personalità, con la quale nasciamo
e che ci suggerisce il comportamento e gli atteggiamenti
(qualcosa di simile al daimon greco, il genio che
accompagna l’anima nell’esistenza); la coscienza. Ora,
questi aggregati, questi fattori costituenti, sono causa
di dolore. Perché? La risposta ci è fornita da un sutra
della tradizione mahayanica, uno dei testi più studiati
ed in alcune tradizioni (zen) venerati come fondamento
della dottrina del Buddha, Il Sutra del Cuore
(Prajnaparamita Hirydaia). Quivi si afferma che i cinque
aggreagati sono nella loro essenza vuoti, ovverosia non
hanno essenza e come tali sono impermanenti, non
sussistenti e condizionati. Analizziamo le tre qualità
(ma forse andrebbe detto non-qualità?)
Impermanente. L’essere umano come nasce, così muore.
Essendo un composto, presto o tardi si disferà perdendo
la temporanea ed effimera identità. Nel finale del Sutra
della messa in moto della ruota della legge, un
discepolo del Buddha, Kondanna, dice: “Ogni cosa che ha
la natura di sorgere, ha anche la natura di cessare.”
L’eternità intesa come impossibilità di una fine dello
trascorrere del tempo non è negata. Negata è l’idea
dell’essere umano che permanga se stesso per l’eternità.
Non sussistente. Mancanza di un ego, di un anima dotata
di una essenza, esistente in sé e per sé stessa.
411
L’identità non è un’unità incondizionata, ma il prodotto
dell’agire dei cinque aggregati e come tale è priva di
natura propria e dunque suscettibile di modifica, di
nascita e cessazione. Non si nega l’Io, solo si fa
notare come esso sia solo un prodotto artificiale, un
artificio per l’appunto.
Condizionato. Nell’Antico Testamento, iddio si proclama
come “Io sono Colui che sono”. Colui che esiste da sé,
indipendentemente da qualunque altra cosa al di fuori di
ciò che è, della sua natura. Iddio è incondizionato.
L’essere umano non è esistente per se stesso, così come
nulla nell’universo è esistente per se stesso, ma
manifesta la propria identità soltanto grazie a una
moltitudine di rapporti con altre entità, animate o meno
che siano, vive o morte che siano. Vuol dire essere
condizionati, vivere in dipendenza di altro, il quale
vive in dipendenza di altro ancora. L’universo allora,
non è un insieme di “cose” a se stanti e dotate di
natura propria, bensì un sistema dove tutto è evento. La
stessa scienza, negli ultimi anni, specialmente con la
meccanica quantistica e la fisica subatomica, sta
riproponendo questa visione dell’universo.
Ora, avendo realizzato che i cinque aggregati sono
condizionati, impermanenti, non sussistenti, dobbiamo
capire come mai siano causa di dolore. E se i cinque
aggregati sono l’essere umano (io che scrivo, tu che
412
leggi), ne consegue che l’essere umano è dolore, è causa
ed è effetto del dolore. Perché?
i . Bodhi. Risveglio, impropriamente tradotto con “illuminazione”. E’ l’alienazione dell’individuodal samsara, e di conseguenza la stessa cessazione dell’individuo in quanto sinonimo di Io ed Ego. E’ la realizzazione totale, e non mentale o razionale, delle Quattro Nobili Veritàe dei Dodici Anelli di Causalità.
ii . Skandha. Aggregati che nel loro agire in relazione reciproca provocano l’illusione apparente della personalità. Rupa: forma materiale. Vedana: sensazione sensoriale. Samjna: percezione on ideazione che segue la sensazione. Samskara: tendenza comportamentale. Vijnana: coscienza nella sua totalità (conscio ed inconscio).
413
La Seconda Asserzione
Causa del dolore
Causa ed effetto. Se accosto una fiamma ad un foglio di
carta, questi brucerà. Il Fuco è la causa, il piccolo
incendio l’effetto. In effetti, anche il fuoco, quale
causa, risulta essere un effetto, dato che ci sarà stata
sicuramente una causa ad originarlo. Così, il piccolo
incendio, pur essendo un effetto, sarà causa del fumo.
La realtà è tutta qui, un sistema complesso di cause ed
effetti. Quale è la causa del dolore? I cinque
aggregati? Il Buddha dice: “La brama che cagiona la
rinascita è accompagnata da appassionato piacere, poiché
trae piacere da questo o da quell’oggetto, cioè a dire,
la concupiscenza, la sete di vivere e la sete di
annientarsi.” Parole potentissime, ma facili da
fraintendere. Si parla anche di rinascita, termine
spesso usato come sinonimo di reincarnazione, intesa
questa come trasmigrazione di un’identità permanente da
una vita all’altra. Vorrei esporre una proposta di
interpretazione alternativa.
Ogni giorno è una rinascita, perché ogni giorno nasciamo
a nuova vita. Il cielo non è quello di ieri, i pensieri
non sono quelli di ieri, le emozioni anche. Sono simili,
è vero, ma non sono le stesse. Tutto il mondo non è lo
stesso, e qualunque cosa facciamo, o proviamo o sentiamo
414
è come se fosse per la prima volta. In tali termini,
rinasciamo ogni giorno. Per quanto riguarda una
probabile anima, non mi pronuncio. Lo stesso Buddha, non
disse mai nulla a riguardo.
Causa del dolore è la brama di questo rinascere, cioè il
desiderio vorace di vivere il mondo traendo piacere
dagli oggetti, dalle persone, dagli esseri viventi, dai
pensieri ed altro ancora. In una sola parola:
attaccamento.
Attenzione a due cose! Il Buddha ci fa notare che anche
il desiderio del non attaccamento (annientamento) è
causa del dolore, ché essendo appunto un desiderio di
qualcosa è di conseguenza una forma della “brama”.
Secondo, sarebbe una visione oltremodo aberrante del
buddhismo ritenerlo un sistema di pensiero che vede la
voglia di vivere e la vita stessa come un male da
estirpare per cessare il dolore. Il Buddha amava la vita
ed ha vissuto con passione. Qaule allora la differenza?
Dobbiamo tornare, dunque, per capire questa seconda
verità, all’impermanenza, al condizionato ed al non
sussistente. Tutte le cose non avendo natura propria,
dipendendo le une dalle altre, sono essenzialmente
vuote. La brama di vita, al contrario, è considerare le
cose come fini a se stesse e dotarle di una natura
propria a prescindere dal rapporto con l’intera
totalità. La brama è dunque considerare se stessi entità
415
dotati di una identità permanente, di una natura propria
sussistente e di una vita incondizionata. In tali
termini si crea desiderio di noi stessi, e di
conseguenza di quello e quell’altro oggetto. Se poi
decidiamo che questo desiderio non va bene e vogliamo
annullarci, ecco che nasce una nuova brama, perché
l’annullamento è un oggetto desiderato.
Ogni brama che proviamo, per un nuovo telefonino, una
nuova moto, un’altra donna, un viaggio esotico, un
affare promettente, un libro interessante, anche per
recitare davanti al Buddha o meditare, è una rinascita.
Non c’entra nulla col fatto di vivere, di mangiare, fare
l’amore, volere bene, sacrificarsi per il prossimo,
scrivere o leggere. Non il fare che crea la rinascita,
ma la modalità del fare.
Il Buddha parla di concupiscenza. Che è un modo per
definire un desiderio smodato. Nell’economia delle
quattro verità esposte, indica un desiderio ottenebrato
dall’ignoranza.
L’ignoranza è lo sfondo della Seconda Asserzione. Non
vine detto apertamente, ma risulta chiaro che tutto il
discorso ruoto attorno a questo stato di essere della
mente. Un’ignoranza che non ha nulla a che vedere con la
mancanza di erudizione, di conoscenza, o con la demenza.
La si vuole intendere come mancanza di prajna, di
sapienza, quella tanto cara ai greci dell’antichità e
416
che mai come in questi ultimi tempi latita nella nostra
tanto amata civiltà occidentale.
La prajnaiii è una delle sei perfezioni cui deve tendere
un bodhisattvaiv, ed attorno ad essa ed alla sua ricerca
che ruotano molte scuole buddhiste del Mahayana. Una
appropriata traduzione, sarebbe: gnosi. Questa sapienza
iii.Prajna. Pra= avanti, al di là. Jna= conoscenza, conoscenda dialettica. La prajna è la conoscenza trascendete al di là della conoscenza dialettica, che è quella ottenibile tramite il ragionamento. Laprajna è una sapienza che trascende la mente, è intuizione metafisica, raggiungibile attraverso il retto sentiero indicato da Buddha nella Quarta Asserzione.
iv.Bodhisattva.Bodhi= risveglio. Sattva= esistenza. Il bodhisattva è una figura mitica, atta a rappresentare un’essere che pur avendo realizzato la buddhità rinuncia volontariamente allo stato di Buddha per aiutare gli esseri viventi. In realtà, il bodhisattva non è solo un orpello mitico per la devozione del fedele. Può rappresentare qualunque cosa aiuti a creare una sorta di frattura della realtà quotidiana in modo da intuire la conoscenza trascendete e dunque percepire, anche se brevemente, lo stato di risveglio; dunque, un oggetto, così come una persona. Va detto che anche chi si adopera disinteressatamente per il benessere
417
trascendente, è ciò che ci permette di intuire l’esatta
origine del dolore. Realizzare non dialetticamente
l’esatta origine del dolore vuole dire risvegliarsi alla
natura di buddha e realizzare la buddhità, entrare nel
nirvana (terza verità). Ecco che, allora, la prajna è lo
stato di illuminazione, è il risveglio, è la natura di
buddha.
del prossimo è un bodhisattva (vedi Maria Teresa diCalcutta). Si può essere bodhisattva anche solo perun attimo, come chi aiuta un proprio collega senza pensare a promozioni, aumenti o lodi da parte del superiore.
418
La vita è un accadimento meraviglioso, è la volontà del
Dharmav che si manifesta, è una qualità dell’universo.
Non bisogna disprezzarla o fuggire da essa. Come dice
chiaramente il Buddha, “sete di vivere e sete di
annientamento” sono le cause del dolore, dove sete di
vivere non è sperimentare con gioia la propria vita
v.Dharma. Concetto chiave del buddhismo, di difficile interpretazione, dato che ha più accezioni e nel corso dei secoli ha assunto significati sempre più profondi. Il dharma (lo scrivo appositamente con la lettera iniziale minuscola) all’inizio della storia del movimento buddhista stava a significare la dottrina del Buddha, ciò che aveva esposto nei suoi insegnamenti. Successivamente, in special modo con il fiorire della visione mahayana, con dharma si è voluto rappresentare la Legge Universale, in base alla quale ogni cosa è quello che è e sarà quello che diverrà. Come dire: il senso delle cose. Ma il vero Dharma è la realtà assoluto trasfenomenica, uncampo mistico che sottende a tutte le cose, create od increate, una forma di energia che compenetra edavvolge dando senso e giustificazione alla realtà. Visto in questa ottica, la realizzazione del Dharmain noi stessi è lo scopo principe della Via del Buddha, a patto che non si cada nell’errore di considerare il Dharma come una manifestazione divina, se non Dio stesso.
419
bensì ritenere che le cose che percepiamo siano da
conquistarsi e da usarsi per raggiungere la gioia dei
sei sensi; e dove annientarsi non è sperimentare la
quiete della meditazione bensì assurdamente cercare di
annullarsi come persona.
La Terza Asserzione
Cessazione del dolore
Voglio riportare le esatte parole del Buddha:
“Questa, o bhikku, è la nobile verità circa la
cessazione del dolore: la completa cessazione,
la rinuncia, l’abbandono di questo bramare, il
completo allentamento della sua presa e il
completo distacco da esso.”
Appare chiaro che non si parla di annientamento
od estinzione della vita, bensì della brama,
420
della concupiscenza che ci porta ciecamente ad
attaccarci alle cose e negare così la verità
dell’impermanenza e transitorietà. Il ritirarsi
a vita ascetica, condurre una prassi
mortificante sia per il corpo che per la mente,
spostarsi verso un estremo di povertà sensoriale
ed emotiva non è la soluzione che il Buddha ha
realizzato e sperimentato. Tutto il discorso
ruota attorno alla ricerca del distacco del
nostro vivere dalla brama del vivere. Sembra un
controsenso, in realtà è una perla di saggezza
ricca di profondità significative. Per noi
occidentali, la cui civiltà ha imposto parametri
basati sul ragionamento, l’appagamento di
421
esigenze materiali non utilitaristiche e gli
effetti di una sempre più raffinata tecnologia,
la vita ci appare come una competizione volta a
guadagnare più spazio, più tempo e cose
possibili, alienandoci la necessità di
un’armonia con il mondo ed imponendo un
costrutto artificiale da addizionare al mondo
stesso, come un mondo nuovo sopra un mondo già
preesistente. Motivo per il quale siamo
disperatamente attaccati alle cose, essendo
questa concupiscenza l’unico mezzo per tenere in
esistenza - e giustificare tale esistenza - il
mondo da noi creato. Prendiamo come esempio la
medicina. Essendo basata sulla tecnica
422
scientifica, più che su un’approccio umano al
paziente, il risultato raggiunto (integrato da
molti altri fattori che elencare adesso
porterebbe il discorso lontano ed in altri
campi) è quello di ritenere qualunque tipo di
patologia od infortunio come un ostacolo ad una
vita che di diritto dovrebbe essere sana e
gaudiente. Siamo arrivati al punto da ritenere
un diritto morire di vecchiaia il più tardi
possibile, mentre ogni malattia, od incidente od
infortunio provochi un ferimento se non la morte
è alieno, estraneo, deturbante e da estirpare.
Non sto dicendo che i mali non vanno curati e
gli incidenti prevenuti; sto dicendo che anche
423
loro rientrano in un disegno dove ogni evento ha
lo stesso valore, e dunque morire di vecchiaia
(per quanto bello ed auspicabile) è identico che
morire di cancro. In entrambi i casi la vita
dell’individuo si realizza perché ogni evento è
un effetto e dunque il suo avverarsi
giustificabile ed inscrivibile nella nostra
effimera esistenza. Se accettiamo ciò, allora
cancelliamo la brama ed estirpiamo il dolore.
Nel buddhismo si parla spesso di nirvana. Dubito
che il suo esatto significato sia a tutti i
buddhisti o studiosi di buddhismo chiaro. E non
potrebbe essere altro, perché concepire con
424
limpidità di mente il nirvana vuol dire
realizzarlo e dunque avere raggiunto lo stato di
Buddha. Il nirvana è la cessazione del dolore,
esso si può valorizzare soltanto con negazioni,
ed allora il nirvana non è attaccamento alla
vita e non è attaccamento alla non-vita, non è
dolore ma non è nemmeno non-dolore, non è l’ego
ed a maggior ragione il non-ego. Il nirvana è la
cessazione non tanto del dolore o della brama,
ma del ragionamento dialettico e della coscienza
discriminante, per cui le cose sono ordinabili
per opposti, e in generale per classi,
categorie, ordini e sottordine, eccetera.
L’universo non è strutturato secondo le leggi e
425
le categorie che l’uomo ha formulato nel corso
dei secoli. Piuttosto, le leggi e le categorie
possono spiegare all’uomo il suo funzionamento,
ma esso esiste al di sopra dei nostri concetti.
La Legge del Dharma che regola ogni cosa, in
realtà è una non legge, perché è l’armonia delle
cose (ma dovrei dire degli eventi) ed il loro
esistere compartecipatamente l’unica (non)regola
che permette alla realtà di manifestarsi. Il
Dharma è esattamente quello che vediamo,
increato, autonomo, assoluto... che si palesa
come creato, dipendente e condizionato.
Il nirvana, come diranno alcune scuole
buddhiste, è il samsara, o meglio, la
426
realizzazione che nirvana e samsara coincidono.
Essere Buddha, quindi, è vivere qui ed adesso e
realizzare la propria esistenza.
La Quarta Asserzione
Via che conduce alla cessazione del dolore
Come si diceva all’inizio, il Buddha espose le
Quattro Verità con l’esprimersi di un medico,
che, analizzato il sintomo e trovatene la causa,
assicura una cessazione del male e dispiega la
ricetta. In questo particolare sutra, la ricetta
427
viene esposta già all’inizio, dove Egli parla
della Via Mediana da seguire per guadagnare il
nirvana. La Via Mediana è una grande rivoluzione
del pensiero, in verità intuita da altri
contemporanei del Buddha (Aristotele in
occidente, quando la cultura greca era in grado
di produrre sistemi di pensiero di altissimo
valore). Il Buddha la spiega con poche ma
concise parole: “Questi due estremi, o bhikku,
non dovrebbero essere seguiti da uno che abbia
lasciato la vita nel mondo: dedizione ai piaceri
dei sensi, che è bassa, rozza, volgare, ignobile
ed inutile, ed infliggersi tormenti, il che è
doloroso, ignobile e privo di utilità.” La Via
428
mediana è esattamente ciò che sta nel mezzo di
questi estremi, come già precedentemente detto,
e si esplica nel seguire l’Ottuplice Sentiero:
retta visione, retto pensiero, retta parola,
retta azione, retta condotta di vita, retto
sforzo, retto rammemoramento, retta
concentrazione.
Le traduzioni italiane dell’Ottuplice Sentiero
sono varie, pertanto ora affronterò ogni
sentiero elencandolo sia in sanscrito che nelle
diverse traduzioni.
1. Samyag-drsti (Retta Visione, Retta Fede)
429
Nel Magga-Samyuttam, capitolo I Avijja, il
Buddha dice che Retta Visione è la conoscenza
delle Quattro Nobili Verità. Una Retta Visione,
è quella che ci consente di vedere la realtà del
mondo, di realizzare l’esistenza del dolore
quale effetto della concupiscenza, di credere
nella possibilità della sua cessazione e nel
perseguire tale fine con il mezzo dell’Ottuplice
Sentiero. Oscar Botto, studioso insigne del
buddhismo, parla di retta fede, in quanto è
necessaria la fede nelle verità esposte dal
Buddha. In questo caso, conoscenza, visione e
fede coincidono.
Entrare nella corrente del Buddha implica una
430
ben precisa presa di posizione, che tuttavia non
va confusa con l’assunzione di dogmi ritenuti
verità indiscutibile al di là di ogni possibile
argomentazione. Le Quattro Verità non sono una
serie di assiomi che pretendono dal fedele una
cieca fiducia e che non necessitano di ulteriori
verità a priori. Il Buddha invita tutti a
verificare l’esattezza delle sue proposizioni
prima di assumerle come fonte di vita, pertanto
è un dovere studiare e capire e realizzare le
sue parole e farle nostre non con passiva
fiducia, ma vivificandole attivamente nella
quotidianità delle nostre giornate. Il primo
sentiero è, in ultima analisi, l’assunzione di
431
responsabilità nei confronti dell’insegnamento
del Buddha e la presa di posizione di essere
individui maturi capaci da soli di giudicare e
sperimentare.
Il Buddhismo non è esattamente come le altre
religioni, le cui fondamenta sono una
rivelazione divina, dunque un discendere della
verità assoluta da un mondo trascendente e
superiore al nostro piano di realtà. Le
scritture sacre sono testimonianza della parola
divina e l’uomo fa leva su di esse con fede per
attraversare la foresta intricata della vita. La
divinità palesa ai suoi profeti una mappa del
cammino. Ma il Buddha non è una divinità
432
trascendete ed onnipotente, non è il creatore
dell’universo e la sua non è una rivelazione per
il bene delle creature umane. Egli è un uomo
come tutti noi, che con le sue forze ha
attraversato la foresta, è tornato con la mappa
da lui disegnata e l’ha mostrata
indifferentemente a chiunque. Che questa
avventura epica sia accaduta in Asia
duemilacinquecento anni fa o in un altro mondo
un tempo imprecisato e remoto è indifferente.
Conta solo il fatto che un essere senziente
caratterizzato dalla transitorietà abbia
realizzato in sé il Dharma, sfuggendo in tal
modo al ciclo delle rinascite. La scelta di
433
seguire le sue indicazioni è il frutto della
maturità come esseri senzienti liberi di agire
non legati da pregiudizi e false credenze.
Divenuto Buddha, Sakyamuni ha sicuramente
raggiunto uno stadio evolutivo eccelso, Egli è
dotato di capacità superiori a quelle degli
uomini e la sua esistenza è affrancata da
qualunque legame a cose, pensieri e fatti.
Tuttavia, ciò che conta, e sapere che all’inizio
del suo cammino egli era un uomo come tutti noi;
ciò ci assicura che chiunque può raggiungere lo
stato di buddhità.
2. Samiak-sankalpa (Retto Pensiero, Retta
434
Risoluzione, Retto Proposito)
Qui, le traduzioni permettono differenti
interpretazioni. Se da una parte, il retto
pensiero è l’invito ad utilizzare l’attività
pensante sempre tenendo presente le Nobili
Verità, dall’altra parte, risoluzione e
proposito sono come un voto che il praticante
deve fare: liberarsi dalla brama e dalla sete.
Sempre nel sutra di cui ho parlato poco sopra,
il Buddha dice: “liberarsi dal desiderio, non
nuocere, non usare violenza.” Con la Retta
Visione, il ricercatore del Dharma ha deciso di
abbracciare la dottrina del Buddha, e di
verificarla di volta in volta lungo il suo
435
cammino. Il secondo sentiero è la presa di
posizione fattiva e concreta: risolgo di
liberarmi dalla brama, di non usare violenza e
di non nuocere al prossimo.
Se io, in quanto essere libero di agire, prendo
la personale iniziativa di dedicarmi alla
dottrina del Buddha, devo garantire anche agli
altri (il mio prossimo) la stessa libertà di
scelta, lo stesso diritto, perché anche io sono
il prossimo rispetto al mio prossimo.
La mia vita di ieri, senza il buddhismo, non è
differente da quella di oggi dopo che ho
abbracciato la dottrina del Buddha. Così
dovrebbe risultare la pratica di un buddhista.
436
La rivoluzione non deve essere esteriore, e la
vita quotidiana è bene che continui così come è
sempre stata. La trasformazione è interiore, con
un nuovo modello di pensiero la cui matrice non
è stata importata, o meglio trapiantata tale e
quale, al pari di un soggiogamento; piuttosto la
matrice è da noi fabbricata, con i nostri mezzi,
interiorizzando le verità esposte dal Buddha,
ispirandosi ad esse così come un pittore si
ispira ad un tramonto (per fare un esempio).
Sicuramente, il pittore non è ipnotizzato o
soggiogato, o peggio ancora non ha subito un
lavaggio del cervello da parte del tramonto;
semplicemente, lascia che la suggestione del
437
tramonto ispiri la sua vena artistica. Allo
stesso modo, dobbiamo lasciare che il Dharma
ispiri la nostra natura originaria, la nostra
buddhità potenziale, guidandoci verso i retti
sentieri. Se ci sarà un cambiamento esteriore,
questi sarà l’effetto di una trasformazione
interiore, pertanto avverrà spontaneameante,
quasi impercettibilmente. Non saranno le cose
che facciamo a cambiare, ma il modo nel quale le
facciamo.
3. Samyag-vac (Retta parola)
Nel Magga-Samyuttam, il Buddha dice: “astensione
438
dalla menzogna, dalla calunnia, dall’aspro
linguaggio, dal vaniloquio.” Ecco elencati
quattro modi di usare in malomodo il dono della
parola: mentire, dunque esprimere
volontariamente ciò che è falso, non
corrispondente alla realtà, con lo scopo di
arrecare danno al prossimo (anche il Buddha non
disse tutta la verità ed usò mezzi differenti
per portare i suoi discepoli all’illuminazione.
E’ detto nel Sutra del Loto. Ma non si tratta di
una menzogna prodotta per arrecare danno, bensì
di un espediente utile ed adeguato alle
circostanze. La verità è relativa, pertanto non
esiste una menzogna assoluto detta dal Buddha,
439
ma solo una verità relativa e circostanziale);
calunnia, nel senso di arrecare danno verbale al
prossimo dicendo di esso cose maligne e non
corrispondenti al vero con il solo scopo di
screditarlo; aspro linguaggio: il vituperio, la
parolaccia, l’esprimersi volgarmente, tutte
parole che nascono da uno stato di rabbia ed
alterità, situazioni emotive queste condannate
dal Buddha; vaniloquio: parlare di cose
inutili, che non conducano ad una crescita
personale o comunque alla costruzione di un
discorso edificante non solo in ambito buddhista
ma in tutto il campo dello scibile umano.
Se ci pensiamo bene, queste quattro proibizioni
440
del parlare, se fossero seguite non solo per
condurre una vita buddhista produrrebbero grandi
benefici alla società umana. Il vaniloquio è
imperante, e lo si assapora malvolentieri nelle
trasmissioni televisive, nei dialoghi di bassa
levatura all’interno dei bar, anche nel triste
parlare fra amici di cose di nessuna importanza.
Qui non si vogliono condannare le frasi di
circostanza o gli scambi di cortesia fra persone
che non si conoscono. Il vaniloquio è tutto ciò
che produce “aria”, fine a se stesso e,
nell’economia buddhista, non conducente alla
comprensione del Dharma. La volgarità verbale è
presente anche nella Camera dei Deputati e
441
nascendo da momenti emotivi alterati da odio,
rancore, invidia o gelosia mette in mostra un
essere umano gretto ed abbruttito. La calunnia,
che in misura minore si può chiamare
denigrazione o pettegolezzo, è imperante nel
mondo del lavoro dove sparlare di colleghi in
loro assenza pare essere una delle attività
preferite oltre quella propriamente lavorativa.
Ma anche nella politica si assiste volentieri ad
un rilancio di accuse e critiche che a volte
risultano solo fini a se stesse. E la menzogna?
Come non mentire nella nostra vita? Parrebbe
essere un compromesso, stipulando il quale ti
senti in pace nel mentire per non metter a
442
rischio parti di te che vuoi che non si
conoscano, o per ottenere un vantaggio o per
moltissimi altri motivi che tutti noi conosciamo
benissimo.
La Retta Parola, tuttavia non è solo astenersi
da queste quattro azioni verbali negative. E’
anche proseguire il cammino iniziato con il
primo sentiero, quello della retta visione, per
cui se io inizio col verificare le asserzioni
intorno al dolore fatte dal Buddha, e mi
propongo di risolvere il dolore nella mia vita
grazie all’Ottuplice Sentiero, ne conviene che
non mi rimane che esprimermi anche in armonia
con quanto deciso e creduto, e pertanto un
443
buddhista parlerà palesando - anche se
implicitamente - la ricerca, tutta interiore,
del Dharma. Gentilezza, disponibilità,
amorevolezza, acume, perspicacia... quste
qualità devono trasparire dal parlare di un buon
buddhista.
4. Samyak-karmanta (Retta Azione)
Magga-Samyuttan: “Quello che è astensione
dall’uccisione di esseri viventi, dal prendere
il non-dato, dalla non-castità, quello o bhikkhu
si chiama retta azione.” Nel canone buddhista
ortodosso, ci sono cinque precetti che si
444
impongono come regola per chi abbraccia la Via
del Buddha: non uccidere, non rubare, non avere
condotta cattiva, non mentire, non inebriarsi
con alcool o qualunque altra sostanza.
L’uccidere un essere vivente è considera azione
sacrilega in quanto si suppone che tutti
abbiano diritto all’esistenza onde avere la
possibilità di realizzare la propria natura di
Buddha. In realtà, il precetto va rivalutato,
riconsiderato. Si può considerare una cattiva
azione quella di un indigeno dell’Amazzonia che
uccide una scimmia per sfamare la propria
famiglia? Il suo gesto è inscritto in un ambito
dove esiste armonia fra i vari componenti e
445
l’uccisione della scimmia è il frutto di questa
armonia. Diverso è il gesto del cacciatore
occidentale che per un giorno abbandona la città
e va a caccia di uccelli per soddisfare chissà
quale necessità. La sua caccia non è in armonia
con le circostanze della sua vita e dunque non è
un agire retto. L’uccidere un essere vivente
quando questo gesto non è la diretta conseguenza
della giusta armonia fra cose ed eventi di un
dato ambiente, quando le circostanze naturali
non ne richiedono l’esecuzione è allora un
assassinio, una cattiva azione.
Il non prendere il non-dato, non è soltanto il
non rubare: è il divieto di prendere qualunque
446
cosa che non ci venga data volontariamente od in
seguito ad un patto stabilito, come un acquisto
od un baratto. Questo per evitare la brama di
desiderare cose, per cui possiamo prendere - ma
non necessariamente avere - solo oggetti che ci
vengono donati o dati volontariamente.
Non si tratta solo di cose materiali. Il
precetto si estende a tutto ciò che possiamo
sottrarre al prossimo, sentimenti, affetti,
idee, e a tutto ciò che vogliamo pretendere dal
prossimo e cerchiamo di ottenere con mezzi
ingannevoli. L’amore di una persona lo posso
accettare, ma non posso pretenderlo ed agire con
malizia per ottenerlo suo malgrado. Lottare per
447
un amore è giusto, ma rubarlo no.
I cinque precetti erano legati all’ordine
iniziale del Buddha, nel lontano 500 a.c.,
pertanto con la castità si riteneva appunto
l’astensione da qualunque tipo di rapporto
sessuale, così come il non prendere il non-dato
si riferiva alla regola dell’ordine di
sopravvivere solo con le donazione dei laici e
di non possedere nulla tranne la veste e la
ciotola delle elemosine. Nella nostra società,
così complessa e diversificata, e tenendo
presente che nel corso dei secoli il buddhismo
mahayna si è evoluto (grazie anche all’apporti
di sutra tardivi e rivoluzionari, come il Sutra
448
del Loto) un precetto sulla castità da imporre
ai laici è improduttivo. La buddhità, essendo la
qualità dell’essere umano, può essere raggiunta
anche nella quotidianità, perché è la qualità di
far le cose che produce karma positivo. La
castità, dunque, non è il divieto di fare sesso
con la persona che amiamo, bensì di fare sesso
come gesto fino a se stesso, per il
raggiungimento di un piacere momentaneo non
legato ad un rapporto stabile e fruttifero. In
alcuni testi, bisogna ammettere che al posto di
castità, si parla di condotta corretta; in
realtà io credo che con castità si voglia
intendere il consiglio di astenersi da tutte
449
quelle azioni che hanno come scopo se stesse ed
un piacere effimero, fugace ed inutile.
Sul non mentire abbiamo già parlato.
Non inebriarsi con sostanze, qualunque esse
siano, è relativa ad una presa di posizione
molto forte nel buddhismo di tutte le scuole e
cioè l’alienazione dell’ottenebramento, visto
come ostacolo. La mente - da non confondersi con
il cervello - ad esempio nello zen, piuttosto
avvicinabile al concetto di psiche, è forse la
nostra natura buddhica. Infatti, spesso si parla
di Mente del Buddha, motivo per cui qualunque
cosa possa compromettere la sua limpidezza deve
essere esclusa. L’ottenebramento, l’alterazione
450
della funzionalità della mente, e della Mente,
conduce ad uno stato che non permette la giusta
concentrazione (samadhi).
Retta Azione è samyak-karmanta, dove karman è la
legge della retribuzione per la quale ad una
data azione risulta una precisa conseguenza.
Ecco che, allora, retta azione è fare e dire e
pensate tutto ciò che produce un buon karma, che
possa permettere all’individuo di avvicinarsi
alla propria natura originaria, la natura di
Buddha. E’mettere in pratica i precetti
insegnati dal Buddha, è fare ciò che nella
quotidianità permette di realizzare le Quattro
Nobili verità, e dunque agire in coerenza con la
451
retta visione, il retto pensiero e la retta
parola. Retta azione assume e implica i tre
sentieri precedenti.
5. Samyag-ajiva (Reatta Condotta di Vita, Retti
Mezzi di Vita, Retto Mestiere)
Se i primi quattro sentieri sono realizzati, o
per lo meno se esiste tale volontà, allora
diventa doverosa condurre la propria esistenza
in linea con i precetti, e specificatamente
avere un mestiere che non vada loro contro.
Oggigiorno, diventa sempre più difficile
mantenere una integra onestà e sincerità nel
452
lavoro che si compie come sostentamento della
propria vita. I piccoli inganni, i piccoli
compromessi, le menzogne, i pettegolezzi, le
invidie e le ipocrisie costellano ogni giorno
lavorativo. Bisogna cercare di chiarificare il
lavoro da tutte queste nequizie e mantenere
un’assoluta coerenza di proposito.
Spesso e volentieri, l’onestà e la fiducia si
mettono da parte per interessi personali,
specialmente quando si ricopre un posto di
responsabilità e si hanno delle persona alle
proprie dipendenze. Un vero buddhista è prima di
tutto un bodhisattva, ovverosia un uomo
“adulto”, maturo e responsabile delle proprie
453
opere, parole e pensieri, e come tale deve
comportarsi in ogni luogo e dove. Essere
buddhisti vuole dire onorare l’insegnamento del
Dharma e non deludere il Buddha; vuol dire
mettere da parte i propri interessi per il bene
del prossimo e prendere le decisione che possono
favorire i nostri sottoposti.
6. Samyag-vyayama (Retto Sforzo)
Come mantenere un retto proposito, un retto
agire ed un retto pensare senza sforzarsi di
farlo? Il retto sforzo è la volontà di
continuare a prodigarsi nei cinque sentieri
454
precedenti. Non solo, ma è lo sforzo di
impegnarsi a mantenersi coerente con gli
insegnamenti che si è voluto prendere come guida
di vita, lo sforzo di realizzare la verità delle
quattro eccellenti asserzioni, lo sforzo di non
deludere il Buddha, lo sforzo di essere un
bodhisattva eccellente, considerando il
bodhisattva come uomo adulto e maturo.
Sempre nel Magga-Samyuttan, il Buddha dice che
lo retto sforzo è la volontà di fare sorgere
salutari elementi quando non sono ancora sorti,
di farli continuare a sorgere se sono già sorti,
di non fare sorgere cattivi elementi ancora
sorti e non ancora sorti. L’elemento in
455
questione è tutto ciò che nascendo dentro di noi
ci stimola ad agire, pensare e parlare. Può
essere un elemento “salutare”, come ad esempio
il desiderio di seguire l’Ottuplice Sentiero,
oppure può essere un elemento negativo, che ci
spinge a commettere azioni disdicevoli. Lo
sforzo sta nel creare e preservare gli elementi
salutari.
7. Samyak-smrti (Retto Rammemoramento, Retto
Ricordo, Retta Attenzione, Retta Consapevolezza)
Personalmente propendo, come traduzione adeguata
al significato del percorso indicato dal
456
sanscrito “smrti”, ad usare il nome di Retta
Consapevolezza. Il buddhista che si è spinto
fino al retto sforzo per far sorgere e mantenere
quei salutari elementi utili alla realizzazione
del Dharma, deve anche essere consapevole di ciò
che sta facendo, ovvero essere consapevole della
propria esistenza, del suo corpo e delle sue
sensazioni. Praticare il buddhismo non è solo
leggere i sutra o recitare formule, ma essere
vigili ed attenti, e mantenere quella stabile
consapevolezza di se stessi, grazie alla quale
possiamo comprendere l’impermanenza e la
transitorietà di tutte le cose. Il Buddha ha più
volte spigato come bisogna prestare attenzione
457
ai cinque aggregati o fattori costituenti:
corpo, sensazioni, ideazioni, coscienza e
tendenze; un vero e proprio esercizio che le
scuole successive hanno sviluppato in vari tipi
di meditazione. In realtà, più che di
meditazione si tratta di attenzione di se stessi
e del mondo che ci circonda.
Nella nostra società, che oserei definire
malata, spesso viviamole giornate senza prestare
attenzione a ciò che ci succede, lasciando che
gli eventi coi scorrano a fianco o dentro noi.
Ad esempio, quando guidiamo speso e volentieri
non siamo attenti completamente alla strada, a
volte la mente divaga e la guida viene eseguita
458
in parta automaticamente. Quando vediamo un
semaforo rosso ecco risalire la vigilanza e la
concentrazione. Possiamo dire, come un famoso
maestro vietnamita contemporaneo, che quel
semaforo rosso è un bodhisattva che ci aiuta a
ritrovare la consapevolezza. Se ogni istante
della giornata noi fossimo presenti a noi stesi,
fossimo consapevoli di quello che siamo, di
quello che facciamo e diciamo e pensiamo, allora
potremmo realizzare le Quattro Nobili Verità. A
volte si dice “io dico quello che penso”, ma,
come replica l’uomo coi baffi della Moretti,
“penso quello che dico” è il giusto
atteggiamento di chi coltiva la consapevolezza.
459
8. Samyak-samadhi (Retta Concentrazione)
Samadhi si presta a diverse interpretazioni ed
i suoi significati possono essere differenti a
seconda delle scuole buddhiste. Nel Terahavada è
lo stato di profonda concentrazione della mente
nel quale si sperimentano stadi successivi di
“estasi trascendentale” chiamati jhana o jnana.
Nel Magga-Samyuttan il Buddha descrive la
concentrazione come il dimorare in quattro stadi
di jhana, ognuno dei quali è caratterizzato da
un differente porsi della mente rispetta a se
stessa. Il primo stadio è il dimorare gioiosi
per il distacco dalla brama possedendo la
460
capacità di vitakka e vicara, ovverosia il fissarsi
l’attenzione su un oggetto di meditazione e
mantenerla liberamente. Nel secondo stadio di
abbandona vitakka e vicara e si sperimenta la gioia
per avere raggiunto l’unità della mente e la
calma interiore. Nel terzo stadio si abbandona
l’estasi precedente e si sperimenta nel corpo la
gioia del distacco. Nel quarto stadio si ci
distacca da gioia e dolore, da letizia e
tristezza, gli opposti si annullano e si
raggiunge la suprema purezza interiore.
Nello Zen, spesso samadhi è satori, in quanto lo
stato di buddhità e lo stato di samadhi
coincidono. In questo caso l’ottavo sentiero è
461
la perfezione suprema, il raggiungimento
dell’Illuminazione, l’essersi svegliati, l’aver
realizzato le Quattro Nobili Verità.
Più verosimilmente, samadhi è l’esercizio di
concentrazione che il Buddha insegnò dopo averlo
sperimentato, e grazie al quale è maggiormente
possibile comprendere l’esatta realtà dei
fenomeni. Nel tempio zen che frequentavo, il
Maestro soleva dire che dal samadhi di una
seduta di zazen nasce un meraviglioso fiore che
bisogna portare seco nella quotidianità della
vita. Solo così facendo è possibile innescare
quel lento processo che può condurre ad un
effettivo miglioramento della nostra esistenza.
462
Ricordo bene che al termine di una sessione di
zazen, uscivo dal dojo con l’animo leggero e
colmo di letizia e fiducia; certo, bastava
l’impatto con la dura realtà per discrepare il
mio piccolo fiore, ma la continuità poteva
assicurare una pulitura dell’animo e di
conseguenza un miglioramento della vita in
generale, dovuto alla sempre maggiore
consapevolezza della transitorietà, della non
sussistenza e della dipendenza reciproca di
tutti i fenomeni.
Nella pratica del Daimoku, cui mi sto applicando
in questi ultimi tempi, mi pare di ottenere
effetti simili se non maggiori. Il mi corpo è
463
pervaso da un forte senso di gioia e fiducia
verso il Buddha ed il suo insegnamento e, in
generale, verso la vita stessa. Penso che il
samadhi ottenibile grazie alla concentrazione
sulla ripetizione del Daimoku (esercizio fatto
con sincerità e devozione) sia sufficiente per
conseguire la realizzazione delle Quattro Nobili
Verità.
Le tre fasi e le dodici vie
464
Dopo avere elencato le quattro asserzioni, il
Buddha chiarisce che la decisione di annunciare
al mondo degli uomini, degli déi, dei demoni, e
in generale a tutti gli esseri viventi la sua
realizzazione fu presa solo quando la conoscenza
e la visione delle nobili verità non fu chiara
secondo tre fasi e dodici vie.
Ogni verità il Buddha l’ha realizzata in tre
fasi: nella prima contempla la verità nella sua
forma espositiva, ad esempio: “nascita è dolore,
malattia è dolore, etc.”; nella seconda viene
manifestata il proposito e la volontà di
comprendere la realtà e l’origine della verità;
nella terza ed ultima fase si è realizzata la
465
comprensione e la verità è per intero stata
studiata, compresa e realizzata. Quattro di
questi gruppi di tre fasi fanno le dodici vie.
Ad ogni fase il Buddha ha conseguito nuova
conoscenza e nuova saggezza.
Quello che meraviglia ed affascina in questa
esposizione di ricerca della verità è la
rigorosa sistematicità di analisi di una
supposizione, che attraverso diversi stadi di
contemplazione mentale viene spogliata nei suoi
elementi costituenti. Tutto il buddhismo delle
origine è basata su questa ricerca rigorosa che
coniuga magistralmente la razionalità logica e
l’intuizione metafisica.
466
Epilogo
A parte l’elenco delle divinità che plaudono la
messa in moto della Ruota della Legge, che ha un
forte sapore folcloristico e che comunque si
avvale della ricca iconografia religiosa
indiana, ciò chemerita attenzione - e di cui ho
fatto cenno all’inizio - è la sentenza del
Venerabile Kondanna: “Ogni cosa che ha la natura
di sorgere, ha anche la natura di cessare.” Mai
parole migliori furono pronunciate per
esemplificare l’essenza del buddhismo, ed
infatti il Beato rende atto al suo discepolo di
avere interamente compreso. Compreso cosa? La
467
transitorietà dei fenomeni e dunque dell’intera
realtà. L’esperienza ci dice che ogni cosa è un
fenomeno e la stessa scienza conferma, sia a
livello subatomico che a livello macroscopico.
Un fenomeno ha la natura di formarsi e di
disfarsi, in quanto è un evento che comporta un
processo fra elementi che a loro volta sono
fenomeni-evento. Anche noi, in quanto esseri
umani, siamo un fenomeno e come tale siamo un
processo di più elementi (i cinque aggregati)
soggetti a nascere, soggetti a cessare. Di cosa
fossimo prima o cosa dopo non se ne può avere
esperienza diretta e dunque non rientra
nell’ambito del buddhismo. Ciò che conta è
468
l’attimo attuale, e precisamente il qui e
l’adesso. Il nostro corpo è vivo nel momento
presente, dunque è ora l’opportunità di
realizzare il Dharma e vivificare la buddhità
latente. Attraverso una libera forma di
meditazione possiamo trascendere la
transitorietà dei fenomeni e realizzare
l’assolutezza del Dharma, di cui si può avere
percezione solo tramite gli effetti
riscontrabili nella realtà sensibile e la cui
“sostanza” è solo intuibile metafisicamente.
469