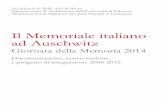FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA - UNSWorks
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA - UNSWorks
Reti, saperi, linguaggi – 2/2014 – pp. 13-36 ISSN 2279-7777 © Società editrice il Mulino
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
LE RAGIONI E I MODI DELLA LORO INTEGRAZIONE,CON LA DISCUSSIONE
DI DUE POSSIBILI OBIEZIONI
Massimiliano Cappuccio
Abstract: Phenomenology and cognitive science. The reasons and the ways of their integration, with the discussion of two possible objections: During the last few decades, phenomenology became the main philosophical op-tion to account for the complexity and, at the same time, the extreme simplicity of consciousness. This paper, in the first place, aims at exposing the specificity of the transcendental method of phenomenology, as opposed to the naturalistic assump-tions of the neurocognitive sciences, and then it will expose the reasons that made desirable an operative integration of phenomenology and neuroscience. In spite of their alleged incommensurability, it will detail the influential theoretical results obtained by the hybrid research style called «neurophenomenology». In the second place, the paper will consider two different reasons of perplexity that motivated, among both phenomenologists and cognitive scientists, the resistance against this integration. To dissolve these perplexities, the paper will highlight how the key no-tions of body, interaction, and experience constitute an anti-metaphysical ground that is shared by both disciplines.Keywords: cognitive science, neuropsychology, mind, consciousness, experience, phenonemenology, embodiment, interdisciplinarity, constructivism, emergentism, transcendentalism.
1. INTRODUZIONE: LA SPECIFICITà DEL METODO TRASCENDENTALE
La filosofia della mente è una componente fondamentale della scienza cognitiva, e occupa un ruolo chiave nella organizzazione interdiscipli-nare di questo sapere fin dai suoi albori. Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un profondo riassetto nel modo di teorizzare la mente in relazione alle funzioni cerebrali, una rivoluzione che ha visto emergere la fenomenologia trascendentale come l’opzione filosofica privilegiata per rendere conto della complessità e, allo stesso tempo, della estrema immediatezza con cui la nostra coscienza funziona. Questo articolo si propone in primo di luogo di esporre i motivi di specificità, e di possibile incommensurabilità, del metodo trascendentale fenomeno-
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
2
logico rispetto agli assunti naturalistici delle neuroscienze cognitive, e le ragioni che – nonostante le differenze metodologiche e fondazionali – hanno reso desiderabile un avvicinamento operativo tra la fenome-nologia e le neuroscienze. L’articolo si propone inoltre di documentare gli influenti risultati teorici che questo avvicinamento ha già consegui-to, dando vita a uno stile di ricerca ibrido chiamato da molti «neuro-fenomenologia». In secondo luogo, saranno prese in considerazione due diverse perplessità che fenomenologi e scienziati cognitivi hanno sollevato, dall’interno delle loro rispettive tradizioni, nei confronti di un’integrazione di queste discipline. Un tentativo di dissipare queste perplessità verrà proposto, sottolineando come la centralità di corpo, interazione, ed esperienza costituisca il motivo anti-metafisico comune a entrambe le discipline.
è da trent’anni almeno che le scienze cognitive ricevono so-stanziali apporti teorici dalla disciplina filosofica chiamata «fenome-nologia»1, soprattutto dopo che il cruciale «problema difficile» della coscienza (Chalmers 1995) si è imposto come un interrogativo non aggirabile dalle scienze della mente: esso chiede non tanto come la coscienza venga realizzata dalle strutture del sistema nervoso centra-le, ma soprattutto se la stessa domanda sulle modalità di questa im-plementazione sia il frutto di un equivoco metafisico di cui la ricerca scientifica potrebbe essere inconsapevolmente vittima. Filosofi della mente come Thomas Nagel (1974) hanno tematizzato la specifica qua-lità dell’esperienza cosciente soggettiva, indefinibile dal punto di vista dell’organizzazione funzionale delle facoltà cognitive perché irrime-diabilmente privata e opaca; altri filosofi, come Joseph Levine (1983; 1993) e David Chalmers (1995) hanno rilevato l’incommensurabilità, rispetto all’esperienza cosciente, del discorso neuroscientifico, basato su meccanismi causali e spiegazioni di stampo quantitativo. Nel tenta-tivo di superare questo iato, o almeno risolvere l’equivocità dei nostri interrogativi, varie opzioni sono state esplorate dalle neuroscienze co-gnitive, dalla filosofia della mente analitica e – appunto – dallo studio della tradizione fenomenologica2.
La fenomenologia partecipa a questa impresa in quanto studio sistematico del vissuto cosciente, delle regolarità interne all’esperien-za, e delle sue strutture tipiche. Questo studio, secondo il padre della fenomenologia, Edmund Husserl (1859-1938), si articola in modo sta-tico oppure genetico (Husserl 2003). Lo studio statico è rivolto all’or-ganizzazione degli atti intenzionali di un soggetto fenomenologico nei
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
3
loro rapporti di dipendenza logico-funzionale (ad esempio: come gli atti percettivi e motori si presuppongono reciprocamente nella cine-stesia, ovvero nell’esplorazione/costituzione dell’esperienza spazia-le). Lo studio genetico è invece interessato a come le stesse forme a priori della soggettività fenomenologica vengano costituite nel tempo da operazioni intenzionali che ne decidono lo sfondo materiale e le precondizioni concrete nell’esperienza. Queste operazioni definisco-no una storia che emerge da esperienze precedenti, la cui traiettoria è tracciata da abitudini, motivazioni, interessi e capacità (ad esempio: come la struttura dell’ego temporale si organizza in un flusso unitario irreversibile a partire dai portati immediati delle esperienze del prima e del dopo).
Le analogie tra fenomenologia e psicologia possono ingannare. Le discipline psicologiche collocano la disamina dell’esperienza co-sciente in un contesto naturalistico, cioè riducendola a fatto empirico situato in un mondo di eventi oggettivi passibili di misurazione esatta e di spiegazione causale; la metodologia fenomenologica, al contrario, studia il campo dell’esperienza cosciente in un orizzonte trascenden-tale, caratterizzandola cioè come pura e semplice trama di significati intessuta nel vissuto di un soggetto situato (Husserl 2002b). Per questo la fenomenologia si distingue non solo dallo studio empirico sui cor-relati fisiologici della coscienza, ma anche dalle psicologie descrittive e introspezionistiche. La sua unicità si riflette nel suo modo di concepire sia il soggetto che è protagonista di un’esperienza in prima persona, sia la struttura normativa e la logica processuale dell’esperienza stessa (Husserl 2002a).
Il soggetto, per le scienze, è un anonimo sistema di dispositivi psicologici neutri e distaccati dal loro contesto di intervento, un mec-canismo causale tra i vari che popolano il mondo naturale; al contrario, per la fenomenologia, il soggetto è il centro di un orizzonte aperto di possibilità di senso intimamente interrelate, una prospettiva orientata sull’esperienza, un irripetibile e coerente modo che il vissuto ha di presentarsi originariamente in una maniera strutturata, coerente con la situazione.
Per quanto riguarda i contenuti e la struttura dell’esperienza soggettiva, essi sono per la psicologia il risultato di processi reali in-formati da rapporti di causalità efficiente (in particolare, per le scien-ze cognitive classiche, essi hanno un contenuto informazionale e una struttura logica computazionale). Per la fenomenologia, al contrario,
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
4
si tratta di atti di natura intenzionale, informati dalla distinzione fun-zionale tra noesi e noema: il primo elemento di questa coppia, la no-esi, designa lo specifico protendersi della coscienza attraverso atti e secondo modi specifici (percezione, immaginazione, ricordo, ecc.), in una relazione aspettativa, esplorativa, di richiesta; il noema, correla-tivamente, rappresenta il polo verso cui gli atti noetici convergono, e il contenuto che viene a rispondere ad essi, o soddisfacendo le loro aspettative, oppure disattendendole, quando i fenomeni sorprendono la nostra coscienza. In entrambi i casi, le possibilità di senso dischiuse da questo incontro seguono una logica che è motivazionale, non causa-le, perché mossa unicamente dalle forze e dai principi interne al campo dell’esperienza soggettiva. Da questa prospettiva, la struttura formale del vissuto (le categorie a priori che la organizzano) deve essere trattata nel suo carattere intrinsecamente cosciente (ma non necessariamen-te consapevole o razionale), ovvero motivata e colorita dal materiale dell’esperienza stessa. Questo equivale a dire che la struttura a priori del vissuto non è pre-esistente o giustapposta all’esperienza concreta (come generalmente presupposto dal cognitivismo classico, il quale concepisce la mente come un computer che elabora in base a un pro-gramma predefinito i dati fornitigli di volta in volta); al contrario, tale struttura emerge dai dettagli qualitativi che caratterizzano il significato dell’esperienza stessa come un evento relazionale, unico e irripetibile, e al tempo stesso intrinsecamente correlato a indefinitamente varie se-rie di possibili modificazioni continue dell’esperienza (Husserl 2002b). La forma dell’esperienza e il suo valore tipico, in poche parole, sono dinamicamente informate dai materiali dell’esperienza stessa, perché essa è sempre incontrata in circostanze e modi che, sebbene particolari e irripetibili, già intrinsecamente predelineano un possibile orizzonte di generalità e di sviluppo nel tempo.
2. FENOMENOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA: TENTA-TIVI DI INTEGRAZIONE
Queste considerazioni dovrebbero essere sufficienti a suggerire che il discorso fenomenologico e quello cognitivo rimangono irrimediabil-mente distinti e non assimilabili. Ciononostante, sono stati compiuti alcuni tentativi di accostare l’architettura computazionale dei processi cognitivi alla struttura intenzionale dei concomitanti atti di coscienza
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
5
(noesi-noema). Alcuni tra questi tentativi, presumendo una compo-nente intrinsecamente rappresentazionale e istruzionistica dell’inten-zionalità (Dreyfus e Hall 1982), o un contenuto semantico-concettuale e una struttura logico-sintattica di tipo quasi-linguistico (McIntyre 1986), hanno promosso per un certo periodo l’idea che la fenomeno-logia husserliana fosse una teoria precorritrice del cognitivismo (cioè l’approccio classico – logico-simbolico, internalista e istruzionista – della scienza cognitiva, da non confondersi con la scienza cognitiva tout court). Espressa in questa termini, l’idea di un’ascendenza hus-serliana della scienza cognitiva ha avuto un’influenza limitata, e oggi le filosofie cognitive fenomenologicamente informate hanno preso la direzione opposta, anti-simbolista e pre-concettualista, nell’inter-pretare la struttura essenziale dell’intenzionalità husserliana (Varela, Thompson, Rosch 1992; Gallagher 2005): allontanando l’interpreta-zione della fenomenologia husserliana dall’ombra del paradigma clas-sico del cognitivismo, esse sottolineano come già in Husserl il corpo svolga un ruolo centrale come medium o sfondo di un’intelligenza che non richiede contenuti rappresentazionali, ma un coinvolgimento di-retto nell’esperienza, una predisposizione interattiva del soggetto nei confronti del mondo. Questo approccio, che ha rapidamente acquisito una posizione dominante nel dibattito odierno (Gibb 2006; Shapiro 2010), sottolinea la funzione regolativa e costitutiva del corpo e delle abilità pratiche nel contesto sociale e intersoggettivo, asserendo che le competenze incarnate pre-riflessive sono sufficienti e necessarie per definire una dimensione normativa basilare scevra di modelli e istru-zioni/regole a priori.
Per non perdere di vista le differenze sostanziali tra fenomeno-logia e cognitivismo occorre ricordare in primo luogo che il requisi-to metodologico dell’indagine fenomenologica è l’epochè (Husserl 2002b) – ovvero la sospensione controllata del giudizio circa il mondo naturale. L’indagine fenomenologica non nega la realtà degli oggetti esperiti nel vissuto, ma prende le mosse precisamente dalla «messa tra parentesi» di ogni giudizio sul loro statuto di realtà o irrealtà, per concentrarsi sul loro significato esperienziale «puro». Il fenomenolo-go, infatti, considera la corrispondenza tra vissuto soggettivo e mon-do naturale non come irraggiungibile, ma come secondaria rispetto al senso del vissuto in sé e per sé. Questo non vuol dire affermare una prospettiva scettica o relativista sull’esperienza soggettiva. Al contra-rio, questo vuol dire che i tentativi di validare l’esperienza soggettiva
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
6
nell’osservazione del «mondo reale» sono possibili e sensati, quando lo sono, proprio perché derivanti dalle trame di relazioni intenzionali che caratterizzano il contenuto dell’esperienza soggettivamente o intersog-gettivamente vissuta (anche l’esperimento scientifico non è altro che una forma di esperienza, che può essere convalidata dagli scienziati perché da essi pubblicamente condivisa e confrontata). Ecco perché, in prima istanza, si tende sempre ad aderire spontaneamente al senso intuitivo del vissuto che ci si offre immediatamente (Husserl 2002b, 109), mentre è solo successivamente che ci si può porre l’obbiettivo di rinunciare a questa adesione, una volta che sia stato posto il dubbio circa l’adeguatezza dell’esperienza percettiva ad un «mondo reale» che starebbe al di là di essa.
Vari tentativi di integrazione tra fenomenologia e scienza cogni-tiva sono già stati compiuti e hanno portato alla luce la proficuità della loro interazione. Sebbene gli autori e gli approcci impegnati in questa ricerca siano molteplici, e operino con modalità, linguaggi, e secondo fini molto vari (anche a seconda dei fenomenologi di riferimento, o delle funzioni cognitive studiate), è possibile elencare tre metodologie fondamentali che hanno definito i contorni concettuali di questa im-presa fino ad ora.
Il primo è l’approccio matematico-formale sviluppato dai teo-rici della cosiddetta «naturalizzazione della fenomenologia» per cat-turare con i modelli della topologia e della morfologia le meccaniche più sfuggenti dell’esperienza spaziale soggettiva (Petitot 1991; Casati 1991). L’aspirazione è di rendere misurabile e modellabile ciò che – con metodologie quantitative meno sofisticate – sarebbe apparso irriduci-bilmente qualitativo e imponderabile. Questo avviene per esempio nei termini della «neurogeometria della visione» di Jean Petitot (1991), che utilizza la morfodinamica di René Thom (1972) per catturare con strumenti matematici avanzati gli algoritmi che governano l’elabora-zione del dato sensoriale proiettato nella retina e poi nella corteccia visiva, fino a trasformarlo in un’esperienza caratterizzata dai princi-pi formali che preservano le proprietà topologiche degli oggetti del mondo reale. In questo tipo di lavoro, il dato fenomenologico, cioè la percezione soggettiva del continuo, delle forme e degli oggetti spa-ziali, è trattato come una guida per ricostruire i fondamenti cognitivi (ovvero le condizioni a priori) della geometria della visione, con il fine di approssimare la funzione dei meccanismi computazionali che rea-lizzano l’elaborazione dell’esperienza spaziale al livello sub-personale.
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
7
In questo caso il lavoro del fenomenologo prepara quello del matema-tico ed è strumentale ad esso, fornendo il materiale esperienziale che sarà utile per elaborare i modelli formali della percezione. Su questo approccio pesa un’obiezione meta-ontologica fondamentale: anche se la naturalizzazione della fenomenologia persegue la continuità del discorso fenomenologico e di quello naturalistico, essa adotta ancora una nozione inindagata, e sostanzialmente metafisica, di natura, una nozione ancora in debito con la concezione classica del meccanicismo determinista. Oltre a essere inadeguata rispetto alle esigenze fonda-zionali dell’epistemologia contemporanea, questa concezione appa-re in ritardo rispetto all’ontologia fenomenologica di Merleau-Ponty (1996), la quale consente un più appropriato avvicinamento teorico delle nozioni di fenomeno e natura, tematizzando quest’ultima non già come sostanza governata da leggi deterministiche, ma come evento e relazione, ricettacolo primitivo di possibilità di significato (Vanzago 2012).
Il secondo approccio è quello «neurofenomenologico» teorizza-to agli albori della scienza cognitiva embodied (Varela 1996). Esso si basa su di un insieme di procedure sperimentali esatte per avvalersi dei resoconti verbali di soggetti opportunamente addestrati a descrivere accuratamente determinati aspetti della loro esperienza soggettiva. Il neurofenomenologo teorizza e mette in pratica nuovi protocolli speri-mentali per utilizzare efficacemente l’analisi metodica del vissuto all’in-terno del lavoro di laboratorio; lo stesso soggetto dell’esperimento deve essere informato dello sfondo fenomenologico dell’esperimento, e par-tecipa attivamente in un’esplorazione del proprio vissuto personale. Per esempio, Lutz et al. (2002) mette in relazione i resoconti verbali di vissuti soggettivi alle diverse tipologie di risposte comportamentali dei soggetti, i quali vengono istruiti in maniera tale da riconoscere diverse forme e modalità della propria attenzione, modificando il proprio stato di coscienza conseguentemente. Lo scopo dell’esperimento è far sì che le differenze riscontrate dal soggetto nella modulazione del proprio stato attenzionale vengano a coincidere con le discriminazioni operate dallo sperimentatore nell’analisi delle risposte comportamentali e neu-rofisiologiche del soggetto. In questo caso il lavoro del fenomenologo si svolge durante l’esecuzione dello studio sperimentale condotto dagli psicologi cognitivi, perché il soggetto stesso dell’esperimento è invitato a diventare un fenomenologo operante «sul campo», e a produrre de-scrizioni adeguate ai fini dell’esperimento. Anche su questo approccio
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
8
pesa un’obiezione fondamentale: Daniel Dennett (1997), basandosi su argomenti sia empirici che a priori contro la nozione di «coscienza fenomenica», ha osservato che tra un presunto vissuto «in presa diret-ta» e il resoconto verbale che lo organizza, cogliendone le regolarità e sottolineandone gli aspetti salienti e rilevanti, esiste sempre uno scarto, una non-coincidenza, visto che il primo si può offrire sempre solo in funzione del, e attraverso il, secondo. Ogni metodologia basata sull’in-trospezione o sull’osservazione del dato fenomenologico in prima per-sona, pertanto, sarebbe di principio inficiata dal fatto che il dato di coscienza non si offre mai come pura e semplice presenza, esaminabile ed osservabile come dato oggettivo, ma sempre solo come traccia o riflesso, ovvero resto e ricostruzione in terza persona («eterofenome-nologia», Dennett 1991, 2007), interpretazione a posteriori mediata da precondizioni e filtri concettuali ineliminabili (per una sistematica risposta a questa accusa si veda Zahavi 2007, nel quale si argomenta come la nozione di coscienza presa di mira da Dennett non corrispon-da al campo puro dell’esperienza esaminata dalla fenomenologia).
Il terzo approccio è quello forse più conforme all’idea del fe-nomenologo come filosofo impegnato nel lavoro di discussione criti-ca e analisi concettuale (Gallagher e Zahavi 2008). Questo approccio utilizza i contenuti delle dottrine fenomenologiche per discutere i ri-sultati sperimentali noti, valutarne la corretta interpretazione teorica, e progettare nuovi esperimenti, in conformità alla conoscenza delle regolarità interne al vissuto precedentemente maturata nell’ambito trascendentale. Con questo approccio, la fenomenologia può entrare in gioco prima del lavoro sperimentale, nella fase di progettazione e valutazione critica degli esperimenti, ma soprattutto dopo l’esecuzione dell’esperimento, quando i risultati comportamentali o neurofisiologici devono essere contestualizzati nell’esperienza dei soggetti dell’esperi-mento. Questo approccio non richiede ai soggetti dell’esperimento di diventare fenomenologi o di produrre resoconti fenomenologicamente informati, e non prevede complessi modelli delle regolarità matemati-che del vissuto soggettivo; ma entrambe queste opzioni sono integrabi-li al suo interno, all’occorrenza.
In generale, nessuno di questi tre approcci metodologici sembra escludere gli altri sul piano del lavoro empirico, ma le premesse teori-che da cui essi muovano sembrano essere talvolta inconciliabili.
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
9
3. ATTUALITà DELLA FENOMENOLOGIA: ALCUNI RI-SULTATI TEORICI SIGNIFICATIVI
Oggi i risultati della fenomenologia di Husserl e degli altri pionieri informano alcuni tra i più promettenti modelli teorici delle scienze co-gnitive, e quindi l’interpretazione dei dati neuroscientifici. Per comin-ciare, consideriamo la nozione di Leib, il corpo vivo percipiente di un agente intenzionale senziente, inteso come complemento del Koerper, il corpo organico studiato dalle scienze mediche in quanto supporto di funzioni biologiche impersonali (Husserl 1973). Questa non banale nozione non è centrale solo per la fenomenologia: a partire dai primi anni ’90 esso ha sistematicamente ispirato la grande svolta degli ap-procci embodied («incarnati», o «incorporati», cfr. Varela, Thompson e Rosch 1991) delle scienze cognitive, e ha ispirato interpretazioni filo-sofiche fortunate di nozioni cruciali in ambito clinico, come la distin-zione tra schema corporeo e immagine corporea (Gallagher 2007) o la di-stinzione tra intenzionalità motoria e intenzionalità cognitiva (Dreyfus 2001). In filosofia della mente, gli approcci embodied muovono contro l’assunto del funzionalismo logico-formale che le funzioni cognitive siano di principio realizzabili indifferentemente da diversi tipi di sup-porti materiali, ovvero che siano indipendenti dagli aspetti contingenti e dalla grana fine dell’organizzazione interna di tali supporti materiali; al contrario, la cognizione embodied afferma che i dettagli del nostro particolare modo di essere incarnati, inclusi gli schemi motori che de-finiscono le nostre possibilità di azione e percezione, anticipano la co-gnizione e la informano, modificandone la struttura e i contenuti. Le implicazioni di questa nozione sono osservabili a vari livelli.
Le osservazioni di Husserl sulla coscienza interna del tempo (Husserl 1904-1905), con le sue dinamiche ritentive e protentive, sono ampiamente in debito con la scienza psicofisica del suo tempo, e oggi hanno ispirato importanti studi neurofisiologici sulla percezione del tempo presente e sulle modalità con cui la variabile estensione dell’ora organizza sincronicamente l’attività di vaste assemblee neuronali (Va-rela 1995; 1996).
La dottrina husserliana dell’empatia e dell’intersoggettività costi-tuente (illustrata nella quinta delle Meditazioni cartesiane, cfr. Husserl 1997) è invece ispirata ai modelli dell’empatia dello psicologo e teorico dell’arte Theodor Lipps (1903) e al dibattito che ne seguì nell’ambito estetologico, coinvolgendo tra gli altri l’assistente di Husserl, Edith
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
10
Stein (2002), e il celebre filosofo Max Scheler (2010). Oggi questi studi filosofici (e.g., Lohmar 2006) informano un ambito importante della cognizione e delle neuroscienze sociali, quello inaugurato dalla sco-perta dei cosiddetti «neuroni specchio» (Fogassi 2005, Gallese 2006, 2007): la teoria husserliana prevede che possiamo comprendere le in-tenzioni che animano le azioni degli altri perché siamo in primo luogo famigliari con l’esecuzione di quelle azioni e con le loro motivazioni; analogamente, le neuroscienze sociali hanno mostrato che il riconosci-mento dello scopo delle azioni altrui è mediato anche dalle competen-ze che abbiamo maturato nell’eseguire quelle medesime azioni.
Anche le teorie husserliane della visione e della percezione tri-dimensionale - con la cosa spaziale posta come sintesi concordante di profili bidimensionali, attraverso serie convergenti di esplorazioni cinestetiche – sviluppano motivi che erano già presenti nella psico-logia della sua epoca, trasponendoli sul piano trascendentale; oggi questi studi diventano un punto di riferimento importante per le teo-rie ecologiche (Gibson 1979) ed enattive (O’Regan e Noë 2001; Noë 2004) della visione, e della percezione in generale – intesa come even-to interattivo ed esplorativo scaturente dal progressivo consolidarsi e stratificarsi delle esperienze sensorimotorie. Queste teorie, di stampo implicitamente pragmatista e relazionista, rilevano come il vedere non sia mai un’attività neutra e distaccata: anche nel momento di massima passività, la visione risulta da uno sforzo attivo di negoziazione e di anticipazione delle contingenze sensorimotorie, che avviene in un rap-porto di circolazione continua tra gli atti esplorativi del soggetto e le risposte (più o meno attese) che esso riceve dall’ambiente.
Il legame tra fenomenologia e psicologia naturalistica è svilup-pato in maniera più esplicita da Maurice Merleau-Ponty (2003), che per primo ne esplora anche le implicazioni nel campo della neurolo-gia, considerando l’esperienza patologica dei soggetti cerebrolesi. In particolare, egli riprende alcune nozioni fondamentali della psicologia behavioristica (comportamento e apprendimento attraverso condizio-namento), valorizzando finalmente la loro dimensione intenzionale e valenza esperienziale, aspetti questi che erano stati sistematicamen-te trascurati nel contesto della psicologia dell’epoca. Merleau-Ponty propone nozioni filosoficamente fortunate e riattualizzate nel dibatti-to odierno attraverso i termini «incorporamento» (i dettagli della co-stituzione materiale del corpo percipiente e percepito informano le strutture a priori della percezione e predispongono i parametri della
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
11
nostra intelligenza pratica), «arco intenzionale» (che cattura la capa-cità adattiva di un agente esperto strutturalmente accoppiato con gli stimoli significativi del suo mondo-ambiente), «intenzionalità moto-ria» (sapere pratico del corpo, ovvero disposizione pre-riflessiva di un agente incarnato ad articolare un flusso di azioni intenzionali adattive per rispondere alle contingenze sensorimotorie del suo ambiente, sen-za possedere regole, rappresentazioni, o principi euristici che guidino le azioni in maniera pianificata).
Il filosofo della mente Hubert Dreyfus, che per primo ha trattato della fenomenologia di Merleau-Ponty e Heidegger in relazione ai sa-peri delle scienze cognitive e delle neuroscienze, ha sistematicatimente utilizzato l’approccio merleau-pontiano ai saperi incarnati per com-prendere l’acquisizione delle abilità motorie e l’articolazione delle cor-rispondenti facoltà cognitive. Dreyfus (2002) ha sottolineato la natura disposizionale e abituale, e per questo non-rappresentazionale, delle capacità motor-intenzionali, postulando che i dispositivi cognitivi sog-giacenti debbano avere una struttura dinamica che rifletta il carattere adattivo e flessibile dei comportamenti esperti, compatibilmente con la fenomenologia dell’azione irriflessiva: un agente motorio esperto è un agente che non solo non riceve beneficio dal monitorare le componen-ti procedurali della sua attività incorporata, ma si trova svantaggiato quando riflette su di esse (o presta loro eccessiva attenzione), visto che non ha a disposizione regole o principi euristici per progettare tutte le sue azioni esperte, con le loro infinite possibilità di variazione con-testuale. L’azione incorporata che egli sviluppa è un continuo, incon-sapevole, intuitivo, quasi-automatico (ma propriamente intenzionale) processo sistemico di adattamento alle contingenze sensorimotorie in vista di un bilanciamento dinamico con l’ambiente. Questo proces-so di modulazione della condotta intenzionale è pertanto unicamente guidato da un movimento non regolato, e tendente al più alto grado di passività possibile, ovvero di diminuzione del senso di deviazione da una configurazione gestaltica soddisfacente.
Ispirato dal senso e dai risultati di questa fenomenologia, Drey-fus ha collaborato con il matematico e neuroscienziato Walter J. Fre-eman (2000), sfruttando i suoi modelli dei bacini d’attrazione per i processi di stabilizzazione dell’energia potenziale delle reti neuronali. Appoggiandosi ai modelli olistici del funzionamento del cervello di Freeman, Dreyfus spiega la regolazione e l’attuazione di competenze motorie incarnate attraverso la tendenza statistica del sistema a ridurre
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
12
il suo grado complessivo di instabilità. Questa tendenza è predisposta non da euristiche (regole e istruzioni definite in termini dichiarativi, ovvero aventi un contenuto assertivo e descrittivo), ma dalla grana fine di configurazioni disposizionali ricavate nella topografia delle reti neu-ronali da paesaggi di attrattori e repulsori. La valenza adattiva di queste configurazioni è definita dalle pregresse esperienze di accoppiamento soddisfacente tra tipologie di azioni incorporate finalizzate e le corri-spondenti varietà di contesti pratici teleologicamente caratterizzati.
La funzione essenziale del corpo nel produrre l’attività intelli-gente consiste nel regolare dinamicamente e, soprattutto, passivamen-te le disposizioni intenzionali del soggetto per conseguire uno stabile adattamento alle fluttuazioni ambientali, nelle loro molteplici manife-stazioni. Le strutture cerebrali che istanziano questa attività intelligen-te devono pertanto possedere caratteristiche non-rappresentazionali, scevre di contenuti figurativi o proposizionali, e riflettere la tendenza del corpo all’adattamento attraverso disposizioni e filtri passivi. Que-sto modello è stato criticato da più parti, perché – a detta dei suoi detrattori – non rende conto di come la finalità dell’azione possa pre-cedere o essere indipendente dal contesto, e di come forme di sapere incorporato possano essere consapevoli, riflessive, e simboliche in na-tura; infine, non rende conto della grande flessibilità dei comporta-menti intelligenti di fronte a contesti problematici che richiedono la mediazione di processi decisionali esplicitamente informati da regole e rappresentazioni (ad esempio attraverso concetti figurativi o lingui-stici). Anche la relativa limitatezza dei risultati empirici conseguiti da Freeman (per lo più confinati alla correlazione tra semplici stimoli olfattivi e comportamenti istintivi elementari, inerenti la nutrizione) pesa sulle attuali capacità esplicative e predittive del modello, che resta però ancora valido e passibile di sviluppi futuri.
La sua forza principale resta l’aderenza alla fenomenologia delle facoltà incorporate e delle abilità motorie: non presentando traccia di informazioni espresse in formato dichiarativo o proposizionale, l’espe-rienza dell’azione irriflessiva (come la performance semi-automatizza-ta di uno sportivo in circostanze standard) non sembra richiedere o ammettere una architettura cognitiva di tipo rappresentazionale. La tematizzazione delle competenze incorporate e sensorimotorie rima-ne pertanto uno dei nodi maggiormente frequentati e diversamente discussi nelle interazioni tra fenomenologia e scienze della mente.
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
13
4. DUE OBIEZIONI
A fronte dei numerosi contributi teorici che la fenomenologia ha of-ferto alle scienze cognitive negli ultimi anni, diverse obiezioni sono state mosse a questo connubio dalle correnti conservatrici delle due discipline. Sul versante del cognitivismo – l’approccio classico e com-putazionalista delle scienze cognitive – diverse perplessità sono state sollevate sulla possibilità di modellare i processi cognitivi in base alla concomitante esperienza soggettiva da parte del soggetto: l’apporto della fenomenologia, nella migliore delle ipotesi, si limiterebbe alla ri-formulazione dell’explanandum, senza per questo poter aspirare alla chiarificazione dell’explanans. La natura descrittiva e non esplicativa della fenomenologia sarebbe pertanto il limite che le impedisce di en-trare nel merito dei meccanismi causali sottostanti all’esperienza co-sciente.
Apparentemente complementare, ma in fondo omogenea, rispet-to a questa obbiezione è quella mossa dalle correnti tradizionaliste del-la fenomenologia, che spesso intendono questo sapere come confinato all’interpretazione storico-letteraria e alla catalogazione archivistica: la domanda posta in questo contesto è come la fenomenologia possa le-gittimamente entrare nel merito dei meccanismi causali sottostanti al funzionamento della mente senza tradire il proprio statuto trascenden-tale. La premessa fondamentale di questa obiezione è che contribuire a un discorso di natura esplicativa richieda necessariamente al fenome-nologo di discostarsi dalla descrizione del vissuto «in presa diretta». Il prezzo da pagare sarebbe una ricaduta nel discorso metafisico, il quale non solo postula un’interazione causale tra invisibili meccanismi psicologici reali e fenomeni intenzionali esperiti in prima persona, ma – a monte – presuppone irriflessivamente l’esistenza oggettiva di piani ontologici incommensurabili (coscienza/cervello), evocando le tanto irrisolvibili quanto artificiose antinomie del dualismo cartesiano.
Queste due obiezioni sembrano reciprocamente opposte perché paventano che la fenomenologia sia troppo o troppo poco empirica, ma complessivamente tendono alla medesima svalutazione del valore pragmatico dell’indagine trascendentale, liquidando l’interazione con la scienza cognitiva come inutile o di principio impossibile. A dispetto di queste obiezioni, i risultati della ricerca degli ultimi trent’anni mo-strano una situazione assai incoraggiante.
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
14
5. PRIMA OBIEZIONE
Le obiezioni del primo tipo vengono neutralizzate dalla proposta, da parte di Francisco Varela e della sua scuola, di una «neurofenome-nologia» (Varela 1996; Laughlin et al. 1992; Thompson 2004; Lutz e Thompson 2003; Gallagher 2009), situata all’intersezione del discorso trascendentale e di quello empirico-psicologico. L’approccio di Varela e coll. si distingue per la sua caratterizzazione anti-riduzionistica e an-ti-localizzazionista del problema dei correlati cerebrali della coscienza: esso cioè milita contro i tentativi di equiparare la coscienza a una fun-zione cognitiva meccanicamente determinata dall’attività di circoscrit-te strutture neurofiosologiche, presumibilmente situate nei lobi fron-tali, così come milita – per altro verso – contro i tentativi di eludere la questione dei correlati neuronali della coscienza come misteriosa e di principio insondabile. La premessa corrispondentista condivisa tanto dal riduzionismo quanto dal misterianesimo è che l’unico modo di spiegare le basi fisiologiche di una funzione cognitiva consisterebbe nell’indicare una struttura staticamente e localmente realizzata nel so-strato fisico-causale neuronale. Varela, e l’approccio enattivo-dinami-cista, mettono in discussione questa premessa fornendo sostegno sia empirico che concettuale alle seguenti tre tesi.
1) Olismo ed esternalismo. La coscienza non è una funzione in-capsulata in specifici moduli cognitivi, o localizzata nelle aree cerebrali attivate in corrispondenza di questo o quel fenomeno esperienziale; al contrario, i modi e le forme della coscienza richiede una regolazione complessiva dei ritmi di oscillazione di vaste assemblee neuronali, la cui sincronizzazione interessa il sistema nervoso centrale in maniera olistica (Varela 1995). Questa regolazione armonica, a sua volta, non è un fenomeno meramente cerebrale, ma un equilibrio complesso che dipende dal rapporto di accoppiamento dinamico che il cervello sta-bilisce con le variazioni occorrenti nel corpo e nella percezione, a loro volta mediate dall’azione del corpo nel mondo circostante. Mente, cor-po e cervello partecipano di un unico evento olistico, in un rapporto di ridefinizione circolare continua scandito dai ritmi di percezione e azione attraverso complessi meccanismi di feedback, anticipazione, e bilanciamento dinamico. Diventa così impossibile affermare che è nel cervello o in una della sue parti che la mente si realizza, visto che è in relazione al complesso mente-corpo-mondo che le funzioni cognitive e la rilevanza delle singole attivazioni neuronali si ridefiniscono contin-
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
15
gentemente. Anche se generalmente compongono configurazioni ma-croscopiche di attività ricorrenti, le attivazioni neuronali contingenti non sono dotate di identità funzionale indipendente – visto che sono solo apparentemente stabili nel tempo e che il loro ruolo funzionale di-pende dalla circostanze con cui sono olisticamente e contingentemente accoppiate.
2) Emergenza e causazione top-down. La coscienza, inoltre, non è riducibile alla somma delle interazioni causali tra le singole componen-ti funzionali che le corrispondono nel cervello perché, auto-organiz-zandosi in configurazioni transienti aperte, i cui parametri di stabilità sono definibili solo dinamicamente, come pattern temporali, l’attività del cervello sviluppa proprietà e dinamiche sistemiche autonomiche (in accordo con la teoria dell’autopoiesi, cfr. Maturana e Varela 1980; 1987). Queste dinamiche sono sufficienti a orientare le interazioni tra le componenti funzionali del cervello secondo uno schema complessi-vo unitario, pur non essendo riducibili a queste interazioni: per esem-pio lo stato di attenzione, modulabile volontariamente focalizzando il pensiero o la percezione secondo specifiche intenzioni.
In primo luogo è dunque vero che le proprietà di questi stati mentali sono sopravvenienti (Kim 1993): non sono riducibili alle pro-prietà e alle dinamiche delle interazioni tra i singoli componenti neuro-fisiologici, ma restano collocate su di un piano normativo e qualitativo virtualmente autonomo, perché appartenente a un ordine descrittivo ed esplicativo differente. In questo senso, l’attività intenzionale della coscienza e i corrispondenti dati dell’esperienza qualitativa sono fun-zionalmente vincolati alla regolazione complessiva del sostrato sub-personale (neurofisiologico) che le sostiene fisicamente, pur rimanendo virtualmente indipendenti da esso nella loro logica interna e nella loro valenza personale. Sappiamo dunque che è anche sempre dal cervello che complessivamente dipende ciò che pensiamo, ma il contenuto e il significato di ciò che pensiamo non sarà mai direttamente attingibile dalla considerazione, per quanto esaustiva, dell’attività del cervello o delle sue componenti locali.
Ma questo non è sufficiente. Secondo i modelli emergentisti top-down della cognizione (Varela 1995), il pensiero si sviluppa come un fenomeno di auto-organizzazione che non solo viene modulato da ma al tempo stesso modula le interazioni complesse tra i suoi compo-nenti, esercitando un’efficacia causale dall’alto (dal composto verso i propri componenti) che non è meno effettiva di quella esercitata dal
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
16
basso (dai componenti verso il composto). In breve, ogni variazione dell’attività mentale (livello personale) implica una qualche variazione nei dettagli del sistema fisico-materiale (livello sub-personale), ma non ogni variazione delle contingenze materiali del sistema produce neces-sariamente effetti sensibili al livello mentale, e in generale prevedere questi effetti non è facile data la notevole sensibilità alle condizioni iniziali del sistema. Questa asimmetria, o eccedenza, dell’ordine espli-cativo del mentale rispetto a quello del fisico, deriva in parte dal fatto che l’attività mentale si costituisce come virtualmente autonoma dal-le contingenze percettive che la manifestano empiricamente. Questa autonomia non va intesa in senso sostanzialistico o metafisico (come proprietà di un’entità spirituale aggiunta al corpo), ma funzionale e normativa (come evento regolatore contingentemente implementato da circostanze complesse che restano irriducibili a specifiche dinami-che fisiche): è, infatti, pur sempre soltanto una relativa indipendenza che attribuiamo all’esperienza del mentale nelle forme e nei modi del nostro riscontro delle funzioni intelligenti.
3) Anti-rappresentazionalismo. In questo quadro dinamicista ed emergentista, venendo a cadere il presupposto di una corrispondenza biunivoca tra le componenti locali del sistema nervoso e i contenuti dell’esperienza cosciente che queste componenti istanzierebbero, vie-ne anche a cadere una delle premesse del rappresentazionalismo, che è stato a lungo uno dei dogmi degli approcci cognitivisti e connessio-nisti delle scienze cognitive. Recenti sviluppi ’radicali’ della cognizione enattiva (Hutto e Meyin 2013) hanno chiarito che l’informazione ne-cessaria a realizzare i contenuti dell’esperienza cosciente non è soltan-to elaborata in parallelo da un dispositivo computazionale continuo, super-posizionale e distribuito (possibilmente anche al di fuori del sistema nervoso), come la teoria connessionistica aveva prefigurato; questa informazione è anche priva di contenuto in senso proprio, cioè scevra di ogni valenza figurativa, proposizionale, ecc.
Il cervello non rappresenta mai i contenuti del nostro pensie-ro e della nostra esperienza cosciente, perché esso non è la macchina rappresentazionale postulata dal cognitivismo. Questo è tanto vero che la stessa metafora del contenuto e del contenitore, classicamente utilizzata per indicare le prerogative mentali di agenti cognitivi che rappresenterebbero nella loro mente immagini o modelli interni di un presupposto «mondo esterno» pre-dato, viene a perdere di valore, ri-velando la sua natura sostanzialmente retorica. Coscienza e pensiero
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
17
non sono un’immagine contenuta, custodita o internamente proiettata dal cervello, a uso di un presunto omuncolo cognitivo localizzato al suo interno. Essi sono invece parte di un evento relazionale e intenzio-nale orientato che il cervello innesca e in parte regola, ma che esso non conosce in quanto tale e del quale certamente non è consapevole: è un evento che il cervello non registra ne’ semplicemente subisce, perché il cervello stesso ne è parte, mentre contribuisce ad attuarlo. Si tratta di un processo che non rappresenta (in forma mediata attraverso modelli e regole), ma che risponde al presentarsi diretto degli elementi del vis-suto cosciente a un soggetto che si relaziona ad essi. Questo soggetto non coincide ne’ fenomenologicamente ne’ in senso funzionale con il suo cervello, sebbene certamente la sua cognizione sia strettamente dipendente dalla biologia di quest’organo.
Questa caratterizzazione «enattiva» rende conto dei rapporti di reciproca dipendenza logica tra la fenomenologia del vissuto coscien-te e l’attività cerebrale, pur fornendo una adeguata descrizione della loro relativa indipendenza causale e virtuale autonomia ontologica. In particolare, il contributo causale dell’attività cerebrale nella determi-nazione dei contenuti del vissuto e dei processi di pensiero viene inse-rito in un quadro più ampio, non riduzionistico, che – oltre ai processi chimico-elettrici istanziati dai neuroni – considera anche il significato complessivo dello sviluppo temporale di questi processi, ovvero dalla storia che li caratterizza in maniera organica e unitaria.
Questa storia si sviluppa in relazione alla realtà extra-neurale del soggetto biologico (la realtà del corpo percipiente e semovente dota-to di occhi, pelle, arti, ecc.), al suo mondo-ambiente circostante (la nicchia ecologica e culturale che definisce le sue possibilità di azio-ne e percezione), e alle operazioni concrete che il soggetto compie su di esso e attraverso di esso. Vanno quindi incluse le operazioni che il soggetto compie in relazione agli altri soggetti, all’esperienza dell’altro da sé (rapporti empatici, di riconoscimento duale), e al mondo inter-soggettivo della socialità incarnata (attenzione congiunta, interazione triadica, conoscenza pubblica), della comunicazione simbolica e della cultura (gesti, pantomima, imitazione, cultura materiale, artefatti,), e del linguaggio (nella sua dimensione di significato sovra-individuale, esterna, e virtualmente indipendente dai corpi dei parlanti).
Le configurazioni strutturali e funzionali assunte dall’attività neuronale in questo modo non sono in sé e per sé significative, non rappresentano e non sono sufficienti a determinare specifici contenuti
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
18
di coscienza, ma contribuiscono all’esperienza del vissuto individuale e collettivo rendendola possibile. Questa possibilità è data unicamente in relazione alla storia degli accoppiamenti funzionali che i soggetti psico-fisici hanno istituito nella trama fine e irripetibile delle loro reci-proche interazioni. In ultima analisi, il fatto che percepiamo un certo contesto di senso come rilevante, intuitivamente riconoscendolo da in-finiti altri estremamente simili, dipende anche, in maniera importante, dai neuroni che si attivano nel nostro cervello; ma il valore funzionale e il significato – per l’esperienza cosciente – di queste componenti or-ganiche dipende a sua volta dallo sfondo infinito di precondizioni con-crete entro cui l’attivazione dei neuroni si ritaglia uno spazio, dal suo accadere come evento situato non solo in un contesto fisico e organico ma anche sociale e culturale. In breve, non è che il cervello custodisca la rappresentazione della nostra esistenza, come l’implicita metafisi-ca delle scienze psicologiche assume; è, per converso, la dimensione esistenziale nel quale accade l’evento fenomenologico del cervello a donare un significato intellegibile alle funzioni del cervello in specifici contesti di esperienza con i quali il funzionamento del cervello è ac-coppiato. Le scienze cognitive non studiano mai solo il funzionamento oggettivo del cervello, ma sempre il funzionamento del cervello in si-tuazione, in relazione al contesto con cui esso interagisce attraverso il corpo.
Questo ci riporta al modo di operare che è unico della fenome-nologia. Pur collocando gli eventi cerebrali nel loro contesto di senso esperienziale, e pur proponendo una descrizione non-riduzionistica e non strettamente meccanicistica dei sostrati fisiologici del vissuto, l’approccio enattivo alle scienze cognitive resta un approccio naturali-stico, preferibilmente orientato verso modelli esplicativi e predittivi di tipo razionale-meccanico, e non originariamente intenzionale in senso rigoroso. L’approccio enattivo è informato dai metodi, dai risultati, e certamente dall’aspirazione anti-meccanicistica e anti-intellettualistica della fenomenologia, ma non per questo consegue lo statuto trascen-dentale che è precondizione per qualsiasi indagine propriamente feno-menologica.
In ultima analisi, una spiegazione del vissuto inferita attraverso l’analisi delle strutture e dei processi enattivi che la sorreggono al livel-lo dell’attività cognitiva soggiacente non sarà mai equivalente all’esame in presa diretta delle forme concrete del vissuto e dei significati delle cose stesse per come esse si offrono direttamente, visto che è soltanto
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
19
nell’esperienza che questi significati si presentano originariamente. Le funzioni cognitive delle diverse aree cerebrali sono sempre identificate sulla base di un’interpretazione di un significato esperienziale che ap-partiene al soggetto, non al suo cervello, mentre di norma non accade l’inverso, cioè che il significato del vissuto di un individuo possa esse-re chiarificato o interpretato sulla base delle concomitanti attivazioni neuronali. Per quanto sottovalutata o metodologicamente esclusa dagli approcci empirici, l’esperienza reale del soggetto cosciente resta la sor-gente fondamentale del senso che è prerequisito di qualsiasi indagine neuroscientifica.
6. SECONDA OBIEZIONE
La priorità assoluta e inviolabile del campo trascendentale motiva la seconda obiezione, mossa dall’interno del discorso fenomenologico. Questa obiezione, tuttavia, sembra ignorare le vicende storiche che hanno portato all’affermazione della fenomenologia. Paradossalmente, nella prospettiva tradizionalista di questa obiezione, la stessa possibili-tà di applicare sistematicamente un metodo basato sull’epochè sembre-rebbe sconfessata dal fatto che – come accennato precedentemente – le osservazioni dei fondatori della fenomenologia sono state ispirate dai risultati sperimentali della psicologia e della fisiologia della loro epo-ca. Alcuni di loro, infatti, a cominciare soprattutto da Merleau-Ponty, hanno mostrato un interesse per i casi della neuropsicologia clinica e l’interpretazione delle correlazioni psico-fisiche tra sistema nervoso e coscienza offerte dalla psicologia scientifica. Il fatto che l’interesse per le interpretazioni degli eventi naturali fosse di tipo critico e non, in sé e per sé, naturalistico non diminuisce l’importanza che queste inter-pretazioni hanno avuto per lo sviluppo della fenomenologia e per il perfezionamento della sua stessa metodologia. Se sviluppiamo il senso della seconda obiezione fino alle sue estreme conseguenze, siamo chia-mati a decidere: o la fenomenologia non è mai stata veramente eser-citata, perché l’approccio trascendentale consisterebbe in una pratica conoscitiva in principio impossibile, visto che i fenomenologi in carne ed ossa non possono non confrontarsi con il linguaggio e le assunzioni della psicologia, oppure essa è possibile ed esiste, ma a condizione di accettare che il portato delle scienze psicologiche possa contribuire a ispirarla e informarla. La seconda opzione sembra preferibile da chi
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
20
realmente crede nel progetto della fenomenologia. Ma, anche se essa si rivelasse ultimativamente corretta, non sarebbe essa in contraddizione con il rigore anti-naturalistico dell’epochè? Questa contraddizione si scopre essere solo apparente se si prende sul serio il fatto che epochè non vuole dire negazione teorica o rifiuto delle scienze, ma condizione per la loro fondazione.
Al fenomenologo è richiesto di sospendere ogni asserzione sullo statuto di realtà del vissuto di coscienza, per attingerne direttamente le strutture dalla sua esperienza originaria, cioè non mediata da impliciti presupposti metafisici, da un’irriflessiva adesione al senso comune, o da atteggiamenti naturalistico-scientifici e/o positivistici; questo però non vuol dire che l’attenzione del fenomenologo e la selezione dei temi fenomenologici più rilevanti non possano essere regolate o motivate da conoscenze pregresse, specifiche aspirazioni della progettualità scien-tifica, e personali motivi di famigliarità con i temi delle scienze sociali e naturali (Husserliana XXXVII, 252). Lo sguardo del fenomenologo è «puro» perché scevro di pregiudizi e presupposti metafisici, ma non in-genuo nel senso di interamente alieno o avulso dal suo oggetto di studio, con il quale – al contrario – è necessariamente già da sempre famigliare.
Il ruolo di questa famigliarità, di questa precomprensione, di-venta centrale per la fenomenologia di Martin Heidegger (1927), che prende le mosse dalla constatazione della situazione di circolarità er-meneutica nella quale ogni indagine fenomenologica si trova situata; la necessaria rilevanza e l’ineliminabilità dello sfondo delle operazio-ni costituenti era però già chiaro, sebbene all’interno di un progetto filosofico diverso, a Husserl, il quale riconosce che tanto gli oggetti dell’esperienza in presa diretta quanto i risultati dell’impresa scienti-fica sono effetti di sintesi passive operate entro un «mondo della vita» (Husserl 2008) al quale il fenomenologo necessariamente appartiene, e continua ad appartenere anche dopo l’epochè. Non tutti i fenomeno-logi valorizzano le implicazioni positive della nozione di «mondo della vita» per il progresso positivo della scienza, soffermandosi piuttosto sullo statuto pre-scientifico che ne caratterizza l’orizzonte, e infatti il punto su cui i sostenitori e gli scettici della cosiddetta «naturalizzazio-ne della fenomenologia» dibattono animatamente è questo (cfr. Vil-lela-Petit 1999; Botero 1999): le nozioni scientifiche e i risultati della conoscenza naturalistica rientrano legittimamente nel novero degli ele-menti di famigliarità e pre-comprensione che possono accompagnare il fenomenologo nella conduzione della sua indagine, o fanno irrime-
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
21
diabilmente parte di quello sfondo di pregiudizi e costruzioni teoriche che l’epochè deve aiutare a escludere, mettendoli tra parentesi?
Prima di rispondere, mi sembra utile ricordare che Husserl stesso subì accuse di psicologismo da Frege nella sede di una discussione sui fondamenti dell’aritmetica; la sua risposta (Husserl 1968) consistette nel rilevare che, mentre è certamente vero che la fenomenologia si di-stanzia dal logicismo perché non postula l’esistenza indipendente og-gettiva delle categorie del pensiero formale, è altrettanto vero che essa non ricade nello psicologia, perché al contempo essa rifiuta di conside-rare queste categorie come componenti reali della mente di un sogget-to psicologico. Lo studio dei fondamenti cognitivi dell’aritmetica può essere trasposto su un piano dell’esperienza pura che Husserl chiame-rà ‘trascendentale’, attraverso una riduzione fenomenologica specifica-mente indirizzata ad analizzare i suoi oggetti di studio sul piano delle regolarità formali degli atti del pensiero. La stessa risposta dovrebbe valere per il fenomenologo che presta le sue osservazioni al lavoro del neuroscienziato, facendone valere le implicazioni in un contesto natu-ralistico senza per questo aspirare a una loro ’naturalizzazione’ (intesa qui come assimilazione dell’intuizione fenomenologico-trascendenta-le alla metafisica del mondo naturale-scientifico). Come si è detto in precedenza, fenomenologia e psicologia differiscono per fondazione e metodologia, ma è altrettanto chiaro che la semplice considerazio-ne di dati empirici e teorie scientifiche non implica automaticamente la compromissione in senso metafisico del lavoro del fenomenologo.
Al contrario, la storia e la metodologia di queste discipline sem-bra suggerire che esse possano illuminare i reciproci percorsi attraver-so corrispondenze indirette e stimoli che contingentemente modulano il percorso dell’una e dell’altra, precisandone meglio il fine e il conte-nuto, ovvero restringendo o allargando di volta in volta il novero delle opzioni descrittive/esplicative plausibili, e di conseguenza suggerendo nuove opzioni che non sarebbero state altrimenti contemplabili. La scienza cognitiva, ad esempio, dischiude alla fenomenologia un intero nuovo orizzonte di indagine quando promuove la descrizione analitica di esperienze particolari come quella dell’arto fantasma, o dell’illusione della mano di gomma (Gallagher 2000); la fenomenologia, per conver-so, svela alla scienza cognitiva un modo interamente nuovo di spiegare l’azione irriflessiva (Rietveld 2008), il ruolo delle competenze motorie nel riconoscimento delle azioni dell’altro (Gallese 2006), la distinzione tra immagine corporea e schema corporeo (Gallagher 2005), ecc.
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
22
Sicuramente non è mai esistito un fenomenologo in carne ed ossa che fosse soltanto un fenomenologo, e nulla vieta che egli possa anche operare come psicologo o come neuroscienziato, a prescindere dal fat-to che egli sia impegnato nell’epochè o meno. Husserl prefigura questa molteplicità non conflittuale di ruoli nel terzo libro di Idee (2002b, 398 ss.), dove asserisce che psicologia e fenomenologia possono con-centrarsi sugli stessi temi e conseguire analoghi risultati conoscitivi, con la sostanziale differenza che mentre la prima tematizza dispositivi oggettivamente presenti e funzionanti all’interno della mente del sog-getto, la seconda si concentra su regolarità e corrispondenze interne al campo dell’esperienza pura.
Questa non-coincidenza, questa costruzione sempre in fieri di un parallelismo dei metodi e delle aspirazioni, non costituisce un’obie-zione pertinente al progetto di una scienza cognitiva enattiva, fenome-nologicamente informata e fondata. La neurofenomenologia propone una metodologia rigorosa per far valere le descrizioni fenomenologi-che all’interno dei contesti sperimentali e la ricerca di laboratorio, e specularmente per indirizzare l’indagine fenomenologica attraverso una riflessione su temi e problemi dischiusi dalla letteratura neuro-scientifica.
Ma questa metodologia non aspira a fornire criteri universali di traduzione o corrispondenza diretta tra la coscienza empirica e quella trascendentale, bensì «vincoli reciproci» (Varela 1989) che di volta in volta restringono o allargano le possibilità conoscitive di ciascuno dei due ambiti sulla base delle scoperte realizzate nell’altro. Ecco perché i due piani rimangono metodologicamente indipendenti e non possono intervenire direttamente l’uno sull’altro. Dati sperimentali ed esperien-ze soggettive non possono sostituirsi a vicenda nei rispettivi contesti di indagine: la fenomenologia non risponde alle domande empiriche della psicologia cognitiva, ma le offre spunti per formulare autonoma-mente nuove domande; i dati raccolti dalle scienze cognitive possono offrire suggerimenti importanti per convogliare l’indagine descrittiva e analitica del fenomenologo, rivelando obbiettivi tematici fino a quel momento trascurati. I due piani restano accoppiati da una rete di re-lazioni analogiche tendenzialmente sistematica e unitaria, ma in realtà sempre flottante, frammentaria, riconfigurabile in maniera molteplice, e per questo sempre emendabile. è una rete che solo idealmente si approssima al limite di un parallelismo interamente dispiegato tra il piano epistemologico e quello esperienziale.
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
23
Come sottolineato dai curatori di Naturalizing phenomenology (Petitot et al. 1999, 66-67), l’aspirazione sistematica di questo paralle-lismo non implica l’assunzione a priori di una relazione analogica tra i due piani, perché non vi è una giustificazione generale che consenta di considerare la semplice somiglianza tra l’ordine dei dati empirici e l’ordine degli eventi trascendentali come una prova forte, in senso metafisico, di una loro corrispondenza logica o causale.
Per questo Natalie Depraz (2006) chiama «passaggi generativi tra l’empirico e il trascendentale» gli effetti conoscitivi delle intera-zioni tra la fenomenologia e la neuroscienza: il metodo e i contenuti di una certa pratica teorica non aspirano mai a riprodurre o replica-re quelli dell’altra (e tantomeno a sostituirla, come taluni paventano) ma a farne uso in modo produttivo e originale nel proprio ambito; non si tratta di scoprire un linguaggio metafisico-causale soggiacente a entrambe queste opzioni, e comune ad esse, ma di offrire occasioni di esplorazione nuove a chi lavora nell’altro ambito, senza necessaria-mente poter prevedere quali implicazioni saranno prodotte da queste nuove opportunità, accettando quindi (anche i filosofi innamorati dei loro argomenti a priori) le sfide che provengono dall’indeterminatezza della scoperta e dall’avvento del nuovo.
L’utilità dell’approccio enattivo-neurofenomenologico pertanto non consiste nel sostituire o aggiornare l’approccio fenomenologico classico, ma nell’accompagnarlo con una infrastruttura metodologica extra-fenomenologica che, per quanto in se e per se confinata all’am-bito naturalistico/sperimentale, è capace di informare l’orientamento e i risultati delle indagini nell’ambito trascendentale.
La relazione tra cervello e vissuto non è deducibile a priori ma sempre constatata a posteriori da una ideale comunità di osservatori che congiuntamente la scoprono, e quindi la istituiscono, attraverso il loro atteggiamento teoretico e obbiettivante-naturalistico. Questa relazione deve cioè instaurarsi come prassi osservativa convalidata intersoggettivamente, come legittimazione di un abito interpretativo istituito nello spazio di una condivisione pubblica, nello sforzo di progressivo consolidamento delle corrispondenze tra dati empirici ed eventi trascendentali che non sarebbe possibile o contemplabile senza la volontà pratica di operare tale consolidamento. Il successo o l’insuccesso di questi tentativi di consolidamento possono solo con-seguire dall’esplorazione del grado di plausibilità riscontrato di volta in volta nelle associazioni stabilite tra questi due piani, dall’esperien-
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
24
za di come la volontà condivisa del consolidamento venga frustrata o agevolata.
Questo requisito intenzionale sembra implicare che è anco-ra soltanto all’interno del vissuto dei ricercatori, nella constatazione della coerenza o incoerenza delle sue trame, che si determina la pos-sibilità delle distinzioni critiche tra mondo esperienziale/mondo na-turale, soggettivo/oggettivo, intenzionale/reale, interno/esterno, etc. In un certo senso, l’indagine della scienza cognitiva enattiva non si è mai allontanata dalla pratica fenomenologica, non è mai uscita dal cerchio dell’esperienza pura dell’epochè, a patto che tale scienza rie-sca a mantenersi sempre consapevole del suo sfondo trascendentale attraverso il costante riconoscimento dei propri atti di pensiero, cioè le operazioni concrete che le consentono di istituire i suoi oggetti di conoscenza come momenti di una prassi intersoggettiva condotta nel mondo naturale. è forse solo sulla base di questa constatazione che è possibile aspirare ad un’integrazione operativa tra fenomenologia e scienze della mente: la stessa distinzione tra esperienza ed esperimen-to, ovvero tra il vissuto (che esperiamo in concomitanza di specifiche attività cognitive dipendenti dal nostro cervello) e il cervello (al quale facciamo riferimento per caratterizzare in senso fisico-causale queste attività cognitive) è una distinzione non originaria o auto-evidente, ma derivata rispetto alle nostre opportunità di frequentare il cervello e la psiche come elementi distinti di un’ontologia locale di tipo fisico-naturalistico e causale. è maturando una consapevolezza costruttivista di come questo dominio dell’esperienza sia costituito contro lo sfondo della nostra percezione incarnata, della nostra memoria culturalmente situata, e delle nostre facoltà storicamente determinate di ricercatori, che le stesse aspettative conoscitive circa il funzionamento cognitivo del cervello acquistano un senso.
Massimiliano CappuccioIndirizzo
NOTE 1 Anche di più, se consideriamo i pionieristici inizi dati da Dreyfus (1967; 1972).2 Il più sistematico ed efficace resta il recente, ma già divenuto classico, Gallagher
e Zahavi (2008), al quale si fa in questa sede ampio riferimento.
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
25
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Andrieu B. (2006), Brains in the flesh: Prospects for a neurophenomenology, in «Janus Head», 9, 135-155.
Botero J-J. (1999), The immediately given as ground and background, in J. Peti-tot, J. M. Roy, B. Pachoud e F.Varela (eds.), Naturalizing phenomenology, Stanford University Press, 322-364.
Laughlin C., McManus J., d’Aquili E. (1992), Brain, symbol and experience: To-ward a neurophenomenology of consciousness, New York, Columbia Uni-versity Press.
Casati R. (1999), Formal structures in the phenomenology of motion, in J. Petitot, J. M. Roy, B. Pachoud, F.Varela (eds.), Naturalizing phenomenology, Stan-ford University Press, 372-384.
Chalmers D. (1995), Facing up to the problem of consciousness, in «Journal of Consciousness Studies», 2 (3), 200-219.
Damasio A. (1999), The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness, London, Heinemann.
Dennett D. (1991), Consciousness explained, Penguin Press. Dennett D. (2007), Heterophenomenology reconsidered, in «Phenomenology and
the Cognitive Sciences», 6 (1-2), 247-270.Depraz N. (2006), Mettere al lavoro il metodo fenomenologico nei protocolli speri-
mentali. «Passaggi generativi» tra l’empirico e il trascendentale, in M. Cap-puccio (ed.), Neurofenomenologia, Milano, Bruno Mondadori.
Dreyfus H., Hall H. (1982), Husserl, intentionality, and cognitive science, Cam-bridge, MA, MIT Press.
Dreyfus H. (2002a), Intelligence without representation – Merleau-Ponty’s critique of mental representation. The relevance of phenomenology to scientific ex-planation, in «Phenomenology and the Cognitive Sciences», 1, 367-383.
Dreyfus H. (2002b), Refocusing the question: Can there be skillful coping without propositional representations or brain representations?, in «Phenomenol-«Phenomenol-Phenomenol-ogy and the Cognitive Sciences», 1 (4), 413-425.
Dreyfus H. (2008), Why Heideggerian AI failed and how fixing it would require making it more Heideggerian, in P. Husbands, O. Holland, M. Wheeler (eds.), The mechanical mind in history, Cambridge, MA, MIT Press, 331-371.
Fogassi L., Ferrari P.F., Gesierich B., Rozzi S., Chersi F., Rizzolatti G. (2005), Parietal lobe: From action organization to intention understanding, in «Sci-ence», 308, 662-667.
Freeman W. (2000), How brains make up their minds, New York, Columbia Uni-versity Press.
Fuchs C., Hofkirchner W., Klauninger B. (2010), The dialectic of bottom-up and top-down emergence in social systems, in «tripleC», 3 (2), 28-50.
Gallagher S. (2005), How the body shapes the mind, Oxford, Oxford University Press.
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
26
Gallagher S. (2000), Philosophical conceptions of the self: Implications for cogni-tive science, in «Trends in Cognitive Sciences», 4 (1), 14-21.
Gallagher S. (2009), Neurophenomenology, in T. Bayne, A. Cleeremans e P. Wilk-en (eds.), Oxford Companion to Consciousness, Oxford, Oxford University Press, 470-472.
Gallagher S., Zahavi D. (2008), The phenomenological mind, London, Rout-ledge.
Gallese V. (2006), Corpo vivo, simulazione incarnata e intersoggettività: Una pros-pettiva neurofenomenologica, in M. Cappuccio (ed.) Neurofenomenologia, Milano, Bruno Mondadori, 293-326.
Gallese V. (2007), Dai neuroni specchio alla consonanza intenzionale. Meccanismi neurofisiologici dell’intersoggettività, in «Rivista di Psicoanalisi», LIII, 1, 197-208.
Gibbs R.W. (2006), Embodiment and cognitive science, New York, Cambridge University Press.
Gibson J.J. (1979), The ecological approach to visual perception, Boston, Hough-ton Mifflin.
Heidegger M. (1927), Essere e Tempo, traduzopne di P. Chiodi, a cura di F. Volpi, Milano, Longanesi.
Hurley S.L. (1998), Consciousness in action, Cambridge, MA, Harvard University Press.
Husserl E. (1962), The idea of phenomenology, The Hague, M. Nijhoff.Husserl E. (1973), Zur Phänomenologie der Intersubjektivität I, Husserliana XIII,
Den Haag, M. Nijhoff.Husserl E. (2002), Meditazioni cartesiane, Milano, Bompiani; ed. or. 1973: Car-
tesianische Meditationen und Pariser Vorträge – Husserliana I, Den Haag, M. Nijhoff.
Husserl E. (2002b), Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomeno-logica, Torino, Einaudi; ed. or. 1952: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie II – Husserliana IV, Den Haag, M. Nijhoff.
Husserl E. (2003), Metodo fenomenologico statico e genetico, a cura di M. Ver-gani, Milano, Il Saggiatore.
Iacoboni M., Molnar-Szakacs I., Gallese V., Buccino G., Mazziotta J., Rizzolatti G. (2005), Grasping the intentions of others with one’s owns mirror neuron system, in «PLOS Biology», 3, 79.
Kelly S. (2000), Grasping at Straws: Motor intentionality and the cognitive science of skilled behaviour, in M. Wrathall e J. Malpas (eds.) Heidegger, coping and the cognitive sciences: Essays in honor of Hubert L. Dreyfus – Volume II, Cambridge, MA, MIT Press.
Kim J. (1993), Supervenience and mind, Cambridge, Cambridge University Press.
Levine J. (1983), Materialism and qualia: the explanatory gap, in «Pacific Philo-sophical Quarterly», 64, 354-361.
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
27
Levine J. (1993), On leaving out what it’s like, in M. Davies e G. Humphreys, Consciousness: Psychological and philosophical essays, Oxford, Blackwell.
Lipps T. (1903), Aesthetik: PsychologiedesSchoenenundderKunst: Grundlegung der Aesthetik, Erster Teil, Hamburg, L Voss.
Lohmar D. (2005), On the function of weak phantasmata in perception: Phenom-enological, psychological and neurological clues for the transcendental func-tion of imagination in perception, in «Phenomenology and the Cognitive Sciences», 4, 155-167.
Lohmar D. (2006), Mirror neurons and the phenomenology of intersubjectivity, in «Phenomenology and the Cognitive Sciences», 5 (1), 5-16.
Uddin L.Q., Molnar-Szakacs I., Zaidel E., Iacoboni M. (2006), rTMS to the right inferior parietal lobule disrupts self-other discrimination, in «Soc Cogn Af-fect Neurosci.», 1 (1), 65-71.
Lutz A., Thompson E. (2003), Neurophenomenology: Integrating subjective expe-rience and brain dynamics in the neuroscience of consciousness, in «Journal of Consciousness Studies», 9 (10), 31-52.
Maturana H.R., Varela F.J. (1980), Autopoiesis and cognition, Boston, D. Reidel.Maturana H.R., Varela F.J. (1987), The tree of knowledge: The biological roots of
human understanding, Boston, New Science Library.McIntyre R. (1986), Husserl and the representational theory of mind, in «Topoi»,
5, 101-113. Merleau-Ponty M. (2003), Fenomenologia della percezione, a cura di V. Flak,
Milano, Bompiani.Merleau-Ponty M. (1996), La natura. Lezioni al Collège de France 1956-1960,
Milano, Raffaello Cortina.Nagel T. (1974), What is it like to be a bat?, in «Philosophical Review», 83, 435-
456.Noë A., Thompson E. (2004), Are there neural correlates of consciousness?, in
«Journal of Consciousness Studies», 11 (1), 3-28.Noë A. (2005), Action in perception, Cambridge, MA, MIT Press.O’Regan J.K., Noë A. (2001), A sensorimotor account of visual consciousness, in
«Behavioral and Brain Sciences», 11 (5), 939-973.Petit J-L. (2004), Empathie et intersubjectivité, in A. Berthoz e G. Jorland, L’em-
pathie, Paris, Odile Jacob.Petitot J. (1999), Morphological eidetics for a phenomenology of perception, in J.
Petitot, J.M. Roy, B. Pachoud e F. Varela (eds.), Naturalizing phenomenol-ogy, Stanford University Press, 330-371.
Petitot J. (2008), Neurogeometrie de la vision. Modéles mathematiques et phy-siques des architectures fonctionnelles, Paris, Ecole Polytechnique.
Petitot J., Varela F., Pachoud B., Roy J.M. (eds.) (1999), Naturalizing phenom-enology: Contemporary issues in phenomenology and cognitive science, Stanford University Press.
Picton T., Stuss D. (1994), Neurobiology of conscious experience, in «Current Bi-ology», 4, 1-32.
MASSIMILIANO CAPPUCCIO
28
Prinz W. (2005), An ideomotor approach to imitation, in S. Hurley e N. Chater (eds.), Perspectives on imitation: From cognitive neuroscience to social sci-ence, vol. 1: Mechanisms of imitation and imitation in animals, Cambridge-London, MIT Press.
Thom R. (1972), Structural sStability and morphogenesis, W.A. Benjamin.Ricœur P. (1950), À l’école de la phénoménologie, Paris, Vrin.Rietveld E. (2008), Situated normativity: The normative aspect of embodied cogni-
tion in unreflective action, in «Mind», 117 (468), 973-1001. Rizzolatti G., Sinigaglia C. (2006), So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni
specchio, Milano, Raffaello Cortina.Rizzolatti G., Fadiga L., Gallese V., Fogassi L. (1996), Premotor cortex and the
recognition of motor actions, in «Experimental Brain Research», 3, 131-141.
Rudrauf D., Lutz A., Cosmelli D., Lachaux J.-P., Le Van Quyen M. (2003), From autopoiesis to neurophenomenology: Francisco Varela’s exploration of the biophysics of being, in «Biological Research», 36, 21-59.
Scheler M. (2010), Essenza e forme della simpatia, a cura di Laura Boella, Roma, Franco Angeli.
Shapiro L. (2010), Embodied cognition, London-New York, Routledge.Spiegelberg F. (1962), The phenomenological movement, 2a ed. in 2 voll., The
Hague, M. Nihjoff.Stein E. (2002), L’empatia, a cura di Michele Nichetti, Roma, Franco Angeli.Thompson E. (2001), Empathy and consciousness, in «Journal of Consciousness
Studies», 8, 5-7.Thompson E. (2007), Mind in life. Biology, phenomenology and the sciences of
mind, Cambridge, MA, Harvard University Press.Thompson E. (2008), Representationalism and the phenomenology of mental im-
agery, in «Synthese», 160, 397-415.Thompson E., Palacios A., Varela F.J. (1992), Ways of coloring: Comparative color
vision as a case study for cognitive science, in «Behavioral and Brain Sci-ences», 15, 1-26.
Thompson E., Varela F.J. (2001), Radical embodiment: Neural dynamics and con-scious experience, in «Trends in Cognitive Sciences».
Thompson E., Lutz A., Cosmelli D. (2004), Neurophenomenology: An introduc-tion for neurophilosophers, in A. Brook e K. Akins (eds.), Cognition and the bnrain: The philosophy and neuroscience of movement, New York-Cambridge, Cambridge University Press.
Umiltà C.A., Kohler E., Gallese V., Fogassi L., Fadiga L., Keysers C., Rizzolatti G. (2001), «I know what you are doing»: a neurophysiological study, in «Neuron», 32, 91-101.
Varela F. (1995a), The emergent self, in J. Brockman (ed.) The third culture: Be-yond the scientific revolution, New York, Simon and Schuster.
Varela F. (1995b), Resonant cell assemblies: A new approach to cognitive function-ing and neuronal synchrony, in «Biol. Res.», 28, 81-95.
FENOMENOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA
29
Varela F. (1996a), The specious present: A neurophenomenology of newness, in J. Petitot, J.M. Roy, B. Pachoud, F. Varela (a cura di), Naturalizing phenom-enology, Stanford University Press.
Varela F. (1996b), Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem, in «Journal of Consciousness Studies», 3, 330-349.
Varela F. (1997), Patterns of life: Intertwining identity and cognition, in «Brain and Cognition», 34 (1), 72-87.
Varela F., Thompson E., Rosch E. (1991), The embodied mind. Cognitive science and human experience, Cambridg, MA, MIT Press.
Villela-Petit M. (1999), Cognitive psychology and the transcendental theory of knowledge, in J. Petitot, J.M. Roy, B. Pachoud, F. Varela (eds.), Natural-izing phenomenology, Stanford University Press, 140-171.
Zahavi D. (2007), Killing the Straw man: Dennett and phenomenology, in «Phe-nom. Cog. Sci.», 6, 21-43.