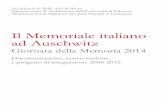Fenomenologia e Psicanalisi. Freud, Husserl, Binswanger
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Fenomenologia e Psicanalisi. Freud, Husserl, Binswanger
Indice
Prefazione 4
I Capitolo
L’itinerario di Freud verso l’ontologia naturalistica della soggettività
Premessa: scienze umane e filosofia 8Fisica speculativa dell’anima 10La definizione dello spazio teorico psicoanalitico: gli Studi sull’isteria 16Un caso clinico esemplare 20Lo sconcerto di Freud 23Nuovi punti di vista 26 E’ possibile descrivere l’inconscio ? 29Ostacoli 33Metapsicologia e neurofisiologia 36Desiderio, Inconscio, Fantasma 40
3
Pluridimensionalità 43Inconscio, Caos, Creazione 46Incivilimento, Coscienza, Fantasma 48Il demone filosofico 53
II Capitolo
La critica alla psicologia dualistica e naturalistica ed il progetto fenomenologico di una nuova ontologia del mondo della vita.Premessa 56Psiche e numero 57Dalla logica pura al mondo-della-vita 61Psicologia o filosofia? 64Scienza, psicologia e mondo-della-vita 67L’origine del dualismo 71
4
Dall’obiettività al trascendentale 75La psicologia dopo Cartesio 77Un’altra occasione mancata: Kant e la psicologia 81L’enigma della relazione vita-pensiero 83Due possibilità di essere desti 87Dall’io al noi 91Critica e rifondazione della ragione psicologica 94Filosofia e psicologia: un destino comune 100
III Capitolo
Psicoanalisi, fenomenologia e daseisanalyse
Coscienza ed inconscio 102Intenzionalità ed inconscio 105La comprensione del Dasein patologico 108Normalità 111Melanconia e Mania 113Delirio 120Delirio, desiderio, temporalità 125
5
Osservazioni conclusive 130
Bibliografia 142
Prefazione
Con la pubblicazione di due opere destinate a fertilissimisviluppi nel corso del secolo, L’interpretazione dei sogni di SigmundFreud e le Ricerche logiche (I volume) di Edmund Husserl, il 1900costituisce una data molto importante per la psicologia, lafilosofia e, soprattutto, per le loro relazioni.L’inizio del secolo XX vede, infatti, la nascita dellaFenomenologia e della Psicoanalisi, le cui premesse, radicalmenteopposte, finiscono però per convergere nelle stesse finalitàpoiché entrambe aspirano a comprendere, ponendo in essere nuoviparadigmi scientifici, le strutture invariabili dellasoggettività-intersoggettività. Le prospettive conoscitive che si aprono con questi due testimostrano subito l’inevitabilità della relazione filosofia-psicologia nonostante, in prima battuta, appaiano opposte, sia perle diversità delle premesse teoriche e metodologiche da cui essesono emerse, sia per gli ambiti problematici affrontati. Tra filosofia e psicologia c’è un doppio movimento: l’Interpretazionedei sogni, opera di psicologia, si conclude con la rivendicazione delsuo valore filosofico-metapsicologico e le Ricerche logiche, opera
6
eminentemente filosofica, si risolve (nel II volume) nel progettodella costruzione della “psicologia descrittiva”.L’Interpretazione dei sogni, infatti, costituisce un primo e determinantepunto d’arrivo per Freud, che qui vede dispiegato un sapere cheillumina il soggetto nella materialità e nella profondità deiprocessi conflittuali che lo attraversano nel suo essere fisico epsichico.A tale sapere viene immediatamente rivendicato valore filosoficopoiché “l’interpretazione del sogno è in grado di fornircichiarimenti sulla struttura del nostro apparato psichico, chefinora abbiamo atteso invano dalla filosofia”.L’universo concettuale della psicoanalisi, dopo la definizione delsuo spazio teorico operata con gli Studi sull’isteria, trova la sua primaorganica formulazione proprio in quest’opera che dal suo autore èposta come fondamento di una “scienza dell’anima nuova” rivolta aconquistare un territorio inesplorato e, nello stesso tempo,inesplorabile dalla filosofia.Nelle Ricerche logiche Husserl, da problemi squisitamente filosoficiintorno alla natura della logica, perviene, attraverso un rigorosoitinerario, alla definizione di un progetto per la costruzione diuna “psicologia descrittiva” rivolta, nella critica e nelsuperamento dell’approccio dualistico e naturalistico checaratterizza proprio la nascente psicoanalisi e le altre correntidella psicologia originatesi nell’ambito del Positivismo, arendere possibile una scienza – trascendentale e nonoggettivistica - del “mondo della vita”. Ciò comporta che la “psicologia descrittiva” (poi Fenomenologia) ela psicoanalisi si costituiscono, in conformità a percorsi teoriciradicalmente e, si potrebbe anche dire, specularmente opposti,come due diversi modi di risalita all’originario (l’Ur-Ich diHusserl e l’Es di Freud) la cui la tematizzazione viene posta, inentrambi i casi, in una prospettiva decisamente fondazionale, purse diversamente qualificata. Il programma di Husserl è rivolto a delegittimare, sulla base diun radicale rinnovamento della filosofia, la psicologia di originepositivista, al fine di recuperarne l’indispensabile funzioneall’interno della ricerca fenomenologica, mentre quello di Freud èfinalizzato a mostrare, in virtù dell’efficacia teorica eterapeutica della psicoanalisi, come la tradizione filosofica delpensiero abbia esaurito la sua funzione storico-culturale e quindisia da consegnare alla preistoria conoscitiva dell’umanità.E’ sorprendente come queste due prospettive divergenti abbianoconosciuto anche una comune esperienza che risale agli anni della
7
loro formazione, essendo stati, sia Husserl sia Freud, allievi delProf. Franz Brentano presso l’Università di Vienna, anche se peril primo ciò avviene tra il 1884 e il 1886, mentre per il secondoesattamente dieci anni prima, tra il 1874 e il 1876.L’incontro con Brentano fu comunque decisivo per entrambi: Husserldecide di dedicarsi totalmente alla filosofia, e al suo radicale rinnovamento, elaborando il concetto di intenzionalità derivato dal suo maestro, mentre Freud se ne allontanerà quasi con sdegno, ritenendola, nell’epoca del trionfo del sapere positivo, un vero eproprio “abuso del pensiero” Da una parte Husserl, movendo proprio dal concettod’intenzionalità derivato da Brentano, “ è convinto di averdinanzi un campo di ricerche in relazione al quale ogniconvinzione filosofica ereditata dalla tradizione non deve neppureessere presa in considerazione”. 1
Il suo obiettivo è di indagare l’esperienza vissuta attraverso laricostruzione della psicologia su basi diverse e la fondazionedella conoscenza delle oggettività ideali. Dall’altra, Freud è altrettanto convinto di procedere in una terradi nessuno alla conquista di un sapere, materialisticamentefondato, sui processi di costituzione della soggettività e deisuoi vissuti esperenziali. Ciò allora comporta che tra Husserl e Freud si pongono fin dasubito due elementi in comune: l’oggetto d’indagine (le struttureprofonde della soggettività e dei suoi vissuti) e le finalità‘ontologiche’ rispetto ad esso, anche se ovviamente questaconvergenza trova origine da prospettive radicalmente diverse edanche se, come si vedrà, l’ontologia del mondo-della-vita diHusserl non è certamente da porre sullo stesso piano degli intentimetapsicologici di Freud. La questione fondamentale che orientaHusserl in una direzione e Freud in un’altra è quella del corpo.La fenomenologia costruisce un orizzonte di senso della corporeitàradicalmente diversa dall’approccio freudiano: il corpo è corpo-soggetto ( Leib ), corpo vivente che non ha nulla a che fare con lasua riduzione naturalistica a cosa ( Körper ), è corpo che non sta,oggetto tra oggetti, nel mondo ma lo abita, aprendosi ad esso nellarete infinita dei suoi rimandi intersoggettivi. Mentre Husserl,partendo dalla problematizzazione del dualismo cartesiano silibera da ogni apprensione cosale della corporeità, Freud,fortemente ancorato, pur se in modo largamente non avvertito, atale paradigma, inizia la sua indagine dell’inconscio da unaprospettiva ancora naturalistica. Ciò, come si cercherà di1 R.Raggiunti, Introduzione ad Husserl, Roma-Bari, Laterza,1994.
8
mostrare, non ha però impedito che, nel corso di questa indagine,la psicoanalisi, anche suo malgrado, perda questa suo sguardooriginario in favore di una considerazione della trascendenza delcorpo dai suoi confini oggettivi e della sua intezionalità iscrittanel mondo-della-vita.Nel ripercorrere i momenti principali e decisivi degli itinerariteorici di Freud e di Husserl occorrerà allora valutare glielementi di fondo che hanno caratterizzato il contesto storico-culturale entro cui questi si sono originati. L’analisi metodologicamente rigorosa dei comportamenti dell’uomo,dei motivi del suo agire, della sua integrazione nella società enell’universo simbolico da esso stesso prodotto e continuamentemodificato, ha trovato concretizzazione, nella seconda metà del1800, con la nascita della sociologia, dell’antropologia culturalee della psicologia.E’ infatti in tale contesto che necessariamente psicoanalisi efenomenologia devono essere comprese : la prima come una delleespressioni più compiute e teoricamente rilevanti del paradigmapositivista nel campo della psicologia (anche se l’opera di Freudnon solo è difficilmente contenibile entro i confini di taleparadigma ma, si può anzi dire, che essa finisce per disgregarlodall’interno, ponendo in essere un pensiero non più contenibileentro la ratio metafisica in cui invece questo paradigma trova lapropria origine), la seconda come una delle correnti filosofichepiù importanti e decisive del secolo che si è originata nel climaculturale della reazione al positivismo.Lo sfondo dell’itinerario che qui viene proposto è dunqueattraversato dalle questioni che si pongono con la nascita dellescienze umane nella loro relazione con la filosofia. Il lorotendenziale egemonismo fondato sull’esigenza di aderire ai ‘datidi fatto’ costituisce il terreno su cui Freud procede, a partiredal concetto di “realtà psichica”, nella costruzione dell’universoconcettuale psicoanalitico rivolto ad afferrare le struttureprofonde ed invariabili della soggettività radicate nellarelazione corpo-mente-In tale contesto il rapporto della fenomenologia (nella suaesigenza fondamentale di ‘praticare’ la filosofia come scienzarigorosa) con la psicoanalisi, contiene aspetti fondamentali, senon addirittura esemplari e paradigmatici, della problematicagenerale del rapporto tra la ‘vecchia’ filosofia e le ‘nuove’scienze umane.
9
Il testo è diviso in tre parti. Nella prima, sulla base delladelineazione dei tratti principali dello sfondo storico-culturaleentro cui nascono le scienze umane, si è cercato di cogliere imomenti decisivi dell’evoluzione del pensiero di Freud che daifondamentali Studi sull’isteria (1893-95) , opera in cui possiamoconcretamente assistere alla costruzione dello spazio teoricodella psicoanalisi, giunge ad una prima sistematizzazione‘ontologica’ delle sue ‘scoperte’ nell’ultimo e più importantecapitolo della Interpretazione dei sogni, cioè la sua “parte filosofica”(così la definisce lo stesso Freud) a cui è finalizzata tuttal’analisi del lavoro onirico. Nella seconda parte, dopo un breve excursus che ripercorre iltentativo di Husserl di ri-fondazione filosofica della psicologia,si discuteranno i temi principali presenti in La crisi delle scienzeeuropee e la fenomenologia trascendentale, dove appunto tale questione trovala sua più articolata e profonda considerazione. Il motivo fondamentale ed originario di quest’opera, “testamentospirituale di Husserl e matura presentazione e messa a punto delprogramma e del metodo fenomenologici”2, è infatti proprio quellodel rapporto critico con i presupposti dualistici (corpo e mente)e naturalistici della psicologia che caratterizzano la strutturaconcettuale della psicoanalisi. Non c’è dunque da stupirsi quindidel titolo originario della Krisis (come si è soliti citare ilcapolavoro di Husserl) che era : La crisi delle scienze europee e lapsicologia .Qui verranno delineati i nuclei tematici fondamentali dell’opera ericostruiti i passaggi decisivi che conducono Husserl ad unacritica radicale della psicologia per liberarla dai vincoli deldualismo e del fisicalismo di origine cartesiana e renderla cosìdisponibile ad un fecondo rapporto con la fenomenologiatrascendentale, finalizzato ad aprire prospettive di ricerca‘ontologica’ sul mondo-della vita. In sintesi, i primi duecapitoli cercano di esplorare il tema del rapporto tra filosofia epsicologia così come si viene configurando nell’evoluzione teoricadi Freud e di Husserl in rapporto alla questione fondamentaledella corporeità.La terza parte è invece dedicata a una sintetica discussione diuna delle esperienze più significative di incontro tra lafenomenologia e la psicoanalisi, avvenuta nel contesto deltentativo di Ludwig Binswanger di liberare la psichiatria dallasua origine naturalistica per collocarla, a pieno titolo,
2 Carlo Sini, Introduzione a L’idea della fenomenologia, Laterza, Roma-Bari,1992, p.8.
10
nell’ambito delle scienze umane, in un ambito cioè in cui il Körpersi fa Leib.Al di là dei veti incrociati di Husserl e di Freud, nellaDaseinsanalyse (analisi della presenza) di Binwanger, psichiatra epsicoanalista svizzero, significativamente allievo di entrambi, sicerca infatti di cogliere, “ciò che è realmente nella coscienza”,per comprendere la sofferenza mentale e fondare l’incontro e ildialogo psicoterapeutico.Come è noto, questo tentativo trova origine nel riferimento alpensiero di Husserl per poi svilupparsi attraverso l’analiticaesistenziale di Essere e Tempo di Heidegger e quindi ritornare, nelledue ultime opere di Binswanger, alla prospettive aperte dallafenomenologia trascendentale. Anche se non è sempre e direttamentechiamato in causa si cercherà di mostrare come, nellaorchestrazione del tema fenomenologico della Daseinsanalyse,l’universo concettuale psicoanalitico è costantemente presente siacome immediato terreno di ricerca, sia come universo categorialedi fondo. E’ però nel modo in cui la relazione fenomenologia\psicoanalisi vive nell’itinerario teorico di Binswanger che vieneposto in essere un approccio alla vita psichica e ai suoi vissutiche finirà per dissolvere, per indebolire o, comunque, perqualificare altrimenti – secondo le diverse interpretazioni a cuisi farà riferimento – gli intenti fondazionalisti presenti, pur sein modi radicalmenti diversi, in Freud ed in Husserl.L’interrogativo che si definisce riguarda perciò il superamento omeno della (metafisica) costruzione\fondazione di un’ontologiadella soggettività in favore della diretta ed immediata aperturaal progetto-di-mondo di una – singola e concreta - presenza, intesanella molteplicità dei suoi modi e nella sua eccedenza rispetto aqualsiasi tentativo di afferrarne essenze o strutture invariabiliche rimandano, pur attraverso vie diverse, alla purezza di un“originario”. Come può essere allora valutato il movimento della teoria della soggettività verso l’ascolto della presenza? Nell’opera di Binswanger e, ancora di più, nella sua pratica clinica che incessantemente attraversa lo spazio tra l’ontico e l’ontologico, viene attivato un progressivo distanziamento dalla tradizione metafisica occidentale, epressa, nel campo del disagio mentale, dall’oggettivismo delle classificazioni clinico-noosografiche della psichiatria classica? C’è effettivamente un movimento verso una nuova capacità di disporsi di fronte alla presenza come ad un originario il cui continuo ed imprevedibile prodursi come differenza è lì, pronto ed immediatamente attingibile? Nelle
11
Osservazioni conclusive, sia attraverso un riferimento all’opera di rinnovamento della psichiatria italiana di Danilo Cargnello (che, fin dal primo dopoguerra, si adopera ad introdurre Binswanger in Italia) sia attraverso le riflessioni di Paul Ricoeur e di Carlo Sini, si discuteranno alcuni aspetti, ritenuti centrali e decisivi, relativi alla possibilità di praticare la relazione fenomenologia\ psicoanalisi su un piano non più occupato da costruzioni teorico-metafisiche della soggettività, ma attraversato da infinite possibilità di interpretazione e di ascolto della presenza, la cui apertura si dà nel porre, eticamente,la coscienza come compito.
12
I Capitolo
L’itinerario di Freud verso l’ontologia naturalistica dellasoggettività.
Premessa: scienze umane e filosofia
Lo sfondo storico-culturale entro cui prende corpo l’idea di un sapere scientificamente orientato che ha per ‘oggetto’ l’uomo, è quello dell’Illuminismo. In tale ambito trova infatti origine la figura dell’intellettuale rivolto pragmaticamente a migliorare le condizioni di vita dell’uomo attraverso l’analisi delle istituzioni storiche e dei costumi sociali , analisi condotta attraverso l’uso libero e pubblico della ragione finalmente uscita da uno “stato di minorità” e dall’”oceano tenebroso della metafisica” (Kant)Le ‘scienze umane’si caratterizzano, fin dalla loro origine, come conoscenza socialmente utile, come sapere pragmatico rivolto a favorire lo sviluppo dell’individuo e della società. Tale carattere emancipativo è, ad esempio, evidente nell’opera di Montesquieu, dove la “scoperta” delle leggi della dinamica socialecostituisce uno strumento atto ad individuare le condizioni della libertà politica del cittadino.Le basi concettuali della ricerca illuminista tesa a comprendere le “leggi” dell’attività umana(l’uomo-macchina regolato da rigide leggi di natura) trovano però la loro più compiuta espressione nella seconda metà dell’Ottocento.Il ricorso ad una ragione liberata e finalmente utilizzabile per fini pragmatici di pubblica felicità, la valorizzazione del saperescientifico e le concezioni laiche ed immanentistiche, costituiscono quegli elementi di continuità tra Illuminismo e Positivismo sui quali hanno trovato la loro origine le scienze umane nella seconda metà dell’Ottocento.
14
In tale contesto la definizione del loro ambito teorico e metodologico non poteva non avvenire che sulla base del processo conoscitivo che caratterizza le scienze naturali dell’epoca.L’idea dell’esistenza di leggi causali universali operanti nel mondo della natura viene sostanzialmente fatta propria dalle nascenti scienze umane e utilizzata per definire il loro confine dal territorio della ‘libera’ speculazione filosofica.Ad esempio la Sociologia, o, più propriamente , la “fisica sociale” viene vista da Comte come un sapere “necessario” per affrontare la crescente complessità sociale. Essa si pone in alternativa alla “filosofia teologica” su cui si reggeva la società nei suoi stadi precedenti a quello positivo (stadio teologico e metafisico).Il compito che viene ad essa assegnato è quello di costituire un sapere assoluto (“sociocrazia”) per l’avvento di una nuova societàin cui la storia viene divinizzata come processo necessariamente eteleologicamente rivolto ad approdare alla piena esplicazione della ragione scientifica.In questi esiti teologico-metafisici dell’opera di uno dei principali fondatori della Sociologia si può leggere in tutta chiarezza la problematicità di una netta differenziazione tra le nuove scienze dell’uomo e la tradizione filosofica del pensiero e , nello stesso tempo , la tensione teorica di porre mano alla costruzione di un sapere positivo, fondato sull’osservazione dei fenomeni, programmaticamente orientato a favorire l’evoluzione della società.L’evoluzionismo fa da sfondo anche ad un’altra scienza dell’uomo ,l’Antropologia, che si è costituita , inizialmente per opera di Taylor e Morgan , sulla base della pre-valenza della cultura europea come punto di arrivo di uno sviluppo unilineare delle culture , caratterizzato da stadi e fasi obbligate e necessarie .Sulla base del valore paradigmatico della cultura europea le primericerche antropologiche sviluppano specifici e complessi strumenticoncettuali e metodologici attraverso cui effettuare analisi comparative rivolte a determinare il grado di evoluzione delle culture altre.L’origine di tale disciplina si definisce dunque in modo diretto ed immediato entro la filosofia evoluzionistica del positivismo anche se, nello stesso tempo, trova una qualche eterodossa correlazione con l’idea hegeliana della storia dell’occidente europeo come storia dell’avvento progressivo della verità. Per un’altra scienza umana, la Pedagogia, il problema della sua relazione con la filosofia si pone in termini diversi e
15
storicamente più complessi essendo essa stata presente nella cultura occidentale, fin dall’età classica, come sapere derivato dalla filosofia.Anche se nel ‘900 la psico-pedagogia ha conquistato una propria autonomia teorico-metodologica, la delimitazione di un confine tra le scienze dell’educazione (quindi non più la” conduzione di fanciulli” filosoficamente fondata) e lafilosofia è ancora oggi un problema aperto.L’antropologia, la sociologia, la pedagogia e la psicologia sono saperi che si definiscono nel processo evolutivo delle società occidentali e nelle esigenze della complessità crescente che tale evoluzione pone in essere ed alimenta. In un’epoca che si caratterizza per la sua complessità tecnica, sociale ed economica il saperepositivo , cioè effettuale, concreto, sperimentale , pragmatico edutile, tende inevitabilmente ad assumere una posizione dominante come sapere necessario all’esigenza della riproduzione di tale complessità e della sua interna logica di sviluppo, distanziandosicosì necessariamente dall’ambito delle concezioni sociali, politiche, antropologiche e relative alla soggettività elaborate nell’ambito propriamente filosofico.In sintesi si può dunque dire che la nascita dell’esigenza di un sapere scientificamente orientato che ha per oggetto l’uomo, entroil contesto culturale e filosofico positivista, assume un duplice carattere. Da una parte trova nel superamento della filosofia comemetafisica il proprio momento fondativo, dall’altra conserva un chiaro fondo filosofico.Questo nuovo sapere così, pur aspirando ad una totale e radicale emancipazione dalla filosofia per assumere pragmaticamente e positivamente una concreta funzione sociale, è facilmente riconducibile a prospettive già presenti, più o meno direttamente,nella tradizione filosofica del pensiero. La questione che allora si pone riguarda la conquista e la definizione di un piano teorico-epistemologico dove costruire una nuova relazione tra la filosofia e le scienze umane, la cui autonomia passa dunque proprio attraverso questa costruzione. Un esempio può essere datodalle proficue interrelazioni e interconnessioni operanti nella ricerca cognitiva che integra diverse discipline come la socio-antropologia, le neuroscienze, la linguistica, la cibernetica con la psicologia e la filosofia. Tuttavia, se soprattutto si assume uno sguardo storico, ciò che subito emerge con la nascita delle scienze umane è un inevitabile conflitto con la filosofia. La situazione che si è venuta così a creare, a partire dalla fine del
16
secolo XIX, nel campo del sapere che ha per ‘oggetto’ l’uomo, è conseguentemente attraversata sia da tensioni e conflitti tra le nascenti scienze umane e la filosofia, sia da grandi possibilità teorico-metodologiche di apertura alla comprensione della complessità del soggetto e dei suoi vissuti.E’ in tale contesto che va compresa sia la rivoluzione psicoanalitica- come “scienza dell’anima nuova” (Freud) in grado di aprire la strada ad un sapere “atteso invano dalla filosofia”- ,sia quella fenomenologico-trascendentale - come “vero positivismo”(Huserl) rivolto a cogliere ed indagare “ciò che realmente è nellacoscienza”, al di là dell’ingenuo quanto radicato atteggiamento naturalistico ed obbiettivistico della psicologia.Come si vedrà, la critica husserliana all’obbiettivismo della psicologia, originato dal radicamento di quest’ultima nel meccanicismo delle scienze naturali dell’epoca positivistica, è rivolto a rendere possibile una psico-logia che sia realmente in grado di cogliere ed indagare la soggettività nei suoi fondamenti ed essenze.Dal versante della psicologia si tende invece a pensare il rapporto con la filosofia in termini di aut-aut come pensava lo stesso maestro di Husserl, Franz Brentano. Il conflitto tra filosofia e psicologia raggiunge allora la sua massima espressione proprio con la contrapposizione frontale tra fenomenologia e psicoanalisi perché è la contrapposizione tra una prospettiva antiobbiettivistica ed una obbiettivistica. Nello stesso tempo questa relazione conflittuale contiene grandi potenzialità teoriche in virtù, per quanto riguarda la fenomenologia, della tematizzazione della profondità dei processi costitutivi della coscienza e della soggettività in generale e, relativamente alla psicoanalisi, della sua indubbia valenza fenomenologico-ermeneutica nell’esplorazione dei derivati dell’inconscio.Prima di occuparci di queste virtualità teoriche, occorre allora ripercorrere il “tortuoso itinerario” freudiano verso questa valenza di fondo del suo pensiero che pone la psicoanalisi radicalmente al di fuori, al di là delle stesse preferenze e autocomprensioni del suo creatore, del paradigma positivista entrocui si è storicamente costituita.
17
Fisica speculativa dell’anima Nel 1873 lo zoologo Carl Brul legge, durante una conferenza il poema La natura di G.C.Tobler 3
Tra gli ascoltatori vi è un giovane particolarmente attento e ricettivo : è il diciassettenne Sigmund Freud che nelle riflessioni lì contenute sulla forza creativa che domina e costruisce la natura e l’uomo, trova una illuminante indicazione sulla strada da seguire.Animato fin d’ora da un preciso e determinato progetto conoscitivosi iscrive alla Facoltà di Medicina e frequenta, accanto ai corsi di anatomia e fisiologia , anche quelli di filosofia 4, essendo ilsuo interesse quello delle relazioni tra corpo e mente.Ma sia la” scienza del corpo “come quella “dell’anima” 5 si rivelano presto strumenti inadeguati per le grandi aspettative di conoscenza già presenti nel giovane Freud. Sessantacinque anni dopo , nel 1938, Freud inizia a scrivere il suo ultimo testo 6 che , in una significativa e sorprendente coincidenza, si interrompe dopo poche pagine proprio con la rivendicazione di aver prodotto una nuova conoscenza dei “vicendevoli influssi tra corpo e mente” superando così il” vicolocieco” in cui il pensiero filosofico (così come il senso comune dell’”uomo della strada”) si era inevitabilmente venuto a trovare per la sua riduzione dello psichico alla sola dimensione della consapevolezza.Al termine della sua opera Freud ritiene che la psicoanalisi “resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida”7 poiché essa ha voluto e saputo prendere “sul serio” il concetto di inconscio in virtù del quale ha mostrato tutta la complessità delle relazioni tra soma e psiche , concetto che la filosofia ha invece o rifiutato o affrontato attraverso un concezionalismo conoscitivamente sterile. Nella nascita della psicoanalisi convergono dunque tensioni scientifiche e filosoficheche , pur assumendo progressivamente forme e modi di espressione diversi, caratterizzeranno l’intero suo sviluppo. Le finalità
3 OSF, X, p. 77 + SI, p.495 . Poema che fu erroneamente attribuito a Goethe , di cui comunque rifletteva compiutamente il pensiero.4 VOF, I, p.68.5 Così si esprime Freud nell’opera che dà avvio alla psicoanalisi, gli “Studi sull’isteria”.6 OSF, XI, pp.641-644.7 Lettera a W. Fliess del 20 Agosto 1899, OP, p.219.
18
ontologiche che muovono la teoria psicoanalitica non potevano allora non porsi in una relazione conflittuale con la filosofia “vera e propria”.Nel periodo in cui prende corpo l’universo concettuale psicoanalitico sono evidenti tutti i motivi che informano le relazioni tra scienza e filosofia su cui esso si costituisce.Vi possiamo distinguere due fasi : una che va fino al tormentato tentativo di descrivere la qualità della vita psichica attraverso l’analisi fisicalista delle sue determinazioni quantitative (Progetto di una psicologia scientifica), l’altra che trova un punto di arrivonel “sapere filosofico” dell’ultimo capitolo della Interpretazione dei sogni , a sua volta teso a strutturarsi in un universo concettuale sistemico con il tentativo degli scritti metapsicologici del 1914-17.All’interno della prima fase assume un ruolo fondativo l’opera in cui si può concretamente assistere al processo di definizione dello spazio teorico psicoanalitico, gli Studi sull’isteria (1893-95).Abbiamo ricordato i primi entusiasmi del giovane Freud per la filosofia ma, contrariamente a quanto si potrebbe supporre , essendo già in pieno periodo positivista, il suo incontro con essanon avviene nel segno della aderenza alla materialità dei dati di fatto, ma in quello di uno spiritualismo proteso a cogliere in ogni manifestazione vivente un principio animico che pervade ed alimenta la totalità cosmica. La Naturphilosophie (Filosofia della natura) è una tarda espressione del romanticismo tedesco che fa riferimento all’opera di Friedrich Wilhelm von Schelling (1775-1854). Tra i suoi aderenti ci sono sia scienziati che filosofi, essendo suo principio fondamentale proprio l’unità di materia e spirito nella natura.Freud evidentemente vi trova ciò che cercava , cioè il tentativo di comprendere unitariamente le interrelazioni tra mondo fisico e mondo spirituale (o psichico).Ricordiamo schematicamente i principi fondamentali della filosofia della natura:
1) ”La natura è spirito visibile, lo spirito è natura invisibile (Schelling).La natura è un assoluto. Essa è unità indissolubile di materia e spirito.La Naturphilosophie è fondata sull’idea dell’esistenza di un’anima delmondo, di un principio spirituale da cui derivano la materia, l’uomo e la natura vivente.
19
Nella variabilità del mondo fisico agiscono, secondo vari livelli di perfezione, le stesse identiche leggi . Esse possono essere conseguentemente colte in ogni manifestazione vivente . L’analogia, strumento conoscitivo cardine nella filosofia romantica, acquista conseguentemente un valore esplicativo fondamentale nella ricerca di ciò che connette ogni manifestazionedella natura alla totalità del vivente.
2) La vita dell’uomo è parte di una totalità cosmica in cui ogni cosa è in profonda interrelazione con ogni altra parte di questa totalità.
3) La totalità cosmica si fonda ed è alimentata da forze opposte, antagoniste e, nello stesso tempo , complementari : maschile e femminile nell’umanità, giorno e notte, forza e materia nella natura, acido e basico nella composizione chimica della materia, veglia e sonno nella fisiologia del corpo umano ecc.. Lo spirito nella natura agisce attraverso una serie di polarità in reciproca interazione dinamica.
4) L’inconscio è per i filosofi della natura qualcosa di reale e fondamentale per l’essere umano . Attraverso di esso l’uomo è legato alla natura essendo il vero terreno su cui si radica lo spirito vitale universale.
Senza enucleare altri principi della filosofia della natura che, in modo più o meno diretto , ci potrebbero sorprendentemente ricondurre , come quelli sopra citati , ai concetti fondamentali della psicoanalisi 8, ciò che occorre qui evidenziare è come Freud , dopo i primi entusiasmi per questo tentativo di cogliere, attraverso il movimento delle sue polarità contrapposte , il processo teleologico del cosmo, muta radicalmente prospettiva per assumere un punto di vista diametralmente opposto.Abbandonati i corsi di filosofia, che frequentava parallelamente aquelli di medicina, accetta in modo incondizionato i principi e i metodi del positivismo, lasciando così cadere le grandi prospettive filosofiche rivolte alla riunificazione di spirito e materia. Ora Freud crede di aver trovato la propria strada nel
8 Come ha mostrato il grande storico della psicologia e della psicoanalisi , H. F. Ellenberger in La scoperta dell’inconscio, Torino, Boringhieri, 1976, 2 voll. , pp. 238-246.
20
metodico impegno in ricerche istologiche su fenomeni naturali circoscritti.Questo tipo di attività, svolta presso l’Istituto di Fisiologia diE.Brucke, è un’esperienza estremamente formativa per il futuro fondatore della psicoanalisi.Qui Freud viene in contatto con un esteso movimento scientifico, noto come “Scuola di Helmholtz”, fondato su una concezione meccanicistico-quantitativa a partire dalla quale si vuole rendereconto delle dinamiche qualitative dei fenomeni.In tale contesto Freud elabora una teoria complessiva sull’anatomia del cervello che lo impegna assiduamente per due anni(1887-1888) e che si qualifica, nell’adesione alla più rigorosa ortodossia positivista tesa a superare ogni vana speculazione metafisica, come un primo tentativo di produrre una conoscenza scientifica della mente umana. Nel rovesciamento tra spirito e materia, cioè nella definizione di una prospettiva in cui è lo spirito o, in altri termini , la qualità, ad essere compresa a partire da categorie quantitative, Freud cerca di emanciparsi dalla ineffettuale speculazione filosofica. E’ però evidente che questo tentativo rimane all’interno di una prospettiva filosofica quale è quella che si esprimeva nella filosofia della natura della Scuola di Helmholtz ,di cui ovviamente faceva parte anche E. Brucke. Come tarda propaggine della filosofia romantica la Mitologia del cervello (Hirnmythologie) è la denominazione di questa versione medico-scientifica delle cosmogonie romantiche che può essere consideratacome una sorta di fisica speculativa dell’anima, rivolta alla comprensione delle forze materiali operanti nell’organismo, forze a cui sono riconducibili tutte le manifestazioni ‘qualitative’ della soggettività ( funzioni intellettuali , giudizi morali, sentimenti , creazione artistica , ecc.). Conseguentemente a tale principio generale i seguaci di questa scuola di pensiero ‘filosofico-scientifica’ si adoperavano nei piùdisparati campi; ad esempio l’attività di Brucke spaziava dalla ricerca istologica alla critica della poesia ed arte tedesca e ciò senza soluzione di continuità per quanto riguarda il metodo dianalisi.In tutti i casi si faceva infatti rigorosamente uso di categorie meccanicistico-quantitative rivolte a dare spiegazione, attraversoun implacabile processo riduzionistico, sia dei fenomeni fisici che di quelli psichici , processi creativi ed ispirazioni poeticheinclusi .
21
Sulla base di un metodico riduzionismo fisiologico, si procedeva poi ad una ulteriore oggettivazione fisico-chimica, a sua volta, matematicamente esprimibile.La vertigine di questo sguardo che, nella più errabonda ed immaginativa speculazione, era rivolto alla quantificazione del tutto, caratterizzava anche il “grande Fechner” : così infatti Freud considerava il fondatore della moderna psicologia sperimentale, altra figura emblematica dello scenario teorico entro cui avviene la sua formazione.La principale ragione dell’interesse di Freud per Gustav Theodor Fechner (1801-1887) risiede nel suo oggetto di studio : le relazioni tra mondo fisico e psichico.La stessa carriera accademica di Fechner rivela il tentativo di pervenire ad una conoscenza unitaria di queste relazioni : dalla cattedra di fisica passa a quella di filosofia senza che ci sia unmutamento nei suoi interessi e nei suoi metodi di analisi. E’ sufficiente scorrere solo i titoli delle sue opere per comprendereil carattere metafisico-poetico e, nello stesso tempo, meccanicistico-quantitativo della sua concezione del mondo spirituale e materiale.Nella Anatomia comparata degli angeli (1825) si tenta , sulla base di unaanalisi evoluzionistica, a partire dalle forme di vita primordialiche coprono il processo che va dall’ameba all’uomo, di svelare la conformazione fisica degli angeli. Questo tentativo ha successo; nel testo viene rivelato che essi sono sferici , che comunicano tra loro attraverso segnali luminosi ed inoltre che percepiscono la forza di gravitazione universale dei corpi, così come gli uomini percepiscono la luce.Nel Manualetto della vita dopo la morte ( 1836) Fechner svela ai suoi contemporanei, nonché ai posteri, che dopo la morte l’uomo raggiunge uno stato di completa veglia mentre prima egli era in una condizione che oscillava tra sonno e veglia. Successivamente, dopo un periodo di malattia dovuto agli esperimenti sui fenomeni visivi compiuti sulla propria persona , Fechner , passato nel frattempo all’insegnamento della filosofia da quello di fisica, approda ad una summa della Naturphilosophie (Zend-Avesta,1851) dove elabora , in virtù di un’idea vitalistica dell’ambiente fisico, cosmogonie mistico-fantastiche sulla stabilità e ripetizione dei movimenti dei corpi celesti.Ora , anche se è facile oggi ironizzare su queste opere, alimentate da una fervida fantasia creatrice di mondi popolati da angeli sferici e piante che vivono psichicamente (Nanna - 1845), va comunque ricordato come proprio attraverso di esse Fechner
22
introduce le prime formulazioni concettuali dei principi psico-fisici, che verranno sistematizzati successivamente (Elementi di Psicofisica, 1860) per porsi poi come base della moderna psicologia fisiologica, che quindi trova così la sua origine in una tarda espressione della filosofia romantica protesa ad elaborare, forse anche ispirata dal parallelismo psico-fisico di Spinoza, ardite concezioni sulle “cose del cielo e dell’aldilà”.La legge psico-fisica, che è il principio su cui si fonda l’opera ‘scientifica’ di Fechner, è frutto di una improvvisa illuminazionemetafisico-poetica; dopo questo puro momento intuitivo, viene immediatamente sottoposta a continue verifiche sperimentali per essere tradotta in termini quantitativo-meccanicistici. Da queste è possibile ricavare conoscenze quantificabili intorno alle relazioni tra la dimensione psichica e quella fisica che trovano espressione, a loro volta , attraverso formule matematiche. Così avviene con la legge più importante formulata da Fechner (psico-fisica) sulla base delle ricerche di Ernst Weber (1795-1878) , fisiologo tedesco che aveva , all’inizio dell’800 , stabilito comela percezione della variazione di uno stimolo sensoriale avviene in base alla relazione tra l’intensità di due stimoli e non alla loro differenza. Illustrando in termini schematici la legge psico-fisica si può ricorrere a questo esempio: percepiamo una intensità di luce 8, per apprezzare una differenza di intensità della luce occorrono 2 unità ; partendo invece da una intensità iniziale 16 , volendo percepire una differenza di intensità della luce , di unità ne occorrono 4 ; se poi l’intensità iniziale fosse di 36 allora una variazione di luce sarebbe percepibile solo in rapporto ad un aumento di 8 unità. Ciò comporta che c’è una costante nella relazione tra la quantità del cambiamento ( cioè delle unità-luce) e l’intensità originaria di luce percepita (2/8, 4/16, 8/36 ). Tale legge può allora così essere espressa :
D I K I dove ^ I = quantità di variazione necessaria nell’intensità dellostimolo I = intensità dello stimolo K = costanteFechner, diversi anni dopo, in base all’idea della costante della legge di Weber adotta la soglia differenziale come unità di misuradella sensazione. Gli stimoli sensoriali sono cioè considerati
23
nella loro relazione e non nei termini della loro grandezza fisicaassoluta. Con ciò si può stabilire che c’è una diretta proporzionalità tra il valore di una sensazione S e il logaritmo naturale del valore dello stimolo R.Definendo ^R la soglia differenziale (cioè la più piccola variazione percepibile) possiamo stabilire una correlazione identica con la sensazione ^S. Per questo motivo le unità di misura soggettive di intensità sonora e luminosa adottano scale logaritmiche e non lineari. S = Klog IRicorriamo anche qui ad un semplice esempio : ascoltando una sinfonia, l’ingresso di due violini in una frase musicale è notevolmente meno percepibile dell’incremento sonoro che gli stessi violini apportano nell’ascolto di un quintetto per archi.Ma, al di là della legge di Weber-Fechner ( così è infatti nota) quello che interessa a noi sottolineare è come Fechner perviene alla sua formulazione perché, poste le necessarie distinzioni, anche Freud procede in questa coesistenza di scienza e libera speculazione. Si può quindi pensare a tale contesto come ad un imprinting teorico della psicoanalisi, la cui “ragion d’essere”, per uno dei suoi più significativi interpreti, Paul Ricoeur, è proprioquesta rivoluzionaria coesistenza tra una energetica ( il momento scientifico-quantitativo ) e una ermeneutica ( il momento interpretativo-qualitativo ) che la psicoanalisi mostra sin dai suoi ambiti di referenza originari. Infatti, pur se ad unostadio ‘primitivo’, da una parte troviamo un approccio fisiologico-quantitativo allo studio del cervello, definito su base scientifico- sperimentale, dall’altra, una linea parallela dianatomofisiologia cerebrale speculativa, che nell’ultima parte delsecolo fu chiamata Hirnmythologie (Mitologia del cervello) e che è da ricondurre, in via più o meno diretta, alla Filosofia della natura. Anche se ciò può sembrare abbastanza sorprendente, sono gli stessi uomini che avevano aperto la via all’anatomofisiologia scientifica del cervello che si abbandonarono poi a una sua considerazione mitologica, pur considerandosi dei “positivisti” e disprezzando la filosofia della natura.Il percorso che conduce Freud agli Studi sull’isteria , opera in cui assistiamo ‘concretamente’ , passo dopo passo, alla nascita della psicoanalisi , è, da una parte, contrassegnato da questa libera speculazione , alimentata da imprevedibili flussi conoscitivi ed improvvise illuminazioni, dall’altra, da una rigorosa ricerca nel campo dell’istologia e della neurologia, condotta con la più
24
scrupolosa osservanza della disciplina dell’attività di laboratorio. Tuttavia, nonostante sia possibile mostrare come specialmente la metapsicologia di Freud contenga alcuni concetti formulati da Fechner ( il concetto di energia mentale, i principi di ripetizione, di costanza , di piacere-dispiacere , la ripartizione topica della mente ) e nonostante che entrambi siano rivolti a rendere conto delle relazioni corpo-mente, alternando libere speculazioni a metodi scientifici , non si può certamente dire che Freud ripercorre le orme di Fechner e dei positivisti-filosofi, essendo gli esiti della loro ricerca radicalmente diversi. Fechner rimane infatti sostanzialmente legato ad una ‘spiegazione’quantitativa della vita psichica: la ”legge psicofisica fondamentale” , che dal suo scopritore è autocompresa come avente carattere universale al pari di quella di Newton sulla gravitazione universale dei corpi, riguarda l’intensità soggettivadi una sensazione in rapporto al logaritmo della grandezza fisica del suo stimolo. Le grandi visioni alimentate da una fantasia creatrice di cosmogonie vitalistiche e spiritualistiche conducono poi Fechner adiventare il padre della moderna psicologia sperimentale , di una scienza cioè che assume una prospettiva fisiologica nell’indagine delle costanti relative ai rapporti fra le entità misurabili del mondo fisico e la loro riproduzione psichica. L’originario tentativo di Freud, mosso dalla diretta influenza da parte di Fechner, nel complessivo contesto storico-culturale positivista, di dare una spiegazione quantitativa ai fenomeni psichici, finisce per porre in essere qualcosa che trova la sua identità teorica e metodologica proprio nel superamento di tale approccio.E’ proprio il fallimento del tentativo di dare una spiegazione esclusivamente quantitativa e causalistico-meccanicistica alle dinamiche corpo-mente che ha definito il terreno su cui ha potuto prendere avvio la psicoanalisi.Come cercheremo di mostrare nella lettura degli Studi sull’isteria essa infatti trova la definizione del proprio spazio teorico grazie alprogressivo superamento dell’approccio che vuole comprendere l’enigma delle relazioni corpo-mente in termini di un meccanismo isterico.La rivoluzione psicoanalitica consisterebbe dunque proprio nelle modalità attraverso cui questo spazio teorico di fatto viene percorso, anche al di là delle stesse intenzioni di Freud originariamente fondate
25
sulla contrapposizione tra spiegazione quantitativa e qualitativa della vita psichica. La psicoanalisi riformula in modo radicalmente innovativo questa alternativa che , nello specifico contesto della psichiatria ottocentesca , si presentava nella classica contrapposizione tra isostenitori dell’origine organica o psichica dei disturbi e delle malattie mentali. Gli Studi sull’isteria, pur rimanendo all’interno della concezione consolidata del dualismo corpo-mente, rappresentano l’opera in cuiviene cercata una definizione di tale alternativa in termini diversi, cioè in termini che non risolvono il dilemma a favore dell’una o dell’altra ipotesi ma che la configurano all’interno diun quadro teorico diverso da quello positivista.E questo è stato possibile soprattutto perché a Freud non interessava direttamente il problema intrinseco relativo alle cause dell’isteria , che , posto come tale , induceva ad una opzione per una delle due posizioni. Freud affronta il problema dell’isterismo e , in generale, della psicopatologia perché “ soltanto quando si studia il patologico s’impara a conoscere il normale”9.Lo specifico interesse verso questo tipo di patologia lo possiamo iscrivere all’interno del progetto conoscitivo che, convergendo intorno alle relazioni tra mente e corpo, è rivolto alla comprensione dell’“intera attività mentale” e dei “grandi segreti della natura”. Gli Studi possono allora essere considerati come un primo e fondamentale momento di un tortuoso percorso che condurrà Freud verso il suo “primo obiettivo, la filosofia”.10
Essi si pongono quindi come prolegomeni alla fondazione di una ontologia della soggettività.
La definizione dello spazio teorico psicoanalitico: gli Studi sull’isteria
9 OSF, I,p. 29610 Così Freud si esprime nelle sue lettere a W.Fliess
26
“E’ costata una lunga battaglia con il mio socio... “.11 Così rivela Freud al medico berlinese Fliess all’indomani della stesuradell’unica breve parte degli Studi scritta in collaborazione con Josef Breuer ( è significativo che le altre sezioni del libro siano firmate separatamente).Il testo in cui viene definito il luogo teorico della psicoanalisimuove quindi da un conflitto che vede Breuer procedere, totalmenteimmerso nel paradigma positivista, verso l’analisi del “meccanismo” psichico dei fenomeni isterici , mentre Freud sta ormai orientandosi , pur nella residua e ‘formale’ accettazione di tale paradigma, verso un suo deciso superamento, essendo già all’interno di una nuova prospettiva conoscitiva intorno alle relazioni tra corpo e mente.Uno scritto di poco precedente (La concezione delle afasie, 1891), mostracome il complesso tematico delle relazioni soma/psiche trova una sua prima enucleazione originale configurandosi all’interno di nuove prospettive teoriche.Per Ernst Jones , biografo di Freud e storico della psicoanalisi, questo lavoro “rappresenta il primo autentico spiraglio sul Freud degli anni seguenti” poiché costituisce “uno stadio della sua emancipazione dagli aspetti più meccanicistici della scuola di Helmohltz”.12
Lo stesso Freud vi si riferisce in termini estremamente positivi (più tardi ne sottolineerà l’intento “critico-speculativo”) distinguendolo nettamente dalle ricerche di natura clinico-fisiologica che nel frattempo portava avanti.Jones aggiunge che “ si può ben comprendere l’interesse particolare di cui Freud lo circondava(...) poiché il linguaggio èl’unica funzione che possa far intravedere un legame tra mente e cervello” . Gli altri scritti di questo periodo si inscrivono in questa linea evolutiva che trova negli Studi sull’isteria (1892-95) un primo importante punto di arrivo.In sintesi, prima di accingerci alla lettura degli Studi, si può dire che Freud, sullo sfondo di un contesto storico-culturale chesi caratterizza per una singolare configurazione di positivismo e filosofia della natura, è, fin dalle origini, mosso da aspirazionifilosofiche più volte dichiarate negli epistolari e comunque rilevabili direttamente nei suoi stessi primi scritti.Tali aspirazioni, che abbiamo visto lo conducono a frequentare le lezioni di Brentano, sembrano poi ridimensionarsi in favore di una
11 LF,p.5512 VOF, I, p.236? OSF, X, p.86
27
assidua attività di laboratorio dominata dagli imperativi positivistici della aderenza ai dati di fatto osservabili, misurabili e, soprattutto, quantificabili.Ma il complesso tematico delle relazioni soma/psiche, che costituisce, fin da Platone ed Aristotele, uno dei problemi classici della filosofia, travalica da ogni parte i confini che Freud si era dato , come si può ricavare dalle sue stesse parole, anche nell’intento di evitare il rischio di disperdersi negli sconfinati , incerti ed impervi territori della speculazione filosofica.Il “desiderio filosofico” di Freud cerca dunque di circoscriversi in una rigorosa autodisciplina scientifica per trovare un modo di espressione che si ponga al di fuori ed al riparo dalla tradizionespeculativo-metafisica, anche se con questo non intende certamenteridimensionare quelle finalità di fondo che a pieno titolo possonodefinirsi ontologiche . Si può anzi dire che il progetto conoscitivo degli Studi è finalizzato a dare corpo ad un sapere della totalità che riesca a colmare lo spazio vuoto che la filosofia (come “scienza della mente”) e la medicina (“come scienza del corpo”) creano in quanto saperi parziali e perciò conoscitivamente sterili per ciò che riguarda il loro “rapporto di interazione”. 13
Il complesso tematico dell’opera da cui prende corpo questo sapereè proprio la dinamica di questa interazione che nell’isteria è visibile in una forma patologica. Gli Studi sono stati pubblicati in due momenti diversi: la Comunicazione preliminare nel 1892 ed il resto dell’opera nel 1895.Già nella preparazione della pubblicazione del 1892 ( che consta solo di tredici pagine ed è una prima informazione alla comunità scientifica di Vienna sul problema dell’interpretazione dei sintomi isterici) erano emerse differenze di posizione tra Freud eBreuer che avevano iniziato la loro collaborazione nel 1889. Differenze che hanno poi reso impossibile la stesura a quattro mani dell’intera opera, che infatti si articola in testi firmati separatamente.Per capire come si è originata la collaborazione tra i due autoridi queste tredici pagine occorre fare un passo indietro.Josef Breuer è per Freud non solo un amico, prodigo di consigli e di aiuti anche materiali , ma soprattutto, ai suoi occhi, appare come la personificazione di un paradigma teorico e terapeutico. L’occasione che fece incontrare i due fu il famoso caso della signorina Anna O. , giovane affetta da isteria che, tra il 1880 e 13 OSF, I, p.94
28
il1882, fu curata da Breuer attraverso l’ipnosi. Freud si interessò al “caso” all’indomani della sua brusca conclusione da parte di Breuer, al quale, nonostante le sue innovazioni rispetto alla psichiatria ed alla medicina dell’epoca, era sfuggita la reale dinamica, non solo della patologia, ma anche e soprattutto di ciò che il suo stesso intervento aveva attivato nella vita psichica ed affettiva della paziente .Breuer si era trovato di fronte ad un processo psico-affettivo checostituirà poi uno degli aspetti centrali della psicoanalisi : il tranfert. Si era cioè determinata una dinamica affettiva da “traslazione” tra la signorina Anna O. ed il suo terapeuta che, però, proprio nel momento cruciale della dinamica terapeutica, parte improvvisamente, anche su ‘sollecitazione’ della propria consorte , all’indomani di una rappresentazione isterica del partodella sua paziente, lasciandola così in una condizione nevrotica non risolta.Breuer descrive questo caso a Freud ma omette dei particolari che avrebbero confermato le tesi, che Freud già in questa fase sostiene, dell’importanza che assume la sfera sessuale nella vita psichica.Ma non è solo questo che costituisce motivo di divergenza tra i due studiosi. In realtà Freud intuisce la reale dinamica del caso, ma forse per rispetto a Breuer, o anche perché non ha ancora elaborato concettualmente il ruolo della sessualità nella vita psichica, nonlo pone come motivo di contrasto con il suo collaboratore.Il caso della signorina Anna O. verrà ripreso molti anni più tardida Freud e in quella sede analizzato in tutti i suoi aspetti, anche se sempre nei limiti del racconto fatto da Breuer. Quello che costituisce invece reale motivo di divergenza, al di là delle specifiche modalità di elaborazione dei cinque casi clinici degli Studi, è la diversa tensione teorica con cui essi guardano alle manifestazioni patologiche, la cui dinamica viene cercata da Breuer, nonostante le sue innovazioni, all’interno delle concezioni statico-meccanicistiche della psichiatria e della medicina dell’epoca, mentre Freud s’interroga sulla potenza delle forze e dei conflitti da cui esse scaturiscono secondo modalità ormai orientate verso nuove prospettive di conoscenza.La natura di tale interrogazione, come si è già sottolineato, non è di carattere esclusivamente clinico Nella patologia, in trasparenza, si possono intravedere le strutture permanenti della “normalità”: l’isteria si pone così come una via privilegiata di
29
accesso all’enigma del rapporto di interrelazione tra mente e corpo.Nonostante ciò Freud si muove ancora, giustificandone lui stesso la necessità, sotto l’egemonia del “momento quantitativo”, come mostra il quadro che emerge dalla Comunicazione preliminare, che può essere così schematicamente raffigurato:
a) il ruolo patogeno nell’insorgenza delle manifestazioni isteriche viene attribuito ad uno o più eventi traumatici, come, ad esempio, esperienze di angoscia, vergogna, terrore, o situazioni di conflitto in cui i desideri non trovano possibilità di espressione per la loro incompatibilità sociale e psicologica. Essi possono cioè non essere rappresentabili sia allo sguardo dell’altro che del proprio.
b) tali eventi traumatici, sommandosi tra loro, vengono commisuratialle diverse “capacità di carico” sostenibili dai singoli soggetti. Ciò comporta che ogni individuo, in relazione anche allasua situazione psichica ed emozionale contingente, può sostenere un certo quantitativo di traumi.
c) l’assenza di adeguati comportamenti ( che possono estendersi dal pianto fino all’atto di vendetta) attraverso cui è possibile scaricare tali eccedenze produce uno squilibrio di forze ed una dissociazione che non consente agli “importi d’affetto” connessi agli eventi traumatici di legarsi ad una rappresentazione psichica e quindi di trovare una qualche loro manifestazione.
d) le cariche energetiche non abreagite si accrescono nel tempo e sitrasformano, per compiacenza somatica,14in sintomi fisici (contratture, paralisi, tic, dolori, disturbi della vista ecc.) attraverso un processo di conversione, che, come abbiamo visto, risulta attivato da una dissociazione tra la rappresentazione e l’affetto.Il “corpo estraneo” vagante nell’organismo prodotto dalla conversione rimane efficiente per molto tempo dopo la sua formazione e viene poi generalmente attualizzato da ricordi.Conseguentemente “l’isterico soffrirebbe per lo più di reminiscenze”
14 Per “compiacenza somatica” Freud intende una debolezza pregressa di una partequalsiasi dell’organismo su cui un’ eccedenza d’affetto trova una via più facile di scarico come manifestazione psichica.
30
e) in ogni isteria si produce una più o meno rilevante scissione psichica (stati ipnoidi)
f) l’isteria è una patologia che può manifestarsi sia in soggetti maschili che femminili. 15
L’intervento terapeutico, entro questo quadro, deve in primo luogoindividuare gli eventi traumatici e quindi ridestarli insieme agli“importi di affetto” ad esso corrispondenti al fine di abreagirli nella loro espressione verbale (“cura delle parole” secondo la stessa definizione della signorina Anna O)I concetti decisivi nella spiegazione dell’origine dell’isteria sono dunque “rappresentazione” ed “affetto”. Con il primo Freud intende, a questo livello di elaborazione degli Studi, “ciò che si rappresenta, ciò che forma il contenuto concreto di un atto di pensiero” .Il termine “rappresentazione” viene derivato dalla filosofia classica tedesca e, più direttamente, dalla psicologia herbartianadove si definisce come stato psichico i cui gradi di intensità sono matematicamente quantificabili ( Vorstellungsmechanik ).Ma ciò che si rappresenta , ciò che forma il contenuto concreto diun atto di pensiero, per Freud assume la paradossale attribuzione di una componente della realtà psichica che non è necessariamente intenzionale e cosciente .Il concetto di “rappresentazione” viene dunque usato in un senso che è aderente ad un modello statico-meccanicistico di spiegazionema, nello stesso tempo, è funzionalmente connesso ad una visione della vita psichica in cui si cerca di rendere conto, da prospettive mai prima di ora tentate, delle dinamiche tra le componenti consce ed inconsce. E’ qui che allora possiamo assistere alle prime concettualizzazioni dell’inconscio. La dissociazione tra la rappresentazione e l’affetto è dovuta ad una specifica configurazione delle relazioni soma/psiche in cui agisce come motivo centrale un processo che non può interamente essere fatto rientrare nel campo attuale della coscienza.Naturalmente il concetto di inconscio trova negli Studi le sue primeformulazioni in termini ancora descrittivi e non topici poiché ciò
15 La psichiatria dell’epoca riteneva l’isteria ( isteria=utero) una patologia solo femminile.
31
sarà possibile solo dopo che Freud troverà una “via regia” di accesso a tale dimensione della psiche con l’Interpretazione dei sogni , dove viene elaborata la differenziazione della mente in “tre luoghi “ (topoi) cioè Inconscio, Preconscio e Coscienza.Con il concetto di “rappresentazione” dunque Freud designa un processo psichico che non trovando adeguato accesso alla coscienzaed alla sua attività di elaborazione, essendosi dissociato dal corrispondente “affetto”, si deposita, come materiale rimosso, nelle tracce mnestiche.Ciò comporta che, pur modificando il suo significato convenzionale, Freud rimane sostanzialmente ancora all’interno della logica della “meccanica della rappresentazione” di Herbarth.Come si vedrà poi in modo più dettagliato, il concetto di rappresentazione, così come d’altra parte avviene per le altre categorie fondamentali della psicoanalisi, subirà una significativa evoluzione all’interno della stessa opera. Anche il concetto di “affetto” viene ripreso dalla psicologia meccanicistica dell’epoca.Freud né opera subito una trasformazione dividendo un suo aspetto “quantitativo” ed uno “qualitativo” : l’”affetto” è visto come espressione qualitativa della quantità di energia pulsionale e delle sue variazioni che vengono designate invece come “importi d’affetto”.E’ allora evidente come Freud stia tentando, pur all’interno dellerigidità del meccanicismo positivista, di conquistare un piano teorico in cui sia possibile tematizzare in modo nuovo la relazione fisico-psichico ed accedere così a ciò che poi verrà definito come l’organizzazione “pluridimensionale e complessa del materiale”.Ma, anche se questi tentativi lo spingono necessariamente fuori dauna prospettiva puramente quantitativa, Freud, che evidentemente avverte il pericolo di una dispersione del suo lavoro in territoria lui ancora sconosciuti, insistentemente ribadisce la sua appartenenza al paradigma scientifico del positivismo. Nonostante ciò, una volta superato il confine epistemologico dato,non è più possibile riassumere l’originaria prospettiva, essendosiormai attivata una nuova esperienza teorica che non può non rimettere in discussione i principi e le modalità teorico-metodologiche del fisicalismo originario. Ora è proprio tale impossibilità a spingere l’analisi freudiana verso un punto di non ritorno.Nel tentativo di dare una spiegazione non organicista delle relazioni corpo-mente e nel contesto dell’analisi dei fenomeni
32
isterici, essa incontra la complessità e la densità dei vissuti esistenziali che ‘irresistibilmente’ la attraggono in una dimensione teorica in cui viene definitivamente smarrito l’approccio iniziale.Più Freud si avvicina all’“organizzazione complessa e pluridimensionale del materiale” ( come egli stesso definirà la dinamica dei processi inconsci) piùvengono irreversibilmente decostruiti gli originari intenti positivistici, anche se il continuo attraversamento delle dimensioni quantitative e qualitative della psiche compiuto negli Studi sull’isteria rimane sostanzialmente ancora all’interno di una logica di tipo meccanicistico.Si può allora dire che la psicoanalisi nasce dallo scarto che si viene a determinare tra il suo insuccesso “scientifico” (impossibile entro i confini dello scientismo positivista) e la permanenza in Freud di grandi aspirazioni filosofiche, che espone il suo pensiero all’attrazione che esercita la dimensione interpretativa nella comprensione della vita psichica. Constatata l’impossibilità di afferrare le relazioni soma/psiche entro la cornice dell’organicismo della psichiatria ottocentesca eanimato, si potrebbe dire ‘pressato’, dal suo imperativo filosofico, Freud si trova in una terra di nessuno dove è costretto a muoversi attraverso “tortuosi itinerari” mai prima percorsi che definiranno, nel loro compiersi, lo spazio teorico della psicoanalisi.Gli Studi sull’isteria, rispetto alle concezioni psichiatriche dell’epoca, che consideravano l’isteria come l’esito di una predisposizione organica attivata da forti eccitamenti, costituiscono dunque un decisivo passo in avanti , nonostante la persistenza del paradigma quantitativo-energetico utilizzato nell’analisi dei percorsi tra i nuclei patogeni e le manifestazioni isteriche.L’’isterica’, che Freud aveva incontrato nell’ospedale parigino della Salpetrière, presso cui si era recato per una borsa di studio, veniva indagata e conseguentemente curata, nonostante alcune innovazioni apportate dallo psichiatra Charcot, direttore dell’istituto di ricovero, ancora attraverso categorie ed approcciinterni alla logica organicistico-quantitativa del positivismo dell’epoca.Anche se è stato raggiunto un punto di vista orientato a cogliere la dinamica di organico e psichico si rimane all’interno della logica rivolta, prioritariamente, alla commisurazione degli “importi d’affetto” rispetto alle capacità di carico del soggetto.
33
Così è possibile pensare alla patologia come ad un corpo estraneo che, una volta individuato e ridestato insieme ad i suoi elementi affettivi, può definitivamente e totalmente essere enucleato e quindi eliminato dalla “cura di parole”.Ma è proprio l’investimento del campo della parola il passaggio decisivo che in modo irreversibile conduce Freud fuori dall’organicismo psichiatrico: il desiderio inconscio viene subitopensato nella sua connessione vincolante con il linguaggio. Nelle prime due grandi opere , gli Studi sull’isteria e l’Interpretazione dei sogni, Freud pone al centro della sua analisi, come afferma Ricoeur, non tanto il desiderio in quanto tale, quanto piuttosto il suo linguaggio: nella prima opera il linguaggio è la specifica dimensione in cui si pongono le relazioni tra dimensione psichica e fisica poiché è nella parola e nel ricordo che viene attivato ilprocesso di conversione, cioè una dinamica che attraversa senza soluzione di continuità componenti psichiche , affettive e fisichedel soggetto.Anche nel suo capolavoro, rivolto sempre ad interrogare le relazioni tra fisico e psichico che muovono l’attività onirica come desiderio fisico di dormire (“il sogno è il custode del sonno”) e come desiderio psichico che tenta soddisfazioni fantasmatico-allucinatorie (il sogno è tentativo di appagamento didesideri rimossi), ci si trova di fronte ad un ‘testo’ il cui contenuto manifesto, per essere compreso, deve essere trasposto, attraverso un’attività interpretativa, in un sottotesto che, a suavolta non costituisce semplicemente quella dimensione fisica che riconduce la psicoanalisi al suo supposto oggetto di studio, cioè il soggetto-natura, perché, come si vedrà meglio in seguito, dopo il lavoro di “trasposizione” compiuto attraverso l’interpretazione, si rimane nell’ordine del linguaggio.Il desiderio, l’inconscio, l’Es, la realtà pulsionale, pur essendoin sé quantità di energia, non possono essere comprese se non all’interno della loro dimensione rappresentativa, cioè iconico-simbolica e linguistica.In questo modo Ricoeur può affermare che la costruzione teorica della psicoanalisi “si iscrive nel grande dibattito contemporaneo sul linguaggio”. 16
Vedremo ora, a partire dalla ricostruzione di un caso clinico, quello della signorina Elisabeth von R., indubbiamente il più importante tra i cinque presentati negli Studi, come gli originari intenti positivisti- cioè oggettivistico-quantitativi della
16 ? Paul Ricoeur, Della interpretazione, Saggio su Freud, Genova, Il Melangolo, 1991,p.15.
34
psichiatria tassonomica ed organicista ottocentesca – investono ladimensione filosofico-qualitativa del linguaggio.
Un caso clinico esemplare
La signorina Elisabeth von R. si presenta al dr. Freud lamentando dolori e contratture in varie parti del corpo, specialmente agli arti inferiori.Non trovando cause organiche dei disturbi, Freud verifica, da una serie di “indizi”, che questi sono soltanto un” fenomeno accessorio” di una patologia di diversa natura, cioè di un conflitto di ordine psichico. La diagnosi è allora quella di isteria.A questo punto occorre “trovare la connessione tra la storia del male e il male stesso”, adottando “un procedimento di svuotamento strato per strato” come nella “tecnica del dissotterrare una cittàsepolta”.Ed è subito un problema tecnico che Freud si trova ad affrontare per poter accedere al nucleo patogeno e ricostruire i percorsi tra la dimensione psichica e quella somatica.Non essendo praticabile l’ipnosi con la sua paziente, al fine di provocare uno stato di coscienza modificata che lasciasse passare ricordi ed associazioni bloccati nello stato normale, Freud, ricordandosi di un caso trattato da Bernheim, uno psichiatra in quel periodo molto conosciuto, esercita una leggera pressione sulla testa della sua paziente per far scaturire “ ciò che si fosse presentato alla mente o le avesse traversato la memoria nel momento della pressione”.E’ un momento tra i più importanti nella storia della psicoanalisipoiché questo “espediente” tecnico (poi attuato senza alcun contatto fisico tra analista e paziente) diventerà la regola fondamentale del trattamento analitico .Pensieri, immagini, ricordi, sensazioni, ecc. senza alcuna resistenza o censura devonoessere comunicati all’analista che fonda la sua attività interpretativa prevalentemente su questo “materiale”.La prima applicazione, si potrebbe dire quasi casuale, della regola fondamentale della psicoanalisi ottiene immediatamente risultati utili . Da ciò-che-viene-in-mente ad Elisabeth, sollecitata in questo modo da Freud, emergono le prime tracce che rendono possibile operare ricostruzioni parziali degli eventi passati da cui è scaturito il nucleo patogeno.
35
Si delinea così un conflitto tra il dovere dell’assistenza al padre malato ed il desiderio della compagnia di un giovane. E’ quievidente lo sforzo di Freud di disegnare una mappa, a partire proprio da un input di tipo fisico (la pressione sulla testa) dei percorsi tra la corporeità desiderante e i processi psichici (anche se non è ancora stato tematizzato il ruolo della sessualitànella vita psichica né ,conseguentemente, il complesso edipico)Attraverso una serie di tentativi, sia di natura interpretativa che tecnica, Freud procede cercando di connettere gli eventi traumatici, i ricordi di questi e la manifestazione isterica con uno sguardo minuzioso e metodico che ricorda il giovane ricercatore di istologia al microscopio.La posta in gioco è la verità di un brano di esistenza. Verità deldesiderio e dei modi, dei tempi e dei luoghi attraverso cui esso, rappresentato come incompatibile, si è dissociato dal suo “importod’affetto” attivando così il conseguente processo di conversione.Dissotterrare la città sepolta deve condurre quindi ad un sapere “oggettivo”: ad un certo punto dell’analisi Freud arriva a determinare la dinamica spazio-temporale del processo che attraversa il corpo e lo fa parlare con il linguaggio delle sue contratture e del dolore. Il processo di conversione si attua con geometrica potenza: i dolori alla gamba sinistra rimandano ad un gruppo di eventi traumatici, mentre quelli alla gamba destra ad un’altra fase dellatormentata vita della giovane.Dopo aver connesso ogni gruppo di sintomi al proprio nucleo patogeno Freud procede implacabilmente all’esatta determinazione del luogo e del tempo in cui è avvenuta la trasformazione del conflitto psichico in manifestazione somatica.Tutto trova così soluzione: i motivi della dissociazione tra rappresentazione ed affetto, i percorsi degli “importi d’affetto” che vagano alla deriva nel corpo della giovane ammalata, i luoghi ed i tempi del processo di conversione, le zone corporee interessate che manifestano in forma “rovesciata” i conflitti di ordine psichico. Il modello causalistico, nella sua forma più rigorosa e compiuta, costituisce così il terreno di formazione delle prime concettualizzazioni psicoanalitiche.Tutta l’analisi di questo caso clinico converge verso una spiegazionedella “meccanica” del processo di conversione: Freud troverà puntualmente e, si potrebbe dire, immancabilmente, il motivo di tutte le patologie fisiche di Elisabeth.
36
C’è un certo numero di eventi traumatici che si sommano fino a superare la tolleranza della portata di carico individuale; in questo modo gli importi d’affetto ad essa collegati si dissociano dalla loro rappresentazione e, invece di essere usurati dal tempo,si accrescono fino a sconfinare nella corporeità dove, per compiacenza somatica, trovano un luogo in cui installarsi e qui finalmente agire. Rispetto al quadro teorico della Comunicazione preliminare l’analisi del caso di Elisabeth non apporta innovazioni di particolare rilevanza teorica; esso costituisce anzi un’esemplare applicazionedelle concezioni ancorate all’analisi quantitativa.Nonostante ciò, quasi ad ogni pagina, è verificabile la progressiva formazione dello spazio teorico della psicoanalisi piùnella densità delle cose che non sono chiaramente espresse che nelcristallino procedimento che condurrà Freud alla risoluzione totale e definitiva del caso, sia dal punto di vista della sua ricostruzione storica che da quello della guarigione clinica.Lo stato nascente della psicoanalisi si configura allora in un singolare contesto che vede Freud procedere, nell’imperativo di aderire ai ‘paradigmi’ dati , verso una prospettiva che pone in essere una nuova dimensione di pensiero destinata a costituire una‘rivoluzionaria’ violazione dei confini epistemologici che tali paradigmi contengono.In altri termini : il positivismo ed il meccanicismo del Freud degli Studi nasconde un movimento di pensiero che cerca spazio ed affermazione in una nuova visione della dinamica soma/psiche in cui è condensata la matrice della psicoanalisi.Innanzitutto, come già rilevato, il caso della signorina Elisabethcontiene la “regola fondamentale”che struttura la relazione analitica. Ciò che è interessante notare è come essa trova origine; è infatti per una concreta necessità che questa tecnica viene sperimentata da Freud , essendo la paziente non trattabile attraverso il consueto procedimento dell’ipnosi. Una caratteristica peculiare ed innovativa della psicoanalisi che allora emerge rispetto alle altre teorizzazioni è che essa procedecome in un meccanismo ad incastro con la sua “prassi”, la cui dimensione “tecnica” contiene la capacità di innestare avanzamentidecisivi nella teoria. In questo modo la “verità” che riguarda un ‘vissuto’ deve essere prodotta attraverso un “lavoro” di analisi di ciò-che-viene-in-mente (Einfall = idea improvvisa) che non conduce però direttamente al nucleo patogeno come punto terminale di una catena associativa inconscia ma attraversa intricati percorsi tra reticoli di linee
37
(Linie), fili (Faden), concatenamenti (Verkettung), sfilate (Zug) le cui intersezioni formano punti nodali (Knotenpunkte).Il “lavoro analitico” consiste allora in un’attività di ri-costruzione che propone possibili verità sulle dinamiche psico-fisiche avvenute.L’ambito di verificazione di queste ri-costruzioni, rese possibilidal materiale prodotto dalle ‘associazioni libere’, non è però quello in cui possono essere applicati i criteri di evidenza tradizionali , ma piuttosto è ciò che esse riescono ad attivare nel soggetto analizzato che costituisce il loro vero parametro di valutazione.Quando ad Elisabeth viene comunicata la verità del suo desiderio, il grido che lancia e la decisa negazione di questa verità costituiscono per Freud altro materiale da sottoporre al lavoro analitico poiché non è ciò che dice l’analizzato che può essere assunto come criterio di verità , sia nella conferma che nella negazione delle ricostruzioni portate a termine.Sono i ‘fatti’ del suo comportamento successivo che costituiscono l’ambito di verificazione di tali costruzioni e , soprattutto, è l’attivazione di materiale ulteriore che queste inducono nel paziente a porsi come l’experimentum crucis che rende ‘visibile’ l’incidenza dell’intervento analitico.Nel caso di Elisabeth , dopo aver individuato il punto dove scavare, tornando alla metafora archeologica, Freud tenta le primericostruzioni la cui veridicità induce una progressiva accelerazione nell’affioramento di nuovo materiale e consente, sulpiano terapeutico, un “venir meno di una certa quantità di dolore”.Quello che inizia a prendere forma è allora un concetto di verità che si pone al di fuori delle prospettive entro cui esso è tradizionalmente pensato, poiché nella psicoanalisi la verità si definisce essenzialmente in relazione al tempo ed alla pluridimensionalità della dimensione psichica della realtà. Nel caso clinico di Elisabeth sono già presenti questi due aspetti: gli eventi traumatici attivano il processo di conversione nella dimensione psichica del loro ricordo ed in un tempo diverso da quello in cui hanno avuto origine. Elisabeth, seduta su un sedile di pietra , in uno stato di nostalgia e ricordo, confessa a se stessa per la prima volta il suo desiderio, cioè l’amore verso il cognato; tornata da questo luogo, avverte i primi forti dolori alle gambe e trova difficoltà anche a stare seduta.
38
Così nell’altra scena le contratture ed i dolori nella posizione eretta sono connessi al momento in cui, in piedi, davanti alla porta della stanza dove giaceva nel letto di morte la sorella, “sfreccia attraverso il cervello di Elisabeth un altro pensiero, che ora si ripresentava inevitabilmente, come un lampo nell’oscurità: adesso egli è nuovamente libero ed io posso diventare sua moglie”. La realtà psichica è dunque una dimensione in cui il soggetto esperisce eventi e dinamiche dotati di concretezza, determinazionee effettualità come nella realtà fisica. Questi eventi non si definiscono però secondo i principi dell’evidenza spazio-temporaletradizionale poiché, nella realtà psichica, tutto assume una qualificazione diversa, irriducibile a qualsiasi possibilità di misurazione oggettiva ed indifferenziata.Per il giovane scienziato Freud, che pubblica studi neurologici sui processi cerebrali e risultati di ricerche di fisiologia, accedere a questa dimensione della realtà, a queste storie cliniche che “si leggono come novelle” e che però rimandano ad unadimensione profonda che sfugge alla presa delle categorie della ragione scientifica e filosofica occidentale, costituisce motivo di sconcerto. “ Non sono sempre stato psicoterapeuta, e ho fatto la mia esperienza medica con le diagnosi locali e con l’elettro- prognosi, al modo stesso di altri neuropatologi, così che sento ancora io stesso un’impressione curiosa per il fatto che le storieche scrivo si leggono come novelle e che esse sono, per così dire,prive dell’impronta rigorosa della scientificità. Devo consolarmi pensando che di questo risultato si deve evidentemente rendere responsabile più la natura dell’oggetto che non le mie preferenze.” 17
Lo sconcerto di Freud
17 OSF, I, p.313
39
Il percorso di Freud verso la “scienza dell’anima nuova”, cioè il tentativo di elaborare un’ontologia della soggettività, non solo ècostellato da una continua riformulazione di concetti e prospettive, particolarmente visibili nell’opera di cui ci stiamo occupando, ma anche da momenti di sincera sorpresa verso la complessità e pluridimensionalità dei vissuti che lo inducono a ricordare a se stesso la sua appartenenza al mondo ‘scientifico’. In altri termini Freud è in una terra di nessuno dove non è più possibile ricorrere ai tradizionali meccanismi di identificazione ‘scientifica’ della propria attività teorica e di ricerca; il suo sconcerto nasce dalla consapevolezza di aver superato un ‘paradigma’ senza che questo lo abbia condotto verso un altro luogo teorico chiaramente definito nell’oggetto e nel metodo.E’ questo un passaggio veramente decisivo nell’evoluzione dell’opera di Freud: la ‘fisica speculativa dell’anima’ incontra il proprio invalicabile confine ed ora si deve procedere senza punti di riferimento certi. Il neuropatologo, armato della logica di laboratorio e dei suoi strumenti ( l’elettroprognosi....), rimane stupito di fronte all’”organizzazione pluridimensionale e complessa” della realtà psichica.Questo stupore costituisce un’esperienza determinante, si potrebbedire un ‘imprinting teorico’, poiché qui si può cogliere il momento iniziale in cui prendono forma due tendenze che , in modo contraddittorio o apparentemente tale (secondo le diverse possibili prospettive di interpretazione), segneranno l’intero sviluppo della psicoanalisi.Da una parte infatti la psicoanalisi si è autocompresa in termini di un processo conoscitivo rivolto in primo luogo a riflettere criticamente su se stesso, dall’altra in essa è presente una tensione costante a costituirsi come una scienza naturale che procede accumulando acquisizioni non più sottoponibili ad una revisione profonda e che si pongono come elementi fondanti un’ontologia della soggettività e dei suoi vissuti. Il sapere è dunque capitale accumulato attraverso un procedimento aperto a continue riformulazioni.In altri termini: il processo conoscitivo aperto e metodicamente problematico verso sé stesso è rivolto a cogliere in modo irrevocabile le strutture invarianti della soggettività e dell’intersoggettività .Ma il movimento dell’autoriflessione è conciliabile con la rivendicazione di appartenenza alle scienze naturali?
40
Per Freud la risposta è affermativa perché, contrariamente alla filosofia che racchiude il reale entro il suo rigido universo definitorio e concettuale, la psicoanalisi, come la scienza naturale, avanza attraverso un processo conoscitivo che in primo luogo opera criticamente su se stesso.Essa perciò “non invidierà alla speculazione la sua prerogativa difondarsi su nozioni precise e logicamente inattaccabili “ in quanto “ si accontenterà di buon grado di alcuni e sfuggenti principi di fondo di cui quasi non si riesce a farsi un concetto, sperando che essi si chiariscano strada facendo e ripromettendosi di sostituirli eventualmente con altri.”L’obiettivo conoscitivo di fondo della psicoanalisi, cioè la dinamica delle relazioni tra fisico e psichico, non può però essere perseguito esclusivamente secondo il procedimento scientifico.Fino all’ultima fase della sua attività Freud attenderà una conferma delle sue teorie dalle scoperte della ricerca neurologicae fisiologica che, non ancora disponibili alla sua epoca, lo hannocostretto ad operare solamente sul piano della psico-analisi .Conseguentemente non è possibile configurare in modo totalmente scientifico le acquisizioni psicoanalitiche correlandole all’interno di una comprensione del funzionamento complessivo dell’apparato cerebrale.La psicoanalisi , in questa prospettiva, è un sapere naturalistico‘incompiuto’ non essendo ancora praticabile sia una fondazione cheuna verifica sul piano propriamente neurofisiologico.Lo statuto del suo sapere attende così uno sviluppo scientifico nelle ‘altre’ scienze naturali.Ora, l’origine di questa aspettativa risale fino agli anni della formazione universitaria di Freud ed è proprio negli Studi sull’isteria che si manifesta in modo evidente e, nello stesso tempo raggiunge il suo punto critico, poiché qui la conquista della “scienza dell’anima nuova” si trova di fronte alla improrogabile necessità di allontanarsi dal laboratorio e dalla sua logica.A Freud non rimane altro che ‘esternare’ una nostalgia delle sue origini (“le mie preferenze”) contro la “natura dell’oggetto” che lo costringe, deviando così dalla oggettività del paradigma positivista, a narrare ed a interpretare , come se fossero delle novelle, le storie cliniche di cui si occupa. Si può allora dire che la ‘rivoluzione psicoanalitica’, che per essere tale comporta necessariamente il superamento dei vecchi paradigmi teorico-metodologici, viene pensata da Freud all’internodi un modello di scientificità indubbiamente inadeguato a
41
contenerla, essendo esso basato su un principio di causalità che, nella cultura positivista dell’epoca, si presenta in una delle sueforme estreme e meccanicistiche.Il caso di Elisabeth può allora essere visto come l’ultimo tentativo in cui Freud , in modo forzato, cerca di applicare tale modello, nonostante “la natura dell’oggetto” non lo consenta.Gli Studi sono, però, un work in progress. Nel capitolo finale Freud, prendendo le distanze da Breuer, recepisce “i nuovi punti di vista” che gli si sono “imposti” e muove decisamente verso il luogo teorico proprio della psicoanalisi, pur continuando ad avvertire la necessità di non oltrepassare il confine di una “relazione quantitativa fra causa ed effetto anche in campo psichico.” Innanzitutto Freud solleva il “venerato amico Josef Breuer” (sulla valenza “teorico-personale” della loro relazione si dirà più avanti) dalla responsabilità per le modificazioni che “a titolo personale” apporta nella spiegazione non solo delle manifestazioni isteriche, ma, in una prospettiva più ampia, delle diverse classi di nevrosi, sullo sfondo di un’inevitabile riformulazione di tutto il quadro teorico-terapeutico fin qui seguito.Anche se qui non è certamente possibile ricostruire in tutti i suoi aspetti e particolari l’evoluzione di tale quadro, cercheremocomunque di cogliere gli elementi essenziali del nuovo ordine teorico entro cui ora procede la ricerca di Freud.La ‘scoperta’ della sfera sessuale come una causa determinante delle nevrosi sembra costituire il problema fondamentale che segnail distacco di Freud dal suo collaboratore. Tuttavia non è la questione in sé, che rimanda alla inconciliabilità di diverse Weltanschauungen, che costituisce il reale elemento di dissidio tra idue perché è piuttosto il diverso modo di procedere teoricamente adeterminare un irreversibile allontanamento tra i due studiosi dell’isteria. Infatti, anche se nella riconsiderazione dei casi clinici presentati negli Studi, a partire da quello di Anna O., che avviene unitamente alla verifica dei problemi di efficacia terapeutica del metodo catartico e del suo strumento ipnotico, l’approccio tradizionale quantitativo viene riconfermato (“non si deve tuttavia dimenticare che si tratta sempre, qui, di un confronto quantitativo, della lotta fra i motivi di forza o intensitàdiverse” è proprio in queste pagine che emerge inequivocabilmente un nuovo tipo di sguardo sulla dinamica corpo-mente. Certamente esso si definisce ancora nel contesto della psichiatria e della medicina dell’epoca, continuando così a configurarsi all’interno
42
di un’analisi di tipo quantitativo. Infatti il riconoscimento del ruolo della sessualità nelle nevrosi ancora viene posto in terminidi pura “forza ed intensità”. Ciò consente a Freud di ricondurre “i nuovi punti di vista” nel quadro epistemologicamente rassicurante del meccanicismo positivista.Diventa allora estremamente importante vedere come e su cosa si consuma la rottura con Breuer e con tutto ciò che esso rappresenta.E’ con il concetto di difesa che avviene il superamento da parte di Freud degli aspetti più rigidamente organicisti e statico-meccanicistici delle concezioni psichiatriche tradizionali.Per difesa infatti si intendeva una semplice ritenzione di importidi affetto (dovuta alla impossibilità di una loro abreazione per circostanze esterne non favorevoli); questa concezione era a sua volta fondata nella visione del soggetto come un puro elemento ricettivo di importi d’affetto che , sommandosi, superano la soglia di tolleranza individuale e danno avvio, secondo un principio di causalità meccanica, ad un processo che culminerà nella conversione somatica.E’ dunque proprio a partire da questo concetto, dove la forma logica del paradigma positivista è esemplarmente mostrata, che avviene l’allontanamento di Freud dal suo collaboratore Breuer e dalle sue prospettive teoriche totalmente definite entro tale paradigma. 18
La difesa, così come viene fin d’ora intesa da Freud, non solo assume la qualificazione di un’attività dinamica dell’Io nei confronti del mondo interno e di quello esterno, ma postula anche una differenziazione topica entro cui si dislocano forze che si aggregano intorno a principi costitutivamente in conflitto reciproco.Poiché allora la vita psichica si esprime come sintesi dinamica disistemi operanti secondo principi e funzioni diverse, la difesa vede nell’Io sia ciò che va protetto, sia ciò che muove l’attivitàdi protezione. Anche se non è ancora stata chiaramente tematizzatae concettualmente articolata tale differenziazione dell’apparato psichico è qui evidente un procedimento che la presuppone. Anche se la divisione metaforica della mente in ‘topoi’ , cioè in luoghi18 Contrariamente a ciò che comunemente viene indicato come motivo della rottura tra i due, e cioè il rifiuto da parte di Breuer del riconoscimento del fattore sessuale nell’insorgenza della nevrosi e, in generale, del suo ruolo nella determinazione della vita psichica, qui si sostiene che ciò era dovuto più a ragioni ‘accademico-sociali’ che a motivi di natura teorica. Come rivela Freud aFliess, Breuer, nel privato manifesta accordo completo sulla questione sessuale,mentre in pubblico oscilla tra posizioni contrastanti.
43
che stabiliscono ordini gerarchici e di relazione reciproci , si radica nella psichiatria e medicina dell’epoca, poiché in essa erano acquisiti i principi anatomico-fisiologici delle localizzazioni cerebrali, tuttavia le innovazioni psicologico-funzionali di Freud risultano decisive nel porre la differenziazione su un piano completamente diverso.Infatti l’innovazione che viene apportata fin dagli Studi (ma sostanzialmente contenuta anche in uno scritto del 1891 dedicato al problema dell’afasia) è determinante: i luoghi non sono solo anatomici ma anche mentali e, soprattutto, non sono solo individuati come esistenti, ma anche come sedi con natura e funzioni diverse pensate in interazione conflittuale reciproca.Ed è su questo terreno che avviene la ‘scoperta’ dell’inconscio poiché postulare un conflitto costitutivo tra ‘luoghi’ dell’apparato psichico porterà necessariamente Freud ad una concezione topica , dinamica ed economica dell’intero funzionamento della mente.Nel caso di Elisabeth, pur nell’imperativo di quantificare la realtà psichica, sono evidenti i tentativi di raggiungere questi punti di vista che aprono nuove prospettive di conoscenza sulle strutture invariabili della soggettività.La tripartizione in Inconscio, Preconscio e Coscienza è già diffusamente tematizzata anche se troverà poi la sua prima sistemazione teorica con L’interpretazione dei sogni; la visione dinamica dell’attività della mente è perciò contenuta nella elaborazione del concetto di difesa dove l’Io è , nello stesso tempo, la posta in gioco e la forza agente dell’azione di difesa. Invece gli aspetti economici, cioè relativi agli scambi di energiapsichica tra i diversi “luoghi” della mente, sono quelli che caratterizzano l’iniziale approccio quantitativo. Essi poi troveranno, pur rimanendo tali, una diversa qualificazione in relazione con le altre prospettive dinamiche e topiche.Nella metafora della attività archeologica dello psicoterapeuta possiamo agevolmente cogliere questa pluralità di sguardi sulla vita mentale.“Dissotterrare la città sepolta” attraverso “uno svuotamento strato per strato” infatti comporta innanzitutto pensare alla psiche come a qualcosa che contiene diversi “strati”, ma anche ad un’attività rivolta a proporre ipotesi di ricostruzione (interpretazioni) degli eventi economici e militari che, nel tempo, si sono succeduti in quella città.Cerchiamo allora di vedere come , nella parte finale del testo, ormai consapevole della necessità di un superamento della sua
44
impostazione iniziale, Freud tenta una prima forma di elaborazioneteorica di queste nuove prospettive che sembrano definirsi quasi di per sé, riuscendo progressivamente ad emergere tra gli imperativi della aderenza ai ‘ dati di fatto’ della fisica speculativa dell’anima.
Nuovi punti di vista
I concetti attorno a cui gravitano le esigenze di innovazione sonoprincipalmente quelli di sovradeterminazione e di rappresentazione essendo sia le formulazioni teoriche di principio nella Comunicazione preliminare che la loro applicazione operativa nell’analisi dei cinque casi clinici fondate su questi.Prendiamo in considerazione il primo.Riferendosi direttamente ai casi clinici trattati Freud ricorda come “la disposizione cronologica lineare” del materiale mnestico relativo agli eventi traumatici si deposita in un “archivio tenutoin buon ordine” come se si trattasse di “fascicoli di ricordi”.Partendo dalle “copertine” di tali fascicoli , cioè dalle singole esperienze traumatiche più recenti, è possibile ripercorrere in senso inverso la loro successione cronologica lineare. Fin qui, dunque, non vi è altro che la formulazione del concetto di sovradeterminazione così come era stato teorizzato nella Comunucazione preliminare ed applicato nell’analisi dei casi clinici.Tuttavia, prosegue Freud, “questi temi presentano un secondo tipo di disposizione: essi sono , non saprei esprimermi altrimenti, stratificati concentricamente attorno al nucleo patogeno”.19 Pur modificando l’organizzazione del materiale patogeno (da lineare a concentrico) Freud non abbandona ancora il modello di spiegazione che possiamo definire statico-quantitativo.In questa seconda formulazione del concetto di sovradeterminazioneinfatti si parla di “strati di uguale resistenza, crescenti nella direzione del nucleo; e quindi zone di uguale modificazione della coscienza” dove emerge chiaramente ancora il rapporto tra la quantità della resistenza e i conseguenti mutamenti nella coscienza.
19 OSF, I, p.425
45
La disposizione concentrica del materiale patogeno non è altro quindi una variazione di quella lineare, essendo una variazione diforma e non di sostanza: l’egemonia del “momento quantitativo” nonè ancora posta in discussione.Menzionati questi due aspetti della sovradeterminazione, probabilmente sia per non introdurre eccessive discontinuità nel testo, sia anche per rispetto del suo “venerato amico Breuer” e della normatività epistemologica che egli rappresenta, Freud avanza ora una formulazione del concetto in una prospettiva che può finalmente dirsi psicoanalitica anche se subito si presenta come “difficile”.Secondo questo terzo tipo di disposizione “il più essenziale”, la sovradeterminazione acquista “un carattere dinamico in contrasto con quello morfologico delle due stratificazioni sopra indicate”.Non è più un determinato e determinabile ammontare di eventi traumatici che si sommano o si aggregano circolarmente ma un insieme eterogeneo di elementi che trovano interconnessioni imprevedibili sul piano orizzontale e verticale. Tale concatenamento “dovrebbe essere indicato con una linea a tratti, che passasse per le vie più ingarbugliate dagli strati superficiali a quelli più profondi e viceversa, avanzando tuttaviain genere dalla periferia verso il nucleo, e che dovesse in tal modo toccare tutte le stazioni, allo stesso modo come lo zigzagaredelle mosse del cavallo, nella soluzione di un problema , tagli i riquadri della scacchiera”La linearità nella formazione del nucleo patogeno che avvia il “meccanismo isterico” è ormai un primo elementare approccio di unaricerca che ora è consapevole della pluridimensionalità dell’“organizzazione del materiale patogeno” la cui estensione, profondità e dinamica qualifica in modo totalmente diverso il concetto di sovradeterminazione.La geometrica potenza del processo di innervazione somatica, così puntualmente verificato nel caso della signorina Elisabeth von R. si dissolve nell’intreccio di linee ramificate, di “punti nodali nei quali due o più fili s’incontrano per proseguire uniti”. Conseguentemente non è più possibile pensare ad una formazione e manifestazione ordinata del nucleo patogeno poiché ad esso “fanno capo in genere più fili aventi andamenti indipendenti, oppure collegati in certi punti da tratti laterali”. Tutto ciò può essere ulteriormente complicato poiché non è raro ilcaso “che si abbia più di un unico nucleo nel materiale patogeno”.In questo caso “ci si può allora facilmente immaginare quali
46
strati e percorsi ideativi debbano aggiungersi, per stabilire un collegamento tra i due nuclei patogeni”. Ora, considerato tutto ciò, appare evidente come il concetto di sovradeterminazione acquista nella parte finale del testo un valore fondamentale non solo nell’analisi del fenomeno isterico ma soprattutto nell’evoluzione teorica complessiva della psicoanalisi.Attorno ad esso si coagulano “nuovi punti di vista” che conducono Freud alla riformulazione di concetti precedentemente definiti entro lo sfondo epistemologico in cui prevalgono principi quantitativo-meccanicistici.Tra questi assume una particolare rilevanza , per il ruolo che esso poi avrà nella riflessione metapsicologica, il concetto di rappresentazione.Come si è già in parte rilevato precedentemente, sia nella Comunicazione preliminare che nell’analisi dei casi clinici esso viene usato in un duplice senso: da una parte è aderente ad un modello statico-quantitativo, dall’altra postula una visione topica e dinamica in cui si cerca di rendere conto della interazione coscienza-inconscio.Nella parte finale del testo anche questo concetto assume un diverso significato poiché Freud lo usa in un modo che poi renderàpossibile la distinzione, che verrà pienamente articolata nei testi metapsicologici molti anni più tardi, tra rappresentazione di cosae rappresentazione di parola.Operando così una totale e radicale estrapolazione del concetto dal suo ambito di elaborazione e di referenza tradizionale Freud lo configura all’interno di una nuova cornice teorica. La rappresentazione da un lato è compresa dal punto di vista preconscio-cosciente e si manifesta attraverso il linguaggio, dall’altro è espressione iconica e figurale del sistema inconscio.Ma, anche qui, come era già avvenuto nel caso del concetto di sovradeterminazione, il passaggio da una concezione quantitativa ad una qualitativa si compie per gradi.
“E’ un indizio del successo della difesa il fatto che le rappresentazioni patogene nella loro ricomparsa sembrino così poco importanti. Si può vedervi indicato in che cosa sia consistito il processo di difesa: è consistito nel fare della rappre- sentazione forte una rappresentazione debole”.
47
Dal rapporto quantitativo di forza tra azione difensiva e rappresentazione risulta un indebolimento (cioè una diminuzione) di quest’ultima.Subito dopo però viene operata una distinzione che avanza una discriminazione qualitativa nel processo della rappresentazione.
“Quando un’immagine è emersa nel ricordo, si può sentir dire il paziente che essa va sbriciolandosi e perdendo chiarezza a misura che egli procede nella descrizione. Il paziente per così dire la smonta nel tradurla in parole.” 20
La parte finale del testo contiene dunque una progressione concettuale che, pagina dopo pagina, decostruisce il solido quadroteorico iniziale. Da un uso meccanicistico, anche se convertito entro un approccio già al di là del confine teorico ed epistemologico positivista, il concetto di rappresentazione guadagna gradatamente un piano teorico su cui verranno poi sviluppate le categorie fondative della psicoanalisi attraverso ladistinzione tra processo primario e secondario e tra identità di percezione e di pensiero.Questo dinamismo teorico del testo non poteva non riflettersi anche nella tecnica psicoterapeutica, che costituisce anzi il tema‘ufficiale’ di questa parte finale degli Studi intitolata Psicoterapia dell’isteria.L’evoluzione dei concetti di sovradeterminazione e di rappresentazione fa infatti cadere l’ipotesi terapeutica del corpoestraneo perfettamente enucleabile dalla vita psichica del paziente, ipotesi fondata sulla possibilità di distinzione tra unacondizione normale ed una patologica dell’Io.In realtà, afferma Freud nel capitolo finale del testo, i gruppi psichici patogeni si trovano aggrovigliati “con elementi dell’Io normale e appartengono, propriamente, a quest’ultimo non meno che all’organizzazione patogena”. Viene quindi a mancare ogni possibilità discriminante dell’analisiche si trova di fronte ad una “infiltrazione” già data, dovuta alla compromissione dell’Io avvenuta contestualmente alla sua attività di difesa nei confronti degli eventi traumatici.Conseguentemente , sul piano terapeutico, non si tratta più di “estirpare qualche
20 OSF, I, pp. 416-417
48
cosa” ma di “liquidare la resistenza aprendo così la via alla circolazione in una via anteriormente sbarrata”.La distanza dal quadro teorico-terapeutico della Comunicazione preliminare è evidente; il “meccanismo isterico” e la possibilità di enucleazione totale e definitiva dei “corpi estranei” che attraversano le dimensioni fisiche e psichiche fanno ormai parte di un approccio superato. Ora non è più possibile seguire il procedimento diagnostico e terapeutico medico che aveva guidato fin qui Freud; la ‘differenzaspecifica’ della realtà psichica rispetto a quella fisica lo costringe a deviare dai percorsi oggettivistici e fisicalistici. Lo stato nascente della psicoanalisi è proprio il raggiungimento di questo interrogativo ‘ontologico’ sul soggetto che non può più trovare formulazione entro i principi, la logica ed il linguaggio della fisica speculativa dell’anima.Gli Studi sull’isteria costituiscono dunque un work in progress dove, paginadopo pagina, vengono prima intravisti e poi ‘scoperti’ nuovi orizzonti di pensabilità del soggetto e dei suoi vissuti.Ora, come disporsi di fronte ad essi? Come procedere nei confrontidi un “oggetto” di studio che sembra essere radicalmente altro da quelli che tradizionalmente impegnano l’attività conoscitiva dell’uomo? Abbiamo già sottolineato lo sconcerto di Freud in uno dei passaggi più importanti del testo, quando si sta delineando unorizzonte conoscitivo del tutto nuovo e che appare non trattabile attraverso le categorie concettuali e le metodiche consuete. Ora, alla fine del testo, dove Freud si svincola, o perlomeno, appare temporaneamente libero dal paradigma entro cui fin qui aveva cercato di contenersi, si pone immediatamente un problema.Come parlare di questo nuovo soggetto e della pluridimensinalità ecomplessità che lo contraddistingue?
E’ possibile descrivere l’inconscio ?
Abbiamo visto come all’inizio del testo Freud fa ricorso ad una terminologia eterogenea per designare i processi del “meccanismo” isterico. Il problema del linguaggio si era infatti subito posto già all’inizio dell’analisi dell’isteria, come testimonia una lettera a Breuer del 1892 in cui Freud scrive : “Mi tormenta il problema di come si possa rappresentare, in maniera piana, qualcosa di tanto complesso come la nostra teoria dell’isteria”.21
21 OSF, I, p. 139
49
Ora il problema a cui si trova di fronte il fondatore della psicoanalisi non è circoscritto all’esigenza di dare descrizione espiegazione, come non era mai stato fatto precedentemente, ad un manifestazione psicopatologica particolarmente complessa sia nellagenesi che nella dinamica sintomatologica in cui essa trova espressione. Certamente c’è anche questo problema ma, più strutturalmente, si pone l’esigenza di porre mano alla costruzione di una “ scienza dell’anima nuova” in radicale alternativa alle concezioni della soggettività elaborate nell’ambito della riflessione filosofica. Per poter comprendere le manifestazioni isteriche occorre cioè abbandonare il coscienzialismo della filosofia in favore di una ricerca, ‘scientificamente’ fondata, rivolta alla individuazione ed all’analisi delle dinamiche inconsce della psiche. Allontanandosi da una visione rigidamente meccanicistica nella ricerca delle cause dell’isteria, Freud progressivamente ‘scopre’ molteplici stratificazioni nella vita psichica, e fa esperienza diretta di come “ soltanto quando si studia il patologico s’imparaa conoscere il normale”. Dall’evoluzione dell’analisi del processoisterico, resa possibile dall’esperienza della prassi terapeutica,emerge allora un soggetto mai prima d’ora pensato in tutta la sua pluridimensionalità e complessità. Ma, nello stesso tempo, con esso emergono inevitabilmente, secondo l’espressione dello stesso Freud, anche le “carenze della nostra descrizione”.Con quale linguaggio è possibile allora dare espressione delle profondità dell’inconscio e, soprattutto, di una realtà psichica in cui coesistono tensioni e processi che sfuggono alle categorie della razionalità classica ? Questo è l’interrogativo fondamentaledella psicoanalisi come teoria dell’inconscio: la sua natura è allora epistemologica ma anche, nelle stesso tempo, terapeutica, nel senso che riguarda direttamente la relazione tra l’analista edl’analizzato. Entrambi infatti sono chiamati, naturalmente dalle loro singole prospettive, a dare espressione delle dinamiche e dimensioni profonde così come progressivamente emergono nel trattamento analitico (che è essenzialmente dunque una “talking cure” secondo la pregnante definizione della stessa signorina AnnaO., il primo celebre caso clinico analizzato negli Studi).Sia da parte dell’analista che da parte del paziente c’è dunque lanecessità di dare descrizione a processi psichici profondi e, nello stesso tempo, la consapevolezza che sia il linguaggio ordinario che quello scientifico e filosofico risultano inadeguatia tale compito.
50
Secondo Freud il paziente soffre anche, (ma , da un certo punto divista, si potrebbe dire, soprattutto) per l’impossibilità di dare espressione verbale a tutto il suo vissuto.Il paziente infatti ritiene “che il linguaggio sia troppo povero per poter tradurre in parole le sue sensazioni, che queste stesse sensazioni siano qualcosa di unico, di non mai accaduto, che non si può neanche descrivere in modo esauriente, e perciò egli non sistanca di aggiungere sempre nuovi particolari e, quando deve smettere, è certamente dominato dall’impressione di non essere riuscito a farsi capire dal medico”
Lo stesso problema viene necessariamente a porsi dalla parte del teorico che analizza i vissuti del soggetto. In particolare , per il giovane ricercatore che aspira a far parte dell’establishement medico-scientifico di Vienna risulta decisamente difficile elaborare un linguaggio che riesca ad essere efficace, nonostante la perdita della “ rigorosa impronta della scientificità”. Possiamo allora comprendere come, nel capitolo finale del testo, dove la teorizzazione propriamente psicoanalitica inizia effettivamente a prendere corpo, Freud avverta il bisogno di “scusarsi” nei confronti del suoi lettori (che, prioritariamente, sono i medici e gli psichiatri dell’Università di Vienna) per l’uso di “una serie di similitudini, che hanno tutte una somiglianza limitata con il tema in oggetto”.Ma ciò che lo guida “è l’intenzione di rendere intuibile da vari punti di vista una situazione mentale estremamente complessa e maisinora descritta”. La necessità di dare “descrizione” a dimensioni pluridimensionali e complesse della vita psichica conduce allora Freud ad attingere un insieme eterogeneo di termini sia dalla fisiologia, dalla neurologia e dalla medicina che dalla filosofia e psicologia. Questi, a loro volta, convergono in un linguaggio metaforico e figurale che non è più identificabile entro un ambito di pensiero o una tradizione culturale specifica. Nonostante ciò, o, forse, proprio per questo, il linguaggio che Freud va progressivamente costruendo assume una sorprendente perspicuità .Non è raro il caso, a partire proprio dagli Studi, che nei momenti decisivi del lavoro analitico , Freud faccia ricorso ad una serie di metafore ed immagini per dare espressione alla densità ed alla complessità delle dinamiche profonde della psiche.Il rigore logico che caratterizza il procedimento argomentativo freudiano trova così anche il modo di pervenire a conclusione attraverso citazioni di opere letterarie di grandi scrittori (preferibimente Goethe e Shakespeare) che, a loro volta, vengono
51
disinvoltamente poste in rapporto a motti e detti popolari, diffusamente frequentati da Freud in tutta la sua opera.Scienze naturali, medicina, psicologia, filosofia, alta cultura edespressioni della saggezza popolare, tutto è utile ad elaborare, non solo un ‘vocabolario’ della psicoanalisi, ma a definire il suostesso spazio teorico.Il linguaggio figurale della “scienza dell’anima nuova” è così , nello stesso tempo, significazione e costruzione delle dinamiche profonde della vita psichica.Il movimento teorico che fonda una nuova “scienza” umana è , da questo punto di vista, uno straordinario esperimento linguistico che scopre dimensioni sconosciute della psiche nel momento in cui riesce, in modi più o meno ortodossi, ad offrirne “descrizioni”. Il premio “Goethe” per la letteratura che verrà consegnato a Freudnel 1930 non riconosce quindi solo le doti di “un grande scrittoreuniversale” (anche se per molti il modo di esposizione freudiano viene inteso solo nei termini riduttivi dello ‘stile’) ma la sua capacità di creare, attraverso l’incertezza (Unsicherheit) e la provvisorietà di un linguaggio figurale (Bildersprache), una possibilità di espressione agli enigmi ed alla poliedricità della vita psichica. Tutto ciò non significa naturalmente che la psicoanalisi riesca a dare una trascrizione esaustiva dei vissuti profondi della soggettività.L’estrapolazione dai loro contesti originari di formazione e di referenza di un insieme eterogeneo di termini e concetti che confluiscono in un argomentare metaforico comporta necessariamentela loro trasformazione. Il linguaggio della psicoanalisi non è dunque una più o meno geniale mescolanza del linguaggio scientifico , filosofico e letterario poiché quello che viene posto in essere è qualcosa di essenzialmente diverso, un singolaredispositivo linguistico che riesce a far emergere qualcosa che inequivocabilmente ‘sentiamo’ come un fatto reale della nostra vita psichica.Il linguaggio della psicoanalisi trova così la sua capacità di significazione non nella possibilità di restituire una visione chiara ed esaustiva dei processi psichici profondi ma, si potrebbedire, proprio nella sua impossibilità a fare questo.La teorizzazione psicoanalitica ha infatti qualcosa di paradossaleessendo il suo principale ‘oggetto’ di analisi (l’inconscio) di per sé inconoscibile e quindi anche indescrivibile.
52
L’assenza del principio di non contraddizione e di temporalità chelo caratterizza costringe il sapere psicoanalitico ad essere un sapere dei derivati del suo proprio oggetto (lapsus, sogni o, meglio, narrazioni e ricordi di sogni, atti mancati, sintomi, fobie ecc.). In quanto tale non può non costituirsi se non come unsapere poliedrico e, nello stesso tempo, incerto e provvisorio checerca la sua ‘scientificità’ su basi totalmente diverse da quelle tradizionali. Il suo linguaggio mostra all’opera’ una forma logica inedita, una epistemologia che è stata definita “sconcertante” In altri termini: la pluridimensionalità , l’apparente contraddittorietà , la concettualizzazione provvisoria e suscettibile di continue riformulazioni , la confluenza di metafore letterariamente pregevoli con detti e motti popolari differenzia radicalmente la psicoanalisi dalle altre scienze umane, essendo tutto ciò la necessaria ed inevitabile conseguenza del progressivo modellamento da parte della ‘natura dell’oggetto’ nei confronti del processo di teorizzazione che vuole comprenderlo. Tutto ciò è esemplarmente evidente negli Studi sull’isteria dove le modalità espositive classiche con cui esso prende avvio vengono pagina dopo pagina decostruite per lasciare spazio ad un linguaggio che “da diversi punti di vista” tenta di dare espressione alla complessità della vita psichica. L’analisi non può dunque costituirsi come un sapere separato dal suo oggetto. Ilsuo linguaggio, perduta necessariamente la sua “rigorosa impronta della scientificità”, non risulta semanticamente depotenziato ma, al contrario, ci svela dimensioni della soggettività “mai prima d’ora descritte” senza che ciò comporti, come d’altra parte tutto lo sviluppo della psicoanalisi freudiana mostrerà in modo sempre più evidente, una traducibilità perfetta ed esaustiva della vita psichica profonda del soggetto. La psicoanalisi trova dunque la sua ‘differenza specifica’ proprio in una inedita configurazione dei rapporti tra incertezza e profondità, parzialità delle prospettive e ricostruzioni della totalità a partire da esse, precarietà e fondatività del suo sapere.Le finalità filosofico-ontologiche di Freud, di cui qui stiamo cercando di cogliere la genesi e i tentativi di portarle a compimento, vanno quindi viste dispiegarsi su questo terreno accidentato e tortuoso.Al termine degli Studi , Freud avverte di aver imboccato la strada giusta che dall’analisi del patologico lo conduce alle strutture permanenti ed invariabili della soggettività ‘normale’ attraverso
53
le verifiche che la prassi terapeutica offre alla teoria: il lavorodi costruzione della “teoria nuova”, cioè di un nuovo sapere dellasoggettività e dei suoi vissuti è ormai ben avviato.Abbiamo visto come in questo testo si definiscono una molteplicitàdi prospettive che progressivamente convergono , in corso d’opera,verso punti d’incontro e di sintesi innovativa, i quali, a loro volta, rendono possibile un nuovo tipo di sguardo sulle relazioni tra realtà fisica e realtà psichica. Il percorso che aveva avuto inizio dagli entusiasmi filosofico-romantici del giovane Freud perl’unità di spirito e di materia, trova, sul piano dell’analisi teorica e dell’intervento terapeutico, un suo primo e fondamentalepunto di arrivo. L’archeologia della soggettività che Freud intraprende nell’analisi dei casi clinici mostra all’opera un sapere che è già in grado di cogliere la complessità delle dinamiche soma-psiche su cui si costitutisce il soggetto ‘normale’.Attraverso l’indagine del patologico (le sue storture fanno emergere processi e dinamiche profonde non altrimenti visibili) Freud vuole pervenire ad una nuova metafisica della soggettività, la metapsicologia.Il percorso che dalle acquisizioni psicoanalitiche conduce alle concezioni metapsicologiche attraversa necessariamente le manifestazioni patologiche della soggettività poiché, come già ricordato, Freud riteneva che “soltanto quando si studia il patologico s’impara a conoscere il normale”. Le de-formazioni rendono visibili le forme strutturali, permanentie normali. Con questo non si vuole certo negare la presenza di uno specifico interesse di Freud verso le patologie psichiche, che è ovviamente un motivo propulsivo della teorizzazione psicoanalitica, ma esso, nella sua ragione più profonda, è riconducibile, oltre che all’esigenza di avviare un attività professionale ed al desiderio di arrivare ad una grande scoperta, alle forze agenti generali della sua attività teorica. L’interesse di Freud verso le nevrosi e le patologie psichiche è alimentato cioè da una chiara, determinata e forte volontà conoscitiva che, convergendo intorno alle relazioni mente-corpo, ètesa alla costruzione di un sapere progressivamente totalizzante, volto cioè alla comprensione dell’ ”intera attività mentale” e dei “grandi segreti della natura”, come più volte rivelato a Fliess. Ma come svelarli se essi sembrano sfuggire alla presa delle forme classiche della razionalità ?
54
Come cercheremo brevemente di vedere, per poter leggere poi ‘storicamente’ la sistematizzzione teorica del VII capitolo della Interpretazione dei sogni , il tortuoso itinerario a cui è stato costretto il pensiero di Freud è sostanzialmente dovuto proprio alla necessità di divergere dalle forme classiche della razionalità senza per questo precipitare in qualche tipo di irrazionalismo, che è quanto di più lontano ed estraneo alla psicoanalisi possa pensarsi. 22 Il problema che ha segnato le origini del pensiero di Freud, e che tuttora permane nel dibattitointorno alla legittimità scientifica della psicoanalisi, è proprioquello della identità teorico-epistemologica di un nuova forma di razionalità.Dove collocare un sapere che si autoriconosce come precario e nello stesso tempo è teso ontologicamente ad afferrare le strutture permanenti della soggettività ?Come si configura la coesistenza, conoscitivamente efficace, di unlinguaggio scientifico, analitico ed oggettivante con il linguaggio dell’incertezza (Unsicherheit) che procede per libere espressioni metaforiche ?Il periodo che va dalla fine degli Studi alla Interpretazione dei sogni è decisivo perché dà una possibile risposta a questi interrogativi.Ritorniamo dunque alla conclusione degli Studi . Freud ha definito uno spazio teorico nel centro del quale ha progressivamente preso corpo un ‘oggetto’ dominante: l’inconscio. Ma nel momento in cui èriuscito finalmente ad inquadrare il bersaglio si accorge che non è possibile centrarlo direttamente. L’inconscio si qualifica in primo luogo come un ‘oggetto’ di per sé inconoscibile che, per di più, non può essere identificato secondo i principi cartesiani della chiarezza e evidenza, né può trovare collocazione in una dimensione inequivocabilmente psichica o fisica.E questo è ciò che è maggiormente temuto dalla scienza che producesapere attraverso una chiara delimitazione di oggetti appartenentio ad una dimensione oggettivo-fisica o ad una dimensione soggettivo-psichica, oggetti che sono penetrabili direttamente daisuoi strumenti di ricerca e di verifica.L’analisi dei casi clinici degli Studi, ma anche di tanti altri che non sono stati riportati nel testo, mostra invece , contro l’organicismo della psichiatria classica, come non solo la dimensione psichica ed affettiva esercita un ruolo determinante
22 Alle accuse di irrazionalità Freud replicava semplicemente ricordando ai suoicritici che era l’oggetto, e non la sua teoria e metodo, a porsi al di fuori dello spazio della ragione.
55
sull’insorgenza dei sintomi fisici ma anche che il lavoro archeologico dell’analista porta alla luce una realtà in cui non èpossibile discriminare tra la dimensione psichica e quella corporea.E’ proprio questo il problema che sconcerta lo stesso Freud al punto tale da indurlo, nonostante tutta l’innovazione degli Studi, a persistere nel tentativo di ricondurre “l’organizzazione pluridimensionale e complessa” del proprio oggetto di studio nei confini epistemologicamente dati.L’opera successiva agli Studi rappresenta infatti un ulteriore, estremo tentativo di rendere conto, nei termini ‘scientifici’ della neurofisiologia dell’epoca, dell’intera attività dell’ “apparato psichico”. Dopo la straordinaria dinamica teorica che caratterizza la sua opera precedente può apparire sorprendere questo arretramento di Freud a posizioni ancora più piattamente positivistiche rispetto alle stesse premesse contenute nella Comunicazione preliminare ma, e questo è uno degli aspetti che differenzia la psicoanalisi rispetto alle altre produzioni teoriche, occorre tenere in debita considerazione gli elementi biografici poiché essi incidono in modo spesso determinante nella elaborazione dell’universo concettuale psicoanalitico. Ciò comporta che, con Freud, la vicenda umana viene posta in gioconella fondazione teorica. La risoluzione del rapporto di dipendenza da Fliess non è estraneaalla risoluzione dei problemi teorici che si erano posti con i tentativi del Progetto e della teoria della seduzione traumatica sessuale infantile. Facciamo brevemente riferimento ad una letteraa Fliess del 4 Marzo 1895. Qui Freud fa il resoconto di un sogno di un suo collega medico e lo interpreta secondo la teoria che verrà poi esposta , cinque anni dopo, nella Traumdeutung ma, sorprendentemente, nella stessa lettera, informa il suo amico che non c’è alcuna novità “sul fronte scientifico”. Perché allora una delle scoperte fondamentali della psicoanalisi ha dovuto attendere diversi anni prima di essere riconosciuta cometale dallo stesso Freud e essere quindi operativa sul piano conoscitivo ?
56
Ostacoli
Cerchiamo di rispondere a questo interrogativo ricostruendo, per ciò che è possibile fare attraverso fonti dirette ed indirette, levicende teorico-biografiche di questo periodo decisivo per lo sviluppo della psicoanalisi.Il tortuoso itinerario che Freud sta percorrendo per fondare la “teoria nuova” presenta infatti rilevanti ostacoli che non sono solo di natura propriamente teorica.Per giungere alla meta finale di questa prima fase fondazionalistadella psicoanalisi, cioè l’ultimo capitolo della Interpretazione dei sogni, dove trovano una prima sistematizzazione organica le sue categorie concettuali fondamentali, Freud si trova di fronte a tregrandi problemi : il primo è costituito da sé stesso, il secondo dalla sua relazione teorico-personale con W.Fliess e l’ultimo dalla risorgenza di ciò che abbiamo definito come ‘fisica speculativa dell’anima’.Il problema personale viene affrontato in modo veramente innovativo e si può anche dire coraggioso, cioè attraverso una sistematica autoanalisi iniziata a partire dal 1897.Il secondo motivo di preoccupazione per le prospettive di evoluzione della psicoanalisi è rappresentato dal ruolo di veto o di assenso che il berlinese dott. Wilhelm Fliess esercitava nei confronti delle nuove ipotesi, delle sperimentazioni teoriche e terapeutiche, delle folgorazioni del suo amico Freud, conosciuto in occasione di un viaggio di studi a Vienna.Il terzo è costituito da un ultimo, radicale ed estremo tentativo di dare una ‘spiegazione scientifica’ del funzionamento della mente secondo i principi del fisicalismo helmholtziano. Al culmine di questo tentativo viene formulata la teoria della seduzione traumatica infantile (di cui ci occuperemo in seguito).Questi ostacoli non sono però tra loro separati essendo essi tre diverse manifestazioni, intimamente legate, di un solo identico problema, che è propriamente costituito dalla straordinaria difficoltà di delineare nuovi orizzonti di pensabilità del soggetto e dei suoi vissuti in un’epoca dominata dall’imperativo della riduzione a fatto quantitativamente determinabile e
57
misurabile di ogni dimensione della realtà, sia essa fisica che umana.Procediamo quindi con ordine nell’analisi di questo periodo perchéè proprio da qui, dalle modalità di configurazione di questi diversi ostacoli che scaturisce una delle ‘invenzioni’ più importanti per tutta la cultura del ‘900.Prendiamo in considerazione il primo aspetto di questo problema che , come abbiamo detto, riguarda non le difficoltà teoriche bensì quelle relative alle dinamiche psicologiche del fondatore della psicoanalisi. A partire dal 1897 Freud si sottopone ad una sistematica autoindagine, che si avvale dei metodi posti in essere dalla sua attività di ricerca (associazioni libere, analisi di sogni, interpretazione di comportamenti, individuazione ed analisi di sintomi come fobie, atti mancati, dimenticanze ecc.).Attraverso l’autoanalisi Freud pone dunque sé stesso in gioco nella fondazione teorica psicoanalitica. Ma è possibile indagare le proprie dinamiche profonde attraverso concetti e tecniche elaborati dallo stesso indagatore? Lo stesso Freud considera la sua autoanalisi come “la più difficile” di tutte e, in un momento successivo, addirittura “impossibile”. Di fatto essa però segna una svolta decisiva nella sua produzione teorica. Questo avviene evidentemente perché più che uno strumento di conoscenza vero e proprio utile a fini diagnostici e terapeutici, l’autoanalisi di Freud deve essere valutata nel contesto della nascita della psicoanalisi come momento di autochiarificazione delfondatore di un sapere che vuole illuminare luoghi ‘oscuri’ della realtà psichica del soggetto.Detto nei termini di Kierkegaard, filosofo che ha riflettuto moltoed in modo penetrante sul rapporto tra teoria e biografia, Freud con l’autoanalisi vuole evitare di edificare una nuova scienza sulla base di una “menzogna” verso sé stesso che invece, per il filosofo di Copenhagen, così come per Freud, costituisce un rischio reale nelle grandi teorizzazioni filosofiche e scientifiche.L’esperienza dell’autoanalisi, comunque valutata rispetto alla suaincidenza nella produzione teorica, è strettamente connessa ad un’altra esperienza estremamente significativa per Freud, cioè il rapporto di amicizia con il dottor W.Fliess, famoso otorinolaringoitra berlinese.A partire dal 1887, anno del loro incontro a Vienna, i due, entrambi ebrei, giovani, medici ed animati da interessi scientifici, intrattengono una corrispondenza epistolare sempre
58
più fitta che inizia a diradarsi solo dopo la pubblicazione dell’ Interpretazione dei sogni (1900), fino a cessare del tutto nel 1904.Un così lungo periodo di intensa relazione sia sul piano teorico-terapeutico che su quello personale-famigliare (ovviamente nel rapporto di amicizia vengono coinvolte anche le rispettive famiglie) non poteva non comportare anche un rapporto di reciprocainfluenza.L’epistolario non è però il solo mezzo di comunicazione teorico-personale perché i due aspiranti scienziati - le lettere sono piene di speranze e reciproche assicurazioni di fama imperitura- si incontrano regolarmente in diverse città austriache e tedesche per approfondire i risultati delle loro ricerche (in seguito questi incontri vennero dagli stessi definiti “congressi privati” e, sia agli occhi degli storici della psicologia che a quelli degli stessi analisti, vengono riconosciuti come i primi convegni del movimento psicoanalitico).Fliess è per Freud un specie di sostituto di J. Breuer, che come ènoto, aveva svolto un ruolo importante nella formazione degli interessi scientifico-teorici del suo giovane amico, agli occhi del quale appariva come una personificazione del paradigma del positivismo all’epoca dominante. Fliess dunque diventa il nuovo punto di riferimento di Freud nonostante la distanza tra i due fosse emersa fin dall’inizio. Infatti tra le ipotesi freudiane sull’inconscio e le formulazioni teoriche di Fliess c’è una evidente differenza di valore. Fliess elabora complesse quanto singolari ipotesi numerologiche sull’insorgenza delle patologie di vario genere e natura (ad es. la combinazione di date di nascita con vicende importanti nella vita del paziente) nel contesto di una teoria che afferma come suopunto principale la corrispondenza tra organi nasali e sessuali. Queste teorie numerologico-sessuali vengono proposte a Freud nel tentativo di una loro integrazione con il possente lavoro teorico di costruzione della psicoanalisi.Quale era allora la reale natura della relazione se , a livello discambio teorico Fliess aveva poco o niente da offrire a Freud ?La risposta a questo interrogativo, che evidentemente si era postolo stesso Freud, è rappresentata sia da tutto l’epistolario (che consta di circa 300 lettere di Freud a Fliess, mentre quelle di Fliess a Freud sono state distrutte da Freud stesso) che dai ‘congressi privati’ che i due regolarmente tenevano in diverse città : Fliess è il primo ed “unico pubblico” della psicoanalisi, è “l’altro” che il fondatore di una teoria rivoluzionaria deve trovare per costituirlo come polarità dialettica necessaria al
59
processo di evoluzione del proprio pensiero e testimone del lavorodi autoanalisi che Freud stava compiendo su sé stesso.Fliess infatti, impersonando gli imperativi scientisti del positivismo, ostacolava ma, nello stesso tempo, rendeva possibile il cammino verso la rivoluzione psicoanalitica 23 poiché nella fondazione e nello sviluppo della psicoanalisi gli avanzamenti teorici hanno avuto bisogno anche di una drammatizzazione sul piano biografico. Sia Fliess che Breuer costituiscono dunque le figure originarie di una serie di relazioni ed amicizie di cui Freud ha avuto ‘bisogno’ per sviluppare il suo pensiero. Nella storiografia psicoanalitica non è quindi possibile prescindere dall’intreccio tra la dimensione teorica e quella personale poiché, puntualmente, ad ogni fase di innovazione teorica del movimento psicoanalitico, corrispondono momenti di rottura , di trasformazione e di intensificazione nelle relazioni personali trai suoi protagonisti. Basta citare i nomi di Jung, Adler, Ferenczi,Rank, Federn per richiamare immediatamente, anche per chi ha una conoscenza solo generale del movimento psicoanalitico, momenti di scontro, conflitto, rottura di amicizie, nuove alleanze, ripudi e riconoscimenti, anche a livello di cariche istituzionali, legati alle fasi di innovazione sia nella teoria che nella terapia. La relazione con Fliess è dunque particolarmente significativa in quanto agisce nella fase fondativa dell’opera freudiana ponendosi come fonte di rinnovato incitamento ‘scientifico’, al punto tale che Freud, di ritorno da uno dei ‘congressi’ che regolarmente i due tenevano in varie città, inizia concitatamente a scrivere in treno un testo che si apre in questo modo:
“ L’intenzione di questo progetto è di dare una psicologia che sia una scienza naturale, ossia di rappresentare i processi psichici come stati quantitativamente determinati di particelle materiali identificabili, al fine di renderli chiari edincontestabili.”
In questa vertigine di scienza, quantità, determinismo, materia e incontestabilità, la soggettività dell’autore è percorsa da forti sconvolgimenti che, proprio nella corrispondenza con Fliess di
23 Freud, che pensa a Fliess come l’ “Altro”, arriva , ad un certo punto del lororapporto epistolare, a proporre al suo amico di non rispondere alle lettere che egli regolarmente continuava a spedirgli essendo sufficiente solo il suo ascolto.
60
questo periodo, emergono in tutta la loro drammaticità in un crescendo di alterni stati emotivi che si risolvono , a sette mesidall’inizio dell’opera, nella consapevolezza del suo totale fallimento:Scrive Freud a Fliess il 29 Novembre:
“Non capisco lo stato mentale in cui ha concepito la psicologia; non riesco a capire come abbia potuto infliggertela. Penso che tu sia troppo cortese; mi sembra sia stata una specie di aberrazione ne.”
Abbiamo già detto che il Progetto di una psicologia scientifica (con questo titolo verrà pubblicato postumo nel 1950 il testo, o meglio, la testimonianza di questo tentativo che Freud chiamava Psicologia per neurologi) costituisce l’ultimo estremo tentativo di una totale riduzione a categorie quantitativo-descrittive dell’intera fenomenologia psichica. In realtà vedremo come qui convergono le problematiche biografiche e relazionali di cui si è detto sopra e si coniugano con il tentativo di costruire (naturalmente nei termini del paradigma neurofisiologico in questo periodo dominante) una ontologia materialisticamente fondata della soggettività.Il modello è ancora quello della “anatomia fantastica” della “mitologia del cervello” ( Hirnmythologie). Sia l’ambito di fondo (Herbarth, Helmholtz, Fechner) che i riferimenti più diretti (Brucke, Meynert, Exner) definiscono il Progetto all’interno della linea evolutiva che , costituitasi in opposizione alla Filosofia della natura, finisce per moltiplicare la filosoficità da cui aveva voluto prendere le distanze.Nell’opera riecheggiano, pur se in forma rovesciata, le polarità schellinghiane di psichico-fisico, piacere-dispiacere, oggetto-soggetto ecc. all’interno di un approccio ed un linguaggio fisico-idraulico (barriere di contatto, vie di conduzione, scarica di quantità, innalzamenti di livelli, isolatori, ecc).Per le finalità di questo studio assume un particolare interesse il fatto che l’ “anatomofisiologia cerebrale speculativa” del Progetto costituisce una delle prime fonti della metapsicologia di Freud.
61
Prima di proseguire nell’analisi del percorso che conduce Freud verso il suo capolavoro, che trova proprio una conclusione metapsicologica, è opportuno aprire un parentesi per chiarire il significato che questo neologismo freudiano assume, anche storicamente, nello sviluppo della psicoanalisi.
Metapsicologia e neurofisiologia
Il termine metapsicologia compare per la prima volta nella lettera a Fliess del 2 Aprile 1896 in cui Freud, significativamente, rivela al suo più importante ed intimo amico che il proprio originario desiderio filosofico è in via di realizzazione nel passaggio dalla“medicina alla psicologia”. Il modo con cui appare questo termine ci indica come il suo significato originario sia duplice: prioritariamente con esso Freud intende il superamento del punto di vista solamente medico, cioè dell’organicismo positivista, ma, essenzialmente, per metapsicologia si deve intendere la legittimità della utilizzazione del sapere prodotto dal faticoso lavoro analitico ai fini della formulazione di un complesso di modelli concettuali, che al di là di riferimenti esperenziali specifici e diretti, riescono a cogliere gli elementi costitutivi della soggettività e dei suoi vissuti nella loro pluridimensionalità economica, topica e dinamica.La metapsicologia in quanto teoria generale della psicoanalisi chevuole comprendere le strutture necessarie ed invariabili della (inter) soggettività si pone in termini di radicale alternativa alla filosofia ed alla metafisica, da cui deriva anche la sua denominazione.E’ possibile leggere il percorso che dai primi entusiasmi per la Filosofia della natura conduce Freud verso l’ultimo e più importante capitolo filosofico-metapsicologico della Interpretazione dei sogni, in termini di un reiterato tentativo di porre in essere una metapsicologia come teoria complessiva della soggettività e dei suoi vissuti.Successivamente a ciò il movimento del sapere analitico verso la metapsicologia si connoterà in modo sempre più radicalmente ontologico come movimento della conoscenza verso la verità.
62
Non può allora sorprendere come, proprio all’indomani delle acquisizioni metapsicologiche del VII capitolo della Traumdeutung, Freud arrivi a proporre di” convertire la metafisica in metapsicologia.”Conseguentemente la metafisica dei filosofi, ormai delegittimata di ogni valore realmente conoscitivo (Freud arriverà addirittura acondannarla sul piano etico come un “abuso” del pensiero umano), verrà progressivamente ad essere posta come oggetto d’analisi da parte della psicoanalisi che la comprende come un tentativo di “costruzione di una realtà soprasensibile che la scienza deve ritrasformare in psicologia dell’inconscio”.Infatti gli ordinamenti complessivi, necessari, universali e soprasensibili a cui si sono da sempre adoperati i filosofi non sono altro per Freud che dei tentativi di com\prendere il reale entro principi primi per assolvere all’esigenza di attribuzione disenso alla totalità.In altri termini, le fondazioni metafisiche dei filosofi si radicano, per Freud, nelle profondità e nelle oscurità dell’inconscio. La psicoanalisi, come scienza dell’inconscio, può dunque ricostruire la genesi dei tentativi di rendere il mondo riconducibile a principi che vanno al di là dei dati sensibili. Questo lavoro genealogico, nel momento in cui riconduce la metafisica alla sua radice “umana, troppo umana”, mostra all’operaun sapere della soggettività che gli consente di “ardire” alla proposta di “convertire la metafisica in metapsicologia.”In termini ancora più diretti: la psicoanalisi è in grado di rispondere alla domanda “Che cos’è la metafisica?” perché essa è la vera metafisica che, essendo riuscita ad afferrare le strutture eidetiche della soggettività, dà spiegazione delle ragioni profonde che hanno alimentato incessantemente costruzioni volte alla fondazione delle strutture metafisiche del reale. In questo modo la metapsicologia ci fa comprendere le ragioni profonde del ‘bisogno’ di metafisica dell’uomo e dei tentativi di soddisfarlo.Ora la radicalità dell’alternativa tra filosofia e psicoanalisi è mostrata proprio dalla presenza di queste posizioni- che troveranno una articolazione maggiore negli scritti successivi- inuna fase che è ancora prepsicoanalitica, in un momento cioè in cuilo spazio teorico freudiano ed il suo universo categoriale sono invia di formazione.Tra le prime forme della teorizzazione psicoanalitica e la tradizione filosofica del pensiero emerge dunque immediatamente, in modo netto ed inequivocabile, una radicale inconciliabilità. Nello stesso tempo, come si è gia rilevato, esiste un costante
63
movimento freudiano verso la speculazione filosofica. Tutto ciò lascia ampiamente intravedere le linee di tendenza del pensiero diFreud che, nel corso di tutta la sua opera, si adopererà incessantemente alla delegittimazione della filosofia, ma, nello stesso tempo, non riuscirà a contenere la sua irresistibile attrazione per l’uso speculativo delle acquisizioni del lavoro analitico.Abbiamo visto come le istanze metapsicologiche del Progetto cerchino, ineffettualmente, espressione neurofisiologica nel tentativo di costruire una “scienza economica della forza nervosa”che vuole trascrivere in termini quantitativi l’intera fenomenologia della vita psichica, comprese quindi tutte le sue dimensioni “qualitative” come il pensiero, la conoscenza, il giudizio, la volontà, la deliberazione cosciente, la memoria ecc..”La domanda che è al centro di quest’opera incompiuta- e necessariamente tale per l’impossibilità di rispondere alla domanda che ne è alla base, perlomeno all’interno dei confini dell’ambito teorico-epistemologico su cui si muoveva Freud- è : “Dove hanno origine le qualità ? ”Il “problema” è dunque quello della qualità, come illustra adeguatamente il titolo del paragrafo VII del Progetto , che deve trovare spiegazione all’interno dei confini della “scienza economica della forza nervosa”. Per qualità Freud intende essenzialmente la “coscienza” ed i suoi contenuti. “Questi devono essere iscritti, per soddisfare il punto di vista della scienza naturale (...) nei nostri processi quantitativi y” 24. Ma, nonostante questa reiterata rivendicazionedi appartenenza alla scienza naturale ed a una “linea di pensiero darwiniana” come inequivocabilmente afferma lo stesso Freud nel Progetto, “un saggio del genere sarebbe stato normale aspettarselo da un filosofo, più che da un patologo” commenta il biografo di Freud e storico della psicoanalisi Ernst Jones .In effetti tutta la febbrile e sofferta stesura del Progetto è alimentata, al suo più alto livello di tensione, da un potente desiderio filosofico che si esprime attraverso una fisica speculativa dell’anima tesa a tradurre l’intera vita psichica in termini neurofisiologici.Al culmine di questo tentativo Freud rivela a Fliess una “grande” scoperta:
24 Freud pone alla base della sua concezione quantitativa della vita psichica due sistemi di neuroni y e j. OSF, II,p. 213
64
“ Ti ho già rivelato, a voce o per lettera, il grande segreto clinico? L’isteria è la conseguenza di uno spavento sessuale subìto nel periodo presessuale. La nevrosi ossessiva è la conseguenza di un piacere sessu- ale provato nel periodo pressessuale che più tardi si tramuta in auto- rimprovero”25
La certezza di”aver trovato la soluzione dell’enigma dell’isteria e della nevrosi ossessiva con le formule dello spavento sessuale edel piacere sessuale infantile” è talmente entusiasmante che, per la prima ed unica volta della sua sconfinata produzione epistolare, Freud dimentica di firmare la lettera.Dunque: le innovazioni degli Studi vengono scardinate dalla “scoperta” che fatti sessuali di tipo traumatico (Freud considera, specialmente in questa fase, la sessualità un fattore puramente organico e quantitativamente esprimibile) sono all’origine delle due principali patologie psichiche, l’isteria e la nevrosi.E’ talmente convinto di questo che, riscontrate su di sé tracce dinevrosi grazie alla propria autoanalisi, sospetta seriamente di essere stato fatto oggetto durante la propria infanzia di attenzioni sessuali da parte di adulti.Tra questi, il maggiore indiziato è il proprio padre.Ora, oltre il desiderio della grande scoperta, che anche in passato aveva fatto fare passi avventati al giovane Freud, come nel caso dell’uso a fine terapeutici della cocaina , qui evidentemente riemerge la necessità di trovare la risposta all’enigma delle patologie psichiche sul piano oggettivo e verificabile dei fatti. E lecito considerare questo arretramento come un ultimo debito che doveva comunque essere ‘onorato’ verso la cultura dell’epoca in cui egli aveva, d’altra parte, ricevuto la sua formazione ? E’ come se, prima di spiccare un grande salto teorico ed epistemologico, Freud avvertisse il bisogno di un ritorno a posizioni precedenti che, proprio per il loro imminente abbandono, vengono assunte nella loro esclusività ed ulteriormenteradicalizzate.In ogni caso, quando viene abbandonata l’ insostenibile teoria chericonduceva ogni patologia psichica ad eventi reali traumatici della25 LF, Lettera del 15 Ottobre 1895.
65
sfera sessuale, Freud lo comunica a Fliess non come una “sconfitta” ma come un “trionfo”. Come è possibile allora che il crollo della teoria della seduzione, che costituiva una soluzione teorica ai grandi enigmi che le patologie psichiche ponevano a medici e scienziati, per Freud si rivela in realtà come un “trionfo” ? “Il grande segreto clinico”, così tenacemente cercato e poi sostenuto con forza e convinzione per un periodo molto più lungo delle teorie neurofisiologiche del Progetto , unitamente al complesso di ipotesi e di approcci che vogliono comprendere la soggettività esclusivamente attraverso i metodi e le categorie delle scienze naturali, ad un certo punto diventa un’ipotesi da abbandonare. Nella “catastrofe generale” però Freud parla di “trionfo”poiché evidentemente vengono finalmente sciolti una serie di nodi di natura teorica e personale che facevano ruotare il suo lavoro teorico intorno al paradigma positivista, conducendolo agli irrigidimenti totalizzanti della teoria traumatica , alla “metapsicologia neurofisiologica” del Progetto ed al rapporto di dipendenza da Fliess. Il contesto in cui avviene ilcrollo della teoria della seduzione traumatica infantile è , significativamente, quello dell’autoanalisi, così come risultaaltrettanto significativo il fatto che la relazione di dipendenza da Fliess s’interrompa all’indomani della pubblicazione dell’ Interpretazione dei sogni.26
Opera e vita, come abbiamo già sottolineato, nella psicoanalisi interagiscono in modo profondamente produttivo.C’è una svolta teorica e, come vedremo, anche ‘metodologica’, decisiva: Freud ora guarda in “modo storico” le sue teorie neurofisiologiche (i”neurotica”) e traumatiche del passato.Superando l’alternarsi di tormenti, ansie, delusioni, istanze tiranniche, rifiuti ed entusiasmi, Freud conquista il suo momento conoscitivo più felice, che vorrebbe anche realizzato nella sua attività professionale, vivendo cioè dell’interpretazione dei sogni a cui sta lavorando proficuamente in questo periodo. Anche in questo occasione il carteggio con Fliess si rivela prezioso poiché nelle lettere coestensive alla stesura della Traumdeutung si può cogliere il mutamento qualitativo della sua produzione teorica che ora procede “fantasticando” in un “felice” e disteso senso di attesa di imprevedibili flussi conoscitivi.26 Nonostante le continue rassicurazioni di Freud a Fliess ( in particolare si vada la lettera del 22 Settembre 1898) sulla stabilità delle loro comuni convinzioni positiviste, la relazione si indebolisce proprio nel periodo di stesura della Traumdeutung. E’ evidente la convergenza di risoluzioni teoriche e personali in questa decisiva fase di passaggio dell’opera freudiana.
66
Il conatus teorico del Progetto, dominato dal fisicalismo helmholtziano, è un’esperienza dimenticata: ora intere parti dellaInterpretazione dei sogni sono state composte “come in un sogno”, mentre l’autoanalisi gli fa conoscere “un indescrivibile senso di bellezza intellettuale”. Ed è in questo contesto che Freud rivela a Fliess il suo “desiderio di conoscenza filosofica” che ritiene di aver soddisfatto con l’ultimo capitolo dell’ Interpretazione dei sogni, denominata appunto come “parte filosofica”. Qui Freud vede dispiegato un sapere che pur essendo ormai svincolato dall’imperativo di una sua fondazione organico-anatomica, non possibile all’epoca, attende un suo completamento dagli sviluppi futuri della neurofisiologia. Operando quindi solo sul piano della psico-analisi Freud avverte di essere pervenuto alla conoscenza dei processi conflittuali che, attraversandola nella sua dimensione fisica e psichica, costituiscono la soggettività.Ciò comporta la conquista di un territorio inesplorato, inesplorabile o, comunque, ineffettualmente occupato dalla filosofia e dai suoi strumenti concettuali.Il giovane studente che non aveva trovato nella scienza del corpo né in quella della mente le risposte alle sue totalizzanti esigenze conoscitive, dopo un avventuroso e tortuoso itinerario teorico, ormai in piena maturità, può affermare che “l’interpretazione del sogno è in grado di fornirci chiarimenti sulla struttura del nostro apparato psichico, che finora abbiamo atteso invano dalla filosofia”.Quali sono dunque gli elementi costitutivi del sapere psicoanalitico ? In base a che cosa viene attribuito valore filosofico-metapsicologico a questo sapere da contrapporre polemicamente alla sterilità del coscienzialismo della filosofia ?La risposta a questo interrogativo è contenuta in particolare nell’ultimo capitolo della Interpretazione dei sogni , che quindi va letto come in trasparenza facendo emergere il sottotesto che esso contiene.Infatti la costruzione di “una scienza dell’anima nuova” che qui prende avvio assume contestualmente e, secondo Freud, necessariamente, una parallela funzione decostruttiva rispetto alle precedenti concezioni filosofiche della soggettività.Quali sono allora gli elementi strutturali dell’ontologia freudiana della soggettività e, soprattutto, come trovano possibilità, nella loro interrelazione, di costituirsi come una concezione unitaria alternativa alle tradizionali riflessioni filosofiche sullo stesso tema ?
67
Desiderio, Inconscio e Fantasma
I concetti di desiderio , inconscio e fantasma sono per Freud la risposta agli interrogativi da cui è partita la sua ricerca poichéattraverso di essi e, ripetiamo, attraverso la loro stretta integrazione, è possibile dare risoluzione al problema del rapporto mente-corpo. Prima di prendere in considerazione il primo di questi tre concetti, cioè il concetto di desiderio , ricordiamo che Freud si interessa all’analisi della attività onirica perché lo “studio deisogni ha un valore teorico per la conoscenza psicologica”, che sappiamo egli intende come conoscenza delle relazioni tra la realtà fisica e quella psichica.Le originarie ascendenze della filosofia della natura da un lato ele implicite premesse cartesiane della separazione tra res extensa e res cogitans dall’altro hanno condotto Freud a ritenere che la soggettività dovesse necessariamente essere compresa come unità dei due “mondi” o “sostanze” che la costituiscono. Nel lavoro onirico queste due “sostanze” si manifestano in tutta la loro potenza ed unità sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Abbiamovisto come il concetto attorno al quale egli cerca di connettere le due dimensioni, nonostante i“nuovi punti di vista” che continuamente si imponevano, era quello di quantità entro il quale bisognava comprendere quello di qualità. Ora, sul terreno necessariamente solo psico-analitico, in attesa di una integrazione con “gli elementi organici del sistema nervoso”- quando ciò sarà reso possibile dagli sviluppi scientifici della medicina- Freud accede ad una dimensione qualitativa della realtà psichica. Ciò gli consente anche di elaborare teoricamente ciò che prima si presentava come una complicazione sgradita (i “nuovi punti di vista” che si imponevano) al processo di “spiegazione” scientifico-quantitativa e quindi di moltiplicare le sue prospettive di indagine.Nella metapsicologia del VII capitolo della Traumdeutung cercheremodi cogliere i suoi elementi fondanti e comprenderli all’interno della linea evolutiva del pensiero di Freud. Partiamo dalla celebre formula che vorrebbe riassume tutto il testo- il sogno è l’appagamento di un desiderio - che in realtà dovrebbe essere espressa in questo modo: il sogno è un tentativo - mascherato e
68
censurato- di un appagamento allucinatorio e fantasmatico di desideri inconsci- rimossi- che hanno la loro origine nell’infanzia.Questa sintetica formulazione contiene i tre concetti fondamentalidell’opera (desiderio, inconscio, fantasma) e, si potrebbe dire, di tutta la psicoanalisi, insieme ad altri concetti a loro strettamente collegati (rimozione, censura, appagamento, vita psichica infantile) che trovano la loro legittimazione teorica all’interno delle nuove prospettive di conoscenza dell’attività psichica che differenziano l’apparato psichico in “topoi” (luoghi), cioè in tre sistemi (Inconscio, Preconscio e Coscienza) e in due modalità di funzionamento (processo primario e secondario).Prendiamo allora in considerazione in primo luogo il concetto di desiderio poiché esso è al centro dell’analisi del lavoro onirico ed anche perché il passaggio dall’approccio oggettivistico e fisicalistico a quello propriamente psicoanalitico risulta evidente dalla stessa evoluzione di questo concetto, in cui inizialmente Freud non discriminava aspetti fisici e psichici. Attraverso di esso Freud, svelando i significati del sogno come espressione di desideri inconsci dell’infanzia, può poi, sulla base di questo sapere, elaborare la metapsicologia del VII capitolo. Il desiderio assume quindi una funzione esplicativa fondamentale nella Interpretazione dei sogni poiché qualifica eminentemente il ‘modo di essere’ dell’inconscio. Questo concetto non è però facilmente formulabile sia perché lo stesso Freud non lo definisce in modo diretto, ma solo indirettamente attraverso il suo uso (in realtà non sempre rigoroso), sia perché, essendo il ‘desiderio’ una categoria generale e, nello stesso tempo, fondamentale, risulta difficile delimitarlo con sufficiente chiarezza e precisione. Nonostante i molteplici usi di questo termine rinvenibili nei diversi testi freudiani, che ne rendono problematico un suo significato univoco, è comunque certo che esso non è certamente comprensibile esclusivamente all’interno della dimensione fisico-organica, pur essendo in essa radicato per la sua origine prevaletemente sessuale.Infatti in un primo tempo Freud considera il desiderio come ciò che muove l’attività onirica nella duplicità del suo essere fisicoe psichico: come desiderio fisico di dormire (il sogno svolge la funzione di custode del sonno) e come desiderio psichico inconsciorimosso orientato alla propria soddisfazione allucinatoria (il sogno che ci rappresenta o, meglio, tenta di rappresentarci, tra mille difficoltà ed ostacoli, come appagati i nostri desideri).
69
Progressivamente esso verrà elaborato sempre più in una dimensionepropriamente psichica e collegato strettamente alle tracce mnestiche in modo da essere nettamente distinto dal concetto di bisogno che invece si riferisce ad uno stato fisico di tensione interna il cui soddisfacimento comporta un’azione specifica (es. fame - cibo). La distinzione del concetto di desiderio da quello di bisogno risulta allora decisiva nello spostamento della ricerca freudiana nel campo psichico: il desiderio ha a che fare con dei segni, non con degli oggetti concreti esterni attraverso i quali occorre necessariamente passare per risolvere lo stato di tensione internache il bisogno fisico produce.Questi segni sono costituiti dai ricordi di passate esperienze in cui compare “ una determinata percezione, la cui immagine mnesticarimane d’ora in poi associata alla traccia mnestica dell’eccitamento di bisogno. Appena questo bisogno ricompare una seconda volta, si avrà, grazie al collegamento stabilito, un moto psichico che intende reinvestire l’immagine mnestica corrispondente a quella percezione , e riprovocare la percezione stessa; intende dunque, in fondo, ricostruire la situazione del primo soddisfacimento.” Nella concezione freudiana, il desiderio va dunque pensato in relazione al ricordo di esperienze di soddisfacimento avute nell’infanzia che siamo indotti a sperare di ripetere.Il desiderio , in altri termini, trova il suo appagamento nella riproduzione allucinatoria di ciò che , a sua volta, era divenuto segno di soddisfacimento. La sua rappresentazione in uno scenario immaginario e fantasmaticolo pone così agli antipodi dai “processi psichici come stati quantitativamente determinati di particelle materiali indentificabili “ del Progetto .Ma l’altra caratteristica essenziale del desiderio è che esso è prevalentemente inconscio: la maggior parte dei contenuti non consapevoli della mente riguarda infatti desideri che risalgono all’infanzia.Per Freud una costante tensione inconscia tesa alla riproduzione di esperienze di soddisfacimento passate domina, più o meno direttamente, l’attività del soggetto.Il desiderio è dunque per Freud essenzialmente desiderio del desiderio.Un’ osservazione di carattere filologico ci può aiutare a chiarirequesto concetto fondamentale della psicoanalisi.
70
Il termine tedesco Wunsch designa qualcosa di diverso dai corrispondenti desiderio in italiano e wish in inglese. Mentre questi convergono sul significato di cupidigia o appettitus , wunsch si può rendere meglio con ciò che ci si augura, ciò che ci si aspetta.Freud accede ad una dimensione propriamente psichica proprio con il concetto di desiderio che viene, si può dire, defisicizzato e fatto coincidere con la sua espressione mentale. Wunsch sta allora per esprimere un desiderio, formulare un voto .Ciò allora comporta che i desideri possono essere realizzati “mentalmente” attraverso il reinvestimento allucinatorio delle percezioni collegate con il soddisfacimento dei bisogni? “ Nulla ci impedisce- scrive Freud- di ammettere uno stato primitivo dell’apparato psichico, nel quale questa via viene realmente percorsa in questo modo e l’atto del desiderio sfocia quindi in una allucinazione.”Nella sua concezione evoluzionistica Freud non esclude che, attraverso una “identità di percezione” (ripetizione della percezione collegata al bisogno), sia stato possibile, alle origini dell’umanità, “allucinare” i ricordi di esperienze di soddisfacimento di bisogni. Ma “un’amara esperienza vitale deve aver modificato questa primitiva attività mentale in una attività più funzionale, secondaria.” Non essendo più possibile ottenere “internamente” soddisfacimenti di bisogni (“si riconosce necessaria l’istituzionedi una ‘prova di realtà’ ”) si è sviluppato, attraverso un lungo processo evolutivo, un secondo sistema che si dà il compito di giungere all’appagamento di desiderio per via “indiretta”, cioè necessariamente attraverso il mondo esterno. La fondamentale distinzione tra processo primario e secondario nel funzionamento dell’apparato psichico viene così posta, su un fondamento evoluzionistico, contestualmente alla scoperta del desiderio inconscio che secondo Freud muove l’intera attività psichica.Si ricorda che, per processo primario, Freud intende la specifica modalità di funzionamento dell’inconscio in cui l’energia psichica, attraverso i meccanismi dello spostamento e della condensazione, passa da una rappresentazione all’altra.La libera circolazione di energia che lo caratterizza converge verso un reinvestimento delle rappresentazioni relative ad esperienze di soddisfacimento.Nel processo secondario invece l’energia non fluisce in modo libero, essendo essa legata dal sistema preconscio-cosciente, ma viene governata dall’attività intellettiva per raggiungere , attraverso valutazioni consapevoli di varie opportunità, il proprio
71
soddisfacimento. Naturalmente non c’è slittamento tra una rappresentazione e l’altra ma sono resi possibili investimenti stabili di rappresentazioni. In sintesi: i due processi , in opposizione tra loro, rispondono adue principi diversi, cioè a quello del piacere (processo primario) ed a quello di realtà (processo secondario).La loro distinzione costituisce una delle maggiori acquisizioni prodotte dalla investigazione analitica sulle modalità con cui si struttura l’attività onirica: nel processo primario, così come neisogni, si producono gli stessi meccanismi che Freud denomina come meccanismi di spostamento, condensazione e sovradeterminazione. Poiché essi caratterizzano indifferentemente l’attività onirica e l’inconscio, il sogno costituisce un’esperienza in cui l’attività mentale dell’uomo ritorna ad essere quasi interamente dominata dalprocesso primario. Mentre la veglia è caratterizzata dalla progressione, nello stato di sonno si attua una regressione che è nello stesso tempo topica (dalla coscienza all’inconscio), formale (vengono riattivati primitivi modi sensoriali di espressione) e temporale (il sognatore regredisce alle situazioni più remote da luivissute, ai suoi desideri infantili, ai moti pulsionali una volta dominanti ). Per questo l’analisi dei sogni per Freud ha valore metapsicologico in quanto essa ci fa conoscere “l’eredità arcaica degli uomini”.E’ questo uno dei momenti più importanti in cui Freud supera le originarie concezioni meccaniciste e fisicaliste in favore di una analisi che, comprendendo in sé l’approccio ‘quantitativo’, guadagna piani e dimensioni teoriche che consentono di esplorare la complessità e la pluridimensionalità della vita psichica. Attraverso l’analisi dei sogni Freud dà una ricostruzione genealogica del funzionamento della mente accedendo quindi ad una dimensione originaria che come tale assume un valoremetapsicologico. Vediamo allora brevemente in che cosa consistono questi tre principali processi, cercando di comprenderli all’interno della dimensione metapsicologica che emerge necessariamente dall’analisidel lavoro onirico.Innanzitutto attraverso lo spostamento, che, come si è già rilevato,caratterizza le dinamiche inconsce, la formazione di sintomi nellenevrosi e l’attività onirica.Esso consiste in un trasferimento della totalità dell’ energia psichicadi una rappresentazione ad un’altra rappresentazione. Freud ha evidenziato questo meccanismo soprattutto nel sogno dove i pensieri latenti più importanti e centrali vengono spostati attraverso varie modalità, come ad esempio una loro sfocatura, per
72
essere posti sullo sfondo nel contenuto manifesto. C’è in altri termini uno spostamento di accento che svaluta ciò che è al centrodel sogno. Esso si produce sia per la natura mobile del processo primario che lo contiene, sia perché utilizzato dalla censura che non consente ai pensieri latenti di passare come tali nel contenuto manifesto.La condensazione consiste invece in un processo che assegna a dei “punti nodali” manifesti tutta una serie di pensieri latenti che così trovano una loro “traduzione abbreviata” condensandosi in unarappresentazione unica. Anch’ essa è, nello stesso tempo, caratteristica del processo primario inconscio e meccanismo operante nel lavoro del sogno.La condensazione non è semplicemente una sintesi perché ogni punto può rimandare ad un numero indeterminato di pensieri latenti (nel riassunto un concetto esposto brevemente rimanda ad un concetto articolato ed approfondito).Conseguentemente viene attivato un processo di sovradeterminazione . Sappiamo che quest’ultimo concetto era già stato tematizzato al termine degli Studi sull’isteria in senso dinamico e qualitativo rispettoad una sua precedente formulazione meccanicistico-fisicalista.Ora, nel contesto metapsicologico della parte finale della Traumdeutung, la sovradeterminazione viene presentata come uno degli elementi generali delle formazioni dell’inconscio che, come tale, è parte attiva anche nel lavoro onirico. Essa fa sì che ogni elemento del contenuto manifesto del sogno costituisca una stratificazione in cui sono reperibili una serie di significati dotati di coerenza interna.Freud paragona la sovradeterminazione ad una lingua arcaica dove ogni frase è suscettibile di molteplici interpretazioni. Spostamento, condensazione e sovradeterminazione costituiscono quindi, nel complesso,i meccanismi che caratterizzano il lavoro onirico e il modo di funzionamento dell’inconscio.Così, mostrando come “l’interpretazione del sogno è la via regia che porta alla conoscenza dell’inconscio nella vita psichica” ( anche se naturalmente tale conoscenza deve essere integrata dall’analisi di altre manifestazioni psichiche, sia patologiche che normali) Freud ritiene di aver posto le basi per la costruzione di una teoria metapsicologica in grado di confrontarsivittoriosamente con le precedenti concezioni filosofiche del soggetto.
Pluridimensionalità
73
Non si deve però intendere la metapsicologia come utilizzazione teorica generale della somma delle conoscenze particolari accumulate dall’ analisi del lavoro onirico, poiché essa è, fin dall’inizio, attivamente presente ed operante. La “via regia” di accesso all’inconscio attraverso l’interpretazione dei sogni è uno sguardo già metapsicologico che si costituisce e si amplia in un rapporto di reciproca utilità coni risultati dell’analisi minuta della fenomenologia della vita onirica.I tre processi di formazione del sogno ( spostamento, condensazione e sovradeterminazione ) sono perciò contestualmente considerati, in termini metapsicologici, da tre punti di vista : topico, economico e dinamico.L’economico designa tutto ciò che nell’apparato psichico può essere suscettibile di aumento, diminuzione, di comparazione e di equivalenza. Esso riguarda dunque la dimensione ‘quantitativa’ della vita psichica. Freud, non rinnegando totalmente le sue concezioni passate, le integra, ampliando le potenzialità conoscitive in esse presenti, con altre prospettive che nel corso di questo periodo così intenso e fondativo erano emerse i modo sempre più netto.Così il punto di vista quantitativo, dominante nella fase prepsicoanalitica, diviene ora una delle prospettive da cui illuminare la complessa fenomenologia della vita psichica. La suaeffettualità conoscitiva, e questo è il punto più importante, è però vincolata alla sua capacità di integrarsi con gli altri puntidi vista, cioè con quello dinamico , che ci permette di seguire i processi conflittuali ed i giochi di forze che caratterizzano le relazioni tra fisico e psichico e con quello topico che differenzia sottosistemi all’interno del sistema complessivo dell’apparato psichico. In questo modo Freud supera il suo originario meccanicismo fisicalistico non abbandonandolo ma integrandolo nel nuovo sistemateorico, la cui composizione plurale ( economico + topico + dinamico ) lo qualifica però diversamente e quindi lo libera dai limiti del positivismo ottocentesco da cui era storicamente emerso.In realtà sia la prospettiva topica che quella dinamica erano sostanzialmente presenti già nell’analisi delle manifestazioni isteriche, ma ora esse, nel percorrere la “via regia” di accesso all’inconscio attraverso l’interpretazione dei sogni , trovano la propria ed esplicita fondazione teorica. L’apparato psichico viene
74
ora distinto chiaramente in diversi ‘luoghi’ che si caratterizzanoper la loro specificità funzionale: l’inconscio, la coscienza ed il preconscio . Freud li comprende come risultanti da un lungo processoevolutivo in cui, attraverso una successione di fasi, l’apparato psichico si è strutturato in ‘sistemi’.Da questa differenziazione,resa necessaria ed inevitabile dal processo di ‘civilizzazione’ dell’umanità, che ha posto in essere istanze diverse all’interno dell’apparato psichico, la soggettività si costituisce nel conflitto tra i principi di piacere e di realtà. Perduta la sua originaria unità fisico-psichica, l’uomo trova il proprio fondamento proprio nella ricerca dell’equilibrio tra le tensioni che lo attraversano sia nell’interiorità più profonda che tra questa e la realtà esterna, fonte di divieti, ostacoli e norme sociali che la sua natura desiderante esperisce come repressive. La concezione topica rimanda così a quella dinamica che comprende i ‘movimenti’ tra i sistemi, a loro volta, resi possibili dalla presenza e dalla disponibilità all’interno dell’apparato psichico di forze ed intensità economicamente quantificabili. La specificitàdella psicoanalisi, rispetto non solo alle altre teorie psicologiche, ma anche alla letteratura, alla filosofia, alle religioni, che avevano già da sempre colto il carattere costitutivo del conflitto interno dell’essere umano, è allora datadalla sua capacità di mostrare il movimento delle forze agenti del conflitto e le loro ‘ragioni’ in una prospettiva evoluzionistica ematerialistica. Nella Interpretazione dei sogni, integrando le prospettive topiche, dinamiche ed economiche in una configurazione sistemica 27Freud ritiene di aver fondato la metapsicologia, che possiamo quindi intendere nei termini di una teoria della soggettività come “interno paese straniero”, costitutivamente inconscio, dilaniato econflittuale.Uno dei concetti principali attorno a cui Freud sviluppa ed integra queste tre prospettive è quello di energia psichica, categoria
27 E’ questo un punto di arrivo di un percorso iniziato nel 1891 con uno studiosull’afasia. A partire da questo breve ma importante scritto fino al periodo immediatamente precedente alla stesura della Traumdeutung , Freud progressivamente si adopera alla definizione di queste tre prospettive che trovano la loro effettualità conoscitiva solo dopo il superamento dell’esperienza del Progetto per una psicologia scientifica. ( Testo comunque fondamentale, anche se poi verrà abbandonato, perché rimane per Freud una fonte da cui attingere continuamente per le sue opere successive, in particolare per il VII capitolo della Interpretazione dei sogni dove la ‘metapsicologia neurofisiologica’ trova nuove ed inedite formulazioni sul piano propriamente psicoanalitico.
75
fondante in cui originariamente convergevano tutti i passati tentativi di comprendere l’intero funzionamento della psiche in termini di quantità oggettivamente determinabili e misurabili. Sono proprio le trasformazioni del concetto di energia psichica che possono mostrarci il carattere sistemico faticosamente conquistatoda Freud attraverso il complesso itinerario che qui si è cercato di ricostruire nei suoi elementi essenziali. Nel quadro teorico che è progressivamente emerso dopo gli Studi e che ha visto definirsi le prospettive dinamiche e topiche, il concetto di energia conosce una irreversibile modificazione, la cui prima conseguenza è il suo sdoppiamento in energia libera ed energia legata. Con la prima designazione Freud intende la quantità di energia psichica che fluisce in modo rapido ed immediato nel processo primario. Questo movimento si caratterizza per il suo continuo slittamento di senso attraverso i processi di spostamento, condensazione e sovradeterminazione ed è deterministicamente rivolto alla ricerca del reinvestimento di rappresentazioni( tracce mnestiche di percezioni ) connesse ad esperienze di soddisfacimento ( identità di percezione \ allucinazione). In realtà per qualificare questo tipo di energia l’aggettivazione libera dovrebbe essere posta tra virgolette, in quanto essa, pur muovendosi in modo incontrollato, è necessitata dalle esigenze della sua natura desiderante che non può non cercare il reinvestimento allucinatorio delle originarie esperienze di soddisfacimento.In termini più diretti : il desiderio non può far altro che desiderare sé stesso, anche se questa necessità trova espressione in un universo complesso di simboli e di segni. L’energia libera ( liberamente mobile ma non liberamente trasformabile ) si esprime come forza e come movimento nel processo primario ( aspetto economico e aspetto dinamico ) mentre, rispetto alladifferenziazione topica, essa si sprigiona all’interno del sistemainconscio.L’energia legata invece procede in modo meno rapido e diretto ; il movimento verso il suo soddisfacimento ( è sempre il desiderio chemuove lo psichico nella sua totalità ) risulta controllato e perciò ritardato. Si impone cioè una valutazione ‘realistica’ delmondo esterno, che la costringe ad un soddisfacimento differito estrinsecandosi attraverso le modalità del pensiero vigile, dell’attenzione e della coerenza logica del processo secondario. Se nell’energia libera c’è slittamento di senso e identità di percezione,
76
qui c’è presenza di senso o comunque ricerca di esso e identità di pensiero. E’ per noi particolarmente interessante e significativo notare come i concetti di energia libera e legata vengono originariamentederivati da Helmhholtz e da Breuer, cioè dal paradigma positivista, per poi trovare una configurazione all’interno di un quadro teorico che, rivolto a rendere conto delle dinamiche qualitative tra fisico e psichico, supera la loro originaria valenza neurofisiologica (Breuer) e fisica (Helmoltz). E questo èproprio ciò che distingue Freud dal fisicalismo e dal positivismo dei suoi maestri ; l’ enucleazione di concetti e prospettive conoscitive dal loro originario ambito teorico-epistemologico ed il loro inserimento all’interno di un nuovo quadro teorico integrano le prospettive topiche, dinamiche ed economiche, ponendocosì l’analisi dei processi psichici su un piano in cui non è più possibile tracciare confini tra quantità e qualità.In questo modo l’interrogativo che era al centro del Progetto, “che cos’è la qualità ?”, invece di ricevere una risposta viene dissolto nella considerazione della complessità della vita psichica come un intreccio di relazioni, di tensioni, di trasformazioni energetiche tra luoghi della mente che sfuggono ad una categorizzazione in termini o quantitativi o qualitativi.Si può allora dire che la psicoanalisi nasce nel momento in cui non è più possibile porre il problema della qualità della vita psichica come problema da affrontare dopo quello della quantità ? L’evoluzione del concetto di energia, con la sua duplice articolazione in energia libera ed energia legata, costituisce unodei principali momenti del tentativo di Freud di superare questa dicotomia che è tutta all’interno del paradigma oggettivistico e causalistico del positivismo, anche se, nonostante questo inequivocabile distanziamento da tale paradigma, permane la ‘solidità’ di una considerazione della vita psichica nei termini dello scientismo positivista. 28
28 Non è possibile , all’interno di questo testo, rendere conto della vastissima letteratura cresciuta intorno alla questione della legittimazione scientifica della psicoanalisi. Un breve riferimento ad uno dei maggiori critici ed interpreti di Freud, J. Habermas , (Conoscenza ed interesse, Laterza, Bari, 1970) ci è comunque utile per sottolineare la coesistenza nella psicoanalisi di due elementi tra loro contraddittori. “La psicoanalisi è per noi importante come il solo tangibile esempio di una scienza che metodicamente fa appello all’autoriflessione”. Accanto a questa valutazione positiva che riconosce alla psicoanalisi la capacità di operare una riflessione critica sulle proprie produzioni conoscitive, Habermas evidenzia anche l’autofraintendimento scientistico freudiano, che viene addebitato alle problemiche che inevitabilmente incontra una teorizzazione che apre nuovi orizzonti di pensabilità del soggetto in un
77
Inconscio, caos e creazione
“Il diritto di ammettere l’esistenza di una psiche inconscia e di lavorare scientificamente in base a questa ipotesi ci viene contestato da più parti. A nostra volta possiamo replicare che l’ipotesi è necessaria e legittima, e che abbiamo parecchie prove dell’esistenza dell’inconscio”.Così, nel1915, Freud inizia il suo saggio sull’inconscio .Per qualificare a grandi linee il concetto di inconscio, che è l’ ‘oggetto’ della psicoanalisi, partiamo da una osservazione di carattere filologico. Prima di questa denominazione Freud, all’inizio della sua attivitàdi ricerca, fu indotto ad utilizzare il termine subconscio invece chedi inconscio, poiché la diffusa e comune identificazione di ‘psichico’ e ‘conscio’ lo indusse a non interferire con questo principio, che, d’altra parte, era autorevolmente legittimato dalla filosofia, essendo per la sua tradizione di pensiero una contraddizione insostenibile qualificare come psichico ciò che nonfa parte della coscienza. Molti anni più tardi lo stesso Freud, nella ricostruzione della storia del movimento psicoanalitico, non mancherà di ricordare questa convergenza del senso comune e della filosofia nel porsi come ostacoli allo sviluppo della psicoanalisi, teoria che è stataqualificata come ‘rivoluzionaria’ proprio per il fatto di aver ‘scoperto’ l’esistenza di una dimensione della realtà che fino ad allora non solo era sconosciuta, ma che non era neanche pensabile secondo le categorie della filosofia e del senso comune. Infatti l’inconscio che scopre la psicoanalisi è ‘altro’ dalle dimensioni nascoste e più o meno profonde della soggettività precedentemente intuite da scrittori e filosofi come, ad esempio, le “piccole percezioni” di Leibniz.L’inconscio di Freud è un prius ontologico che totalizza l’intera fenomenologia della vita psichica del soggetto’, è il “cerchio maggiore che racchiude in sé quello minore del conscio” e che,
contesto teorico-epistemologico rivolto invece a chiudere, attraverso le forme della razionalità positivistica, entro confini oggettivistici qualsiasi dimensione della realtà, compresa quindi anche quella del soggetto.
78
conseguentemente, rovesciando l’identificazione tra psichico e conscio, pone l’inconscio come lo “psichico reale”.Abbiamo visto come con gli Studi sull’isteria Freud arriva ad accertare, nel fuoco della prassi terapeutica, l’esistenza di processi psichici profondi e potenti che vengono per la prima volta qualificati come “inconsci”. Il problema che al termine di quest’opera si poneva era quello di comprenderli nella loro dinamica e nella loro relazione con gli atti psichici consapevoli.Proprio nelle pagine conclusive del testo Freud si interroga su quale possa essere la via che può condurlo ad esplorare tale dimensione inconscia, essendosi subito rivelatasi come inaccessibile ad una indagine diretta.Come aprire alla conoscenza un luogo che, per propria essenza, è inaccessibile? Ci si deve limitare ad una più o meno vaga consapevolezza che la vita psichica non si esaurisce negli atti consapevoli,ma poggia sudelle vaste ed abissali profondità, però assolutamente insondabili?Oppure l’inconscio (di per sé inconoscibile) è qualcosa che può essere indagato attraverso sue manifestazioni altre come i sogni, i sintomi, i lapsus, le dimenticanze ecc.?L’ Interpretazione dei sogni costituisce la risposta affermativa a questosecondo interrogativo essendo la “via regia” che consente finalmente a Freud di pervenire al proprio oggetto di investigazione attraverso l’analisi di uno dei suoi principali derivati ( il lavoro onirico attraverso cui si formano i sogni ).E’ questo un decisivo punto di arrivo poiché ciò pone le condizioni per l’organica costruzione di un sistema di concetti e categorie che Freud intende chiaramente in termini di una nuova ontologia della soggettività.Come si è già visto, si definisce, in primo luogo, una visione topica, dinamica ed economica della vita psichica in cui l’inconscio risulta l’elemento centrale e fondante della soggettività.Esso infatti non è una seconda coscienza ‘oscura’ ma un luogo psichico che ha in sé energie, contenuti e meccanismi che lo qualificano in modo specifico come lo “psichico reale”.Nel corso della sua opera Freud ha formulato il concetto di inconscio da più punti di vista, ora restringendone i confini in termini ontogenetici ( riferibili all’individuo), ora estendendonei contenuti e l’azione in termini filogenetici ( riferibili alla specie). Nell’ Interpretazione dei sogni sono presenti entrambe le prospettive. Da una parte l’inconscio trova origine in relazione a
79
ciò che è infantile e a ciò che è rimosso, costituendosi quindi sulla base del vissuto individuale.Dall’altra, il suo nucleo più essenziale e remoto rimanda ad una dimensione pre o sovraindividuale.Nell’analisi dei sogni riemergono infatti sia contenuti rimossi, più o meno direttamente riconducibili ad esperienze infantili, siacomplessi simbolici riconducibili a forze ed a energie impersonali, cioè a determinazioni filogenetiche che lasciano trasparire l’esistenza di una realtà sovraindividuale.“ Ogni sogno ha perlomeno un punto in cui esso è insondabile, quasi un ombelico attraverso il quale esso è congiunto all’ignoto”. E’ significativo che questa considerazione venga formulata nel contesto dell’analisi di uno dei sogni più celebri della Traumdeutung , quello di Irma, in cui Freud mostra all’opera l’efficacia conoscitiva del sapere psicoanalitico nella decifrazione del contenuto di un sogno particolarmente arduo da interpretare.Questa dimensione ignota ed impersonale del sogno ci conduce alla seconda topica ( Es, Io e Super-Io ) formulata da Freud negli anni 1920-23.Il termine Es viene derivato, attraverso George Groddeck (medico e psicoanalista che elabora in modo spregiudicato e radicale il pensiero di Freud), da Friedrich Nietzsche. Nella lingua tedesca Esè il pronome neutro di terza persona e viene usato in qualità di soggetto dei verbi impersonali. Corrispondendo al latino Id designaciò che vi è di impersonale e, nello stesso tempo, di necessario edi ‘oggettivo’ nella psiche umana.Es allora è forza sconosciuta, energia primigenia, pulsionalità pura ed indomabile; pur equivalendo approssimativamente al sistemainconscio della prima topica, se ne differenzia per due aspetti fondamentali.In primo luogo l’Es non si identifica prevalentemente con il rimosso, così come sostanzialmente finiva per fare il sistema Inc. Ora anche parti dell’Io e del Super-Io, che sono da un punto di vistagenetico derivazioni dall’Es, risultano ancora parzialmente inconsce. La seconda topica non è dunque alternativa alla prima ma bensì integrativa, anche se definisce i suoi sistemi in modo diverso, come per esempio accade con il sistema Inc che ora è più esteso rispetto allo ‘spazio’ che occupava nella prima topica.In secondo luogo l’Es viene qualificato come “il grande serbatoio” della libido, come polo pulsionale della personalità che, al pari dell’inconscio, non può essere conosciuto direttamente e quindi positivamente analizzato e descritto.
80
Dell’Es si può allora dire solo ciò che non è : “ ..non ha una organizzazione, non promuove alcuna volontà generale..”, non presenta determinazioni specifiche poiché è puro caos, entità indifferenziata in cui coesistono forze, impulsi ed energie tra loro contraddittorie che, nello stesso tempo, non si elidono a vicenda.Il pronome neutro con cui questa forza cieca ed indistinta è indicata esprime appropriatamente l’assenza di una identità positiva e coerenteNel passaggio dalla prima topica alla seconda e nella centralità che l’Es assume nell’evoluzione del pensiero di Freud possiamo allora cogliere l’esito finale di un approccio che prende avvio dall’interrogazione filosofica sulle relazioni tra corpo e mente.Con la teoria dualistica delle pulsioni ( Eros e Thanatos ) e la seconda topica, la risoluzione di questo interrogativo originario si definisce su un terreno filogenetico e naturalistico. Come abbiamo già ricordato l’inconscio non si identifica più solamente con il rimosso , che è riconducibile alla singolarità divicende esistenziali più o meno traumatiche e produttrici di processi di rimozione, poiché anche parti dell’Io e del Super-Io sonolargamente inconsce. Conseguentemente la nuova visione freudiana della vita psichica, facendo emergere quello che in parte era già contenuto nelle precedenti opere, risolve il problema della relazione tra corpo e mente in termini sempre più biologizzanti e naturalistici, all’interno di un orizzonte in cui ontogenesi e filogenesi trovano una integrazione progressivamente più vincolante.La genesi delle diverse istanze della psiche ( Es, Io e Super-Io ) è vista come un processo di progressiva differenziazione ed organizzazione di un originaria realtà fisico-psichica indistina edominata dai moti pulsionali e scariche liberatorie di energie e tensioni . Come accade nella cultura e nella filosofia greca classica, in cuila creazione equivale ad un ordinamento ed a una differenziazione di una materia caotica originaria ( Caos = Nulla \ Kosmos = Mondo,Ordine ), così per Freud la nascita della coscienza e del senso morale, cioè la nascita di ciò che è propriamente psichico ed umano, avviene attraverso un lungo processo che dal caos iniziale pone progressivamente in essere attività psichiche specifiche e funzionalmente interrelate. La ricerca psicoanalitica, che aveva trovato origine dal problema del rapporto tra fisico e psichico, approda così ad una ri-
81
costruzione genealogica della mente e della coscienza di tipo naturalistico e biologizzante.
Incivilimento, Coscienza, Fantasma
Ciò che allora qualifica essenzialmente la concezione freudiana, rispetto soprattutto alla considerazione filosofica della soggettività, è la convinzione che, a monte del processo di emancipazione dell’uomo dalla naturalità indistinta originaria, non c’è un progressivo riconoscimento della propria inevitabile determinazione interiore alla coscienza ed alla moralità, ma una necessità esterna che proviene dalle esigenze di sopravvivenza fisica dell’individuo e della società. Come in Hobbes, l’ homo natura freudiano, ha dovuto rinunciare alla libera espressione della sua pulsionalità per adattarsi a vivere in situazioni sempre più socialmente interrelate. Nell’opera del 1929, Das Unbehagen in der Kultur ( Il disagio della civiltà, ma sarebbe stato forse più adeguato mantenere la locuzione originariacon Il Disagio nella civiltà ) in cui Freud riflette filosoficamente sugli esiti naturalistici della psicoanalisi ( dopo la cosiddetta ‘svolta’ del 1920 ) , il processo della civilizzazione (Zivilisation ) è ridotto ad incivilimento essendo il soggetto attivamente recalcitrante di fronte alla sua necessità. L’uomo perviene a sé stesso per necessità esterna e non per processo interno di scoperta e di progressiva autodeterminazione; il primigenio “grande serbatoio” dell’Es è un’istanza “crudele” che costringe l’Io , sempre più interrelato in contesti retti da norme e divieti,in una condizione di costante difesa da forze minacciose interne. Nello stesso tempo, da un altro versante, il Super-Io , che affonda le sue radici inconsce nell’Ed, impone in modo sadico e dittatoriale all’Io principi morali e rinunce dolorose. Conseguentemente Freud iscrive all’interno del soggetto un conflitto costitutivo ( Ichspaltung ) tra “l’Io e l’Es” (1922), che è anche iltitolo di un’opera fondamentale successiva alla formulazione dellateoria dualistica delle pulsioni.
82
La “peste” 29 che Freud riteneva di portare con sé nel suo viaggio statunitense è questa precipitazione del soggetto, che la filosofia costruisce nel suo asettico laboratorio, nell’incondizionato mondo dell’Es dove viene dissolta ogni evidenzafondata sui principi logici della ratio metafisica occidentale. Il pensiero, la coscienza, la fede morale e tutto ciò che vi è di piùalto e spirituale nell’uomo viene iscritto nel processo di incivilimento ( Zivilisation ) che necessariamente ha imbrigliato l’originaria fluidità naturale del desiderio. Come Nietzsche, Freud riconduce alla radice umana, troppo umana, le grandi conquiste spirituali e morali. Nella definizione freudiana della coscienza “come un organo di senso che percepisce un contenuto chesi dà altrove” riecheggiano le parole di Nietzsche sull’origine del logico determinato “da un conflitto di istinti” di cui noi “sperimentiamo di consueto solo il risultato della lotta, tanto rapido e nascosto si svolge oggi il funzionamento di questo primordiale meccanismo”.30 Freud e Nietzsche riducono così la coscienza ad un “organo di senso” che si è originato per esigenze di sopravvivenza. Non è quindi casuale che L’interpretazione dei sogni si concluda, nietzscheanamente, in questo modo :
“E’ istruttivo imparare a conoscere il terreno, profondamente scavato, sul quale si ergono fieramente le nostre virtù. La complessità di un carattere d’uomo, aperto dinamicamente in tutte le direzioni, si adatta assai di rado a una liquidazione per mezzo di una semplice alternativa, come vorrebbe la nostra antiquata dottrina morale.”
In sintonia con la decostruzione nietzscheana delle concezioni filosofiche del soggetto e della sua moralità, Freud, al termine dell’opera in cui ha faticosamente conquistato la prima sintesi metapsicologica, puntualmente, rivendica alla psicoanalisi la capacità di indagare la pluridimensionalità e la complessità del soggetto e dei suoi vissuti, ponendola di fronte alla sterilità conoscitiva della filosofia che , nel corso della sua storia, non ha prodotto altro che superficiali identificazioni tra coscienza evita psichica.
29 Freud così si rivolge a Jung nel giorno della partenza per gli Stati uniti, dove erano stati invitati per una serie di conferenze presso Università e Centridi ricerca.
30 F.Nietzsche, La gaia scienza,Milano,1965, Adelphi, p.44.
83
Sia in virtù del lavoro analitico ( che svela i significati dei sogni ) sia in conseguenza dell’azione terapeutica ( la cui efficacia e incisività sui pazienti, retrospettivamente, convalidala teoria in base alla quale essa ha preso avvio ) il sapere psicoanalitico può, in pieno diritto, rivendicare la facoltà di “ fornirci chiarimenti sulla struttura del nostro apparato psichico che finora abbiamo atteso invano dalla filosofia” 31 e quindi consentire a Freud di avventurarsi in affermazioni ontologiche di questo tipo :
“ Il pensiero non è altro che il surrogato del desiderio allucinatorio ed è ovvio che il sogno sia l’appagamento di un desiderio dato che nulla , all’infuori di un desiderio, è in grado di mettere in moto il nostro apparato psichico.”
Che cos’è allora la mente per Freud ? E’ un teatro in cui vengono eternamente rappresentate le vicende della natura desiderante dell’uomo ? Come abbiamo visto, il desiderio è qualcosa di essenzialmente diverso dal bisogno poiché ha a che fare più con dei segni piuttosto che con delle cose. Naturalmente il desiderio è rivolto alla ricerca dell’oggetto nel reale ( è cioè teso alla sua realizzazione ) ma tale ricerca passa attraverso l’universo semiotico che si è prodotto a partire dalle sue originarie esperienze di soddisfacimento.Come Freud ha potuto constatare nella indagine sui sogni, il desiderio è costitutivamente connesso al linguaggio. 32 Esso si radica quindi nella dimensione fisiologica come segno e traccia mnestica di esperienze di soddisfacimento dei bisogni. A questo punto il desiderio, come entità che esprime psichicamente la pulsionalità del corpo, come si connette all’apparato psichico nelsuo insieme ? Formulando la domanda nei termini iniziali: che cos’è la mente in rapporto al desiderio? Che cosa la connette ad esso ?
31 OSF, III, p.140.32 “Il sogno ed i suoi analoghi vengono a collocarsi in una regione del linguaggio che si preannuncia come luogo delle significazioni complesse in cui un altro senso nello stesso tempo si dà e si nasconde in senso immediato”. P.Ricoeur, Della interpretazione, cit,. p.17
84
Freud risponde in modo che può, in prima battuta apparire paradossale, cioè elaborando un concetto fondamentale della psicoanalisi, quello di fantasma.Anche qui occorre un premessa filologica in quanto fantasma traduce il termine tedesco phantasie, il cui significato è più ampio rispetto alla sua traduzione italiana. Fantasma infatti restringe il campo semantico del termine ad una particolare formazione immaginaria mentre phantasie evoca una dimensione ed una attività immaginativa più ampia e generale ( attività fantasmatica ).Si è visto precedentemente ed appena ricordato come il desiderio cerca la propria realizzazione interamente guidato dalla relazionecon le precedenti percezioni di soddisfacimento. Infatti per Freudsono proprio le configurazioni di segni in cui si strutturano queste esperienze che costituiscono i fantasmi.“ Il primo atto di desiderio pare sia stato un investimento allucinatorio del ricordo del soddisfacimento”.Il fantasma è dunque presenza nella dimensione immaginaria in cui viene messo in scena il desiderio ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è meno ‘reale’ della realtà comunemente intesa. Anche se inizialmente Freud muove da un’opposizione tra immaginazione e realtà nella tematizzazione del concetto di fantasma, ben presto, cioè all’indomani del crollo della teoria della seduzione traumatica infantile, tale concetto viene pensato all’interno della dimensione della realtà psichica che, a sua volta, costituisce una categoria necessaria e fondante della psicoanalisi.La realtà psichica non equivale all’interiorità, cioè a quello che comunemente designa il campo della psicologia, ma a ciò che assumevalore effettivo per il soggetto. La realtà psichica è ciò che è presente nell’apparato psichico in modo strutturato, resistente inmodo tale da poter essere commisurato alla concretezza della realtà materiale: essa equivale essenzialmente al desiderio inconscio ed ai fantasmi ad esso connessi.Secondo Ricoeur “la realtà non è, come in psicologia, l’ordine degli stimoli, così come li conosce lo sperimentatore, ma è il senso vero che il paziente deve attendere attraverso il dedalo oscuro del fantasma. Questo rapporto al fantasma (…) costituisce la specificità del concetto freudiano di realtà”. 33 Il momento in cui il concetto di fantasma viene da Freud elaborato ci rivela tutta la sua centralità nella psicoanalisi; esso infatti segna il passaggio dal periodo prepsicoanalitico a quello propriamente 33 P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Milano, Jaca Book,1972, p.202.
85
psicoanalitico, essendo stato definito conseguentemente all’abbandono da parte di Freud della ricerca delle cause delle nevrosi negli episodi di seduzione traumatica subiti dai suoi pazienti nell’infanzia.Freud si accorge cioè che il ruolo patogeno poteva essere esercitato, oltre ché dagli eventi reali, anche dalla ‘concretezza’ di ciò che è contenuto in forma di fantasma nella psiche del soggetto. Ciò comporta che il fantasma, come contenuto principale della realtà psichica, è qualcosa di essenzialmente diverso da una generica e non altrimenti qualificata dimensione immaginativa per gli inestricabili e costitutivi vincoli interni che lo connettono al desiderio e all’ inconscio. L’individuazione di questa configurazione sistemica di desiderio, inconscio e fantasma è dunque unaprima risposta di Freud agli interrogativi sulle relazioni tra fisico e psichico che avevano mosso la sua attività teorica fin dagli anni degli studi universitari. Il luogo elettivo in cui avviene la connessione tra queste due dimensioni è proprio il concetto di fantasma attraverso cui la spinta pulsionale e il segno che la rappresenta trovano la loro fondazione unitaria. Come vieneribadito da Ricoeur 34 è la dimensione fantasmatica che connette l’approccio quantitativo a quello qualitativo.Proprio nel VII capitolo della Interpretazione dei sogni , cioè nel capitolo in cui la riflessione metapsicologica affronta per la prima volta in modo organico l’articolazione tra energetica ed ermeneutica, il concetto di fantasma trova una connessione necessaria ed essenziale con l’inconscio, anche se possono darsi sue manifestazioni consce ed originarie.Infatti qui si qualifica il desiderio come inconscio e fantasmatico: nel lavoro onirico il fantasma è ciò che unifica i due estremi del sogno essendo, da una parte, legato ai desideri inconsci profondi( e quindi, in un ulteriore scavo, alla dimensione fisica della pulsionalità ) e, dall’altra, al processo di elaborazione secondaria ( cioè relativa al lavoro psichico di formazione del sogno).Il fantasma è quindi a monte ed a valle dell’attività onirica che, come sappiamo, è una delle principali manifestazioni della vita
34 “Economia del desiderio, sì, ma attraverso la semantica del desiderio. Energetica, sì, ma attraverso una ermeneutica. E’ all’interno e per mezzo degli effetti di senso che lo psichismo lavora.” ( Ricoeur, Della interpretazione, cit, p.201.)
86
dell’inconscio, che a sua volta è “lo psichico reale”, il “cerchiomaggiore che racchiude quello minore del conscio”.La fitta rete di rimandi e connessioni vincolanti tra inconscio, desiderio e fantasma è contenuta nello stesso termine freudiano Wunschphantasie ( fantasma di desiderio) che ovviamente va dislocato nella dimensione inconscia.L’originaria ‘fisica speculativa dell’anima’ approda ora alla complessità delle connessioni che attraversano la dimensione psichica del desiderio inconscio, la sua messainscena fantasmatica, la dimensione fisica della pulsionalità ed il suo carattere prevalentemente sessuale.Così come era avvenuto per l’inconscio ed il desiderio ( ricondotti in ultima analisi alla dimensione fisiologica dell’Es e al dualismo ‘naturalistico-ontologico’ delle pulsioni di vita(Eros ) e di morte ( Thanatos ), Freud definisce in una dimensione filogenetica e naturalistica il concetto di fantasma, proiettandolo così nello scenario evolutivo dello sviluppo dell’umanità.“E’ possibile che tutti i fantasmi che ci vengono raccontati oggi nell’analisi (...) siano stati un tempo alle origini della famiglia umana, una realtà, e che il bambino, nel creare fantasmi,si limiti a colmare, con l’aiuto della verità preistorica, le lacune della verità individuale.” 35
I fantasmi originari per Freud scaturiscono da esperienze universali nella sfera sessuale ( scena originaria, castrazione, seduzione ) e vengono trasmessi ereditariamente di generazione in generazione. Il concetto di fantasma originario, in quanto costituente della soggettività non riconducibile alla singolarità dei vissuti individuali, non può allora occupare una posizione marginale nellateoria psicoanalitica poiché la sua rilevanza e centralità è data anche dal fatto che esso può essere agevolmente posto in relazionecon l’altra grande esperienza universale che per Freud struttura lo sviluppo dell’individualità, cioè il complesso di Edipo.Così come nell’analisi dei desideri ostili o amorosi del bambino nei confronti dei propri genitori Freud supera sia la singolarità della dimensione individuale che quella delle culture, per accedere a quella della ‘specie’, nello stesso modo riconduce le immagini fantasmatiche ad una dimensione che travalica i confini della soggettività individuale.
35 OSF, XI, p.527.
87
I fantasmi originari ed il complesso edipico sono dunque elementi invariabili e presenti , pur se necessariamente in diverse forme, in ogni società e cultura.In estrema sintesi si può allora dire che la ‘sostanza’ della realtà psichica è da Freud ontologicamente compresa attraverso la progressiva tematizzazione e l’elaborazione dei concetti fin qui presi in considerazione, desiderio, inconscio, fantasma e dei loro correlati ( rimozione, pulsione, rappresentazione, affetto, ecc ) ed all’interno di prospettive generali ( topiche, dinamiche ed economiche\ processo primario-secondario\ pulsioni di vita -pulsioni di morte ) che , nel corso dell’evoluzione del suo pensiero, inclinano sempre più verso una inestricabile congiunzione di una dimensione naturalistica e biologizzante con una di natura linguistica e culturale. Il percorso che dalla originaria adesione alla Filosofia della natura conduce Freud alla fase più matura della sua opera può essere visto complessivamente come una progressiva costruzione di questa rivoluzionaria coesistenza di una energetica con una ermeneutica della soggettività che pone al pensiero filosofico unasfida che non può essere evitata semplicemente con una valutazionedella psicoanalisi nei termini di un ineffettuale scientismo di matrice positivistica. Il tortuoso itinerario, di cui abbiamo cercato di ricostruire i passaggi centrali, che la ricerca freudiana ha dovuto percorrere testimonia come il pensiero psicoanalitico abbia operato un rivolgimento filosoficamente significativo nella ratio della speculazione metafisica occidentale.La ‘scoperta’ dell’inconscio ha fatto emergere qualcosa che si pone su un piano diverso dal principio di non contraddizione e dalle categorie che da Aristotele in poi hanno contrassegnato lo sviluppo del sistema di sapere occidentale.La dimensione che la psicoanalisi ha portato alla luce non è certamente ciò che i filosofi avevano, prima di Freud, intravisto o intuito ; essa sfugge alla presa delle categorie che la voglionocomprendere come l’altra faccia della psichicità consapevole.Gli interrogativi che allora, a questo punto, si pongono, riguardano sia la consapevolezza della psicoanalisi di essere una “scienza di frontiera”, sia il fondamento della sua autorivendicazione di sapere rivoluzionario. Da quanto emerge in modo esplicito dall’opera freudiana si può rispondere in un duplice modo poiché Freud, da una parte, rivendica l’alterità dell’inconscio rispetto alle nozioni tradizionali di coscienza e di soggetto ma , dall’altra, configura
88
la sua scoperta e la sua analisi entro i confini della razionalitàclassica deterministica e meccanicistica emersa dalla rivoluzione scientifica galileiano-cartesiana.In questo modo la psicoanalisi mostra in modo evidente il suo limite autoriflessivo, cioè la sua difficoltà assumere tutta la valenza filosofica della sua evasione dalla ratio del pensiero occidentale.Come già ricordato, questa contraddizione è interpretata da Paul Ricoeur 36 nei termini di una compresenza nell’opera freudiana della relazione tra una energetica ed una ermeneutica, la cui configurazione pone conseguentemente il problema decisivo.Secondo il filosofo francese “la ragion d’essere della psicoanalisi” è proprio data dalla coesistenza di una prospettiva quantitativo-energetica con una qualitativo-ermeneutica che quindinon va intesa come contraddizione insanabile ma come l’elemento fondativo della sua ‘rivoluzione’.Infatti “l’energetica passa attraverso una ermeneutica, e l’ermeneutica scopre una energetica.Questo punto è quello in cui la posizione del desiderio si annuncia entro e mediante un processo di simbolizzazione”.37
La configurazione che assume la relazione dei concetti fondamentali della psicoanalisi – desiderio, inconscio, fantasma –può allora essere letta proprio da questa prospettiva: il freudismo è costituito essenzialmente da un intreccio – mai esperito nella tradizione filosofica occidentale – tra una spiegazione di tipo naturalistico ed una comprensione di natura fenomenologico-ermeneutica.“Pare a me che tutto il problema dell’epistemologia freudiana si concentri in un unico interrogativo:come è possibile che la spiegazione economica passi attraverso una interpretazione che verte sui significati e, in senso contrario, che l’interpretazionesia un momento della spiegazione economica? Precipitarsi in una alternativa è più facile:o una spiegazione di stile energetico, o una comprensione di stile fenomenologico. Ora bisogna ammettere
36 Particolarmente in Della interpretazione, Saggio su Freud e in Il conflitto delle interpretazioni,il cui approccio complessivo al freudismo costituisce il punto di riferimento fondamentale per questo studio37 E’ noto come per Ricoeur, Freud è uno dei tre maestri del sospetto – accanto aMarx e a Nietzsche – ed, in quanto tale, si pone entro una prospettiva impegnatanon “nel compitare la coscienza del senso, ma nella decifrazione delle espressioni” attraverso un’arte interpretativa. In quanto elaboratore di un metodo di decifrazione della “falsa” coscienza ( che teleologicamente aspira ad ampliare il campo e la funzione della coscienza ) Freud è a pieno titolo posto da Ricoeur entro una prospettiva ermeneutica.
89
che il freudismo non esiste se non grazie al rifiuto di questa alternativa” Anche se, come si è cercato di mostrare prima, in Freud permangonoautofraintemdimenti scientistici, è evidente che sia il percorso teorico-metodologico sia quello terapeutico della psicoanalisi è segnato da una progressiva scoperta della dimensione ermeneutica che, nelle opere finali, arriva ad esplicarsi come interpretazionedella cultura e dei diversi modi della rappresentazione ( arte, ideali, religione ) La psicoanalisi fonda dunque la sua ‘rivoluzione’, nonostante il perdurante scientismo del suo fondatore rivolto a mantenere le distanze con la filosofia, sul terreno dove il percorso teorico sisnoda in un itinerario energetico che incontra e si intreccia proficuamente, al di là dei confini epistemologicamente dati, con quello fenomenologico- ermeneutico.
Il demone filosofico
Come pensa però Freud il rapporto tra la psicologia e la filosofia? In queste considerazioni finali si cercherà di individuare gli elementi principali della considerazione di questarelazione ai fini soprattutto di un confronto con le modalità con cui essa si pone nel progetto filosofico di Husserl.Nelle pagine precedenti abbiamo interpretato il percorso verso le conquiste ‘scientifico-filosofiche’ della Interpretazione dei sogni come un “tortuoso itinerario” rivolto a raggiungere una ontologia dellasoggettività che si oppone frontalmente alla filosofia, delegittimando ogni sua possibilità di comprendere le dinamiche reali dei vissuti, della coscienza e della soggettività in generale. Da questo momento in poi Freud radicalizza lo scontro con la filosofia “vera e propria”, cioè con la tradizione filosofica occidentale, fino ad approdare alla inclusione delle produzioni teoriche dei filosofi tra ‘oggetti’ della investigazione analitica.Dall’alto di una conquista teorica che pone di fronte al coscienzialismo della filosofia l’ inquietante magmaticità della parte nascosta della psiche, la psicoanalisi si scopre in grado difornire una interpretazione della ‘funzione’ principale che la
90
riflessione filosofica ha assolto nel corso della sua storia: quella di costruire “sistemi” attraverso cui com-prendere il mondo.Perché può fare questo ?La psicoanalisi, ha ripetutamente asserito Freud, fa parte delle scienze naturali ed in quanto tale acquisisce il suo sapere attraverso un processo conoscitivo, programmaticamente orientato a riflettere criticamente su sé stesso, contrariamente al rigido universo definitorio entro cui la filosofia racchiude irrevocabilmente ogni suo ‘oggetto’. Essa perciò “non invidierà alla speculazione la sua prerogativa difondarsi su nozioni precise e logicamente inattaccabili”, in quanto si “accontenterà di buon grado di alcuni sfuggenti e nebulosi principi di fondo di cui quasi non si riesce a farsi un concetto, sperando che essi si chiariscano strada facendo e ripromettendosi di sostituirli nuovamente con altri”E’ dunque da questa posizione che la psicoanalisi, come “scienza nuova” la cui prassi conoscitiva opera criticamente su sé stessa, può avanzare ‘spiegazioni’ della nascita e della permanenza più che bimillenaria della filosofia nella storia e nella cultura occidentale : sul piano filogenetico essa è funzionalmente giustificata come “una delle grandi istituzioni della nostra civiltà” i cui sistemi hanno risposto alla “necessità” collettiva di “dominare il mondo”.La filosofia, che qui come altrove Freud riduce a Weltanschauung , “procede (...) parallelamente (...) al progredire del dominio dell’uomo sul mondo come una forma di pensiero che si origina all’interno della linea evolutiva che dalla fase animistica raggiunge la fase scientifica attraverso la fase religiosa”.La filosofia è parte quindi del tessuto ideologico della Kultur scaturito dal processo della Zivilisation ( Incivilimento ) che la psicoanalisi è in grado di comprendere nelle profonde forze conflittuali che lo muovono. Ora, senza entrare in modo più dettagliato dentro le considerazioni freudiane verso la filosofia ( che in diversi testiverrà addirittura paragonata ai deliri paranoici ) è evidente comeper Freud la filosofia abbia esaurito la sua funzione storico-culturale, a meno che essa, “ costretta a prendere partito dalla scoperta psicoanalitica dell’inconscio, modifichi “ le sue vedute relative al rapporto tra psiche e corpo, sino a farle corrispondere alle nuove conoscenze”. Ma non è solo la funzione sociale che la filosofia ha assolto nel corso della sua storia che entra nel campo visivo dello sguardo
91
analitico, poiché Freud rivendica alla psicoanalisi anche la facoltà di fornire interpretazioni delle dinamiche pulsionali-inconsce che muovono l’ apparentemente “imparziale lavoro logico” del filosofo. I sistemi filosofici, sul piano della loro produzione individuale,costituiscono così una “psicografia della personalità” che li disloca in una dimensione non solo teoretica, anche se questa mantiene certamente per Freud tutto il suo valore e significato. Iconcetti filosofici acquistano in questo modo significati polivalenti che possono così essere ‘analizzati’ come una scrittura che si radica nell’intera soggettività di chi li ha posti in essere. Ora, nel momento in cui la psicoanalisi si riconosce in grado di ricostruire le “trasformazioni” delle “forze pulsionali” che, in modo più o meno mediato, muovono il lavoro filosofico verso determinate direzioni, è immediatamente evidente l’ autorivendicazione della sua superiorità teorico-conoscitiva rispetto ad una forma di pensiero che, agli occhi del fondatore della psicoanalisi, ha esaurito il proprio compito storico.Conseguentemente Freud porrà il suo veto a tutti coloro che cercheranno di riflettere filosoficamente, cioè secondo la tradizione del pensiero occidentale, su ciò che emerge dalla ricerca analitica e dalla sua prassi terapeutica. L’unica possibilità speculativa a cui è consentito formulare libere riflessioni sulle conoscenze prodotte dalla ricerca psicoanalitica è quella metapsicologica , cioè una possibile formadi pensiero post-filosofica emersa dalle ceneri della metafisica. Da una parte quindi la certezza positivistica della “realtà psichica” e della sua complessa articolazione, dall’altra la libera speculazione su di essa ormai emancipata dal coscienzialismo e dal concezionalismo sterile della filosofia tradizionale.Ma è possibile questa radicale partizione teorica nel campo della fenomenologia della vita psichica?Se, come afferma Ricoeur, la “ragion d’essere della psicoanalisi”-che è di natura rivoluzionaria per il pensiero occidentale – consiste proprio nella fertile coesistenza di una energetica con una ermeneutica, perché Freud struttura la sua attività teorica secondo due chiare linee di sviluppo in cui, da una parte, si adopera all’approfondimento del sapere ‘naturalistico’ della psicoanalisi, e, dall’altra, muove verso l’enucleazione delle virtualità speculative che questo sapere contiene?
92
Inibizione, sintomo ed angoscia (1926), può esemplarmente rappresentare la prima forma di attività teorica, mentre Al di là del principio del piacere, nel cui stesso titolo nietzscheano possiamo già cogliere la sua natura speculativa, (1920) si formulano ipotesi complessive e generali sulla struttura e sulla genesi dell’apparato psichico.La “scienza dell’anima nuova” vivrà cioè tra il lavoro di arricchimento dell’universo concettuale che gli è proprio e la tendenza, o, sarebbe meglio dire, la tentazione irresistibile a darsi una “sovrastruttura speculativa” che però, come precisa preoccupato lo stesso Freud, sarà costantemente esposta al pericolo di cadere tra le “grinfie del demone filosofico”. 38
Nello stesso tempo la decostruzione della filosofia “vera e propria” assumerà un ritmo progressivamente più martellante. Freudarriverà a trovare “concordanze vistose e profonde” tra i sistemi filosofici come “costruzioni di falsa coerenza” che devono soddisfare “l’esigenza (...) della funzione intellettuale che richiede unificazione, coerenza e comprensibilità” e il delirio paranoico trova la sua ragione d’essere nel tentativo di dare un ordine sistematico al caos ed allo smarrimento del soggetto. Nonostante tutto ciò i riferimenti alla filosofia non scompaiono dai testi freudiani poiché essa, così ripetutamente e drasticamente allontanata dallo spazio teorico della psicoanalisi,viene reintrodotta da Freud nella sua opera attraverso una serie di riferimenti ai filosofi. Tutto ciò è contraddittorio ? I riferimenti ad i filosofi, diffusamente presenti in tutti i testi freudiani, non solo non costituiscono motivo di contraddizione o comunque di perplessità rispetto alla posizione che assume Freud nei confronti della filosofia, ma convergono nel valorizzare ulteriormente la psicoanalisi come una esperienza teorica profondamente innovatricee produttiva di un sapere scientifico sulle relazioni tra mente e corpo.Infatti quando Freud cita i filosofi ( in particolare Schopenhauere Nietzsche, figure di pensatori ovviamente molto significativi per le strettissime contiguità tematiche della loro opera con l’universo concettuale psicoanalitico) l’intento è quello di cogliere nelle loro concezioni alcuni anticipazioni dei concetti della psicoanalisi che però, e questo è il punto decisivo, sono stati, attraverso un rigoroso lavoro teorico a cui i filosofi “nonsono avvezzi”, da essa confermati e scientificamente elaborati.
38 Così si esprime in una lettera a L. Binswanger, cit.
93
Quello che allora viene costruito dalla psicoanalisi è qualcosa diessenzialmente diverso dalle intuizioni ‘protoanalitiche’ più o meno vaghe della filosofia. La definizione della psicoanalisi come “scienza dell’anima nuova” risponde quindi all’esigenza di distinguerla chiaramente da tutto ciò che, pur riguardando la dimensione profonda della psiche, è aldi qua del suo spazio teorico.C’è però un ulteriore motivo di presenza dei filosofi nei testi freudiani .In diverse occasioni infatti essi sono idealmente chiamati a rivedere le loro concezioni alla luce delle ‘scoperte’ psicoanalitiche come, ad esempio, avviene con Kant. In virtù della scoperta dell’inconscio e della sua atemporalità, Freud propone una revisione delle rivoluzionarie conseguenze dellaprospettiva trascendentale del filosofo di Königsberg fondata sulla apriorità del tempo nella mente umana.E’ quindi evidente come per Freud la metapsicologia si pone direttamente in conflitto con la filosofia nella individuazione delle “forme necessarie del nostro pensiero”, anche se occorre dire che la ricezione da parte di Freud della Critica della ragione pura, nonostante i diversi riferimenti ad essa, è decisamente episodica e priva di una reale comprensione delle premesse e della natura della rivoluzione copernicana operata da Kant. Un’ultima annotazione. Nel 1915 Freud pubblica cinque impegnativi saggi sui concetti fondamentali della psicoanalisi che costituiscono una parte dei dodici previsti e programmaticamente finalizzati, come è stato esplicitamente dallo stesso affermato, acostruire un “sistema psicoanalitico”. Perché allora Freud, il cui motivo principale di critica alla filosofia è proprio rappresentato dalla irrevocabilità entro cui isuoi sistemi rinchiudono il mondo, si adopera, in un modo che ci riconduce alla febbrile attività di stesura del Progetto per una psicologia scientifica, “a chiarire ed approfondire le ipotesi teoriche che potrebbero essere poste a fondamento di un sistema psicoanalitico” ?Anche qui, nel titolo originario dei saggi Preparazione alla metapsicologia, che richiama i Prolegomeni ad ogni metafisica futura di Kant, traspare a chiare lettere, il “desiderio filosofico” freudiano.Ma esso, ancora una volta, nel corso della sua realizzazione, incontra il proprio limite: dopo i primi cinque saggi, scritti in brevissimo tempo, il tentativo ha termine. I cinque scritti verranno pubblicati, senza enfasi alcuna, in riviste di psicologia
94
con un altro titolo, Rassegna delle nevrosi di traslazione che li delimita entro un ambito specificatamente psicoanalitico. Possiamo allora considerare questo episodio, ricorrendo alle stesse categorie psicoanalitiche, come una riattualizzazione della‘pulsione filosofica’ freudiana, che dopo essere stata così faticosamente contenuta, trova il modo di emergere, per poi entrare rapidamente in crisi ed autodistruggersi ?La stessa dinamica caratterizza la sua opera più dichiaratamente speculativa: dopo aver pubblicato Al di là del principio del piacere, Freud, impietosamente, si riferirà ad essa come “ad un qualcosa di molto stupido”.Evidentemente, per chi considera la metafisica “un abuso del pensiero”, la consapevolezza di esporre la propria attività teorica alle “grinfie del demone filosofico” non può non porre in crisi ogni rinato tentativo compiuto in questa direzione.Il sapere critico-materialistico della psicoanalisi si lasciainvece proficuamente sedurre dalla “metapsicologia strega”, senzache questo comporti “vendere l’anima al diavolo”, le cui grinfienon possono afferrare quel pensiero che vuole deprivarledefinitivamente della loro presa.
95
II Capitolo
La critica alla psicologia naturalistica e dualistica: il progetto fenomenologico di una nuova ontologia del mondo della vita.
Premessa
Il 25 Settembre 1906, in una pagina di diario, Husserl così scrive:
“In primo luogo dico i compiti generali che debbo risolvere per me, se voglio potermi chiamare un filosofo. Intendo una critica della ragione. Una critica della ragione logica e della ragione pratica, della ragione valutante. Senza venire in chiaro con me stesso, almeno in tratti generali, circa il senso, l’essenza e i metodi e
96
i principali punti di vista di una critica della ragione, senza aver mediato, progettato, stabilito e fondato uno schizzo generale, non posso vivere in modo vero e veritiero. I tormenti della mancanza di chiarezza, dell’oscillare del dubbio, li ho goduti a sufficienza. Io devo giungere ad una solidità interiore. So che si tratta di qualcosa di alto e sommo; so che grandi geni vi sono naufragati. Se volessi paragonarmi a loro, dovrei disperarmi d’avanzo. Non voglio paragonarmi a loro ma senza chiarezza non posso vivere. Io voglio e debbo con un lavoro di dedizione, con un approfondimento puramente oggettivo, avvicinarmiall’altra meta. Io lotto per la mia vita e perciò credo di poter procedere con fiducia. Le più dure difficoltà della vita, l’autodifesa contro i pericoli della morte, danno una forza insospettata, smisurata. Io non aspiro ad onori e fama, non voglioessere ammirato; non penso agli altri né alla mia carriera. Solo una cosa mi preoccupa: debbo raggiungere la chiarezza se no non posso vivere, non posso sopportare la vita se non credo che ce la faccio, che davvero posso guardare nella terra promessa, e di persona e con lo sguardo limpido.”
Questa stessa passione per la conoscenza che unisce l’uomo e la sua opera possiamo trovarla anche in Freud. L’epistolario con W. Fliess ne è la testimonianza più chiara ed esemplare. In una lettera del 1 gennaio 1896 Freud così scrive al suo amico berlinese:
“ Vedo che per le vie traverse della medicina, ti stai sforzando di raggiungere il tuo primo ideale, la comprensione fisiologica dell’uomo, mentre io nutro segretamente la speranza di arrivare per le stesse vie al mio primo obiettivo, la filosofia. Perché questa fu la mia originaria ambizione, prima di sapere per quale fine fossi al mondo.”
E in una lettera successiva (2 aprile 1896) questa speranza è già prossima alla sua realizzazione:
“ Quando ero giovane, non ero animato da altro desiderio che non fosse quello della conoscenza filosofica, e ora nel mio passaggio dalla medicina alla psicologia, quel desiderio si sta avverando”
Opera e vita rimandano l’una all’altra: i grandi progetti di conoscenza di Freud e di Husserl trovano alimento nei più profondimotivi interiori per convergere, pur da prospettive specularmente
97
opposte, sugli stessi problemi teorici, al centro dei quali dominala relazione tra filosofia e psicologia, anch’essa teoricamente posta ed elaborata da punti di vista radicalmente diversi.39 In questa seconda parte, dopo aver schematicamente individuato le origini di tale relazione nel pensiero di Husserl, vedremo come essa viene sviluppata nella sua ultima opera incompiuta, cioè nella Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (1936), dove giunge alla sua più matura definizione nelle possibilità aperte dalla ricerca fenomenologica.
Psiche e numero
Come e perché, nella sua riflessione sulla natura della logica, ilgiovane matematico Husserl incontra la psicologia?E’ possibile cercare la risposta a questo interrogativo già nella sua prima opera (Filosofia dell’aritmetica, 1891) dove viene posta l’esigenza di una chiarificazione dei rapporti tra logica e psicologia; prendendo posizione su una vivace polemica filosofica sulla natura dei numeri e delle operazioni logiche, che aveva impegnato prevalentemente filosofi tedeschi tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, Husserl mostra subito quello che sarà il tema dominante di tutto il suo progetto filosofico, già strutturalmente delineato fin d’ora e destinato ad un complesso quanto avvincente sviluppo e che si concluderà con la Crisi delle scienzeeuropee e la fenomenologia trascendentale, il cui titolo originario era però La crisi delle scienze europee e la psicologia.Nella Filosofia dell’aritmetica Husserl, tematizzando la relazione tra logica e psicologia, definisce il punto di partenza della sua opera che ruoterà tenacemente intorno alla necessità di fondare 39 Come vedremo nella Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale,Milano, Il Saggiatore,1961 Husserl, pur riconoscendo in parte la validità delle scoperte psicoanalitiche sui “comportamenti inconsciamente motivati”, prende inevitabilmente le distanze da Freud ( “con le cui teorie tuttavia non ci identifichiamo”) (p.258). Da parte sua Freud porrà un veto fermo e deciso, anchese in realtà inutile, al suo seguace L. Binswanger, allievo però anche di Husserl, che aveva sviluppato un approccioantropoanalitico alla soggettività fondato sull’integrazione delle prospettive fenomenologiche e psicoanalitiche.In una lettera del 21 agosto 1917 Binswanger (citata in P.L. Assoun, Freud, la philosophie e les philosophes, Paris, P.U.F., 1976, p.38 ) viene prontamente messo in guardia da Freud sul pericolo di cadere “tra le grinfie del demone filosofico” nelle sue utilizzazioni filosofiche della psicoanalisi.
98
filosoficamente tale relazione, configurandola su un piano teoricomai prima di allora esplorato.Senza entrare nella sua analisi dettagliata, cercheremo di capire come nasce e si sviluppa il problema logico-psicologico a partire dai termini in cui esso si presenta a Husserl nel dibattito che vedeva, da una parte, i logicisti (da Bolzano fino a Russell) affermare l’esistenza indipendente delle leggi e degli oggetti logici e matematici, mentre, dall’altra, gli psicologisti (da Millfino a Mach), ritenevano invece che ogni atto conoscitivo, comprese quindi le leggi logiche e i concetti scientifici, dovesseessere compreso sul terreno della realtà storico-empirica della psiche del soggetto.Gli interrogativi fondamentali di questo dibattito riguardavano dunque in ultima analisi la natura universale e assoluta o particolare e relativa della conoscenza.Questo problema, pur radicandosi nel dibattito scientifico-filosofico di fine ‘800, in realtà non solo ha attraversato, in varie forme e in modo più o meno diretto, gran parte della storia del pensiero occidentale ma si può dire, come d’altra parte ritiene lo stesso Husserl, che su di esso si è costituita la stessa tradizione filosofica del pensiero occidentale.Il ‘problema degli universali’, emerso, sulla base dell’interpretazione della filosofia greca, nell’ambito della logica e della metafisica medievale, è una delle sue espressioni più importanti.Come si ricorderà, tale problema consisteva nel tipo di esistenza dei generi e specie universali di cui si fa continuamente uso in ogni argomentazione (Uomo, Cavallo, Eloquenza, Coraggio ecc.) : sono ontologicamente presenti nelle cose o solo nella mente ? E, se sono in re , cioè nella cosa, hanno una natura corporea o incorporea ?Ed inoltre, possono essere pensati fuori degli oggetti sensibili osono in essi realizzati ?Questi interrogativi, nati da uno scritto (Eisagogè) di Porfirio (233-305, filosofo neoplatonico greco) rivolto ad utilizzare la parte che si riteneva valida della logica di Aristotele nella filosofia neoplatonica, avevano prodotto due possibili soluzioni.Una che vede l’universale come l’essenza necessaria o sostanza dellecose (Realismo), la seconda invece che lo qualifica come segno mentale delle cose (Nominalismo).Così, secondo i realisti, l’universale umanità ha una sostanzialità ontologica permanente che è prima, sopra ed oltre
99
gli uomini individuali, materiali ed accidentali soggetti a ‘generazione e corruzione’. Nella prospettiva nominalista, invece, sono i singoli individui adessere considerati i soli esistenti poiché l’universale ‘umanità’ non è altro che un termine convenzionale o un concetto posto in essere dalle facoltà astrattive della mente umana che, per procedere nella comprensione del mondo (per poi intervenirvi), necessariamente deve cogliere gli elementi comuni ad una molteplicità di oggetti singoli e di realtà date.Ora, nel dibattito intorno alla natura della matematica di fine ‘800 rivive , per molti aspetti, quello sugli universali posto in essere dai logici e teologi medievali, anche se naturalmente la diversità dei contesti storico-culturali qualifica in modo fondamentalmente teologico il problema affrontato dai nominalisti e dai realisti, mentre nella questione discussa dai logicisti e dagli psicologisti tedeschi prevale l’aspetto teoretico-gnoseologico.Comunque, senza entrare nel dettaglio rispetto a come sono state poi ulteriormente articolate nella filosofia scolastica le soluzioni proposte al problema degli universali, ritornando al dibattito tra logicisti e psicologisti sulla natura degli enti matematici, è facile capire come nei primi riemerga la soluzione realista e nei secondi quella nominalista.Infatti, da una parte, gli psicologisti sono rivolti alla comprensione delle modalità logiche attraverso cui la mente umana attivamente costruisce, per generalizzazione, astrazione ed associazione le categorie universali mentre, dall’altra, i logicisti, nell’intento di evitare gli esiti scettici a cui secondo loro conduceva questa posizione, si adoperano a cogliere icontenuti logico-ideali in sé dei concetti, nella convinzione che si possa pervenire alla loro esistenza oggettiva indipendente dalle operazioni psichiche soggettive.In termini più diretti, facendo riferimento ad una celebre battutapolemica di G. Frege (1848-1925), filosofo e logico interessato alla fondazione antipsicologista della matematica, è importante sapere che cos’è il “mare del Nord” e non come si forma psichicamente nel soggetto l’immagine o il concetto di “mare del Nord”.In quest’ultimo caso infatti non può essere evitato un esito scettico, essendo tutti i nostri concetti vincolati ai processi associativi, selettivi, ecc. cioè ad un’attività di costruzione del reale da parte del soggetto in cui viene a mancare ogni carattere di universalità. In sostanza, l’interrogativo di fondo che pone in essere questa contesa, dove riemerge, in forme
100
diverse, la tradizionale opposizione tra razionalisti ed empiristi, si può così definire: se la psicologia si configura come una scienza della particolarità e dell’accidentalità delle operazioni psichiche del soggetto, da dove scaturiscono gli universali logici e matematici e la loro indipendenza dalle operazioni psichiche del soggetto ?La risposta di Husserl a questo interrogativo è per noi particolarmente interessante, poiché è proprio nel modo in cui affronta tale problema che possiamo cogliere, nei suoi caratteri costitutivi ed essenziali, l’origine della relazione tra la futurafenomenologia e la psicologia.Per comprendere la sua posizione rispetto alla disputa tra logicisti e psicologisti, occorre ricordare, anche se in linea molto generale, un concetto elaborato dalla filosofia medievale.Sia per quanto riguarda la formulazione del problema della natura della logica che la sua possibile soluzione, c’è un ‘oggettivo’ rimando, ovviamente filtrato attraverso un millennio di storia delpensiero, ad idee che trovano addirittura origine nella filosofia araba di Avicenna e che si sviluppano poi con Alberto Magno e S.Tommaso.E’ questo il caso del concetto di intentio che Husserl recupera ed utilizza in modo innovativo, sia rispetto alla sua formulazione nella filosofia scolastica, sia relativamente alla sua presenza nella psicologia empirica di Brentano, di cui appunto aveva seguito le lezioni (come aveva già fatto lo stesso Freud dieci anni prima presso l’Università di Vienna).Intentio: nell’ultima fase della scolastica indica il riferimento a qualcosa d’altro da sé, ma, poiché tale nozione originariamente è dapprima stata usata nella sfera pratica (direzione verso l’oggetto), si è sedimentato nel linguaggio comune il significato di intenzione come ciò che si intende fare. Filosoficamente il concetto di intenzionalità, al di là delle varie accezioni che è venuto assumendo nel corso dello sviluppo del pensiero occidentale (che qui ovviamente non possiamo ricostruire), designa invece la relazione costitutiva e ineliminabile tra la coscienza e i suoi oggetti.Brentano recupera tale significato e lo utilizza come categoria generale che consente di individuare e classificare tutti i fenomeni psichici.L’intenzionalità dunque è ciò che qualifica essenzialmente ogni atto psichico come atto di coscienza inseparabile dagli oggetti immanenti ai quali si riferisce o, meglio, entro e per i quali si produce.
101
Così una rappresentazione si forma per riferirsi ad una cosa esterna al soggetto, mentre un giudizio è una presa di posizione su una situazione di fatto o comunque esperibile come dato posto di fronte all’individuo o, ancora, un sentimento viene mosso da una persona o da una particolare realtà che coinvolge, dall’esterno, il mondo emozionale interno.Non potendo essere dunque pensata indipendentemente dai suoi oggetti, la coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Ciò permettea Brentano di sviluppare una Classificazione dei fenomeni psichici (1921) a partire proprio dalla molteplicità dei suoi riferimenti. Ora, senza entrare negli aspetti specifici della psicologia empirica di Brentano, che in realtà poi problematizza la natura degli oggetti (reale o irreale ?) prendendo alla fine posizione a favore dell’ipotesi “realista”, ciò che qui va ricordato è come il principio generale dell’intenzionalità rimane limitato entro una prospettiva solamente psicologico-empirica della coscienza.A questo punto Husserl, pur rifacendosi al suo maestro Brentano, acui riconosce il merito di aver colto l’elemento essenziale della coscienza, assume il concetto di intenzionalità cercando di liberarlo dai vincoli empirico-soggettivi entro cui era stato formulato, per farlo vivere filosoficamente in una nuova dimensione logico-oggettiva.Nella Filosofia dell’Aritmetica è già presente, programmaticamente ma anche già operativamente, l’esigenza del superamento della alternativa radicale tra ciò che è empiricamente psichico e ciò che è idealmente logico. Nel dibattito con i logicisti viene infatti da Husserl sottolineata l’insensatezza di questa alternativa che non consente di pervenire ad una qualsiasi risposta soddisfacente, cioè ad una risposta che in un senso o nell’altro possa essere considerata una soluzione teoricamente valida del problema.In altri termini Husserl pone la questione della natura degli entimatematici su un piano in cui sono poste le condizioni della comprensione della natura logico-oggettiva degli “oggetti universali in sé” senza che questo però comporti, rimanendo con ciò ancora all’interno di una concezione metafisico-platonica, la liquidazione di ogni valore gnoseologico della vita psichica empirico-soggettiva.Come sono presenti gli oggetti matematici e logici nella mente che, al di là della loro genesi empirico-soggettiva, lasciano trasparire una sostanza eidetica e sovraindidividuale ?
102
E’ questo l’interrogativo che Husserl si è posto, con straordinaria lucidità teorica, da subito, già con la sua prima importante opera, Filosofia dell’aritmetica: si potrebbe allora pensare allo sviluppo del suo pensiero come ad una lunga ed articolata risposta a tale interrogativo che dai concetti di “aggregato” , di“pluralità”, di “categorizzazione psicologica”, di “atto dell’interesse e del notare unificanti” arriva, in un’incessante riconfigurazione del problema su altri piani, fino al progetto di costruzione di un’ontologia del mondo-della-vita nella sua ultima opera incompiuta, La Crisi delle scienze europee.
Non è questa una forzatura se lo stesso Husserl così si esprime volgendosi indietro:
“Proprio adesso che ho percorso tutta la strada, cosciente e responsabile dei miei compiti, adesso che con le conferenze di Vienna e di Praga (da cui scaturirà la Krisis-.) , per la prima volta sono riuscito a rifarmi soltanto a mestesso, del tutto spontaneamente, e ho messo le basi di un piccolo inizio, ecco, devo interrompermi e lasciare il mio compito inadempiuto. Proprio adesso, alla fine, adesso che sono finito, so che dovrei ricominciare da capo....”
“Piccolo inizio”: al di là “dell’umiltà e della consapevolezza chesono proprie dei grandi filosofi”, come nota Carlo Sini nella sua introduzione ad un’opera di Husserl , esso può essere inteso proprio come il modo corretto e giusto di impostare la risoluzionedel problema teorico di fondo attorno a cui si è definita la fenomenologia trascendentale.Problema che, originatosi in rapporto al dibattito tra logicisti epsicologisti, è progressivamente cresciuto articolandosi in varie forme ma gravitando, si può dire tenacemente, attorno a due concetti fondamentali : quelli di scienza e di vita conoscitiva dell’uomo.Essi infatti vivono all’interno della ricerca , ad alto livello diastrazione, sui fondamenti logico-matematici di sistemi teorici (la scienza), compiuta unitamente al privilegiamento dell’analisi
103
dei processi conoscitivi immersi nella prassi del mondo-della-vita(vita conoscitiva dell’uomo).Il problema è allora quello di fondare le condizioni di una ricerca volta a comprendere le modalità della manifestazione delleleggi logico-oggettive nella mente umana unitamente alla possibilitàdi quest’ultima di pensare alle verità logico-ideali a priori.Ed è proprio da come si configura la relazione tra scienza emondo-della-vita che emerge la necessità di una chiarificazionesulle strutture generali della coscienza.L’interesse per la psicologia da parte di Husserl scaturiscequindi da problematiche di teoria della conoscenza che possiamocosì sintetizzare :
1) La coscienza è una realtà così come lo sono le altre realtà delmondo? Come può essere qualificata all’interno del mondo-della-vita entro cui essa è immersa? Quali sono i suoi “oggetti”? Qual’èla sua relazione con questi “oggetti” e con se stessa?
2) Che cos’è una scienza “esatta”? Quale sapere produce? Come puòessere garantita la validità e l’universalità delle scienzenaturali? Quali sono le origini delle teorie scientifiche? Qualerelazione si è definita tra scienza, sue applicazioni pratiche emondo-della-vita?
La Filosofia dell’aritmetica contiene i prolegomeni di tali interrogativiche, in questo primo momento, vengono affrontati da Husserl dalversante ‘psicologista’, senza però intendere con ciò lariproposizione di una spiegazione riduttivamente empirico-soggettiva degli enti matematici e logici.Husserl, teso al superamento dell’alternativa tra psicologismo elogicismo, si muove già su un terreno in cui la validità ideale delleoperazioni matematiche e logiche viene gnoseologicamente fondatasui concreti vissuti psichici del soggetto. Così, anche quando, inanni successivi, pressato dalle critiche di Frege che aveva postoprioritariamente l’esigenza di una fondazione puramente logicadelle operazioni matematiche, Husserl criticherà la Filosofiadell’aritmetica, ciò che viene messo in discussione non è certamente lasua finalità ultima - comprendere l’idealità logica tenendo inconsiderazione gli atti conoscitivi reali della soggettività-bensì il rapporto che lì veniva istituito tra aritmetica e logica.Alla critica di Frege, fondata sulla contrapposizione tra numerocome rappresentazione
104
( soggettiva) e concetto (oggettivo), sfuggiva quindi la sostanzadell’interrogativo che Husserl si era posto relativamente alleoperazioni con le quali la coscienza intenzionale costruisce lavalidità ideale degli oggetti matematici e logici.E’ chiaro quindi che, rimanendo valido l’intento di fondodell’opera, il problema che affronta la Filosofia dell’aritmetica è unaprima tematizzazione - non ancora posta in termini propriamentefenomenologici (come avverrà con le Ricerche logiche) - degliinterrogativi che sopra si è cercato di sintetizzare e che segnanol’intero percorso filosofico di Husserl.La domanda che l’uomo (di scienza) si pone, come è il mondo ?, inrealtà deve necessariamente e filosoficamente porsi in un altromodo, cioè come ho il mondo ?.Ciò comporta abbandonare l’atteggiamento conoscitivo di tiponaturalistico per assumere uno sguardo trascendentale orientato, al di làdell’immanenza dell’hinc et nunc, a cogliere i fondamenti e lecondizioni dell’esperienza stessa del mondo. Nella Filosofiadell’aritmetica Husserl “sta già tentando di definire la legalitàinterna degli atti psichici, una legalità che per essere compresaappieno, richiede un approccio ben diverso da quello offerto dallamera psicologia.” 40 La relazione filosofia-psicologia trova così la sua originariaespressione in questo testo in cui Husserl lavora per “salvare sial’oggettività del concetto, sia l’oggettività degli enti chevengono assunti di volta in volta sotto il concetto stesso”arrivando, fin da questo momento fondativo del suo progettofilosofico, a tematizzare, ad esempio attraverso l’analisi dellagenesi dei sistemi numerici a partire dall’uso delle dita dellamano nelle popolazioni “primitive”, ciò che nelle sue operesuccessive verrà definito come Lebenswelt (Mondo-della-vita)Tutto ciò, si è detto, è già presente in questa prima opera diHusserl anche se gli interrogativi da cui essa muove sono relativiad un ambito delimitato della conoscenza, cioè quello relativoalla natura del numero e dei concetti fondamentali dellamatematica.In sintesi: la Filosofia dell’aritmetica è per noi opera particolarmenteinteressante perché è qui che trova origine il rapporto traHusserl e la psicologia, rispetto alla quale viene subito postal’esigenza di una sua emancipazione dai confini naturalistici edempiristi entro cui storicamente essa si è costituita come“scienza”. La nuova formulazione del concetto di intenzionalità è
40 G. Leghissa, Introduzione a E. Husserl, Filosofia dell’aritmetica, Bompiani, Milano, 2001, p.22
105
l’elemento decisivo in base al quale, superando l’alternativa trapsicologisti e logicisti, Husserl coglie all’interno della domandakantiana come ho il mondo ? la necessità di comprendere, in una piùradicale problematizzazione della separazione tra soggetto epredicato, chi è l’io che ha il mondo.
Dalla logica pura al mondo-della-vita
E’ nelle Ricerche logiche che Husserl cerca di perseguire questoscopo. Occorreva però chiarire preliminarmente qual era ilsignificato della posizione “psicologista” che era venuta adassumere, soprattutto agli occhi degli altri filosofi impegnatinel dibattito sulla natura della logica, la Filosofia dell’aritmetica.Per questo Husserl premette alle sei ricerche logiche, i Prolegomenia una logica pura come un necessario momento intermedio tra iltentativo “psicologista” della Filosofia dell’aritmetica e quello“logicista” delle Ricerche logiche (le virgolette ormai sappiamointenderle nel modo giusto, cioè come impossibilità di ridurre ilpensiero di Husserl a questa alternativa).Qui però, pressato anche dalle critiche di Frege e dall’incontrocon la Dottrina della scienza (1837) di B.Bolzano, in cui le veritàlogiche sono assunte come oggettività ideali, Husserl procede aduna liquidazione di ogni equivoco psicologistico in modo tantoradicale da coinvolgere anche la Filosofia dell’aritmetica. Il compito prioritario è cioè quello di difendere “l’inseità”delle operazione logiche dal riduzionismo psicologistico chericonduce sul terreno dell’esperienza sensibile e contingente ogniatto psichico. Ma, come in realtà era già avvenuto con la Filosofiadell’aritmetica, questo intento viene ancora tenacemente perseguitoincludendovi la dimensione della soggettività, anche se quil’analisi è strutturalmente centrata sull’esigenza prioritaria disalvare le leggi logiche dal relativismo e dal convenzionalismocui necessariamente conduce l’approccio naturalistico dellapsicologia.Nel secondo volume delle Ricerche (1901) vi è però una più maturariconsiderazione delle esperienze vissute e quindi delle modalitàin cui le oggettività ideali si incarnano nella soggettivitàempirica. Ciò che consente a Husserl di pensare l’universalità deiprincipi logico-ideali non in opposizione alla particolaritàempirica dei vissuti del soggetto, è l’uso innovativo, rispetto
106
sia alla tradizione filosofica che alla sua ripresa nel campodella nascente psicologia, del concetto di intenzionalità.Non è certamente possibile ricostruire qui, anche solo per grandischemi, l’articolazione delle sei ricerche rivolte a definire lecondizioni di possibilità di una logica pura; questo obiettivoteorico viene perseguito non solo sullo sfondo immediato di uncontesto caratterizzato dalla radicalizzazione dell’alternativatra logicisti e psicologisti, ma anche e soprattutto in rapportoai passaggi fondamentali nella storia del pensiero occidentalemoderno, che per Husserl sono la distinzione kantiana tra fenomenoe noumeno da una lato e a quella cartesiana tra res cogitans e resextensa dall’altro.Come vedremo meglio nell’analisi della Krisis, Husserl assume sia ilproblema della contrapposizione kantiana tra cosa in sé e fenomeno cheil dualismo cartesiano cercando non di risolverli come tali,mantenendo cioè le loro premesse, ma di dissolvere il lorocontenuto oppositivo per poter poi cogliere unitariamente in ogniatto di coscienza, realtà noumenica e fenomeno da una parte e rescogitans e res extensa dall’altra. Questi intenti comportano conseguentemente un arduo lavorofilosofico perché costringono Husserl a pensare contro lecategorie fondanti che si sono sedimentate non solo nellatradizione filosofica del pensiero occidentale ma anche, più ingenerale, nella sua cultura, sia umanistica che scientifica.La ricerca fenomenologica deve così procedere nella radicalità di unapproccio innovativo e nell’indipendenza dalle risoluzioni che lefilosofie precedenti hanno dato ai problemi gnoseologici edepistemologici sul terreno profondamente scavato dallacontrapposizione tra oggettivo e soggettivo e tra fenomenopsichico e fenomeno fisico.Nelle Ricerche logiche Husserl ripensa, a partire dal concetto diintenzionalità e collocandola in uno spazio teorico nuovo, larelazione io-mondo, mostrando innanzitutto come sia impossibileprima “cosalizzare”, come entità tra loro separate, io e mondo, perindagare poi come esse entrano in relazione.Io e mondo sono già una realtà integrata prima di ogniteorizzazione ed il compito della fenomenologia, le cui premessevengono poste in questo testo di intensa elaborazione , è proprioquello di tematizzare la “misteriosa correlazione che sempre sipone tra atti della coscienza intenzionale e oggetti della realtà”considerata dallo stesso Husserl come “l’intuizione piùsconvolgente della sua esperienza di ricercatore”.
107
La “scoperta” di questa correlazione ha immediate conseguenze:ogni tipo di ipotesi e prospettiva assunta dal pensiero filosoficoprecedente sulla “realtà” della coscienza (spiritualismo onaturalismo, idealismo o materialismo) veniva a cadere proprioperché, sul piano teorico della correlazione, non è più ormaipossibile pensare la coscienza come realtà in sé indipendente dalmondo, così come quest’ultimo non è tematizzabile al di fuoridella coscienza, essendo esso sempre mondo percepito, pensato,immaginato, ecc..Quello che ora viene posto al centro della riflessione filosoficaè la relazione stessa tra coscienza e mondo in cui si risolvetotalmente il problema della conoscenza.Nella prospettiva fenomenologica rivive quindi il problemakantiano che , a questo punto, Husserl fa proprio nella prospettivadi superare la distinzione tra fenomeno e noumeno su cui esso erafondato.Infatti per Husserl non si dà più qualcosa che rimane, come cosain sé, al di fuori della coscienza. Ogni residuo di realtàtrascendentali viene dissolto. Tutto è fenomeno della coscienza,così come tutto è fenomeno di mondo, compresa la coscienza.Non essendo allora possibile cosalizzare metafisicamente mondo ecoscienza come res indipendenti che troverebbero poi una qualcheforma di relazione, occorre esplorare questa stessa relazionedalle sue due polarità o dimensioni costitutive: dalla prospettivadella coscienza che nei suoi vissuti si dirige verso l’oggetto,intenzionandolo, (noesi) attraverso l’attività prensiva delricordare, del percepire, dell’immaginare ecc. e da quella dellemodalità con cui l’oggetto si offre alla coscienza come oggettoricordato, percepito, immaginato (noema). Oggetto però non nellasua cosalità, cioè nella sua materialità, ma piuttosto nei dati enei predicati attraverso cui esso si dona alla attività noeticadella coscienza.Il fiore immaginato, ricordato, percepito è perciò un polo attornoa cui si aggregano diversi modi di essere (fresco, appassito, profumato ecc.) che sono relativi a come, nella realtà dell’esperienza vissuta, esso si dona all’attività (percettiva, immaginativa, rimemorativa, ecc.) della coscienza.Husserl può così operare una fondamentale distinzione: da unaparte c’è il modo di essere della coscienza che è immanente, cioè èun modo d’essere che non ha alcunché di mediato perché essa si dàa se stessa direttamente, dall’altra si danno fenomeni dipercezione trascendente di oggetti esterni che si manifestano allacoscienza in una pluralità di forme e modalità. Una torre distante
108
che io percepisco come circolare è un dato assoluto per lacoscienza, nel senso che io effettivamente esperisco una torrecircolare la cui realtà fisica esagonale non annulla la miaesperienza, che perciò esiste come dato ‘reale’. Per la coscienza (la “posizione assoluta”) non si dà quindidistinzione tra apparire ed essere mentre ciò avviene perl’oggetto esterno. La torre circolare non esiste nella realtàfisica, ma è come se esistesse nella realtà immanente ed assolutadella coscienza. Come Cartesio, Husserl problematizza la realtàdell’oggetto (la torre esiste davvero ? è realmente circolare ?)mentre pensa all’atto di coscienza come un qualcosa di apodittico(è indubitabile la mia percezione della torre e della suacircolarità).Su questa distinzione – che qui possiamo solamente ricordare nellesue caratteristiche generali – si fonda l’idea della fenomenologiae, correlativamente, la critica alla psicologia scientifico-positiva.Infatti l’intenzionalità, come elemento essenziale di ogni vitapsichica e come relazione della coscienza con l’oggetto (io-mondo), deve essere, conseguentemente a questa decisivadistinzione, esplorata da entrambe queste polarità, cioè dallaprospettiva della coscienza in cui si hanno intuizioni dell’oggetto eda quella della cosa dove si manifestano rivelazioni, evidenze. Husserl , portando coerentemente alle estreme conseguenze questa‘duplicità’della vita psichica, considera come limitato efuorviante l’approccio psicologico-positivo alla soggettivitàperché esso guarda ad una sola polarità di questa relazione,sostanzializzandola secondo i principi dualistici e fisicalisticiingenui.Attraverso la riduzione fenomenologica (“un metodo per togliermiil mantello empirico-oggettivo) Husserl vuole cogliere invece ladimensione della pura datità della coscienza, escludendo ( artificiosamente e temporaneamente) quella empirico-naturale.La finalità ultima è liberare la coscienza dalla sua naturalitàper indagarla in se stessa, nella realtà delle sue struttureeidetiche, nella purezza delle sue appercezioni.Si potrebbe dire che dietro, sotto o dentro la coscienza immediatavive una coscienza originaria che la psicologia non riesce acogliere proprio perché naturalizza e sostanzializza la primasenza avvedersi che questa è possibile e pensabile solo sulla basedella dimensione altra che la contiene.“La coscienza – questo è l’errore fondamentale dello psicologismo(al quale sono soggetti non solo tutti gli empiristi, ma anche
109
alcuni razionalisti) - non è un vissuto psichico, un plesso divissuti psichici, una cosa, un’appendice (stato, attività) di unoggetto naturale. Chi ci salva dalla reificazione della coscienza? Costui sarebbe il salvatore, anzi il creatore della filosofia.”41
L’io empirico va quindi necessariamente compreso nella dimensionecostitutivo-trascendentale che lo contiene e lo rende possibilepoiché “!a trascendenza relativa a ogni forma è carattereimmanente dell’essere, costituendosi al di dentro dell’ego.”42 Il mondo-della-vita , cioè la dimensione del vissuto e delconcreto, dell’immediatezza, va quindi compresa alla luce diun’indagine delle componenti d’essenza di cui essa è intessuta.
Psicologia o filosofia ?
Abbiamo visto come il concetto di intenzionalità conduce Husserl,pur da un versante ancora “psicologista”, ad indagare oggettilogici e matematici al di là della contrapposizione tra percezioneempirica ed intuizione eidetica.Come viene sviluppato questo concetto così importante sia nel suopensiero che nella riflessione successiva dove, con e attraversoHeidegger, approda fino ai nostri giorni ? Con esso infatti prende avvio e si definisce il compito filosoficodi costruire una nuova e radicale ontologia del mondo-della-vita acui Husserl lavorerà tenacemente fino ai suoi ultimi giorni e chetroverà nella Krisis la sua più compiuta espressione, anche sequest’opera è dallo stesso autore considerata solo un “piccoloinizio”. Le Ricerche logiche (1900) , successive a la Filosofiadell’aritmetica, costituiscono il momento fondativo del progetto dellanuova ontologia del mondo-della-vita poiché è proprio qui che lafertile applicazione del concetto di intenzionalità conduceHusserl a porre l’esigenza, nel secondo volume, di unaricostruzione fenomenologica della psicologia. Il tema principale di quest’opera rimane il rapporto tra logica epsicologia; ora, però, è esplorato dal versante delle categorieideali della logica, proprio per superare definitivamente ogniresiduo equivoco psicologista nella fondazione filosofica di
41 E Husserl, Meditazioni cartesiane, Milano, Bompiani,1997,cit., p.16542 Ibid., p.107.
110
quelli che Husserl definisce come i “ mirabili metodi dellamatematica”, cioè, più in generale, i saperi specialistici degliscienziati.Su questo problema capitale Husserl, facendo agire il concetto diintenzionalità, dà corpo alla prospettiva fenomenologica che ponealla psicologia l’esigenza di una sua emancipazione dal paradigmapositivistico. La posta in gioco è alta : qual’è la scienza del futuro ? E’ la psicologia, come vorrebbe già Brentano che nell’introduzionealla sua opera principale la Psicologia dal punto di vista empirico (1874) lapone come un sapere programmaticamente destinato ad assumere unruolo egemonico sia nell’ambito teorico-conoscitivo che in quellopratico-applicativo ? Oppure, come è nell’intenzione di Husserl, è la filosofia che i“funzionari dell’umanità” sono chiamati a portare a necessariocompimento, recuperando l’idea originaria di aletheia e logos , perrealizzare ciò che è all’origine della forma di vita dell’uomoeuropeo?Lo sviluppo teorico e applicativo della psicologia nel nostrosecolo, fino ai suoi esiti più recenti, mostra che il conflittocon la filosofia, subito emerso nel contesto positivista di fine‘800, permaneal centro del dibattito filosofico contemporaneo, anche se assumeforme e modi diversi di espressione,Il problema di fondo della riflessione filosofica nel ‘900diventa, nell’epoca dello sviluppo delle scienze umane, la suastessa possibilità di esistenza, nel senso che tali scienze sipongono come nuove forme di conoscenza che minano alla base itermini in cui venivano posti ed affrontati temi e problemitradizionalmente di pertinenza della filosofia. Le vecchie questioni filosofiche risultano così dissolte nei lorofondamenti più che risolte. Le scienze umane, pur essendo natedalla filosofia, rivendicano non solo la loro autonomia di oggettoe di metodo, ma anche la facoltà di consegnare ormai allatradizione del pensiero e delle forme culturali di specificicontesti storici, la speculazione filosofica, la cui funzione, purpreziosa per l’umanità, si è perciò esaurita. L’istituzione dei primi laboratori di psicologia da parte di Wundt, diKulp e di Stumpf ebbe come conseguenza immediata l’acquisizione dirisultati conoscitivi rispetto a questioni dibattute dai filosofi nelcorso di tutta la storia del pensiero occidentale e,conseguentemente, la rivendicazione di una superiorità conoscitivae metodologica della psicologia rispetto alla sterilità
111
dell’approccio filosofico. Tutto ciò aveva ripercussioni anchenella riformulazione degli ambiti accademici e nella distribuzionedelle cattedre universitarie - che quindi rispecchiavano imutamenti nel quadro del sapere istituzionalmente riconosciuto –poiché molte cattedre di filosofia furono occupate da psicologi.Lo stesso atteggiamento di molti psicologi rispetto all’opera diHusserl rivela come la crisi della filosofia fosse un dato difatto acquisito nella cultura dell’epoca poiché la fenomenologiaveniva considerata come una disciplina sostanzialmentepsicologica, anche se presentava, al pari della psicoanalisi, unimpianto di base fortemente innovativo.Alle Ricerche logiche, in cui vengono esposti programmaticamente ifondamenti ed i compiti teoretico-conoscitivi della fenomenologia,Husserl premette i Prolegomeni ad una logica pura proprio per chiarireche tra la psicologia – perlomeno quella scaturita dal contestopositivista - e la fenomenologia c’è una netta opposizione, nonsolo metodologica (la prima procede induttivamente mentre laseconda intuitivamente), ma anche e, soprattutto, relativa siaalle loro rispettive premesse teoriche di fondo (filosoficamentenon chiarite o consapevolmente poste sul terreno della teoriadella conoscenza) sia alle loro finalità ultime (pragmatico-terapeutiche o etico-teoretiche).Il conflitto tra nuove scienze umane e vecchia filosofia, che siesprime soprattutto come conflitto tra psicologia e filosofiametafisica, diventa un motivo centrale nella cultura dell’epoca;si può allora comprendere perché Husserl ritorna negli annisuccessivi su questa opposizione sia per difendere la propriaproposta teorica dai fraintendimenti immediatamente emersi, siaper dissolvere le premesse erronee su cui essa è fondata,mostrando, nello stesso tempo, un atteggiamento totalmente diversodagli psicologi che vedevano nella filosofia una speculazioneormai improponibile nell’epoca del sapere positivo. L’intento diHusserl era infatti quello di fondare un nuovo rapporto tra lafilosofia e la psicologia che, come si vedrà meglio in seguito,assumerà sempre più valenze di natura sia teoretica sia etico-sociale. Il saggio che scrive nel 1911 per la rivista Logos, La filosofia comescienza rigorosa, si iscrive all’interno di tale questione decisiva.Husserl intende chiarire ulteriormente che tra la scienza cherende ragione di sé stessa (epistéme) e le diverse forme di saperepositivo c’è una netta separazione.La psicologia, con le sue pretese fondative di tutte le scienzedello spirito, è, per Husserl, un “controsenso”, perché non è
112
assolutamente possibile elaborare una teoria della conoscenzaall’interno delle scienze della natura. Occorre invecefaticosamente guadagnare un piano teorico in cui non vi sia alcuncompromesso con dati empirico-contingenti poiché essicontaminerebbero la purezza di un’indagine sugli a-priori dellacoscienza.La psicologia e la fenomenologia, pur avendo lo stesso oggetto diindagine, cioè i vissuti psichici, si differenziano per lemodalità di approccio in quanto la prima li analizza sul pianodelle datità empiriche che trascendono la coscienza (i vissuticoncretamente esperiti nella particolarità di una situazionespazio-temporale), mentre la seconda li assume nella loroessenzialità a-priori. Si definiscono così due prospettive: unatrascendente e l’altra immanente in cui la psicologia vieneconsiderata da Husserl una scienza empirica che indaga i vissutipsichici come fatti che avvengono nello spazio-tempo dei contestireali in cui il soggetto vive. 43
Ciò non comporta però una distanza incolmabile con lafenomenologia, che invece si occupa le forme essenziali a-prioridella coscienza, indipendentemente dalla loro individuazionespecifica in determinate forme di vita reale. L’intento di Husserlè esattamente l’opposto: conciliare il punto di vista psicologicocon quello della prospettiva generale della fenomenologia.Nell’articolo per Logos, a cui si sta qui facendo riferimento, ciòche preme a Husserl, preoccupato delle cattive interpretazionipsicologiste della sua opera, è la chiarificazione dellaspecificità dei due approcci (psicologico e fenomenologico) allostesso oggetto di ricerca, cioè i vissuti di coscienza. Certamenteessi devono essere compresi nella co-appartenenza costitutivadella loro immanenza e trascendenza in modo tale da porre laquestione della relazione soggetto-oggetto, io-mondo su un pianoteorico in cui non solo non sia più possibile pensare questarelazione in termini alternativi ma, al contrario, diventiineludibile il lavoro filosofico rivolto a porre le condizioni per43 E’ proprio questa distinzione che, dopo la pubblicazione dell’articolo per Logos, suscita le obiezioni più decise. La psicologia, sempre pensata come scienza dell’esperienza interna, nella prospettiva di Husserl assume invece il compito di comprendere l’esperienza trascendente. Il dibattito che si sviluppa su questo tema e su altri aspetti decisivi del rapporto tra fenomenologia e psicologia tra Husserl ed i suoi critici ( in particolare August Messer e Theodor Elsenhans ) risulta particolarmente interessante per il nostro argomento. Essendo stato ricostruito con precisione e accuratezza nell’introduzione di Paolo Volonté a E. Husserl, Fenomenologia e teoria della conoscenza, Bompiani, 2000, ad essa si rimanda.
113
la loro integrazione. Ciò che però risulta essenziale nelraggiungimento di un terreno teorico radicalmente nuovo è proprio lanetta separazione degli ambiti del sapere fenomenologico epsicologico. In questo testo dunque Husserl chiarisce come glioggetti dell’esperienza immanente, cioè i vissuti della coscienza,sono dati puri che si offrono alla “visione d’essenza”(Wesenschauung) tutti d’un pezzo ed immediatamente, mentre quellidell’esperienza trascendente (cioè di un’esperienza che non puòessere vissuta solo all’interno della “posizione assoluta “ dellacoscienza in quanto soggetta alle condizioni dello spazio e deltempo oggettivi) richiedono una comprensione per “adombramenti”,per successivi atti che approssimano progressivamente eprospetticamente la loro conoscenza. E’ possibile così avere unapluralità di esperienze di oggetti naturali mentre ciò non lo ècon i fenomeni puri della coscienza che si offrono nella loroessenzialità costitutiva. Il problema è, per Husserl, determinato proprio dall’ “incantoche esercita l’atteggiamento naturalistico” , dalla sua‘facilità’, che viene indebitamente estesa anche all’indagine deifenomeni della coscienza, a cui ci si rivolge come se fosserooggetti naturali. La difficoltà dell’atteggiamento fenomenologicoperò non consiste nel fatto che le “essenze” risiedano in abissaliprofondità quasi inaccessibili, bensì proprio nel contrario,essendo esse troppo vicine “perché noi già per così dire levediamo costantemente” Il problema è dunque “riconoscerle nel lorocarattere specifico invece di naturalizzarle in maniera assurda” Sono quindi necessarie una fenomenologia della coscienza e una scienzanaturale della coscienza che, posta la loro differenza di fondo,costituiscono due modi di conoscenza rivolti, in un rimandoreciproco, a consentire l’accesso alla totalità della relazioneio-mondo. Ciò comporta una necessaria deviazione dagli itineraritradizionalmente percorsi dalla filosofia attraverso i suoi -ismi(positivismo, idealismo, materialismo, empirismo, razionalismo,ecc) per porre in essere nuovi fondamenti alla speculazionefilosofica nell’epoca dello sviluppo delle scienze umane ed inparticolare della psicologia che, ricorderà Husserl nella Krisis,“pretende di essere la scienza fondamentale, astratta,definitivamente esplicativa rispetto alle scienze concrete dellospirito”. 44
44 E. Husserl, La crisi delle scienze..., cit., p.34
114
Contrariamente agli psicologi che intendono il conflitto con lafilosofia in termini di aut-aut, Husserl ritiene che il compitodella filosofia non sia quello di liquidare la psicologia e le suepretese scientifiche “definitivamente esplicative” ma, si puòdire, il contrario. La ricerca fenomenologica è infatti l’unicastrada percorribile per liberare la psicologia dallainconsapevolezza filosofica delle sue origini fisicalistiche ecartesiane; solo in questo modo essa diviene un veicoloprivilegiato di accesso, come psicologia che ha finalmentericonosciuto la sua natura trascendentale, all’auto-conoscenzapura in cui la filosofia può ritornare ad essere quella che perHusserl era stata e deve necessariamente essere nell’epocaattuale, così esposta al rischio di nuovi imbarbarimenti, cioè lariflessione dell’umanità su sé stessa.45
Scienza, psicologia e mondo-della-vita
Ciò conduce Husserl in un lungo, complesso ed avvincente percorsoal termine del quale troviamo la sua opera della vita(Lebenswerke) , cioè La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentalealla quale, con un salto vertiginoso, facciamo ora riferimentoperché è proprio qui che convergono tutti i temi relativi alrapporto tra filosofia e psicologia presenti in vari modi nellesue opere precedenti.Dalle Ricerche logiche alla Krisis il pensiero di Husserl, purattraversando varie fasi, ruoterà tenacemente attorno agli stessitemi che, più o meno direttamente, in ultima analisi, riguardanola trasformazione della psicologia in rapporto alla nuovafilosofia fenomenologica. Tutti i suoi testi, dalle Idee per unafenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1912-1929) fino alle45 Non è certamente casuale che Ludwig Wittgenstein, al termine della sua operaaffronterà lo stesso problema, anche se vi converge da una prospettiva teoricadiversa da quella di Husserl. Il motivo unificante della sua riflessione sullafilosofia della psicologia è comunque in sintonia con la critica husserlianarivolta a deligittimare ogni pretesa egemonica della psicologia come scienza delcomportamento umano e della soggettività.Wittgenstein fa emergere, si può dire fenomenologicamente, le“essenze” dellanostra vita psichica nell’ascolto delle espressioni con cui esteriorizziamostati d’animo, emozioni, sensazioni, umori, intuizioni ma anche cognizioni,volontà, intenzioni ecc. ( Osservazioni sulla filosofia della psicologia, scritte tra il1945 e il 1949 e pubblicate nel 1953).
115
fondamentali Meditazioni cartesiane (1931), esplorano da prospettivediverse, la possibilità di fondare un proficuo rapporto trafilosofia e psicologia. In particolare, il problema vienedirettamente posto ed analizzato in La filosofia come scienza rigorosa(1911) e in Psicologia fenomenologica (1925).Le analisi contenute in questi testi confluiscono al loro gradopiù sistematico di elaborazione nella Krisis per trovarvi unastraordinaria sintesi creativa su un piano teorico ormaidecisamente trascendentale . Non essendo qui certamente possibile ricostruire, anche nelle suelinee generali il complesso percorso che lo conduce alla sua operapiù nota - e da più parti riconosciuta come l’opera capitale,nonostante la sua incompiutezza - dopo aver delineatoschematicamente la prospettiva teoretica generale, cercheremo oradi cogliere i temi fondamentali attraverso cui Husserl getta lebasi per la costruzione dell’ontologia del mondo-della-vitanell’intento di rendere possibile un confronto con lametapsicologia freudiana.Partiamo proprio dal titolo originario dell’opera che, a questopunto, non dovrebbe sorprenderci : La crisi delle scienze europee e la psicologia .Già nella trasformazione deltitolo in La crisi delle scienze e la fenomenologia trascendentale emerge il temaprincipale dell’opera e cioè lo stretto e vincolante rapporto trascienza e vita essendo la fenomenologia un’indagine del mondo-della-vita e dei processi conoscitivi che in essa originariamente siradicano.Come si è già rilevato, tutta l’opera di Husserl ruota attorno adue ordini di interrogativi che non possono essere postiindipendentemente l’uno dall’altro e che riguardano, da un lato,la coscienza e i suoi “oggetti” e, dall’altro, la scienza e i suoimetodi.Ora è evidente come in questi due ordini di problematiche rivival’originaria investigazione sulla verità e sull’essere: con Husserl sipone l’esigenza di un ritorno alla radicalità delle domande chehanno animato lo spirito della ricerca filosofica greca. Questaesigenza, che investe in modo risolutivo il problema della stessasussistenza del pensiero filosofico nell’età del trionfo dellescienze positive, emerge in rapporto allo specifico contestostorico , tecnologico e politico (oltre che strettamentefilosofico) del secolo XX, le cui strutture culturali portantitrovano origine nella ridefinizione del concetto di verità operatadalla cultura , in particolare tedesca, della fine del 1800.
116
Contrariamente all’imperativo della aderenza ai fatti checontraddistingue questo periodo storico, l’opera di Husserl non sioccupa di essi ma delle essenze (o, meglio, delle essenzeattraverso i fatti), in una prospettiva in cui l’antico efondativo conflitto parmenideo tra alétheia e dòxa torna a nuovavita. Come ci ricorda Husserl nella Krisis il vero essere è sempre unfine ideale, un compito dell’epistème, della “ragione”, incontrapposizione a quell’essere che la doxa ammette e suppone“ovvio”.Questa contrapposizione non trova espressione solo nelladimensione teoretica poiché essa investe in pieno ecostitutivamente la soggettività (o, meglio, come vedremo,l’intersoggettività) . “ In fondo ciascuno avverte questadifferenza che si riferisce alla sua autentica e vera umanità ,così come, già nella vita quotidiana, avverte la verità come uncompito, come un fine, anche se soltanto nella singolarità e nellarelatività.” La verità, dunque, si pone come necessità teorica e, nello stessotempo “pratica”, cioè come compito della filosofia e “dell’umanitàche lotta per la propria autocomprensione”. (ibid. p.43)I filosofi non possono allora essere identificati come costruttoridi teorie intese come visioni del mondo più o meno illuminanti,suggestive o originali : essi sono “funzionari dell’umanità” checonsapevolmente assumono su di sé la responsabilità di ricondurrel’uomo a sé stesso, cioè alla propria essenza che è la ragione.Gli ardui problemi teorici che Husserl affronta devono sempreessere visti sullo sfondo concreto del mondo-della-vita che è il "terreno su cui si fonda il mondo scientificamente vero e cheinsieme lo include nella propria concezione universale”. 46
La radicalità che Husserl rivendica alla fenomenologia non èdunque da intendersi solo come ritorno alla radicalità originariadell’interrogazione filosofica sul vero essere, in quanto essarisiede piuttosto nell’aver mostrato la necessità di un ritorno“alle cose stesse” nel contesto di un’epoca che ha vistoaffermarsi la “verità” delle scienze esatte contro il mondo-della-vita, cioè contro le esperienze originarie (“ le cose stesse”) delmondo-della-vita.La Krisis è l’opera in cui giunge a completa maturazione il compitodi raggiungere la soggettività pura dell’anima (la psico-logia,psiche-logos, come “scienza delle pure anime in generale”. Lafinalità ultima dell’opera è di consentire alla scienzaobiettivistica di riconciliarsi con il mondo-della-vita attraverso46 La crisi…. ,cit. p.160
117
il superamento del suo “razionalismo erroneo” di fondo, divenutobandiera di un progressismo che lascia inalterate le questioniprofonde e reali dell’uomo.La radicalità della fenomenologia si autolegittima quindi comeesigenza di ritrovamento della ragione filosofica dell’occidente,divenuta vitale nell’epoca del dominio della ragione strumentale edella sua potenza tecnica. Naturalmente ciò non va inteso come un’ingenua valorizzazionedella tradizione come tale; al contrario, una riassunzione delladimensione teleologica della ragione filosofica occidentale siconfigura come atto rivoluzionario teso a superare il mancato oparziale dispiegamento dell’originario logos che, si può dire, èstato ostacolato proprio dai suoi successi nella dimensionetecnico-scientifica.Nella Dissertazione “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, compresa cometesto integrativo della Krisis, Husserl rivendica inequivocabilmentequanto decisamente tale significato rivoluzionario dellafenomenologia : “Sono convinto che io, il presunto reazionario,sono molto più radicale e molto più rivoluzionario di coloro cheoggi si bardano di un radicalismo meramente verbale.”Ora, nella specificità del problema che qui si sta trattando,perché per Husserl sono i problemi della psicologia a rendereevidente la crisi della scienza ?E di quale crisi può parlare Husserl in un contesto storico che sicaratterizza proprio per la continuità dei successi delle scienzeesatte ?Da questi interrogativi prende avvio l’ultima opera di Husserl edè a partire da essi che vengono proposte soluzioni per problemi dinatura filosofica che, nello stesso tempo, assumono un valoredecisivo per il reale progresso dell’umanità in generale e diquella europea in particolare.La Krisis, divisa in tre parti con l'aggiunta di testi integrativi(dissertazioni ed appendici), affronta nella sua prima parte ilproblema della natura della asserita crisi delle scienze europee(vedremo poi in che senso vengono così qualificate).Di quale crisi può parlare Husserl nell’epoca del trionfo dellascienza e della tecnica?Essa innanzitutto non investe l’operare teoretico e metodologicodelle scienze che, inequivocabilmente, per Husserl “resta fuoridiscussione” .Da Newton ad Einstein la scienza, al di là della riformulazionedei suoi paradigmi, cioè al di là degli sviluppi novecenteschidella fisica classica, “ continua ad essere una scienza esatta” e
118
continua a mostrare straordinari risultati che destano un’unanimeammirazione.In che senso allora Husserl può radicalmente parlare delfallimento delle scienze esatte?Per rispondere a questo interrogativo occorre ritornare fino alleorigini dell’epoca moderna , cioè al Rinascimento dove si pongonole basi per la costituzione della scienza quale oggi laconosciamo.E’ necessario dunque ripercorrere il cammino della scienza percomprendere ciò che essa è e, soprattutto, ciò che essa significaper l’uomo europeo-occidentale. Husserl in questo modo poneun’esigenza conoscitiva prioritaria di carattere storico, ma nonnel senso che bisogna procedere ad una ricostruzionedell’evoluzione delle acquisizioni teoriche e delle applicazionipratiche delle varie scienze. Oltre alla storiografia dellescienze esatte occorre comprendere i sensi e i significati che inesse si sono sedimentati a partire dalla loro originariacostituzione come idealizzazioni e strumenti di intervento sulmondo fisico. La ricerca fenomenologica si fa, come si esprime lostesso Husserl, “archeologica”, “genetica”, investendo così, su unpiano teorico da essa stessa conquistato duramente e non posto inbase all’immediatezza di qualche Weltanschauung, la dimensionestorica e temporale.Il Rinascimento è visto da Husserl come un periodo di cruciale ditrasformazione della società e della cultura occidentale in cui,sulla base del superamento delle strutture ideologiche, politichee sociali del medioevo, l’uomo europeo conquista la sua autonomiadi individuo, ritrova la sua libertà nel sistematico appello allaragione e procede, in una rete di reciproche connessionivincolanti e necessarie, verso l’ideale di una scienza dellatotalità dell’essere.Tale scienza ha il carattere della onnicomprensività in quanto sidefinisce nell’unità di un sistema teoretico che raccoglie econnette i risultati parziali delle diverse scienze. Per Husserl,nel Rinascimento si costituisce in questo modo un’idealeconoscitivo programmaticamente e progressivamente rivolto allacostruzione di un sapere della totalità; esso si caratterizza peril suo infinito e aperto procedere in vista della soluzione deiproblemi teorici ed umani che si pongono nel corso dell’evoluzionestorica .Questo ideale conoscitivo si radica nell’orizzonte storico dellesocietà europee come telos ad esse immanente e connaturato: digenerazione in generazione l’umanità europea costruisce se stessa
119
realizzando ciò che è ad essa stessa innato e cioè una “entelechiache permane attraverso tutte le vicende delle forme di vitaeuropee” Husserl connette dunque il progresso delle conoscenze aldispiegamento della forma spirituale europea, cioè ad un telosimmanente alla storia d’Europa che trova fin dalla Grecia anticala sua originaria espressione e che conosce nel XVI secolo undecisivo punto di svolta ” verso quella forma di vita e di essereche costituisce il suo eterno polo ideale”.Qual’è allora la teleologia dello spirito europeo, quali sono leforme di vita e di essere che ne costituiscono l’essenza?Si può semplicemente rispondere con due parole : libertà eragione.L’essenza della forma di vita europea è originariamente unacostitutiva compenetrazione della libera costruzione della propriaesistenza storica con le idee di ragione che infinitamentealimentano gli ideali di conoscenza autentica, i valorifondamentali, i criteri etici che guidano i comportamenti. Ogni popolo è, per Husserl, animato da un’unità spirituale.L’Europa è una comunità di nazioni che al di là delle formeculturali e storiche specifiche si pone , anche nei confronti dialtre comunità di nazioni, con elementi unitari propri, con unaspecifica identità sovranazionale.La questione che allora si pone è se il telos della filosofia grecache si è dispiegato nell’Europa è uno sviluppo casuale diun’umanità casuale in mezzo ad altre umanità e ad altre societàcompletamente diverse o, piuttosto, siamo di fronte ad un’entelechiache è propria dell’umanità in quanto tale ?In quest’ultimo caso la filosofia, cioè l’atteggiamento teoreticoesprimerebbe il movimento storico della ragione universale“innata” dell’umanità: l’Europa dunque come necessità, non comeentità antropologica tra le altre.Alle sue origini Husserl, come abbiamo visto, pone l’assunzione diun atteggiamento teoretico : la filosofia e la scienza greca anticasegnano un decisivo passaggio da uno stato ingenuo-naturale che siesprime nelle forme arcaiche, mitiche e religiose ad un processo lacui forza agente è il logos come discorso che rende ragione di sestesso. La filosofia è theoria dell’essere in quanto essere chesubordina a sé tutte le conoscenze prodotte dalle scienzeparticolari, autolegittimandosi così come ideale del sapere dellatotalità.Il ritorno ai classici nel Rinascimento va quindi visto come lariconciliazione degli interrogativi specificamente umani con la
120
ricerca scientifica e filosofica; la considerazione razionale deiproblemi esistenziali dei singoli e delle comunità avviene nelsegno di una libera e liberatoria riunificazione di uomo escienza. Queste prospettive scientifico-teleologiche, spiritualmente estoricamente costitutive dell’Europa come forze propulsiveoperanti dal XV sec., conoscono però un progressivo edinarrestabile ridimensionamento.L’ idea di ragione , fondata su promesse di totalità ed umanità ,ha finito per assumere nel secolo XX un senso diverso.Così, per Husserl, l’ideale della philosophia perennis conobbe “unintimo dissolvimento” le cui “ragioni” vengono indagate in questasua ultima opera: dall’originario atteggiamento teoretico-filosofico programmaticamente orientato verso l’autocomprensionedell’umanità non è rimasto altro che un metodo scientifico cheproduce meri risultati e dati di fatto privi di senso, difondamento e significato per i problemi più urgenti dell’umanità.Nonostante ciò i successi delle scienze positive si pongonoinevitabilmente di fronte alla proliferazione di una serie digrandiosi sistemi filosofico-metafisici costantemente inopposizione tra loro, mostrando risultati specifici utili controinverificabili e confuse generalizzazioni teoriche, formulate perdi più, quasi invariabilmente, in un linguaggio difficilmentecomprensibile e sulla base di premesse teoriche di fondo nonadeguatamente indagate e giustificate.In altri termini, l’univocità, l’evidenza, la verificabilità dellemisurazioni\descrizioni\quantificazioni delle scienze positiverende ineffettuale e teoricamente sterile l’eccessiva polivocitàdelle grandi costruzioni della filosofia.In tale contesto lo smarrimento dell’ideale filosofico universaleè inevitabile; la filosofia diventa necessariamente ”un problemain sé stessa“, cioè una tradizione di pensiero che si trovadirettamente di fronte alla possibilità del proprio dissolvimento.Nella sua lotta “per conferire un senso razionale all’esistenzaumana individuale e umana in generale” , la filosofia, animata daprincipi di ragione e libertà, incontra la scepsi intorno aglistessi motivi di questa lotta.Il “diluvio scettico” disgrega e frammenta l’ideale unitario chemuove la filosofia verso il compito primario dell’autocomprensionedell’umanità. C’è dunque un conflitto permanente (e si potrebbe dire originario)che Husserl vede all’opera tra le filosofie scettiche (cioè ineffetti non-filosofie avendo esse perso la coscienza dei loro
121
compiti) e quelle che trovano il loro fondamento nell’ideale diuna considerazione universale e razionale del mondo. Rispetto aquesto conflitto tra due idee di ragione: una, fondata su premessee, nello stesso tempo, promesse, di totalità ed umanità , l’altra,risolta in un metodo produttivo di risultati fattuali, Husserlpone la fondamentale esigenza di liberare la filosofia dalpericolo totalitario di una riduzione dell’idea di ragione allasua sola dimensione strumentale, restituendo così la filosofia aisuoi compiti e mostrando la possibilità “pratica” della suaattuazione nel mondo-della-vita. Nel perseguimento di questointento, incontra la psicologia: nella seconda parte dell’operaviene conseguentemente indagato , a partire da una prospettivastorico-filosofica, la relazione tra mondo-della-vita epsicologia. Ed è qui che troveremo la risposta all’interrogativoda cui siamo partiti sulla natura della crisi delle scienze e sulruolo della psicologia in rapporto a tale crisi.
L’origine del dualismo
Nella II parte della Krisis, a partire dalla ricerca sull’originedell’idea di scienza moderna Husserl affronta il problema dellacategoria del “trascendentale” così come si configura da Descartesin poi. In questo percorso vengono prima ricostruiti i momentidecisivi nella formazione dell’approccio naturalistico inpsicologia e successivamente indagati i motivi sia obiettivisticiche trascendentali contenuti nell’opera di Descartes, Locke,Berkeley, Hume e Kant.Cerchiamo allora di comprendere i nessi che connettono questitemi.Husserl procede innanzitutto verso l’individuazione del momentodecisivo in cui si sviluppa una nuova idea di scienza in rapportoalla filosofia, poiché è da tale relazione che si definisce poi lostatus teorico-metodologico della “scienza” della soggettività,cioè la psicologia.L’analisi del processo attraverso cui si configurano nuovirapporti tra scienza e filosofia diviene quindi indispensabileperché su di essi si radicano i fondamenti della psicologia comescienza. In questa parte dell’opera Husserl ci dice come è nata la
122
psicologia moderna, che cosa essa è in grado di fare e,soprattutto , di non fare, alla luce del problema trascendentaleche le filosofie di Descartes e di Kant avevano posto, senza peròportarlo alle sue necessarie quanto radicali conseguenze.Prima di scrivere la sua ‘storia della psicologia’ , Husserl deveprendere in considerazione il paradigma teorico-metodologicoscaturito dal Rinascimento e dalla Rivoluzione scientifica sullabase del quale essa è stata poi epistemologicamente definita.La domanda che guida l’analisi di Husserl può essere cosìsinteticamente riformulata: la rivoluzione scientifica dei secoliXV e XVI pone in essere le condizioni per la fondazione di unapsicologia in grado di afferrare scientificamente la soggettivitàed i suoi vissuti ?Per rispondere a questo interrogativo occorre ritornare brevementea come si configuravano i rapporti tra filosofia e scienza prima edopo Galileo e Cartesio perché, occorre sottolinearlo ancora, è suquesti rapporti che la psicologia trova la propria fondazione elegittimazione scientifica. Ma, in un percorso a ritroso, occorreritornare fino alla filosofia antica dove, sulla base dellaquestione fondamentale che riguarda la configurazione gerarchica ecorrispondente dei rapporti tra pensiero ed essere, Platone ponela relazione tra scienza e filosofia: superata la soglia dellaconoscenza sensibile, cioè della congettura e della credenza, siaccede alla dimensione dell’essere, cioè della sostanza reale incui dimorano essenze eterne ed immutabili che, a loro volta, sonoseparabili come idee-matematiche ed idee-valori; le prime nonriguardano la matematica nella sua operatività pratica ma nellasua essenzialità, cioè nel suo essere puro pensiero di entitàquali il pari, il dispari, l’unità, la dualità , le figuregeometriche, i vari tipi di angoli ecc., mentre le seconde sonocostituite dai valori relativi all’uomo ed alla sua vita sociale(giustizia, bellezza, ecc). La dimensione etico-politica delleidee-valori stabilisce un rapporto di superiorità con le idee-matematiche, le quali pur necessarie e propedeutiche all’eserciziodella filosofia come dialettica (è vietato ai non matematicil’ingresso nella sua Accademia !), sono in una posizionegerarchicamente inferiore.Alla forma di conoscenza superiore delle idee-valori si accededunque attraverso la conoscenza delle essenze geometrico-matematiche, che, a sua volta, è resa possibile da una sorta diponte costituito dalla misurazione empirica. Il ruolo che riveste il concetto di “misura” nella fondazionedella metafisica da parte di Platone ci interessa perché lo
123
ritroveremo in altra forma in Galileo e attraverso di esso si puòchiarire meglio continuità ed innovazioni nella relazione trascienza e filosofia. Per Platone la misura è ciò che permette di orientarsi o, meglio,di disporsi verso la conoscenza delle essenze poiché attraverso diessa, pur rimanendo all’interno della conoscenza sensibile, siriesce a raggiungere un primo accordo intersoggettivamente validosu qualche oggetto percepito. Così, ad es., noi possiamo vederequalcosa in una pluralità di modi ma se procediamo a darne unamisurazione in termini di peso, lunghezza e larghezza raggiungiamouna percezione comune di essa. Il valore della scienza dei calcoliè allora quello di condurci “ a trattare dei numeri in quantotali, mentre i “ minimi rudimenti della geometria (...) cicostringono “ a volgerci al mondo delle essenze”. 47 Essendo lavera conoscenza svincolata dalle forme sensibili, la misurazionepuò valere solo come primo momento ancora radicato nella realtàempirica che ci permette, in quanto prima esperienza che supera ilcaledoscopio soggettivistico, di accedere gerarchicamente alleidee-matematiche in sé, fino a raggiungere poi il vertice dove èpossibile contemplare del vero essere che si manifesta nelle idee-valori. 48
La misura è dunque un veicolo verso la conoscenza filosofica checi consente di sfuggire all’inganno delle apparenze sensibili, purrimanendo ancora all’interno della percezione delle cosesensibili.Nella rivoluzione scientifica del Rinascimento la filosofia, identificandosi nella scienza universale della totalità razionale del mondo, conferisce un significato diverso alla metodica della misurazione. Husserl individua in Galileo (come riferimento esemplare di una situazione che ovviamente è più variegata e complessa) il punto di svolta decisivo nella trasformazione della relazione tra scienza e filosofia. Come sappiamo, attraverso un processo di astrazione il mondo vienedepurato dalle essenze, dalle finalità, dalle qualità, dalla 47 Repubblica,VII 525 D-E48 Nelle idee-valori ritroviamo, pur se ad un altro livello, il paradigma matematico-misurativo. Nel Filebo, dialogo scritto nella vecchiaia sull’idea-valore che riassume tutte le altre, cioè sull’idea del bene, il concetto di misura assume il valore centrale. E’ infatti l’attività ordinatrice e misurantedella sua intelligenza che può permettere all’uomo di vivere in armonia, conferendo un limite alla sua tendenza illimitata ai piaceri. C’è cioè una scienza della misura- di origine pitagorico-socratica- anche nella dimensione dei valori, e per Platone questa è l’unica via che permette all’uomo di raggiungere la virtù.
124
spiritualità : ridotto a pura cosa corporea circoscritta in sé diviene oggetto esattamente misurabile. La scienza , afferma Galileo nel Saggiatore , deve indagare “come vadia il cielo”, e non quindi porsi nella prospettiva della tradizione platonico-aristotelica del che cos’è ? rivolta ad afferrare “l’essenza vera ed intrinseca delle sostanze naturali” rispetto alle quali invece occorre limitarsi ad avere “notizia di alcune loro affezioni”, cioè “ il luogo, il moto, lafigura , la grandezza, la opacità, la mutabilità, la produzione edil dissolvimento”.Tutto ciò allora è oggettività materiale identificabile da cui , attraverso metodiche descrittivo- misurative sempre più precise e affinate, è possibile estrarre dati intersoggettivamente evidenti ed incontrovertibili. La misurazione quindi ora non è più un veicolo, come in Platone , utile a raggiungere la conoscenza dei valori, delle essenze eterne ed immutabili di natura etico-estetica, poiché diventa una tecnica che mostra all’opera, nelle particolarità concrete del reale, come la scienza, da cui essa stessa scaturisce, conosca già la struttura “essenziale del mondo“, che è di natura matematica.Il faticoso cammino della scienza può allora essere visto proprio come un incessante perfezionamento di conoscenze ed affinamento ditecniche e metodiche misurative da cui emerge sempre di più le verità relative alle ramificazioni di tale struttura “essenziale”.Possiamo allora dire che con Galileo tramontano definitivamente lecosmologie metafisico-religiose unitamente alle loro finalità ed essenze?Autodefinendosi filosofo in quanto fisico, supera radicalmente l’orizzonte metafisico fondato in Grecia? In realtà, pur nella vertigine della riduzione oggettivistica che dissolve ogni qualità dal mondo, il termine “essenza” non scompare dal suo orizzonte.Abbiamo detto che la scienza, cioè, per Galileo, essenzialmente laFisica, possiede già la conoscenza della struttura profonda del mondo che è pura oggettività di corpi governati da una causalità universale. L’universo è “scritto in lingua matematica e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile ad intendere umanamente parola: senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.”Questo cieco vagare lo troviamo anche in Platone che lo riferisce a geometri e matematici che “come sonnambuli” procedono con le loro dimostrazioni verso l’essere senza però vederlo “così com’è, in uno stato di veglia” in uno stato cioè in cui si è consapevoli
125
dell’origine degli assiomi da cui essi muovono, costituita dalle forme-essenze geometrico-matematiche.Ma il “cieco vagare” di Platone non può essere superato solo dallaconoscenza della struttura matematica dell’essere, come in Galileo, perché, per conquistare “lo stato di veglia”, occorre salire sul piano ontologico delle idee valori e soprattutto delle loro relazioni. Conseguentemente per Galileo il matematico è filosofo poiché conosce gli elementi ultimi della realtà fisica (l’unità, la dualità, le figure geometriche, la retta, il punto, ecc.) e quindiprocede in un progressivo affinamento dei propri metodi e perfezionamento dei propri risultati che lo approssimano alla conoscenza della realtà delle cose. Per Platone, che invece include nell’essere la dimensione del valore, il matematico, anchenella conoscenza delle essenze su cui fonda le sue dimostrazioni, potrà solo “muoversi nei confronti dell’essere” senza potersi chiamare filosofo, cioè conoscitore dialettico delle relazioni trale idee valori.Nonostante ciò la concezione galileiana rimane essenzialista, in quanto non viene messa in discussione la sostanzialità di una dimensione ideale, pur essendo, nello stesso tempo, realista, poiché questa dimensione si rivela nell’universo fisico (da qui il conflitto con le gerarchie clericali, il cui potere ideologico veniva ad essere deprivato del proprio fondamento, essendo ancorato alle categorie finalistiche e quindi all’essenzialismo metafisico di origine greca).Husserl nella sua genealogia dell’idea di scienza, pur ammirando ericonoscendo la valenza rivoluzionaria della concezione galileiana, non la considera totalmente fuori della prospettiva metafisica che permane in ogni tipo d’interrogazione sull’ordine ontologico a- priori. E’ proprio questa persistenza di uno sguardoontologico tradizionale che non consente a Galileo di problematizzare filosoficamente l’evidenza della matematica e della fisica; non ponendosi quindi interrogativi sul “come” si sono costituite le scienze esatte, Galileo manca di compiere l’ultimo atto che lo qualificherebbe come scienziato ‘totale’.In questo modo egli, come uomo del Rinascimento, cioè come uomo che è libero dalla ricerca delle qualità nell’universo, attraverso“ le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni”, cioè attraverso un metodico procedere sperimentale in una circolarità di induzione e deduzione, nel momento in cui cerca di cogliere l’ordine oggettivo dell’universo fisico al di là della molteplicità delle sue manifestazioni, pone in essere
126
un’idealizzazione matematica che occulta il “senso proprio e peculiare della scienza”.Non problematizzando l’origine delle sue capacità obiettivanti e delle sue evidenze, ad esempio, “Galileo era lontanissimo dall’immaginare che per la geometria in quanto ramo di una conoscenza universale dell’essente (in quanto ramo della filosofia) potesse essere importante, anzi essenziale, fare dell’evidenza geometrica, del “come” della sua origine, un problema.”Per Husserl , che dunque vede Galileo come uno scienziato che omette di operare un’autoriflessione critica sull’origine del proprio procedere, occorre ricostruire le fasi attraverso cui si èsviluppato il pensiero matematico e geometrico poiché solo attraverso una genealogia delle scienze esatte è possibile comprendere il significato e , soprattutto , le conseguenze che larivoluzione scientifica del Rinascimento ha comportato per la conoscenza in generale.Ciò che infatti va necessariamente indagato è il processo storico e quindi pratico-esperenziale che ha reso poi possibile la matematizzazione galileiana del mondo.Le metodiche misurative che Galileo riceve dalla tradizione emergono infatti da una preliminare definizione di concetti e dalla individuazione di unità di misura rinvenute empiricamente nella realtà fisica: esse si radicano perciò, per Husserl, nel mondo pre-scientifico-intuitivo , cioè nella concretezza vivente delle attività umane.Ad esempio, nella pratica sociale di divisione delle risorse naturali si pone il problema di un accordo intersoggettivamente valido sugli strumenti e sulle metodiche di misurazione di un terreno agricolo (geo-metria).Attraverso la loro applicazione si è potuta raggiungere l’univocità in relazione a determinate forme corporee e, in un inevitabile quanto necessario processo di estensione di queste funzioni misurative verso ambiti più vasti e complessi, l’originario interesse pratico (che è alla base di quello che Husserl definisce “primo atto produttivo”) è divenuto interesse teorico, producendo così un’idealizzazione della misurazione empirica che, a sua volta, costituisce la base della formazione del pensiero geometrico.Solo procedendo in questa direzione la conoscenza può consapevolmente autofondarsi. Gli scienziati devono quindi avere ”la capacità di risalire e di indagare il senso originario di tutte le lorostrutture di senso e di tutti i loro metodi; il senso storico della
127
fondazione originaria, e, in particolare, il senso di tutte le eredità di senso inavvertitamente o successivamente assunte”. 49
Il vero ideale scientifico deve necessariamente essere perseguito sul terreno della autoconsapevolezza delle sue idealizzazioni originarie: la fenomenologia si proporrà conseguentemente come unascienza rigorosa che ha un suo specifico oggetto o campo problematico ed un proprio metodo di analisi.La mancanza di questa capacità di attingere il senso originario delle nuove scienze nella dimensione extra-scientifica del mondo-della-vita non può quindi che condurre, per Husserl, direttamente al dualismo corpo-mente che sarà filosoficamente giustificato da Descartes.
Dall’obiettività al trascendentale
Ma, si chiede Husserl, è possibile ricostruire genealogicamente unsapere rimanendo “prigionieri” degli occultamenti di senso che si sono inevitabilmente formati nel corso della sua costituzione e della sua storia?In altri termini, la conoscenza che l’uomo occidentale ha prodottonel corso della sua storia può farci apparire ciò che essa stessa ha occultato? E’ allora evidente che “ veniamo a trovarci in una specie di circolo ” da cui sembra impossibile uscire. L’unica possibilità, per Husserl, di tentare un ritorno all’originario, sola condizione perprocedere alla reale comprensione dello sviluppo scientifico come “sviluppo di senso ”, è quella che necessariamente deve retrocede “a zig-zag” 50 in un gioco di rimandi di prospettive dove “ ogni elemento deve contribuire al chiarimento dell’altro”. La fenomenologia può allora essere considerata come un metodo elaborato per percorrere
49 La crisi…, cit. p.85 )50 Anche Freud, di fronte alle stesse difficoltà nella comprensione dell’originario che riguarda la vicenda esistenziale dei suoi pazienti, converge necessariamente verso lo stesso procedimento a ritroso in cui deve saltare da una prospettiva all’altra nella speranza che questo rapido mutare di punti vista riesca alla fine ad illuminare l’ “organizzazione pluridimensionale e complessa “ del nucleo patogeno e le stratificazioni, si può ancora dire, di senso che si sono nel tempo accumulate. Freud, Studi sull’isteria, cit., pp. 423 ss.
128
gli spazi tra costituito e costituente e i processi genetici da cui si origina questa dialettica, come un movimento di andata e ritorno che lo stesso Husserl, nei testi degli anni trenta, definisce come Abbau-Analyse (analisi di decostruzione) e Aufbau-Analyse (analisi di costruzione).51
Nella ricerca che riguarda l’intersoggettività conoscente Husserl si trova così di fronte al problema dell’accesso all’originario come un’inevitabile necessità che scaturisce dalla stesso svolgimento del suo percorso teorico. Le innumerevoli difficoltà che subito scaturiscono da un’indagine costretta a procedere a ritroso riguardano soprattutto il metodo poiché ogni ricerca genealogica appare esclusa a priori, indipendentemente da ciò che essa vuole trovare, da percorsi conoscitivi progressivi, lineari ecartesianamente fondati sui criteri dell’evidenza e della distinzione.In questo modo, paradossalmente, la filosofia, per dare nuovamentea se stessa una legittimità teorico-conoscitiva nell’epoca del sapere scientifico, deve porsi al di fuori delle categorie logichedella ratio occidentale. Il problema che allora immediatamente si pone è: come procedere in quest’itinerario verso l’originario se lo stesso linguaggio è intessuto da una ragione filosofica che lo occulta?Certamente, afferma Husserl, non con la terminologia scientifica che “è stata evitata coscientemente” perché in essa stessa si esprime e si radica l’occultamento di senso operato dal sapere obiettivistico rispetto alla sua stessa origine.Occorre allora, anche se ciò comporta grandi difficoltà, “ un giusto ritorno all’ingenuità della vita” ed al suo linguaggio per porre in essere un pensiero che s’innalzi sopra di essa. 52
L’obiettivismo va quindi ‘superato’ non procedendo oltre perché ciò comporterebbe un ulteriore radicamento nella metafisica di cuiesso è l’espressione ultima; per oltrepassare la prospettiva metafisico-oggettivistica occorre invece una discesa verso il basso, vale a dire verso l’immediatezza del mondo-della-vita e delsuo essere a portata di mano. Per accedere realmente alla soggettività è allora necessario comprendere la presenza del suo enigma nella più pura e semplice quotidianità. Da questo punto di vista si potrebbe intendere tutta l’opera di Husserl come un continuo tentativo, fondato su un costante movimento di discesa-ascesa, reso possibile dall’epochè, di definire prospettive entro
51 Cfr. E. Husserl, Metodo fenomenologico statico e genetico, Milano, Il Saggiatore, 200352
129
cui scorgere i modi attraverso cui la trascendenza è presente nell’immanenza.La critica all’obiettivismo fisicalistico ed al suo linguaggio va praticata attraverso la ricostruzione del suo radicamento nel pensiero occidentale, unitamente ad una ricerca volta a mostrare come la dimensione trascendentale, pur presente in tale pensiero principalmente con Kant e Cartesio, non è stata filosoficamente enucleata fino alle sue necessarie ed estreme conseguenze.Questa genealogia della conoscenza, da cui emerge come la lotta tra obiettivismo e trascendentalismo ha caratterizzato, in varie forme, tutto il pensiero occidentale, si pone quindi come un necessario lavoro teorico preliminare da cui sarà poi possibile avanzare in modo corretto verso la pluridimensionalità del trascendentale.In tale prospettiva, la psicologia, come disciplina direttamente investita dall’egemonia dell’obiettivismo fisicalistico, mostra ilconflitto tra la visione naturalistica (derivata appunto dall’affermarsi del paradigma del razionalismo obiettivistico) e quella trascendentale, che essa contiene in virtù del suo ‘oggetto’ di studio, l’uomo.Cerchiamo allora, a questo punto, di chiarire ciò che Husserl intende per obiettivismo e per trascendentalismo attraverso le sue stessedefinizioni :
“La caratteristica dell’obiettivismo è quella di muoversi sul terreno del mondo già dato come ovvio nell’esperienza e di perseguirne la verità obiettiva, ciò che in esso è di incondizionatamente valido per ogni essere razionale, ciò che esso in se stesso è.”
“ Il trascendentalismo afferma invece: il senso d’essere del mondo-della-vita già dato è una formazione soggettiva, è un’operazione della vita esperiente, pre-scientifica. In essa si costruisce il senso e la validitàd’essere del mondo, di quel mondo che vale realmente per colui che realmente esperisce.”
Nella prima prospettiva la realtà del mondo è un dato obiettivo dacogliere con le categorie e i metodi della ratio scientifica , mentre nella seconda viene rifiutata l’esistenza autonoma del datoobiettivo che deve allora essere necessariamente compreso come costruzione di senso della soggettività (o, come vedremo meglio inseguito, dell’intersoggettività).La prima conseguenza di un approccio trascendentale è che occorre risalire ai modi attraverso cui l’intersoggettività pre-scientifica e scientifica ha prodotto “ le validità del mondo ed i
130
loro contenuti ”, cioè quello che l’obiettivismo accetta come datodi fatto indagabile come tale.Naturalmente Husserl non vuole opporre all’obiettivismo il suo nemico di sempre, il soggettivismo, e quindi con ciò ritornare su una posizione tradizionalmente espressa in varie forme da molti altri pensatori precedenti, ma intende bensì superare questa alternativa, come con grande consapevolezza aveva già fatto molti anni prima nel dibattito tra logicisti e psicologisti.
“ Il trascendentalismo più maturo protesta contro l’idealismo psicologicoe, mentre contesta la legittimità della scienza obiettiva in quanto filosofia, pretende di instaurare una scientificità di tipo completamentenuovo, trascendentale. La passata filosofia non aveva nemmeno presentito un soggettivismo di questo stile. Mancava un motivo efficiente perché l’atteggiamento di fondo potesse mutare, per quanto un atteggiamento di nuovo genere sarebbe stato pensabile in base all’antica scepsi, e proprioa partire dal suo relativismo antropologico.”
Per riaprire dunque nuovi orizzonti alla filosofia occorre superare l’alternativa paralizzante tra obiettivismo e soggettivismo, perché nel primo caso ci si attarda ancora in una visione metafisica, anche se di natura diversa da quella tradizionale, mentre nel secondo si finisce scetticamente per cadere nella relatività antropologica.In realtà Husserl, nel momento in cui afferma che tutta la storia della filosofia “è storia di poderose tensioni tra la filosofia obiettivistica e la filosofia trascendentale”, ci rivela come il soggettivismo sia stato un’immatura espressione di quest’ultima, la quale però ormai è giunta alla sua “forma finale”, cioè alla fenomenologia. La piena assunzione di questa prospettiva comporta “come uno dei suoi momenti di rilievo, una forma finale della psicologia” a cui è finalmente consentito di liberarsi dal naturalismo delle sue origini. 53
Diventa allora importante ripercorrere il processo di costituzionedella psicologia naturalistica perché solo a partire da questo si può mostrare, nello stesso tempo, sia la sua impossibilità di afferrare “la soggettività operante” (il suo fallimento) sia la necessità di far emergere la sua natura trascendentale (la sua realizzazione) nella prospettiva di aprire, con essa, una via d’accesso alla soggettività ed alle sue operazioni di costituzionedelle validità del mondo che l’obiettivismo assume come realtà giàdate.53 La crisi…, cit.,p.98.
131
La psicologia dopo Cartesio
Husserl dunque si adopera a “chiarire realmente il senso unitario dei movimenti filosofici moderni” perché è nel loro ambito che “verrà ben presto in luce il ruolo svolto dallo sviluppo della nuova psicologia” il cui superamento è necessario per dare avvio alla ricerca fenomenologica.Abbiamo visto come con Galileo si pone nella cultura filosofica e scientifica occidentale un ideale conoscitivo oggettivante di tipomatematico-fisico e, nello stesso tempo, ancora metafisico.Ma è con Cartesio che questa prospettiva viene ad essere filosoficamente giustificata in modo tale da sedimentarsi profondamente nella cultura occidentale.Una delle opere più importanti di Husserl, come dichiara lo stessoautore che la pone sostanzialmente sullo stesso piano della sua Lebenswerke (opera di tutta una vita), cioè della Krisis, è dedicata proprio a Cartesio, definito “patriarca” della fenomenologia.Il titolo di quest’opera (Meditazioni cartesiane) scaturito da due conferenze tenute a Parigi da Husserl il 23 e il 25 Febbraio 1929 proprio all’Amphithéatre Descartes alla Sorbona, ci rivela subito il debito della fenomenologia verso Cartesio e nello stesso tempo l’intento di andare oltre “ il corso meraviglioso delle sue meditazioni”.Le cinque meditazioni in cui è diviso il testo convergono sul problema dell’intersoggettività, la cui risoluzione costituisce ilpassaggio decisivo che consente a Husserl di individuare ciò che lega la dimensione trascendentale alla realtà effettuale del mondo.Tra le Meditazioni e la Krisis, dove, come vedremo, viene articolata larelazione tra soggetto e mondo, tra pensiero e vita, c’è quindi una strettissima continuità.In estrema sintesi : Husserl, partendo dalla radicalità della messa fuori causa di tutte le conoscenze e dalla purezza dell’ego-cogito di Cartesio, si pone come un suo continuatore, nel senso che egli intende dare “ inizio ad una chiarificazione radicale delsenso e dell’origine del concetto di mondo, natura, spazio, tempo,esseri animali, uomo, psiche, corpo, comunità sociale, cultura”.Husserl ripropone dunque l’ideale di una filosofia come conoscenzadella totalità, cioè l’ideale della piena e vera realizzazione
132
della ragione che, storicamente espresso dalla tradizione metafisica occidentale , dal cogito di Cartesio in poi, va perseguito sul terreno della soggettività trascendentale.Ciò comporta che un nuovo inizio in filosofia deve preliminarmentedissolvere il contenuto oppositivo delle coppie di categorie attraverso cui la tradizione ontologica occidentale ha cercato di afferrare la totalità : oggetto e soggetto, interno ed esterno, immanenza e trascendenza, reale ed irreale, materia e spirito, psiche e corpo, devono essere ripensati in un orizzonte diverso, cioè quello fenomenologico.Il punto di partenza di questo grande progetto filosofico è rappresentato dall’ego cogito cartesiano, la cui valenza rivoluzionaria era però rimasta inesplicata e irretita dal ripiegamento psicologistico del suo stesso geniale creatore. E’ quindi da qui, da questo psicologismo e dai suoi sviluppi che occorre ripartire per poter riaprire la filosofia a nuova vita.Come abbiamo visto, per Husserl, l’asse portante dello sviluppo del pensiero moderno è la contrapposizione tra obiettivismo e trascendentalismo e proprio su questo sfondo egli legge il costituirsi della psicologia come “scienza fondamentale”, che pretende di essere “definitivamente esplicativa rispetto alle scienze concrete dello spirito”. Nell’opera di Cartesio , strutturalmente attraversata da questa contrapposizione, essendo egli il “ fondatore dell’idea moderna di un razionalismo obiettivistico e insieme del motivo trascendentale chiamato a diromperlo”, Husserl trova così il proprio punto di partenza ed insieme il compito di superarlo.La nuova idea di filosofia che prende corpo con Galileo e che trova in Cartesio il suo sviluppo si fonda sulla credenza che sia possibile una mathesis universale di un mondo in generale. Anche se tra i due fondatori della filosofia moderna come scienza non c’è una continuità programmata e consapevolmente assunta come compito, c’è una loro convergenza di fatto intorno all’idea della nuova filosofia che porta Husserl a postulare l’esistenza di una nascosta teleologia storica- si potrebbe dire, vichianamente, un’eterogenesi dei fini teoretici- che opera “ senza che queste persone abbiano la possibilità di rendersi conto di ciò a cui tendono.” 54
E’ quindi la “potenza di quella nuova idea della filosofia che agisce attraverso tutta l’epoca moderna” che rende anche i fraintendimenti fecondi e salva le sue temporanee manifestazioni banali e verbalistiche dall’inutilità.54 Ibid.,p.102
133
Nelle Meditazioni metafisiche questa potenza si esprime in un modo così pieno e diretto che “perfino Cartesio” non riuscì a cogliere la sua profondità lasciandosi così sfuggire “quella grande scoperta che aveva già tra le mani.”Non ci si deve quindi “lasciar spaventare dall’apparenza di rudimentalità teorica , dal fatto, ben noto, che Cartesio svaluta le sue scoperte con prove paradossali e contraddittorie dell’esistenza di dio, né dalle altre oscurità ed ambiguità” poiché “non si tratta soltanto di residui della tradizione scolastica, di pregiudizi casuali del suo tempo, bensì di ovvietà millenarie, che possono venir superate soltanto mediante un chiarimento e un’ulteriore elaborazione che porti alle sue estremeconseguenze ciò che si nasconde nel suo pensiero.” Il compito che si dà Husserl è perciò quello di individuare il nucleo originario della nuova idea della filosofia per poter poi esplicitarlo, sradicando così la tenace persistenza e resistenza delle categorie logico-formali su cui si è definito il paradigma oggettivistico-metafisico nel pensiero occidentale.Come essere filosofo ? , come esercitare in modo proficuo la propria ragione ?, come superare ogni possibilità di dubbio nell’esercizio della propria ragione ? .“ Ogni filosofo, almeno una volta nella vita, deve procedere così,e se non lo ha fatto, anche se già dispone di una propria filosofia, bisogna che lo faccia.”Ponendosi radicalmente questi interrogativi Cartesio conquista infatti l’ego cogito e l’epochè , che per Husserl costituiscono “ il punto d’Archimede di qualsiasi autentica filosofia” Anche se la loro semplicità e purezza viene inevitabilmentecontaminata dal peso della storia del pensiero occidentale, ciòche per Husserl è decisivo è che essi segnano una svolta decisiva.Sospendere ogni validità, da quelle scientifiche e filosofiche fino a quelle del mondo-della-vita, è quindi dovere primo di ogni filosofo.L’atto rivoluzionario che pone l’ego apoditticamente al di sopraed al di fuori di ogni cosa non viene però portato da Cartesioalle sue necessarie quanto estreme conseguenze. Troppo pressatodall’urgenza della sua meta finale- la giustificazione filosoficadel razionalismo obiettivistico- non si avvede che egli stessofalsifica in senso psicologistico l’ego puro a cui era approdatoattraverso il dubbio iperbolico.Mens sive animus sive intellectus : dopo aver posto in essere l’epochè, la sospensione di tutte le conoscenze e le validità precedenti,
134
Cartesio nomina l’io come parte di quel qualcos’altro che aveva dissolto con il suo dubbio iperbolico.Ma in questo modo l’ego si fa “residuo del mondo”, è qualcosa che rimane dopo aver tolto il corpo, è cioè un’entità che richiama in gioco quello che era stato sospeso e di cui allora si continua a riconoscere la validità.Per Husserl è la purezza dell’ego che invece deve persistere come tale, non essendo altrimenti qualificabile se non ricorrendo a ciòdi cui si era sospesa ogni validità, cioè a categorie preesistentiche non erano evidentemente state del tutto rese inoffensive dallaradicalità dell’epochè.La purezza dell’ego attinto mediante l’epochè viene come implementata da parte dell’io psichico; mentre occorreva invece mantenere saldamente la distinzione tra ego puro ed io psichico poiché solo in questo modo è possibile far emergere dal primo la sua dimensione trascendentale-fenomenologica.Ciò non comporta naturalmente che l’ego puro è vuoto mentre quellopsicologico, movendosi nell’orizzonte fluente-costante del mondo-della-vita, è totalmente pieno. La sua costituzione è opera di unariduzione metodologica che lo ritaglia dall’io empiricamente coinvolto nel mondo (io psichico) per cogliere la sua virtualità intenzionale con il mondo, cioè il suo legame indissolubile e costitutivo con le possibilità del mondo.Una delle finalità più importanti dell’intera opera di Husserl è mostrare proprio come non sia possibile pensare l’io da una parte e il mondo dall’altra. Non bisogna dunque confondere i diversi piani su cui si dislocano metodologicamente l’ego puro, l’ego trascendentale e l’ego empirico con la realtà data ed immanente incui essi vivono come unità inscindibile.Anche se Cartesio finisce per identificare l’ego con l’anima, sovrapponendo così io psichico ed io puro, egli rimane, per Husserl, colui che “ comincia effettivamente una filosofia di genere completamente diverso” poiché essa da questo momento cercherà “ la propria fondazione ultima nella sfera della soggettività” essendo “ ormai impossibile sottrarsi alla necessitàdi questa esigenza”.Husserl spiega questa confusione con l’urgenza da parte di Cartesio di giustificare filosoficamente l’obiettivismo delle scienze esatte mentre, invece, rimanendo all’interno dell’epochè, egli avrebbe avuto la straordinaria possibilità di sviluppare un’analitica dell’ego puro e quindi esplorare la sua dimensione trascendentale.
135
Ma poiché questo non è avvenuto, il corso della storia dellafilosofia è stato caratterizzato dagli esiti obiettivistici delsuo pensiero, in cui sono comprese anche le reazioni ad esso. Daquesto punto di vista razionalismo ed empirismo costituiscono perHusserl due diversi ed erronei modi di declinare l’obiettivismo diCartesio che, risolvendosi in scetticismo (empirismo) e indogmatismo (razionalismo), non riescono a rendere conto dellarelazione tra soggetto ed oggetto.Dopo aver colto in Cartesio il momento in cui la filosofia conosceun radicale rinnovamento, poiché in essa emerge in modo prioritario il concetto di trascendentale, e dopo aver constatato il fatto che questo concetto finisce per essere indebitamente confuso in senso psicologistico, Husserl guarda alla successiva riflessione filosofica soprattutto da punto di vista della sua relazione con la psicologia.La sopravvivenza della filosofia, nell’epoca del sapere positivo edei successi della scienza, passa infatti proprio attraverso l’emancipazione della psicologia dal suo dualismo e naturalismo. Nella sua ricostruzione dell’itinerario filosofico che ha condottoalla fondazione della psicologia come ‘scienza’ obiettiva della soggettività, Husserl mostra come anche Locke, partendo dal concetto di idea di Cartesio, finisce per legittimare una psicologia naturalistico-gnoseologica sulla base del suo modellamento sul paradigma teorico-metodologico delle scienze naturali.Locke, secondo Husserl, nella sua convinzione che ogni atto conoscitivo è totalmente riconducibile all’esperienza reale, non solo lascia cadere ogni possibilità di uno sviluppo diverso del concetto di trascendentale che si era affermato con le Meditazioni metafisiche di Cartesio ma, ancora più originariamente, non coglieche l’essenza della coscienza è l’intenzionalità.“Egli non considera il fatto che nelle percezioni, negli “Erlebnisse” di coscienza è sempre presente, come tale, ciò di cui essi sono coscienza, il fatto che la percezione è in se stessa percezione di qualcosa, di “questo albero”.Consegnandosi ad un irrevocabile sensualismo dei dati psichici, che costituiscono “un reale chiuso in sé come il corpo”, Locke costruisce la “prospettiva di un ingenuo naturalismo” dove appunto“l’anima viene intesa come spazio per sé”.Questo è per Husserl “ciò che sarà particolarmente negativo per lafutura psicologia e per la teoria della conoscenza” 55 che, come già sappiamo, sono costitutivamente connesse.55 La crisi…, cit., p.113.
136
Per Locke c’è uno spazio interno, che viene ben rappresentato con la metafora della superficie della tavoletta di cera, dove l’esperienza imprime i suoi contenuti contingenti , da indagare come un reale chiuso in sé. La psicologia per Locke è dunque analisi delle modalità dell’esperienza interna nelle sue determinazioni psico-fisiologiche. Abbandonando così ogni residua possibilità di cogliere la dimensione trascendente delle validità egologiche, presente nella problematizzazione cartesiana della soggettività, il pensiero di Locke, secondo Husserl, consolida l’idea della psicologia obiettivistica e naturalistica. Che cos’è che collega lo psichico all’extra psichico? Locke non si pone filosoficamente questo interrogativo rimanendo così nell’ovvietà della provenienza esterna di ciò che, attraverso i sensi, si produce nello spazio interno. Il suo collegamento con le cose esterne, la sua certezza, viene garantita dal fatto che esso è possibile perché attualmente una realtà esterna lo ha prodotto, mentre si ha solo una conoscenza probabile degli oggetti che non sono più testimoniati dai sensi.Da questo quadro, in cui non si dà alcuna consapevolezza dell’essenza intenzionale della coscienza, cioè del suo nesso costitutivo con il mondo, non poteva non emergere, secondo Husserl, uno sviluppo paradossale. Sono le “ingenuità e incongruenze” della psicologia naturalistico-gnoseologica di Locke che infatti rendono possibile l’idealismo immaterialistico di Berkeley il quale, mosso da una difesa ad oltranza dei valori spirituali, enuclea una delle virtualità filosofiche effettivamente presenti nell’empirismo.Pur nella sua paradossalità, la spiritualizzazione del tutto attraverso cui Berkeley annulla ogni sostanza reale e materiale, si fonda sulla immanenza empirica dei processi conoscitivi affermata da Locke. Ma è con Hume che si giunge alle estreme conseguenze della mancataconsiderazione della dimensione trascendentale dell’ego: l’esito èinfatti il solipsismo e una totale improponibilità di conoscenze scientificamente fondate.Come è noto Hume riduce ogni atto conoscitivo all’abitudine, cioè ad un processo psicologico che va ricondotto alla forza ed alla immanenza dell’impressione che costituisce la fonte originaria sulla cui base i processi di associazione e di relazione tra idee costruiscono credenze, come ad esempio quella, fondamentale, di causa. In questo modo, partendo dal sensualismo di Locke , Hume dissolve ogni possibilità al sapere obiettivo della scienza ma, nello
137
stesso tempo, si autolegittima come fondatore newtoniano di una psicologia scientifica della natura umana. Husserl coglie questo paradosso chiedendosi come sia possibile, dauna parte, fondare una teoria come vera, universalmente e necessariamente vera, e, nello stesso tempo, affermare che ogni nostra conoscenza non è altro che un esito di processi psicologiciassociativi che si imprimono nella tavoletta della mente.Conseguentemente “ come qualsiasi scetticismo, qualsiasi irrazionalismo, anche quello di Hume finisce per dissolvere se stesso.” 56
Il problema della conoscenza, che riguarda la natura della relazione tra soggetto ed oggetto , rimane dunque più aperto che mai.
Un’altra occasione mancata: Kant e la psicologia
Come sappiamo, l’obiettivo dell’opera di Kant è proprio quello di definire, nello spazio teorico posto in essere dalla sua rivoluzione copernicana, una nuova prospettiva che, liberando l’empirismo e il razionalismo dalla loro unilateralità e dalla loro opposizione infeconda, renda possibile comprendere i rapportitra soggetto ed oggetto in un modo nuovo.Dalla prospettiva fenomenologica di Husserl l’opera di Kant, come punto di convergenza, e nello stesso tempo di superamento, dell’empirismo e del razionalismo, da una parte, pone in essere lecondizioni per dare un fondamento trascendentale alla psicologia,dall’altra è proprio con ‘opera del filosofo di Konisberg che avviene“la fatale separazione della filosofia trascendentale dalla psicologia”Conviene appena ricordare come Kant si sia trovato di fronte ad una situazione in cui, da una parte, è stata messa in discussione l’ovvietà della corrispondenza tra le leggi della ragione con la verità metafisico-obiettiva (scetticismo) - e ciò pur nella paradossalità della rivendicazione della verità della propria conoscenza che afferma il carattere ‘finzionale’ di ogni conoscenza - e, dall’altra, con gli esiti del razionalismo protesialla costruzione di sistemi metafisici del tutto indipendenti dalla conoscenza empirica (dogmatismo).
56 Ibid., p.116.
138
Entrambe queste prospettive filosofiche non riescono a chiarire lanatura profonda della relazione tra soggetto ed oggetto, tra ragione ed esperienza, tra pensiero e vita.Per Husserl la risoluzione di questo problema è capitale in quantoesso è il primo problema della filosofia che non può essere inteso come un’operazione preliminare che, una volta compiuta, non occorre affrontare più, come se, individuati i fondamenti, si può costruire sopra di essi in modo non più problematico.Non si tratta cioè di scoprire qualche fondamento già dato, un originario in quanto tale ma, piuttosto, di porre mano alla definizione di una prospettiva in cui possa emergere progressivamente un percorso filosofico che fonda se stesso nel suo stesso farsi .L’origine è dunque un originarsi in actu , un incessante movimento di autoriflessione crititica sul proprio operare teorico e metodico che, nel momento stesso in cui chiarifica e giustifica ogni suo passaggio, pone in essere i propri fondamenti.E’ la “ratio nel costante movimento dell’autorischiaramento” che Husserl vede dispiegarsi in particolare nell’opera di Kant, il cuiatteggiamento critico consiste proprio nella ridefinizione di una nuova prospettiva che consenta alla ragione di comprendere se stessa (sia nella validazione che nella limitazione) nel processo del suo farsi.Kant, tentando di connettere la struttura della coscienza con la conoscenza scientifica, vuole superare la mancanza di fondamento del razionalismo proprio attraverso l’apertura di una prospettiva in cui la filosofia possa costituirsi nel processo del suo stesso dispiegamento.La Critica della ragion pura è solo un necessario lavoro propedeutico rivolto a rendere possibile un nuovo sistema della metafisica, la cui funzione non potrà però più essere quella di costruire visionicomplessive e sistematiche dell’essere ontologicamente colto nellasua oggettività, ma sarà invece quella dello studio dei principi a-priori che permettono la conoscenza, come, ad esempio, avviene nell’indagine dell’azione morale (Fondazione della metafisica dei costumi) edella natura ( Principi metafisici della scienza della natura).In questo modo Kant ha ricondotto la filosofia al suo compito primario ma, secondo Husserl, non ha portato alle necessarie ed estreme conseguenze la sua rivoluzione copernicana che pone -senzaricadere in precedenti concezioni- il soggetto conoscente e non l’oggetto da conoscere al centro della sua riflessione. La rifondazione della filosofia esigeva per Husserl di
139
problematizzare anche quelle “validità d’essere” che invece lo stesso Kant “usa senza indagare” Esse sono costituite da ciò che viene comunemente ritenuto come ovvio, anzi come dice lo stesso Husserl, dalle“ più ovvie ovvietà”: il nostro essere attivi, passivi, tematici, non tematici, rimemorativi, soggetti in atto, oggetti di riflessione o soggetti di riflessione, egoità corporee e percettive, corpi percepiti ecc.in un “mondo in comune già dato, nel nostro vivere-insieme.”Sono proprio queste ovvietà già da sempre date e non problematizzate che costituiscono quelle “validità d’essere” che ifilosofi devono indagare, poiché esse sono “i presupposti costanti” della scienza e dello stesso pensiero filosofico. Una volta tematizzate, infatti, “dischiudono una dimensione nuova ed estremamente enigmatica” che rivela la natura profonda delle relazioni ( soggetto-oggetto, pensiero-vita, ragione-esperienza, scienza-coscienza) su cui Husserl vuole ri-fondare la conoscenza filosofica, riaprendola in questo modo alla sua originaria ricerca.Ora è proprio questa elementare coscienza del mondo che rimane fuori della pur rivoluzionaria prospettiva di Kant, il cui fine principale è sì quello di “ risalire alle condizioni soggettive della possibilità di un mondo obiettivamente esperibile e conoscibile”, ma che, secondo Husserl, non è stato perseguito finoagli estremi confini del “regno del soggettivo”, dove avvengono i processi spirituali costituenti forme di senso. La loro profonditàè celata da una manifestazione “ovvia” e per questo risulta estremamente difficile indagarli da un punto di vista radicalmentetrascendentale. Non solo l’originario, come ci rivela Eraclito, per sua natura, “ama nascondersi”, ma esso è stato ulteriormente celato dalle stesse categorie che la filosofia ha incessantemente costruito nel corso della sua storia.E’ questa per Husserl la ragione che spiega le “caratteristiche” difficoltà del concetto di trascendentale, la cui oscurità e nebulosità è dovuta alla sua tematizzazione solo parziale e sempreerroneamente pensata in opposizione alla dimensione empirico-immanente.Anche se Husserl riconosce a Kant il grande merito di aver cercatoil trascendentale in modo radicalmente diverso dalla tradizione metafisica occidentale, tuttavia considera la sua rivoluzione incompiuta poiché la trascendentalità del “regno del soggettivo” èancora contaminata dalla empiricità del suo psichismo.
140
Da questo punto di vista si potrebbero allora spiegare le sue oscillazioni nella definizione e nell’uso di questo concetto decisivo. 57
Husserl addebita ciò sia alla predominanza, nell’epoca di Kant, diuna psicologia razionale fondata sul paradigma teorico-metodologico delle scienze naturali sia alla straordinaria resistenza delle formazioni logiche che nel corso della storia delpensiero si sono profondamente sedimentate, parallelamente al progressivo occultamento delle proprie origini.Ciò che allora ci si dà come ovvio , evidente e non tematizzabile come campo di ricerca è per Husserl esito di operazioni spiritualidi senso radicate e scaturite dalla realtà storica del mondo-della-vita, cioè da una dimensione già-data.Il primo compito della ricerca fenomenologico- trascendentale saràproprio quello di far emergere il ‘lato oscuro’ delle categorie logiche mostrando come esse non siano pure processualità oggettivedel pensiero ma esiti di un processo originario di “costituzione” che solo la fenomenologia è in grado di indagare. Essa infatti, alcontrario di Kant che, nonostante la sua rivoluzione, permane entro un orizzonte in cui “ si mescolano il fattuale e l’apriorico”. 58 è la sola via che conduce alla dimensione trascendentale.
L’enigma della relazione vita-pensiero
Nell’opera di Husserl acquistano allora particolare importanza le ricerche sull’origine delle strutture logiche che si sono sedimentate nella cultura filosofica occidentale. In Esperienza e giudizio (ma anche in altre opere, e probabilmente anche in ciò che ancora non è stato reso noto del suo vasto Nachlass, ancora in corso
57 Nella Critica della ragion pura si possono enumerare più di dieci significati di trascendentale. La polivalenza semantica del termine è talmente ampia che in qualche caso ne fa le spese la sua stessa delimitazione nello spazio teorico delcriticismo, poiché Kant arriva ad usare in qualche occasione il concetto di trascendentale quale sinonimo di trascendente. E’ comunque unanimemente accettato che il campo semantico del termine, determinato anche dalla sua frequenza statistica nei testi kantiani, è quello centrato sul significato di studio filosofico delle condizioni a-priori che rendono possibile le conoscenze fenomeniche58 E. Husserl, Kant e l’idea della filosofia trascendentale, Il Saggiatore, p.33
141
di trascrizione e pubblicazione) la ricerca genealogica è rivolta a ricostruire la natura del rapporto tra procedimenti logici ed esperienza. La fenomenologia procede dunque sia sul piano statico che genetico59, perché, da una parte si interroga sulla coscienza, sull’ego, sulla loro costituzione e sui loro vissuti (chi è l’io che ha il mondo?), dall’altra non può non investire l’orizzonte temporale radicato in ogni atto di coscienza, in ogni vissuto (come si autocostituisce il flusso della soggettività?). Husserl, negli anni successivi al 1910 rilegge la Critica della ragion pura in rapporto alla costituzione genetica della coscienza, trovando poi ulteriore materia di riflessione su questo tema decisivo con le opere di Natorp (Philosophie und Psicologie e Allgmeine Psicologie), filosofo neokantiano interessato a percorrere lo spazio teorico tra logica e psicologia. Conseguentemente a questi sviluppi, e cioè principalmente al fatto che ogni atto intenzionale si radica e si esprime in un orizzonte temporale, Husserl pone una domanda di ritorno o di secondo grado (Rückfrage) sulla domanda iniziale finalizzata a tematizzare e ad indagare il processo di costituzione che rende l’io capace di avere un mondo. Attraverso una “archeologia fenomenologica” (così si esprime lo stesso Husserl) si deve risalire alla comprensione del mondo valido per tutti; in questo modo risulta evidente la necessità del nesso tra temporalità ed intersoggettività. E’ infatti nel mondo-in-comune, cioè sul terreno dell’esperienza reale intersoggettiva che trovano origine le verità della logica, che sono dunque “verità predicative” fondate sulla realtà di statidi cose empiricamente reperibili. Il concetto di “verità predicativa” postula però l’esistenza del suo opposto, cioè di “verità non predicativa” che viene da Husserl denominata come “verità antepredicativa”. Così è possibile distinguere tra verità relative a stati di cose reali (verità che si predicano in situazioni e dati di fatto) e verità di natura eidetica, che riguardano cioè essenze pure ( verità che non si predicano in situazioni e dati di fatto). A loro volta queste verità vengono investite dalla Rückfrage, cioè da un’interrogazione sulla loro genesi che può procedere solo con la tematizzazione e l’analisi della temporalità nel tentativo di districare il complesso intreccio di fili che connettono il costituente con il costituito.
59 Come evidenziano Carlo Sini e Mario Vergani ( rispettivamente nella Prefazione e nel Saggio introduttivo a Metodo fenomenologico statico e genetico, titolo di una serie di manoscritti di ricerca degli anni venti che Husserl dedica all’analisi del ruolodel tempo nell’intuizione e nella conoscenza.
142
Le verità antepredicative non vanno quindi cercate nella dimensione visibile degli enunciati-specchio della logica che riproducono, nel linguaggio, stati di cose reali. Il compito dell’indagine e del metodo fenomenologico è rivolto preliminarmente, risalendo al di qua della logica classica fondata daAristotele sul concetto di verità ‘in connessione’, cioè di veritàcome adeguamento a qualcos’altro, a far emergere la dimensione antepredicativa della verità. Non è questione allora di mettere in discussione la validità ed il fondamento di questo tipo di logica “superficiale”, ma di superarla per “ raggiungere realmenteuna sfera più profonda, di coglierla puramente in se stessa e di definire il genere di esperienza che le è peculiare. Allora risulterà chiaro quanto profondo sia l’antagonismo tra la via ‘patente’ in superficie e la via ‘latente’ in profondità.” 60
A chi scenderà in questo universo profondo ed insieme originario dell’esperienza - profondo anche in quanto originario- “ a colui che cerca di penetrarlo, balzano incontro, dal buio, tanti fantasmi logici, antinomie paradossali, controsensi, sotto forma di familiari e riconosciute strutture concettuali. Perciò “ in nessun altro settore è tanto viva la tendenza a scivolare in un’aporetica logica, in dispute logiche e a ritenersi così soddisfatti della propria scientificità, mentre il vero e proprio substrato della ricerca, i fenomeni stessi, si sono dileguati dal campo visuale.” 61
C’è una dimensione profonda di natura pre-logica, pre-categoriale e pre-scientifica che pone ai filosofi ed insieme agli scienziati il compito di porre mano alla costruzione di una scienza più alta in grado di indagarla. Da questo punto di vista si potrebbe dire che l’intera opera di Husserl è la costante ricerca della definizione delle condizioni preliminari che consentono di intraprendere questa forma di conoscenza radicalmente nuova, che non si fonda e non si sviluppa “sopra l’ovvietà del mondo-della-vita”, ma, al contrario, la problematizza per aprire all’indagine filosofica le sue profondità eidetiche. In questo modo l’ovvio (l’”ob-vius “, ciò che è sulla via a portata di tutti) è il già-dato, cioè validità d’essere in cui da sempre siamo e che diventano un “problema filosofico universale”.Il “piccolo inizio” della Krisis di cui parla Husserl - in realtà “matura definizione e messa a punto del programma e del metodo fenomenologici” 62 e approdo di uno straordinario percorso teorico
60 La crisi…, cit., p. 14961 Ibid.62 Sini, Introduzione a L’idea della fenomenologia, cit p.8.
143
che ha impresso una svolta decisiva a tutta la filosofia del ‘900,consiste allora nell’aver individuato la problematicità teorica del già-dato. Ciò avviene nel momento stesso in cui si abbandona l’atteggiamento diretto e naturale in cui il mondo è per noi costantemente una realtà non ulteriormente indagabile, se non nei termini empirico-fattuali in cui esso si offre.Ciò comporta la definizione di uno spazio teorico che non è stato mai programmaticamente posto dalla ricerca filosofica nella sua necessaria radicalità, anche se naturalmente Husserl lo iscrive nella tradizione del pensiero filosofico di un’umanità “ che si concepisce come un’umanità razionale che comprende di essere razionale nel voler-essere-razionale” e che con alcuni pensatori, come Descartes e Kant, era già stato chiaramente individuato e produttivamente percorso. Per Husserl dunque “la ratio nel costante movimento dell’autorischiaramento” non può non approdare all’esigenza di problematizzare filosoficamente “l’orizzonte fluente-costante che abbraccia tutti i nostri fini”, compresi quelli scientifici.La tematizzazione del mondo-della-vita include perciò quella dellaprassi teoretico-logica che guida l’operare della scienza, essendoquest’ultima fondata proprio sull’evidenza del mondo-della-vita, in cui, ci ricorda Husserl, sono immersi gli stessi scienziati: laricerca delle apparecchiature, l’acquisizione delle conoscenze tecnico-scientifiche precedenti, l’individuazione e l’organizzazione di sedi operative per la ricerca, la richiesta agli apparati burocratici e di potere dei finanziamenti necessari alle loro attività, la relazione degli scienziati tra loro e con altri uomini all’interno di culture e politiche nazionali ed internazionali, i rapporti con le strutture economiche, finanziarie e produttive, ecc., fa sì che “tutto quanto entra in funzione” nel processo che li conduce alle loro conoscenze ‘ obiettive ’.C’e quindi un ineliminabile “momento soggettivo-relativo” che è profondamente intersecato con le validità oggettivo-assolute che gli scienziati perseguono.Per Husserl non è dunque possibile disancorare questo momento dalla prassi teoretico-logica della scienza che deve essere iscritta nella “ piena concrezione del mondo-della-vita “.La situazione che si viene a configurare vede perciò da una parte il mondo-della-vita con le sue evidenze originarie non indagate, edall’altra, la prassi scientifico-obiettiva che, basandosi su questo terreno di datità non filosoficamente analizzate, costruisce un sapere che vuole essere, al di là delle stesse
144
convenzioni logiche in cui si radica, metafisicamente oggettivo e trascendente la dimensione storica e umana soggettivo-relativa. Come è allora possibile conciliare il “mondo obiettivamente vero” (derivante dai procedimenti teorici del pensiero scientifico) ed “il mondo-della-vita” (direttamente ed immediatamente intuibile prima di qualsiasi teorizzazione) ?La risposta a questa decisiva questione richiede, per Husserl, unatale radicalità che diventa impossibile fare appello alle filosofie precedenti, nonostante le grandi opere di Cartesio primae di Kant poi si siano decisamente poste in questa direzione.A rendere la soluzione di questo “enigma” non a portata di mano è l’esigenza di una sua definizione su un nuovo terreno scientifico che non può però essere sia quello tradizionale filosofico-concettuale, sia quello logico-matematico. Ciò che per Husserl allora occorre è un nuovo inizio in filosofia che in primo luogo sappia “ approfondire il senso del compito che ci siamo proposti”.Dovendosi quindi muovere in una dimensione accuratamente decontaminata dai pregiudizi, in una piena e coraggiosa autonomia di pensiero, non è possibile fare riferimento ad alcuna logica normativa già data, né consentire intromissioni esterne, cioè utilizzare prassi teoriche o concezioni filosofiche consolidate . Anche se inevitabilmente ciò comporta grandi difficoltà, il cuisuperamento non è certo garantito fin dall’inizio, questa perHusserl è l’unica strada percorribile per evitare di ricaderenell’ingenua presunzione di conoscere metafisicamente un ordineesterno ed oggettivo al soggetto ed ai suoi atti.Occorre dunque ripartire da una dimensione non tematizzata e da sempre ritenuta naturale ed al di fuori di qualsiasi indagabilità.. La renovatio mentis a cui ci invita Husserl ci deve preliminarmente liberare dal predominio che nel pensiero occidentale ha avuto la logica predicativa che, mentre mostra, da una parte, tutta la sua efficacia conoscitiva positivamente verificabile nella fondazione, nello sviluppo e nell’applicazione delle strutture concettuali della scienza, dall’altra risulta invece totalmente inadeguata nella costruzione della scienza dellasoggettività . E’ quindi proprio la nascita della psicologia, modellata dall’obiettivismo fisicalistico, che fa emergere il limite di questo paradigma conoscitivo, essendo esso incapace di afferrare la “soggettività operante”. E’ proprio allora nella pretesa di conoscenza della psicologia che giunge a mostrasi la contraddizione fondamentale della teoria della conoscenza metafisicamente fondata.
145
La connessione vincolante tra filosofia, scienza e psicologia dovrebbe, a questo punto, iniziare a delinearsi . La psicologia rende evidente la necessità di superare le categoriepredicative su cui si è originato il pensiero scientifico-filosofico poiché, procedendo solo con queste, non riesce a com-prendere le strutture ultime della soggettività, accessibili solo ad un’indagine che abbia già precedentemente tematizzato il mondo-della-vita nella sua dimensione trascendentale e non esclusivamente nelle sue determinazioni empiriche particolari.Come abbiamo già visto la psicologia, nel processo della sua auto-costituzione come scienza autonoma che si allontana definitivamente dalla filosofia, si era trovata inevitabilmente difronte il paradigma teorico-metodologico delle scienze naturali a cui storicamente non poteva non fare riferimento.Si può però anche dire, rovesciando la prospettiva, che è dalla stessa logica di fondo di tale paradigma che emerge inevitabilmente l’esigenza di indagare anche la sfera della soggettività con criteri oggettivi e scientifici. Mantenendo separato l’ambito propriamente filosofico del pensiero da quello scientifico, la nascita della psicologia risulta determinata da undoppio movimento: quello che la spinge fuori dall’ambito filosofico del pensiero alla ricerca di una propria autonomia teorico-metodologica e quello esercitato dalla forza di attrazionedelle scienze esatte che, per una dinamica espansiva interna al loro paradigma, vogliono sottrarre alla filosofia tutto ciò che può essere ad essa sottratto, inclusi i suoi tradizionali ambiti di riflessione come il problema della soggettività e dei suoi vissuti.La psicologia, estendendo tale paradigma, senza alcunachiarificazione filosofica delle sue origini, alla comprensionedell’uomo, delle sue qualità psichiche e comportamentali , nonriesce- inevitabilmente, constata Husserl - ad afferrare lasoggettività e con ciò scopre l’assenza di una radicalegiustificazione filosofica del fondamento delle scienze esatte, ilcui modello teorico-metodologico scaturisce dalle premesseinindagate degli a-priori universali del mondo-della-vita, cioè diquella dimensione che proprio la psicologia dovrebbe essere ingrado di tematizzare e di indagare.Solo una psicologia consapevole della sua profonda natura trascendentale può farlo e così dare avvio ad un processo
146
conoscitivo in cui sia soddisfatta l’esigenza dell’apoditticità rispetto alla fondazione delle scienze. 63
Poiché il paradigma teorico-metodologico delle scienze esatte, dalmomento della sua formazione con Galileo e Cartesio fino al periodo in cui opera Husserl, non è ancora approdato alla problematizzazione filosofica della sua costituzione (ad eccetto naturalmente del celebre tentativo delle Meditazioni metafisiche , dove però Cartesio, con i piedi ancora nella filosofia e nella teologiascolastica, non affronta in un modo adeguato, cioè all’altezza della sua scoperta del cogito, la decisiva questione della fondazione della scienza).Per Husserl “occorrerebbe una distinzione sistematica delle strutture universali, dell’a- priori universale del mondo della vita e dall’a-priori universale “obiettivo”; successivamente occorrerebbe definire la problematica universale del modo in cui l’a-priori “obiettivo” si fonda sull’a-priori “soggettivo-relativo” del mondo-della-vita, oppure, per esempio, del mondo in cui l’evidenza matematica trova la propria fonte disenso e di legittimità nell’evidenza del mondo della vita.” 64 A chi spetta questo compito ?Come movimento di incessante auto-comprensione in cui l’uomo è “essere-chiamato a una vita nell’apoditticità”, la filosofia è perHusserl investita totalmente da questa esigenza in un modo radicale perché essa deve riattingere l’originario senza ricadere,nell’epoca del superamento irreversibile di ogni visione ingenuamente oggettivistica, in un’improponibile metafisica o in una delle mille Weltanschauung possibili. 65
La filosofia deve allora necessariamente quanto preliminarmente chiarire il proprio compito nell’epoca in cui le scienze naturali o esatte rivendicano un sapere apodittico in modo tale da riconfigurare, su basi nuove, i suoi rapporti con queste, compresala psicologia che vuole farne parte. Si viene così a creare un circolo in cui scienza, psicologia efilosofia, integrandosi e i rimandandosi l’una all’altra, trovanoil loro fondamento proprio nella giusta configurazione delle loroprofonde e necessarie interrelazioni. Solo in questo modo è63 Nelle Meditazioni cartesiane Husserl, partendo dal dubbio cartesiano, aveva già posto con chiarezza il rapporto tra evidenza e scienza autentica, ponendolo naturalmente sul piano di un sistema trascendentale in cui sia possibile discriminare tra evidenze ontologico-formali ed ontologico-materiali.64 La crisi…, cit.,p.168.65 Nel saggio La filosofia come scienza rigorosa Husserl ha chiaramente distinto la ricerca filosofica dalla elaborazione di mereWeltanschauungen poiché “ non potremmo più nutrire alcuna speranza in risultati teoretici, qualora divenisse predominante l’impulso alla Weltanschauung così da ingannare con le sue forme scientifiche anche le nature teoretiche”, cit., p.100.
147
possibile accedere all’originarietà delle “cose stesse” ed allaloro pura manifestazione e comprendere la genesi dell’operativitàteoretico-logica della scienza come prassi umana scaturita dalla “piena concrezione del mondo-della-vita”. La psicologia è così chiamata da Husserl a farsi carico di uncompito fondamentale, quello di mostrare come le evidenze delmondo-della-vita in realtà costituiscano dei presupposti da sempregià dati su cui gli uomini di scienza, in contesti culturali estorici determinati, sviluppano progetti teorici e pratici diconoscenza e di intervento sulle cose secondo l’ideale dellascientificità come conoscenza dell’essere-in-sé. Solo in questomodo, attingendo alle formazioni di senso originarie è possibilefondare un nuovo tipo di scientificità che ha superato la suanatura metafisico-oggettivistica. La psicologia e la scienzadevono quindi essere ripensate alla luce della prospettivafondazionale della fenomenologia in modo tale che siano poste lecondizione per aprire la ricerca filosofica all’esplorazione delrapporto tra vita e pensiero ed accedere così allo psichico insenso puro.Per Husserl ci sono due possibilità per aprire la filosofia allericerche fenomenologico-trascendentali: una che passa attraversola tematizzazione del mondo-della-vita già dato (cioè allariconsiderazione delle sue strutture formali-generali) e l’altrache muove dalla psicologia.Per il tema che qui si tratta è quest’ultima modalità di accessoche per noi assume un’immediata rilevanza, ma prima occorreconsiderare, perlomeno nelle sue linee generali, anche l’approccioche, attraverso l’epoché e la riduzione trascendentale, ci conducenel cuore del mondo-della-vita.
Due possibilità di essere desti
Per Husserl ogni uomo è immerso in un “orizzonte fluente-costante”, dove si costituisce, in un contesto di fini, transitorio permanenti, la sua coscienza intenzionale; in un qui ed ora, inun modo a portata di mano, si radica l’ego ed i suoi atti.L’immediatezza di questo esperire il mondo non è però l’unicapossibile in quanto “ può esistere un modo completamente diverso
148
di vita desta nell’aver coscienza del mondo” che pone il soggettonella condizione di poter valutare, attraverso un atto consapevoledi decisione, la pluralità dei modi, dei come il mondo vieneappreso e costituito.Ciò allora comporta il superamento della via naturale ed immediatadi vivere nell’orizzonte fluente-costante; l’interrogazione sulcome, tematizzando il “già-dato”, consente un’esperibilità del mondoin modi non immediati. Questo diverso atteggiamento è rivolto a costituire una scienzadel mondo-della-vita che esplora il mondo come terreno per ognivalidità d’essere.Lo strumento e la via per costituire una scienza dei fondamentiultimi e dell’universo puro della soggettività è l’epochè universaleche, d’un colpo solo, apre nuove prospettive filosofiche edantropologiche ponendo fuori gioco le validità d’esseredell’orizzonte-fluente costante.Epochè perì panton: il recupero dell’atteggiamento degli scettici, purnelle mutate condizioni scaturite da un dibattito filosoficobimillenario e da un progresso tecnologico che ha mutato il mondoe l’umanità, costituisce ancora per Husserl l’unica possibilità difar rinascere la libera ricerca filosofica, la cui essenza rimanequella di percorrere vie sperimentali (paratèresis) superando illimite della solo indagine diretta (autopsia).Questa trasformazione del modo in cui naturalmente il soggetto èinerente ad un orizzonte, per evitare pericolosi fraintendimenti, deveperò essere totale e radicale in quanto astensioni graduali disingole validità risultano insufficienti a porre il filosofo inuna condizione di reale libertà, cioè in una specie di grado zerodella teorizzazione rivolta ad attingere l’originario. Infatti levalidità naturali, in cui da sempre siamo immersi, non hannocarattere isolato ma, al contrario, costituiscono una totalitàdinamica in cui ogni dimensione della vita immediata si compenetracon le altre in un rapporto di muta convalidazione. “Quindi, in virtù di questa inerenza ad un orizzonte(Horizonthaftigkeit) costantemente fluente, qualsiasi validità direttamenteprodotta nella vita mondana naturale presuppone sempre altre validità;essa risale mediatamente o immediatamente a un sottofondo necessario divalidità oscure ma occasionalmente disponibili e riattivabili, le quali,tutte insieme e con gli atti veri e propri, costituiscono una connessionedi vita inscindibile”
149
L’epoché, per essere veramente tale, non può allora non porre fuorigioco l’insieme delle validità del mondo, sia quelleimmediatamente operanti, sia quelle “implicitamente fungenti”.Il carattere strutturalmente interrelato di ogni validità, la lorointerconnessione profonda, non consente di attuare l’epochéattraverso una serie di astensioni graduali. Se si opera in questomodo, necessariamente ogni atto di astensione di singole validitàporrà nuovi modi di validità “sul terreno naturale del mondo”. 66
Conseguentemente per non far fuggire in avanti il terreno dellevalidità d’essere è necessario attuare in modo radicale e totaleun’autentica epoché che però non toglie sostanza, consistenza esolidità al mondo.Husserl chiarisce subito che l’epoché non dissolve la validità delmondo, in cui il soggetto continua a vivere condividendo sensi esignificati intersoggettivi dati; essa consente però di renderlofenomeno, riducendone la complessa stratificazione di valori,problemi, interrogativi, sensi, esigenze pratiche ecc.alla soladimensione trascendentale.Conseguentemente, utilizzando un’espressione freudiana - in modoovviamente improprio - vi è come una “scissione dell’io” che dàluogo ad un suo raddoppiamento in cui accanto ad un io interessatoe aderente alle datità mondane “si stabilisce l’io fenomenologicocome spettatore disinteressato” L’epoché non è quindi una concezione filosofica del mondo ma,all’opposto, è un decidersi a perderlo per poi riconquistarlo inun modo più consapevole e pieno da una prospettiva che comunquenon potrà più essere come quella ingenuo-naturale precedente. L’epoché è un dunque un decidersi, un fare, la cui processualitàdialettica (del perdere e del ritrovare) favorisce una renovatiomentis che, come tale, non interessa solo il filosofo ma anche ogniuomo che ha costantemente di fronte a sé la possibilità diprendere le distanze dalle proprie contingenze esistenziali, perscoprirvi poi nuovi e più profondi sensi e significati. Il “ricominciare radicalmente da capo” diventa allora possibilequando si supera il limite dato dal rapporto immediato e naturalecol mondo così com’è, con le sue verità di fatto, con le sueconcretezze del qui ed ora, che totalizzano il soggettoesponendolo al rischio di ripetere staticamente esperienzedestinate a ripresentarsi come tali e ad opacizzareprogressivamente i suoi vissuti.
66 Ibid., p.177.
150
L’atteggiamento fenomenologico rivela qui tutta la sua originariae costitutiva valenza etica, spesso inspiegabilmente consideratamarginale anche da parte di diversi interpreti di Husserl.In una serie di scritti del 1923-24, recentemente pubblicati , lanatura originariamente e costitutivamente etica dellafenomenologia viene chiaramente rivendicata da Husserl, nella cuiintera opera, anche nei testi più profondamente impegnati inproblemi logico-teoretici, è sempre presente come motivopropulsivo di fondo.Il “funzionario dell’umanità” che riconosce e, si può propriodire, osserva fenomenologicamente nel proprio vissuto il “destinodi una esistenza filosofica” è colui che prende posizione neiconfronti dello spirito e del telos dell’umanità europea,assumendosi conseguentemente il compito di contribuire aritrovarlo e a rianimarlo nell’epoca del dominio della ragionestrumentale.La renovatio è nello stesso tempo nell’uomo e nella cultura, è unprendere coscientemente posizione nei confronti di se stessi edegli altri nel contesto della forma di vita e di scienzaprodottasi in Europa con la nascita del pensiero filosofico escientifico.L’etica è quindi parte non indipendente dalla attivitàscientifico-razionale poiché il rinnovamento si concretizzanell’impegno personale e collettivo di una humanitas che vuoledestarsi ad “un’autentica coscienza di sé” Nei testi dedicati in modo specifico e diretto all’etica Husserlchiarisce in modo inequivocabile che, nell’epoca dello smarrimentodella ragione filosofica e del dominio di quella strumentale, laricerca fenomenologica trova origine non nella ragione teoreticama in quella pratica.Il rinnovamento individuale e sociale è mosso dall’idea di umanitàrazionale e libera scaturita dalla nascita del pensiero filosoficonella Grecia classica: ogni uomo, sia esso filosofo o no, èchiamato “a fare il meglio possibile individualmente nelle condizioni date”e, nel momento in cui ciò è accettato responsabilmente, egliassume un valore assoluto. Dai vissuti degli individui fino aiproblemi di natura planetaria Husserl traccia un unico movimentoprogressivo di volontà che attraversa individui, gruppi, comunità,nazioni, stati e organismi sopranazionali in direzione di un’ideadi humanitas fondata sulla possibilità e sulla necessità diun’etica sempre più universale. L’intelletto è al servizio diquesto movimento progressivo della volontà che dall’imperativo
151
etico del singolo si amplia per gradi fino ad annettere quellodell’intera comunità umana. Il motivo più autentico e nascosto della fenomenologia consisteproprio in questa assunzione di responsabilità che coinvolgetutti, uomini e filosofi.La conoscenza è dunque per Husserl una pratica etica mossa dal telosimmanente all’umanità europea, quello di un divenire costante delrapporto tra libertà e ragione. Autoelevazione, passaggio da unadignità minore ad una maggiore, progressiva acquisizione diconsapevolezza sia da parte del singolo che della comunità, ecc.costituiscono, per Husserl, le fasi necessarie per superare il“razionalismo erroneo” in cui lo spirito europeo, nell’epoca deldominio della tecnica, sembra essersi smarrito.Naturalmente non si tratta, come precisa lo stesso Husserl, di unaforma di conservatorismo che ripropone come tale una passata formadi aristocrazia spirituale; al contrario, la fenomenologia èessenzialmente “desiderio di futuro”.L’epoché, come atto necessario di libertà e ragione a “cui ci sideve decidere una volta per tutte”, è la strada da percorrere perdare un nuovo impulso all’originario spirito filosofico europeo. Dei due modi di essere desti (dentro e fuori l’orizzonte fluente-costante)quello che si avvale dell’epoché, assume così una doppia valenza:etica e conoscitiva.L ’epoché deve quindi cogliere la soggettività nei modi determinatiin cui “allestisce in sé il mondo in quanto senso d’essere”; ilsuo compito è di “portare alla luce” la soggettivitàtrascendentale secondo i modi di una “nuova scientificità”.Escludendo di determinare le categorie della realtà così comepredicativamente si mostrano, l’epochè deve procedere ad una nuovaforma di tematizzazione del fiume eracliteo del mondo-della-vitain un modo tale da far emergere la complessità e la dinamicitàdella dimensione trascendentale dei vissuti soggettivi.Attraverso un universo concettuale costantemente aperto a nuoveconfigurazioni ( concetti di rappresentazione, genesi,anticipazione memorativa, presentificazione, ritenzione, coscienzadell’orizzonte, accomunamento d’esperienza, evoluzione dellevalidità, a-priori correlativo, campo percettivo e cinestesi ) eche ci mostra in modo inequivocabile come al centro dellafenomenologia, oltre alla relazione con l’altro, ci sia la questione deltempo, 67 Husserl procede verso l’indagine “delle strutture
67 Come afferma uno dei maggiori interpreti italiani di Husserl, Enzo Paci, secondo il quale la sua opera “ è tutta dominata da questi due temi”, il tempo ela relazione. Enzo Paci,Tempo e verità in Husserl, Laterza.
152
invariabili del mondo-della- vita” che intende, senza alcunaesitazione, in termini ontologici.C’è infatti una “tipologia essenziale” da cogliere al di là delladimensione soggettivo-relativa delle forme storiche checaratterizzano la costante evoluzione del mondo-della-vita.Ciò naturalmente non significa individuare le categorie del mondovero in sé, secondo la tradizione platonico-galileiana a cui si èfatto riferimento precedentemente ma, al contrario, occorrepreliminarmente problematizzare ciò che viene posto come evidenza,come ultimo orizzonte del conoscibile, sia o non sia esso dinatura matematico-oggettiva .Il compito ontologico della fenomenologia si contrapponenettamente a quello della tradizione poiché quest’ultima procedesul “terreno naturale, cioè al di fuori degli interessitrascendentali”.La coscienza, come unica realtà cosciente di se stessa, rendetotalmente improponibile il vecchio ideale conoscitivo di tipoontologico. E’, infatti, per Husserl, un non-senso pretendere diindagare l’essere psichico nella sua pura esteriorità fattuale,anche se è pensabile e possibile conservare l’universalità nelladescrizione trascendentale delle sue strutture eidetiche. Ilcampo d’indagine dischiuso dall’epoché e dalla riduzionetrascendentale, superando la molteplicità dei modi di datità delmondo-della-vita, compresi gli a-priori matematici che Galileointendeva metafisicamente cogliere, rende possibile la ricercafenomenologia delle pure evidenze che non sono forme oggettive delmondo ma realtà fenomenico-trascendentali .Questa nuova forma di scientificità ovviamente “non è quella deglipsicologi …che si muove sul terreno del mondo, del mondo che essapresuppone ovvio ed essente; l’epoché ci ha invece privato diquesto terreno. Essa produce un atteggiamento mirante puramentealle correlazioni, e il mondo, l’obiettività, diventano unasoggettività particolare.” Ma c’è una ulteriore e decisiva differenza tra l’ontologiatradizionale e quella fenomenologica poiché quest’ultima,contrariamente alle scienze esatte, ed in particolar modo allamatematica, una volta operata l’epochè radicalmente ed una voltaritornati ad un atteggiamento naturale non più ingenuo, produce unmovimento nel suo stesso oggetto, cioè nelle anime degli uomini.Essa è cioè una ricerca che arricchisce, nel processo del suodispiegamento, i contenuti del proprio “oggetto”. Al contrario, adesempio, della fisica teorica che lascia inalterato l’essere dellanatura dopo qualsiasi conoscenza da essa prodotta, la ricerca
153
fenomenologia “arricchisce in tutte le dimensioni il contenuto delmondo” Quando lo scienziato produce conoscenza, l’oggetto della suaindagine rimane lo stesso, ma quando il filosofo acquisisce saperesulle strutture eidetiche della coscienza, questo sapere pone inessere trasformazioni del grado di consapevolezza della coscienzadi se stessa.L’ontologia che coglie un essere dato e lo illumina obiettivamentein gran parte o tutte le sue determinazioni non è alloracertamente quella praticata dalla fenomenologia che invece “ cilibera dal vecchio ideale obiettivistico del sistema scientifico,della forma teoretica delle scienze naturali matematiche, e cilibera perciò dall’idea di un’ontologia dell’anima analoga aquella della fisica.” “Ci libera”: la fenomenologi non è solo ricerca di nuovaconoscenza ma è la risposta, consapevole della sua valenza etica,al fisicalismo imperante nell’epoca moderna che Husserl considera“una rinuncia al compito impostoci dalla storia di una filosofiache attinga ad una visione ultima e a un’assoluta universalità” 68
e la manifestazione di una ragione che, dimentica delle sueorigini filosofiche, è ormai totalmente ripiegata sul pianostrumentale.Il fisicalismo è cioè l’espressione del “razionalismo erroneo”della nostra epoca.
Dall’io al noi
Come recuperare l’originaria ragione filosofica nell’indaginepsicologica della soggettività ?Quale rapporto stabilire con una disciplina che indaga lasoggettività, secondo metodi rivendicati come scientifici, su unterreno che è stato dissolto dall’epoché?E’ possibile, per Husserl, che la psicologia scaturita dalpositivismo possa autolegittimarsi come una scienza naturale ? E qual’è la scientificità della fenomenologia rispetto a quella(eventuale ) della psicologia? 68 La crisi…, cit., p.284, anche le citazioni immediatamente precedenti.
154
E’ possibile una relazione tra questi due fondamentali approccialla soggettività ?La Krisis affronta questi interrogativi nella sua parte finalefacendovi convergere il suo intero percorso tematico. Quest’ultimaparte dell’opera ha dunque un valore risolutivo e, nello stessotempo, fondativo di una nuova configurazione dei rapporti trafilosofia e psicologia ( ricordiamo che il titolo originariodelle conferenze da cui è scaturita l’opera era La crisi delle scienzeeuropee e la psicologia). Come sappiamo il percorso teorico di Husserlsi è sviluppato intorno alla questione della relazione tra vita epensiero che lo ha condotto, sulla base del concetto diintenzionalità derivato da Brentano, alla fondazione dellafenomenologia come scienza universale dei vissuti nelle lorostrutture noetico-noematiche e della loro genesi nell’io puro . L’epoché,strumento necessario del metodo fenomenologico, operando unadelimitazione, un restringimento del campo totale della coscienza( riduzione trascendentale ) ci pone di fronte ai suoi “residui”,cioè i fenomeni come correlati della coscienza intenzionale. Essaci consente così di indagare la dimensione trascendentale dellacoscienza e le operazioni attraverso cui essa costituiscesignificati a-priori. Sospendendo l’atteggiamento naturale neiconfronti del mondo, fondato sulla credenza che da una parte cisia l’io e dall’altra, in una assoluta indipendenza e oggettività,le cose, Husserl ci mostra come ogni esperienza sia comprensibilenella dimensione dell’a-priori trascendentale che la contiene. Nonsi potrebbe infatti intenderla senza riferirla alle forme noetico-noematiche costitutive della coscienza.Questa consapevolezza, prodotta dal superamento della coscienzaingenua del mondo, apre un nuovo e vasto spazio teorico allafilosofia, quello delle forme essenziali della coscienza e dellaloro genesi. Anche se in realtà, già con Cartesio, Hume e Kantquesto spazio era stato definito e proficuamente percorso,l’intento di Husserl è quello di attraversarlo in un modo tale daintegrare le direzioni e le prospettive dei suoi primi scopritoried esploratori. Al di là del ripiegamento psicologistico diCartesio, dello “scetticismo accademico” di Hume e deltrascendentalismo non interamente realizzato di Kant, Husserlvuole indagare non più io vuoti di contenuto ma il flusso concretoe costante di vissuti e di esperienze, cogliendovi struttureessenziali e noetico-noematiche nella dimensione dellatrascendentalità. Ciò comporta immediatamente affrontare ilproblema della loro genesi, cioè delle modalità attraverso cui sisono formate e sedimentate le correlazioni intenzionali della
155
coscienza, cioè, in altri termini, come si è costituito l’iostesso.69 Non è certamente questa la sede per ripercorrere l’evoluzionedella vasta e complessa analisi husserliana dell’io, ma, inrelazione al tema qui discusso, occorre chiarire, anche se in modoschematico, il passaggio dall’io al noi nella fenomenologia geneticaperché è proprio sulla corretta impostazione di questo problemache Husserl fonda il rapporto tra filosofia e psicologia. Ci sonoalcuni elementi di fondo nello sviluppo della concezionehusserliana dell’io che in primo luogo riguardano la sua relazionecostitutiva con il tempo; l’io trova e realizza la sua identitànella dimensione temporale in base alla permanenza e la coerenzadei suoi atti (emotivi, intellettivi, ecc.) che possono anchecambiare ma sempre in un rimando tra loro interno che sidispiega nel tempo. L’io si rapporta attivamente alla suaevoluzione attraverso la ricostruzione di ricordi di eventi eopinioni passate che lo confermano nella sua identità costruitanel tempo. L’io è però anche qualcosa che ci è dato, essendo siala corporeità che lo psichismo determinazioni manifestatesi nelflusso temporale, a cui, possiamo dire, ci si trova di fronte, o,meglio, si è immersi.L’io così, da una parte, è costantemente impegnato in processi diriorganizzazione di sé stesso da cui emergono prospettive semprenuove che annullano o pongono sullo sfondo i vecchi punti divista i quali, a loro volta, sono esposti ad ulteriori mutamentiin rapporto al progressivo definirsi di nuove motivazioni,finalità, esperienze. In un altro senso esso è anche qualcosa didato nelle sue caratteristiche psichiche e fisiche, modellateall’interno di forme di vita determinate. Sia nella sua ricettività che nella sua attività l’io è comunqueoriginariamente connesso ad altri io sia perché è immerso in unorizzonte di valori, segni e significati collettivamentecondivisi, sia perché poi è chiamato a dare espressione attiva disue prese di posizione, interpretazioni, intenzioni che hanno comefine l’integrazione progressivamente sempre più consapevole nellasocietà.
69 Anche se tutto ciò certamente richiama, oltre agli autori prima citati, sia lastoria pragmatica della coscienza di Ficthe che la fenomenologia hegeliana, , èevidente come Husserl cerca, aprendo l’orizzonte della ricerca fenomenologico-genetica, un’ integrazione tra le principali prospettive filosofiche sulla relazione io-mondo che si sono definite a partire dal cogito cartesiano, cioè iltrascendentalismo di Kant e successivi sviluppi, lo storicismo diltheyano e il tentativo compiuto dall’idealismo tedesco classico.
156
Il tema dell’intersoggettività che, si può dire, attraversa, purse da prospettive diverse, tutta l’opera di Husserl, ruota attornoad alcuni concetti centrali come appresentazione, io originario,empatia, orizzonte, intenzionalità accoppiante, ecc, 70 che a lorovolta convergono verso i molteplici significati che il concetto dimondo-della-vita assume nell’incessante elaborazione rivolta adabbattere il muro delle ovvietà che occultano la dimensionetrascendentale della relazione io-altri.Infatti per Husserl “si tratta di dissolvere l’ovvietà raccolta inquesta proposizione:’ecco un uomo in una cerchia sociale dipersone che si conoscono reciprocamente, ecc,’ e di esaminarlanella sua problematicità trascendentale.” (p.209)Husserl ci pone di fronte al singolo, al suo essere-per-sé ed in-sé, al suo mondo-della-vita originalmente peculiare, ma la suacoscienza del mondo è possibile in quanto “ ha esperienzeentropatiche”, cioè in quanto fa continuamente esperienza di altrecoscienze, di altri singoli che hanno mondi ed appercezioniproprie.Conseguentemente ogni soggetto egologico è tale in virtù della suaappartenenza ad un orizzonte di entropatie, cioè di consapevolezzedi altri campi percettivi, di altri mondi-della-vitaoriginalmente peculiari.Le difficoltà relative all’epochè, su cui in queste pagine Husserlinsiste in modo particolare, riguardano il suo necessariocarattere universale che va però teoreticamente elaborato sulterreno profondamente scavato della singola soggettività.Il mondo-della-vita è cioè un mondo orientato, è un mondo chenello stesso tempo è proprio e, in quanto presuppone un sostratodi connessioni intenzionali profonde comuni, è anche degli altri iquali, a loro volta, hanno mondi-della-vita singolari possibiliproprio grazie alle esperienze entropatiche, cioè alle esperienzedei vissuti altrui.Certamente ciò non comporta alcun annullamento dell’individualità,della propria originalità e della propria irripetibilità, che perHusserl è invece il fondamento di ogni singolo uomo, ma essa è“già sempre” ( immer wieder ) orientata ad un “ essente mondano” ,ad un orizzonte di sensi e di significati condivisi, ad unacomplessa intenzionalità in cui l’io si connette in modoinestricabile con il tu , con il noi , con il voi ecc.70 Non è qui certamente possibile illustrare, anche solo schematicamente, i significati di questi ed altri concetti fenomenologici che, d’altra parte, Husserl non elabora come categorie definitive del suo pensiero, ma come concettiattraverso cui definire uno spazio teorico in cui possa dispiegarsi l’infinità del telos filosofico.
157
Anche se sui “dettagli” si possono avere le contraddizioni piùradicali e dilaceranti “ nessun soggetto può sottrarsiall’implicazione intenzionale per cui rientra nell’orizzonte ditutti i soggetti” (p. 275 )In quanto si dà una condivisione profonda delle validità d’essere,la fenomenologia è la strada che dovrebbe consentire una realeesplorazione di questa dimensione, che è nello stesso tempo,esteriore ed interiore, visibile e nascosta, immediata e mediata.Ma è possibile porre mano ad un’ontologia della coscienza edell’autocoscienza nella forma di leggi definite e rigorose” ? Nelle pagine finali della Krisis Husserl sottolinea più volte lestraordinarie difficoltà che si pongono con l’epochè rivolta acogliere gli a-priori universali della coscienza dentro le singoleed immanenti correlazioni intenzionali. Chi può assolvere questofondamentale compito ?La filosofia, come scienza rigorosa, non ha in sé la potenzialitàdi esplorare la dimensione trascendentale dell’intersoggettività?Soprattutto con la filosofia trascendentale di Kant non eranostate poste le condizioni migliori per procedere in questadirezione ?Perché, dopo Kant, si è ritornati a concepire una filosofiafondata “su oscure anticipazioni metafisiche” (p.225) chiudendol’orizzonte aperto dalla rivoluzione trascendentale ?Certamente anche in Kant, come in parte abbiamo già visto,permangono oscurità e limiti.“Tutti i concetti trascendentali di Kant, quelli dell’io,dell’appercezione trascendentale, delle diverse facoltàtrascendentali, della cosa in sé, ( che sta a fondamento dei corpicome delle anime ), sono concetti costitutivi, che si oppongono diprincipio ad una chiarimento ultimo. Ciò vale, a maggior ragione,per i successivi sistemi idealistici” la cui “forza erigogliosità” non fa sì che possa essere eliminata la “loroincomprensibilità ultima” (p.224)Il compito della filosofia postkantiana era quindi quello dipensare la soggettività- intersoggettività superando glistraordinari ostacoli che sempre si ri-costituiscono“nell’innalzarci dal terreno naturale fino alla regionetrascendentale”(p.224)“Il completo rivolgimento dell’atteggiamento naturale di frontealla vita, la sua trasformazione in un atteggiamento ‘innaturale’impone esigenze estreme di radicalità e di consequenzialitàfilosofica. L’intelletto umano naturale, e l’obiettivismo radicato
158
in esso, sentirà la filosofia trascendentale come uno smarrimento,sentirà la sua saggezza come un’inutile follia, oppure lainterpreterà come una psicologia che non immagina di esseretale.”(p.225)Invece Husserl pensa che proprio una psicologia consapevole dellasua natura trascendentale e, conseguentemente, del suo compito didiventare “una scienza universale dell’essere psichico” (p.227)possa contribuire in modo decisivo, nella sua corretta e proficuarelazione con la fenomenologia genetica, a porre le condizionidella ricerca sul problema della relazione io-mondo e quindidell’intersoggettività.Infatti Husserl si chiede, dato che la filosofia postkantiana “sivedeva obbligata a elaborare una considerazione del mondopuramente spirituale(…) perché non si rivolgeva alla psicologiache da secoli veniva praticata con tanto fervore ?” (p.226)Certo la filosofia poteva anche procedere autonomamente ma ilproblema fondamentale rimane sempre quello della separazioneinconciliabile, radicata nella storia del pensiero occidentale,tra soggettività empirica e soggettività trascendentale, che perHusserl è il motivo fondamentale per cui anche “la filosofiatrascendentale era destinata a portare la croce della propriaincomprensibilità.” (p.226) Occorreva dunque una “psicologiagenuina” per poter pervenire “ad un concetto scientifico dellaragione assoluta”(p.227)Ma “la filosofia trascendentale, a parte le precauzioni di fronteal psicologismo, aveva buoni motivi per non sperare consigliodalla psicologia. Ciò dipendeva dalla psicologia stessa e dallefatali vie traverse che le erano state imposte dalla particolaritàdell’idea moderna di una scienza universale obiettivisticacostruita more geometrico e dal dualismo psico-fisico che essacomportava.” (p.227) Da una parte quindi la filosofia non può fare appello alle proprierisorse perché la stessa rivoluzione copernicana di Kant non solonon era stata portata alle necessarie e radicali conseguenze manel, periodo successivo, si sono riproposti nuovi potenti ostacoliche hanno finito per approfondire ulteriormente la separazione tradimensione trascendentale e dimensione empirica.Dall’altra il radicamento della psicologia sul paradigmametodologico delle scienze naturali o esatte, orientato da unideale obiettivistico, la espone inevitabilmente ad una serie difallimenti e quindi all’impossibilità di diventare una scienzadella soggettività trascendentale che trova la sua legittimazionenel rapporto con la filosofia trascendentale.
159
Il problema rimane dunque quello della comprensione del passaggiodall’io al noi, cioè delle modalità in cui si articola la dinamicasoggettività-intersoggettività.Per affrontarlo senza ricadere nell’ingenuità di uno sguardorivolto a cogliere dati oggettivi negli atti intenzionali dellacoscienza, occorre preliminarmente procedere ad una criticaradicale alla psicologia dualistica e naturalistica, critica cheHusserl sviluppa nella parte conclusiva del testo e di cui ora cioccuperemo.
Critica e rifondazione della ragione psicologica
La psicologia è per Husserl “il vero campo delle decisioni”(p.232) in quanto scienza rivolta alla comprensione dellasoggettività universale e delle sue strutture essenziali.Ciò allora comporta che tra la psicologia e la filosofiatrascendentale ci sia un nesso necessario ed inscindibile fondatosulla differenza ed identità dell’io psicologico e dell’iotrascendentale; l’ io disposto nella concretezza della dimensionespazio-temporale( io psicologico ) è, nello stesso tempo,comprensibile come io-originario( Ur-ich ) che si costiuisce,nell’orizzonte degli altri io, nella dimensione altrettantoconcreta e reale della trascendentalità ( io trascendentale ). La psicologia che però Husserl si trova di fronte non può, per lesue premesse metodologiche e filosofico-metafisiche di fondo,avvertire l’esigenza di indagare la pluridimensionalità dell’io.Due sono principalmente i motivi- profondamente tra loro connessi-di questa cecità della psicologia alla dimensione trascendentaledell’essere psichico: il suo dualismo corpo-mente di originecartesiana e il suo -conseguente- obiettivismo fisicalistico.Partiamo dunque dal primo presupposto di cui la psicologia non siavvede nel modo dovuto, cioè l’assunzione non filosoficamenteproblematizzata della separazione tra mente e corpo, perché perHusserl esso è la prima causa del suo “fallimento”: la separazionedi una sostanza spaziale, priva di consapevolezza e meccanicamentedeterminata, da una sostanza libera, consapevole e non fisicamenteafferrabile e determinabile, è stato fatto proprio dallapsicologia nell’atto della sua costituzione come scienza‘autonoma’. Il corpo è così divenuto “corpo tra gli altri corpi”,
160
dimensione altra dalla soggettività che lo muove, ‘oggetto’ che èpossibile conoscere attraverso la logica fisico-meccanica dellamedicina. A questa concezione della corporeità è alloranecessariamente e specularmene connessa l’anima, come realtàpsichica, come sostanza complementare che la psicologia pone comeproprio ‘oggetto’ di investigazione. Soggettività ed oggettivitàsono allora due dimensioni opposte ma, nello stesso tempo,indagabili dagli stessi metodi, quelli delle scienze naturali, dicui la psicologia vuole fare parte a pieno titolo come scienza delcampo psichico. Ma, obietta Husserl, tutto ciò si basa su “unpregiudizio secolare” che da una parte considera l’anima e ilcorpo come due realtà distinte e di natura diversa e, dall’altra,in quanto realtà “sostanzializzate”, le espone ad uno stesso tipodi indagine, quello obiettivistico rivolto a cogliere le leggicausali che ne governano l’accadere.La dimensione della soggettività pone però subito un problema:come accedervi ? Attraverso una prospettiva fiscalista che trattale anime come corpi ( come realtà naturali ) o assumendo unprocedimento rivolto a “ indagare le anime nel loro essere-in-sé eper-sé, attraverso l’esperienza interna- l’esperienza internaprimordiale che lo psicologo ha della propria soggettività ?”O, ancora, si interroga Husserl, attraverso “la mediatezzaintenzionale di una entropatia pure rivolta verso l’interno( “verso l’interiorità delle altre persone tematiche” ) ? Si tratta cioè di muoversi su un terreno totalmente oggettivato edoggettivabile o procedere su una base empirica fondando lapsicologia sull’esperienza interna ? La prospettiva fenomenologica dissolve questa tensione tra lapsicologia obiettivistica o soggettivistica, giudicandolairrisolvibile all’interno del dualismo cartesiano entro cui siorigina. Ma, su questo problema decisivo, lasciamo parlare direttamente iltesto :
“Questi due compiti {cioè, indagine obiettivistica e soggettivistica }apparivano ovviamente connessi, sia riguardo al metodo, sia riguardo alloro oggetto, e tuttavia non andavano d’accordo. L’epoca moderna eracaratterizzata fin dall’inizio dal dualismo delle sostanze e dalparallelismo dei metodi more geometrico, oppure, si può dire, dell’idealemetodico del fisicalismo. Per quanto con il tempo questo fosse diventatovago e fosse impallidito, e anche se non conobbe mai una vera e propriarealizzazione, continuò a determinare una concezione fondamentalmentepsicofisica dell’uomo e tutti i modi di por mano ad una psicologia, e dipromuovere la coscienza metodica della sfera psichica. Il mondo veniva
161
perciò considerato”naturalisticamente”, come un mondo a due straticostituito da fatti reali e regolato da leggi causali. Le anime venivanoconsiderate appendici reali dei corpi propri concepiti nel senso dellescienze esatte della natura; la loro struttura era diversa da quella deicorpi, esse non erano res extensae e tuttavia erano reali in questostesso senso. Esse andavano perciò indagate nella loro inerenza al corpoe secondo “leggi causali”: cioè attraverso teorie che di principio eranodello stesso tipo di quelle, esemplari ed insieme fondanti, della fisica”(238,K)
E’ dunque la visione naturalistica del “mondo a due strati” che lapsicologia, per essere veramente tale, deve superare per accederea quello che Husserl ritiene essere il suo compito fondamentale,cioè la conoscenza delle pure anime.( Con questo termine Husserlnon intende ovviamente l’anima come realtà a sé da cogliere inmodo metafisico-obiettivistico ma come datità psichica originariadel mondo-della-vita.) Occorre dunque liberare la psicologia dal dualismo cartesiano chela fonda come scienza dell’anima derivata dal corpo, cioè comescienza della res cogitans opposta e, nello stesso tempo,complementare alla fisica, alla meccanica ed alla medicina comescienze della res extensa.Per Husserl, che si pone nella prospettiva del superamento diquesto dualismo che fonda l’alterità del corpo rispetto all’anima,è necessario in via preliminare distinguere tra corpo fisico( Körper ) e corpo proprio ( Lieb ) poiché con il primo termine siindica una sua pura determinazione fisico-naturale, mentre con ilsecondo lo si intende in relazione alla soggettività vivente neisuoi atti e facoltà( Vermogen ). Mentre il corpo cartesiano ( Körper ) è puro congegno spaziale-meccanico, il corpo proprio ( Lieb ) è attività del “fungereegologico”, inteso sia come ‘funzione’ visiva, auditiva, ecc., checome ‘funzione’ coscienziale.In questo modo l’egoità corporea non può essere sostanzializzatacome entità a sé, cioè ridotta alle sue oggettive determinazionifisico-naturali, analizzabili dall’anatomia e dalla fisiologia( anche se, precisa Husserl, in un certo senso è possibile farlonella consapevolezza dei limiti di questo tipo di comprensione delcorpo); i molteplici modi dell’egoità corporea , costituendo unatotalità dinamico-evolutiva, devono essere indagati come unità- di-atti- nell’orizzonte- del- mondo . Solo operando su questo terreno è possibile liberarli dallaprigione cartesiana che li costringe entro pure causalità fisico-meccaniche. Il concetto di corpo si espande così sia nella
162
dimensione della singola soggettività che in quella comune del“vivere insieme”( Miteinander-leben ) in modo tale che il corpo-cosa (Körperding ) che i testi di anatomia mostrano, diventa una dellemodalità della sua presenza.Sinteticamente: il corpo proprio è nel mondo attraverso lamolteplicità dei suoi vissuti (Erlebnisse), il corpo fisico è un puro ed‘astratto’ oggetto senza alcuna rilevanza psichica.Come si vedrà nel terzo capitolo questa distinzione husserlianatra Lieb e Körper risulterà decisiva nella psichiatria adorientamento fenomenologico che la utilizzerà nella comprensionedelle patologie che trovano origine da disfunzioni nellastrutturazione della propria presenza nel modo, la cui modalitàesistenziali e co-esistenziali rimandano in primo luogo alladimensione della corporeità.Seguiamo ancora il testo in questo suo passaggio fondamentale:
“Occorre interrogare originariamente il che cosa e il come delle anime-innanzitutto delle anime umane – il loro modo di essere nel mondo, nelmondo-della-vita, il modo in cui “animano” i corpi propri, in cui sonolocalizzate nella spazio-temporalità, il modo in cui ciascuna “vive”psichicamente in quanto ha “coscienza” del mondo in cui vive e in cui ècosciente di vivere; il modo in cui ciascuna esperisce il “suo” corpo nonsoltanto come un corpo particolare, bensì in un modo assolutamentepeculiare, come il “corpo proprio” , come il sistema degli “organi” cheessa muove egologicamente ( nel suo agire ), il modo in cui essa“interviene” ( eingreift ) nel mondo circostante di cui è cosciente, nellaforma dell’ “io spingo”, dell’ “io trascino”, dell’ “io sollevo”, questoe quello, ecc.”
Può la psicologia cogliere questa essenzialità dell’anima?Certamente no se la sua forma logica fondamentale rimane ancorataal dualismo cartesiano, ma virtualmente sì se viene indotta a“scoprire” la sua natura trascendentale.Nella parte finale della Krisis questo è propriamente ciò che intendefare Husserl a partire dalla critica radicale ai suoi presuppostidualistici e fisicalistici che, filosoficamente nonproblematizzati, costituiscono la principale causa del suofallimento. Essa è infatti scienza del già dato, scienza cioè di quelli cheHusserl definisce “poli oggettuali costituiti”, cioè i vissutisingolari ed empirici rispetto ai quali, essendo teoreticamenteimpotente di fronte alla dimensione trascendentale che li contienee li rende possibili, non si pone alcun interrogativo.
163
Husserl pone la coappartenza originaria di io e mondo, comerelazione costitutiva ed inscindibile, di fronte alla psicologiaper liberarla dall’oggettivazione cartesiana del sum come res erenderla, quindi, a pieno titolo, scienza degli atti con cui l’iosi rapporta al mondo. L’io, la soggettività, non è qualcosa cheoggettivamente è al mondo ma è l’insieme degli atti – attivi epassivi – per cui qualcosa si costituisce come oggetto.Gli atti intenzionali – siano essi momenti attraverso cui l’iocostituisce i suoi oggetti mondani o modalità attraverso cuiquesti ultimi si danno alla coscienza – sono dunque ciò che lapsicologia deve indagare.Quali sono i modi del ricordare, del percepire, del valutare, delprovare emozioni, ecc., nella correlazione intenzionaleintersoggettiva delle nostre esperienze vissute? La psicologia hail compito di assumere questa complessità, questa fittissima retedi interrelazioni profonde che pur nella loro indeterminatezzacostituiscono il fondamento di ogni validità. Eludere questocompito significa mancare la tematizzazione del come dei vissuti,delle modalità profonde che li sostanziano e li producono in unaesteriorità immediatamente attingibile. Secondo Husserl ogniteoria psicologica, per essere veramente tale, deve connettere ilsuo sapere che pragmaticamente afferra, denomina, descrive ciò chepuò chiaramente essere esperito attraverso un’indagine diretta deivissuti, a ciò che è strutturalmente operante al loro interno comeinconscio trascendentale.Non si deve certamente equivocare su questa denominazione poiché èchiaro come Husserl sia lontanissimo dal concetto di inconscio,così come è stato elaborato da Freud ma, e questa è evidentementela questione decisiva nella relazione fenomenologia-psicoanalisi,ogni tentativo di rendere conto del processo di costituzione dellasoggettività-intersoggettività non può non avvenire sul terrenodella dinamica tra conscio ed inconscio.Nella Krisis c’è un rapido ma per noi prezioso passaggio doveHusserl, a proposito del carattere inconsapevole dei “modi moltodiversi di intenzionalità”, fa riferimento ai “comportamentiinconsciamente motivati che sono stati scoperti dalla recente‘psicologia del profondo’” (p.258)Anche se Husserl si affretta a prendere immediatamente leinevitabili distanze da Freud ( “con le cui teorie noi tuttavianon ci identifichiamo ) è evidente come sia nella psicoanalisi chenella fenomenologia ci sia una convergenza nella loro ricercadell’originario, cioè nell’indagine di ciò che viene occultato nelprocesso di costituzione della soggettività e della
164
intersoggettività. Si è già visto come tale convergenza sidefinisca sulla base di prospettive radicalmente diverse ( naturalistica quella della psicoanalisi e trascendentale quellafenomenologica ) ma è lo stesso riferimento alla dimensione“inconscia” della costituzione dell’io e del mondo da parte diHusserl a legittimare la comparazione che qui si sta tentando diesplorare. Infatti, in una appendice ( XXI ) al paragrafo 46 deltesto, Eugen Fink 71, collaboratore di Husserl, prende posizione,evidentemente in sintonia con gli orientamenti del suo maestro,nei confronti della legittimità teoretica dell’analisidell’inconscio da parte della psicoanalisi. Il paragrafo che viene sviluppato da Fink è intitolato “L’a-prioriuniversale delle correlazioni” dove viene affrontato il problemadelle modalità attraverso cui la coscienza, nel flusso dell’Erlebnis,si dirige sugli oggetti del mondo. Attraverso i concetti dirimemorazione, presentazione, presentificazione, ritenzione,protensione, viene sviluppata un’analisi intenzionale dei modi dirappresentazione, fondati sulla dimensione temporale e sugli a-priori.Per Fink questi concetti costituiscono “l’ABC dell’analisiintenzionale” della coscienza da cui necessariamente si devepartire per elaborare una teoria complessiva della soggettività.La psicologia del profondo, che come abbiamo visto aspira a porsicome la vera scienza della soggettività, essendo l’inconscio lo“psichico reale” non ha invece, secondo i teorici dellafenomenologia, un fondamento filosoficamente giustificato perchénon è possibile teorizzare sull’inconscio senza sapere prima checos’è la coscienza.71 La Krisis, opera incompiuta ed aperta, di sintesi e introduzione nello stesso tempo, è integrata da due tipi di testi: dissertazioni ed appendici. Le prime mostrano il delinearsi dei temi centrali del testo ( l’idealizzazione matematicadella natura, il rapporto tra scienze della natura e scienze dello spirito, la crisi dell’umanità europea in relazione alla filosofia ) rispettivamente elaborati negli anni 1926-28, 1928-30 e 1935. Quest’ultimo è il testo della celebre conferenza tenuta da Husserl a Vienna nel mese di maggio ( 7 e 10 ), ampliato e riproposto in occasioni simili in Novembreall’Università di Praga. Da suoi ulteriori elaborazioni ed approfondimenti è scaturita la Krisis, che però, a sua volta è un testo incompiuto, sia perché Husserl ha dovuto, costretto dalla malattia che lo condurrà alla morte, ad abbandonarlo, sia perché ciò, si può dire, è un suo carattere costitutivo essendo la sua principale finalità quella di riaprire la ricerca filosofica in una pluralità di direzioni, a loro volta, virtualmente produttive di nuovi ed imprevedibili orizzonti teoretici mai definitivi e sempre ridefinibili.Le appendici invece costituiscono sviluppi ed approfondimenti dei diversi paragrafi del testo a cui lavora anche Eugen Fink, ex assistente di Husserl ed ora suo stretto collaboratore nel periodo di stesura della Krisis.
165
Dalla prospettiva fenomenologica la psicoanalisi appare quindicome un insieme di “mitiche teorie abbozzate sullo sfondo diun’opaca empiria”, il cui problema principale è costituito nontanto dalla sua infondatezza epistemologica quanto daun’omissione. E’ infatti una “ingenuità filosofica” che rende lapsicoanalisi un sapere senza fondamenti poiché “se non si sa checos’è la coscienza” non è conseguentemente possibile aspirare allacostruzione di una “scienza dell’inconscio”. Ma, si chiede Fink,è possibile avanzare critiche alla psicoanalisi dal punto di vistadell’analitica della coscienzialità? Ciò non comporta muovere dalpregiudizio che fa equivale la vita della soggettività con ilconscio? In realtà, precisa il collaboratore di Husserl, il problemadell’inconscio si può porre solo dopo aver tematizzato ciò cheinvece la psicoanalisi non ha nemmeno presentito come terreno diindagine possibile, cioè i modi di datità di quello checomunemente si intende per coscienza.Mentre la fenomenologia “distrugge” la loro apparenzaimmediatamente attingibile e ci “introduce ad una scienza digenere nuovo, difficile da realizzare, attraverso la quale siimpara a poco a poco a vedere e a capire che cos’è la coscienza”(K, p.500), la psicoanalisi assume ingenuamente un insieme difenomeni psichici come realtà già data , vivendo così nelparadosso di una psicologia del profondo che non si avvede dellaprofondità dei processi psichici che essa indaga.Così, anche se ciò può apparire controverso, una teoria dellacoscienza - la fenomenologia- individua il limite di una teoriadell’inconscio - la psicoanalisi – proprio nel fatto chequest’ultima manca la reale profondità della psiche essendo essaun’ indagine delle regioni della psiche i cui risultaticonoscitivi non sono solo parziali (essendo limitati alla sferanaturalistica della pulsionalità) ma, soprattutto, non si radicanosu una precedente e necessaria esplorazione di ciò checaratterizza lo psichico in quanto tale, cioè le struttureeidetiche della coscienza. Non è allora possibile procedere allapsico-analisi dell’inconscio senza aver precedentementetematizzato tutta la complessa dinamica di costituzione delconscio, da Freud compresa in modo evoluzionistico enaturalistico. La coscienza è infatti per Freud un luogo psichicoche l’umanità è stata costretta a sviluppare, da una dimensionepulsionale originaria, per esigenze di sopravvivenza. Non è certamente casuale che il riferimento alla psicoanalisi siapresente in una parte decisiva della Krisis, poiché qui Husserl
166
precisando ed approfondendo la funzione dell’analisifenomenologica dell’intenzionalità fa emergere il problema deiprocessi inconsci della psiche.Essa infatti deve necessariamente esplorare la soggettività in un“duplice modo”, sul piano della coscienza e su quellodell’inconscio, o, meglio, sul piano delle operazioni originarieche pongono gli oggetti intenzionali come tali senza la piena echiara consapevolezza di ciò. Nella critica alla ragione psicologica che Husserl fa nella partefinale della Krisis possiamo allora legittimamente includere anche lapsicoanalisi che, nonostante le sue virtuali convergenze con laricerca fenomenologia, rimane dentro i presupposti dualistici diorigine cartesiana da cui necessariamente deriva una visioneobiettivistica dell’essere psichico. Dalla prospettiva fenomenologica la psicoanalisi non può alloranon apparire come una psicologia positivistica che, separandonettamente campo fisico-oggettivo e campo psichico-soggettivo,aspira ad una conoscenza scientifico-naturalistica dellasoggettività.La fenomenologia cerca invece di fondare-aprire nuove prospettivedi ricerca non più dominate da questi presupposti che rendonosostanzialmente sterile le pur rigorose analisi psicologiche e, amaggior ragione, per i motivi sopra accennati, psicoanalitiche.Il problema fondamentale è dunque quello di lavorarefilosoficamente alla costruzione di una via di accesso alladimensione trascendentale che comprende anche l’esplorazione deiprocessi inconsci tematizzata da Husserl soprattutto attraversol’analisi della genesi passiva dei nessi intenzionali. La psicoanalisi, dalla prospettiva fenomenologica, appare quindichiusa entro il suo dualismo ed il suo obbiettivismo; come talenon è una teoria rivoluzionaria rispetto alle altre psicologieanch’esse ingenuamente rivolte ad afferrare una pretesaoggettività della sfera psichica e dei suoi vissuti. Facciamoriferimento ad una delle rare esemplificazioni di Husserl, che,specialmente ora, risultano preziose:
“ Di un albero si può dire che brucia, ma un albero percepito “come tale”non può bruciare ; dirlo sarebbe un controsenso; perché si attribuisce aduna componente di una percezione pura, che è pensabile soltanto comemomento essenziale di un soggetto egologico, la possibilità di farequalcosa che ha un senso soltanto per un corpo di legno, cioè dibruciare” (K.,p.262)
167
La psicologia che opera solo sul piano della descrizione di eventirimane ancorata alla percezione dell’albero che brucia mentredovrebbe invece dirci qualcosa sull’albero in sé come “oggettointenzionale”, che ha una realtà diversa da quella fisica delcorpo di legno.Si può allora dire che la psicologia si imbatte continuamentenegli alberi senza vederli perché non scorge lo spazio teorico“assolutamente in sé concluso” che li contiene. Conseguentementeessa, come scienza della soggettività operante, non riesce adaccedere al problema reale della sfera psichica che soloattraverso l’epochè è esperibile nella sua essenza e nella suapurezza.Soltanto in questo modo si accede “all’orizzonte universale dellapura “vita interiore” in quanto vita che attua un senso ed unavalidità”, soltanto circoscrivendo “la problematica reale,autentica ed in sé conclusa dell’intenzionalità” ( K.p.263 ) èpossibile produrre conoscenze della sfera psichica. Si trattaallora di guadagnare un piano teorico che renda possibile un nuovorealismo. Lo strumento per compiere questo salto è, come abbiamo,visto l’epochè le cui caratteristiche essenziali vengonoulteriormente precisate da Husserl nella parte finale del testoperché con essa si pongono “eccezionali difficoltà” e”sorprendenti paradossi che devono essere chiariti e superati unodopo l’altro” ( K.p.261 )Innanzitutto va chiarito che l’universalità dell’epochè è “unatteggiamento artificioso” che deve essere fatto proprio dallopsicologo attraverso un rigoroso e continuo esercizio rivolto,come sappiamo, a far emergere altre evidenze oltre quelleimmediatamente accessibili, già ritenute note nella loro “essenzaed esprimibili attraverso la lingua popolare”. L’esperienza, il vissuto, è una dimensione che presenta un aspettoesteriore, una superficie immediatamente accessibile ( l’uomo “che pensa, che ha sentimenti, che agisce, che vive il desiderio,il dolore e simili “ ) che è però sostenuta e resa possibile da ununiverso profondo di sensi e significati da sempre già dati econdivisi.L’accesso a questo universo deve essere consentito dall’epochè che,rispetto alla stessa tradizione occidentale del pensiero, si ponecome un vero e proprio atto “rivoluzionario”.Ma, a questo punto, ci si può chiedere qual è il valoreconoscitivo e teoretico della psicologia che non si avvede neanchelontanamente di questa esigenza ?
168
A questa domanda decisiva ed inevitabile Husserl risponde,coerentemente alle premesse ed alle finalità della sua criticaalla ragione psicologica, in questo modo : “Non posso fare a menodi negare che finora la psicologia non si è mai mossa sul terrenodi una vera psicologia” ( K.269 ) Si noti il “non posso fare a meno” : tutta l’opera filosofica diHusserl, a partire dalla Filosofia dell’aritmetica, convergenecessariamente su questa posizione radicale nei confronti delsapere prodotto dalla psicologia scaturita dal contestopositivista.Nonostante ciò Husserl non afferma in modo definitivo che ognirisultato della ricerca psicologica è privo di qualsiasi tipo divalore conoscitivo perché subito aggiunge e precisa che “ soltantoquando ci sarà una simile psicologia sarà possibile valutare ifatti multiformi e certo preziosi forniti dalla psicofisica edalla psicologia che vi si rifà, valutarli nel loro vero contenutopsicologico, e chiarire quali siano, da entrambi i lati, i membridella relazione delle regolamentazioni empiriche” ( K.p.269 )Il problema è dunque quello del raccordo tra il metodo dell’epochèe quelli comunemente praticati dalla ricerca psicologica. Ciòcomporta abbandonare il piano teorico che indaga solo i ‘fatti’psicologici “esterni”, la “superficie della sfera psichica” peraprire “abissi di senso” all’analisi psicologica. ( K,p.269)La riduzione psicologico-fenomenologica non deve solo condurre adun’astrazione universale ( welt-universal ) della soggettività in quanto tale - procedendo inquesto modo come le scienze naturali che idealizzanomatematicamente i loro oggetti sulla base delle osservazioni dellestrutture a-priori e del riconoscimento della loro normatività.Essa deve procedere in modo diverso dalle scienze esatte perché lacoscienza, essendo l’unica tipo di realtà che è cosciente di sestessa, non può essere oggettivata come qualsiasi altro tipo direaltà. La psicologia ha invece tentato ripetutamente, pur se da diverseprospettive, di oggettivare la coscienza come un insieme di datiche vi si imprimono, come ad esempio accade con l’idea della“tavoletta della coscienza” , ma ciò che la qualificaessenzialmente è proprio il fatto che questa tavoletta è coscientedi essere tale, “ che è nel mondo ed ha coscienza di questo mondo”(K. 270 )Se dunque coscienza equivale necessariamente ad autocoscienza neconsegue che la psicologia deve partire da questo fondamentale a-
169
priori per poter poi, attraverso l’epochè, accedere alle modalitàcon cui la coscienza è coscienza delle cose singole, del suoorizzonte nel mondo e di se stessa.La descrizione psicologico-fenomenologica di tutto ciò, cioè deglia-priori, non può allora non avere un carattere universale perchéogni uomo, nel momento in cui è consapevole di sé, è consapevoledell’altro da sé, il suo essere consapevole è co-umano e vive“nell’orizzonte aperto dell’umanità ( … ) nel flusso unitariodella storicità, in cui questo presente, il presente umano e ilmondo in cui esso è cosciente, è il presente storico di un passatostorico e di un futuro storico.” (K.272)In questo modo Husserl supera lo psichismo individuale che ritienepensabile e, nello stesso tempo, possibile solo all’internodell’orizzonte che lo contiene: quello della famiglia, dellacomunità popolare, delle istituzioni, cioè quello della storicitàumana.La fenomenologia diventa così un metodo che procede su dueversanti, quello psicologico e quello storico. Individuo ecollettività, strutture eidetiche e temporalità costituiscono isuoi elementi costitutivi ed inscindibili la cui conoscenza nonpuò non essere interrelata.Lo psicologo però , per Husserl, deve operare l’epochè “ a partireda sé stesso ed in sé stesso”, deve cioè “ rifarsi alla suaesperienza originaria e alla coscienza del mondo che gli èoriginariamente propria” (272-3 ) in modo tale da diventare“osservatore disinteressato di sé stesso” ed essere così capace diridurre a fenomeno sia il mondo che i suoi stessi vissuti.Ciò comporta ritirarsi dalla concretezza delle proprie occupazionie di quelle che ci mettono in contatto con gli altri ?L’epochè come “ esercizio rigoroso” e metodico ci allontanadall’altro e dalle contingenze della nostra situazioneesistenziale ? Non ricorda forse la meditazione, che nelle cultureorientali è praticata anche per distanziarsi dagli affanni delmondo ? Per Husserl è vero esattamente il contrario: l’epochè è la via piùradicale ed efficace per conquistare una maggiore consapevolezzadi sé stessi, del senso delle nostre attività e del lorosignificato nell’orizzonte aperto dell’umanità.Attraverso di essa non si perde ma si conquista il mondo perchépiù si scende nella propria soggettività, più avvertiamo che essarimanda all’orizzonte della co-soggettività. Appropriarsi semprepiù delle esperienze originarie significa scoprire
170
progressivamente l’infinità di tutto ciò che connette lasingolarità ad un mondo in comune.
Filosofia e psicologia: un destino comune
L’epoché però, di per sé, non garantisce tutto ciò perché essa, inrealtà, è solo “ il portone d’entrata oltre il quale si dischiudeil regno della pura soggettività” (p.276) e quindi, come tale, èindispensabile alla psico-logia come suo momento costitutivo.La psicologia positivista con i suoi risultati, le sueacquisizioni ottenute “sul terreno del mondo già dato” senzaoperare alcuna epoché, è però una realtà, anche istituzionale edaccademica la cui valenza conoscitiva viene fortementedelegittimata, ma non totalmente annullata da Husserl.La psicologia, per essere veramente tale, cioè analisi rigorosa emetodicamente fondata su principi apodittici, non può allora nonidentificarsi con la filosofia trascendentale.Ritorniamo ancora al testo:
“Naturalmente sarebbe errato affermare che sia impossibile unapsicologia come scienza sul terreno del mondo già dato, cioè unapsicologia degli uomini ( e poi degli animali ) nel mondo. Certo è chenon è possibile una psicologia in questo senso senza un’indagine su ciòche è proprio ed essenziale dell’essere psichico, ed è altrettanto certoche l’essere psichico non può essere attinto, per così dire,gratuitamente, non è qualcosa a cui basti rivolgere lo sguardo e che siagià a portata di mano anche se inavvertito” (p.277)
Ciò che lega indissolubilmente la psicologia alla filosofia èallora la necessità di operare la riduzione fenomenologico-trascendentale attraverso l’epochè per poter accedere allasoggettività pura che la psicologia non può indagare“gratuitamente”, senza cioè guadagnare il piano teorico delle suedimensioni originarie e costitutive. Ci si può però chiedere, come poi fa lo stesso Husserl, se allapsicologia interessa “l’interiorità trascendentale” dato che essa,operando sul terreno della realtà del mondo immediatamentepresente, è costantemente rivolta ai vissuti reali di uomini realiin contesti concreti e determinabili anche sul piano statistico-oggettivo.
171
Come tale, cioè come una scienza i cui principi teorico-metodologici sono scaturiti dal paradigma positivista, lapsicologia non può avvedersi della sua natura trascendentale conle sue sole forze.Spetta allora alla filosofia, ed in particolare allafenomenologia, favorire questo processo di ampliamento dei compiticonoscitivi della psicologia possibile solo in relazioneall’abbandono di qualsiasi residua finalità obiettivistica.Una psicologia consapevole che i suoi compiti sono quelli di unascienza dello spirito e non della natura è una psicologia che si èliberata dell’obiettivismo naturalistico, da Husserl consideratocome “una tentazione forte quanto comprensibile” a cui non solonon hanno resistito le scienze umane nate nella seconda metà delXIX secolo, perché essa ha profondamente orientato la stessastoria del pensiero occidentale a partire dal realismo metafisicodi Platone.Solo quelle filosofie che sono partite dal soggetto - o vi sonoritornate - vanno viste come dei tentativi di non cedere a questa“tentazione forte” che però, alla fine, viene spesso soddisfatta,come nel caso dell’idealismo, le cui originarie intenzioni nonhanno poi portato, per aver “mancato completamente il propriometodo” ( p.286 ) ad “indagare concretamente e analiticamente” lasoggettività.Le scienze dello spirito, per Husserl, una volta disancoratesi dalnaturalismo obiettivistico devono necessariamente procedere indirezione fenomenologico-trascendentale, non nel senso ovviamenteche devono fare propria una concezione filosofica generale o unsistema di idee, ma piuttosto come assunzione di un nuovo pianoteorico-metodologico in cui possano essere ricercate le struttureeidetiche della soggettività. Solo in questo modo è possibileliberarsi dal realismo ingenuo che indaga il mondo fattuale comemondo già dato e totalmente oggettivo, realismo che la psicologia,all’atto della sua nascita, ha fatto proprio senzaproblematizzarlo, cioè senza valutarne il valore conoscitivonell’analisi dell’essere psichico. La fenomenologia è perciò una scienza pura, cioè un’indaginerigorosamente razionale di tutte le determinazioni essenziali deivissuti di coscienza che soggiacciono, come strutture profonde efondanti, ad ogni forma logica delle diverse modalità conoscitiveottenute attraverso esperienza o ragionamento.Come tale affronta radicalmente il problema gnoseologico pereccellenza, che si è subito posto a partire dal confitto tra
172
Platone ed i Sofisti sulla natura della conoscenza, per assumerlonella sua forma più alta.Il proficuo incontro tra la psicologia e la filosofia si caricacosì di valenze che investono non solo i filosofi ma anche esoprattutto gli uomini europei nel loro vivere personale ecomunitario poiché, per Husserl, il fondamento fenomenologico-trascendentale di tale relazione realizza in pieno la teleologiadella ragione filosofica occidentale. L’ideale conoscitivo dellafenomenologia, nel suo necessario rapporto con la psicologia, sipone infatti come un “vitale impulso dell’umanità, giunta al suogrado più alto” ( p.287 )La nascita della filosofia è come il rosso dell’alba che inizia arischiarare la “notturna oscurità” in cui vivevano gli uominiinconsapevoli della potenza della ragione in loro innata; essa èquindi nel suo costante movimento Aufklarung ed entelechia, cioèragione che si dispiega auto-rischiarandosi e realizzandosi inmodo sempre più pieno.Il contributo del “funzionario dell’umanità” Edmund Husserl non ècertamente quello di aver elaborato una teoria della conoscenzapiù efficace, profonda ed originale di altre ma quello appunto diaver operato con determinazione e tenacia allo sviluppo infinitodella ragione dell’uomo e della società.La ragione, come essenza della persona e della comunità, è ciò chei singoli e la collettività sono chiamati a realizzareall’infinito, sia come progressiva trasformazione di sé stessi inun “vero, libero ed autonomo io” sia come assunzione sempre piùalta di “responsabilità universali” da parte comunitàistituzionali, nazionali e sopranazionali. ( p. 287 )Così etica sociale ed autonomia dell’individuo trovano il lorofondamento necessario nella verità più profonda ed originaria cheil soggetto è chiamato a scoprire in sé stesso.Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas : la citazioneagostiniana con cui Husserl concludeva le sue Meditazioni cartesiane laritroviamo, anche se non direttamente, nelle ultime pagine dellaKrisis dove la filosofia viene concepita, al contrario degli idealidella scienza positiva che ci fanno abbandonare il mondo e ciallontanano da noi stessi, come riflessione dell’umanità su séstessa e come realizzazione della ragione che trova la sua vera evitale origine nell’interiorità dell’anima.
173
III CAPITOLO
Psicoanalisi, Fenomenologia e Daseinsanalyse
Coscienza ed inconscio
Come abbiamo visto nella prima parte, la posizione (ufficiale) diFreud nei confronti della filosofia è inequivocabile; la suasterilità conoscitiva è posta di fronte alla fecondità di unsapere che la psicoanalisi non solo mostra di possedere, ma anchedi usare efficacemente nella prassi terapeutica.Infatti, per Freud, nello spazio teorico della psicoanalisiconfluiscono, in un’interconnessione inestricabile con lemanifestazioni della vita psichica, emozionale ed affettiva, ancheed inevitabilmente, molti dei complessi tematici affrontati dallafilosofia nel corso della sua storia. Tra questi, in particolare,assume una rilevanza decisiva, per l’insieme dei problemi in essocoinvolti, la questione del rapporto tra mente e corpo. Larivoluzione psicoanalitica consisterebbe dunque proprio nel porrele questioni relative alla soggettività-intersoggettività su unpiano teorico inattingibile al coscienzialismo della tradizionefilosofica del pensiero, sia perché ad esso manca una prassi chelavora, in un nesso costitutivo, con la ricerca speculativa, siaperché per accedere alla soggettività, nell’insieme profondamenteinterrelato delle sue componenti, occorre superare la ratiometafisica entro cui, storicamente, la filosofia ha posto laquestione del rapporto corpo\mente. La psicoanalisi si autocomprende quindi come fondazione-costruzione di un sapere che riesce per la prima volta atematizzare in tutta la sua molteplicità e multidimensionalità larelazione mente-corpo
174
( della cui fondazione filosofica però non si avvede) e nel fareciò si adopera, correlativamente, alla decostruzione, attraversol’esercizio del sospetto, della pretesa dell’auto trasparenzadella coscienza sedimentata nella cultura e nella filosofiaoccidentale. Husserl lavora invece, in un senso che in primis apparecome opposto, alla delegittimazione della psicologia scaturita dalcontesto positivista (compresa la psicoanalisi) ed allarealizzazione completa del telos filosofico occidentale, in cuivengono dissolti i termini stessi in cui si è storicamenteconfigurata l’opposizione tra mente e corpo, assumendo quindi nelmodo più diretto e strutturale il processo teoretico della suacostruzione nello sviluppo del pensiero occidentale. Tuttavia, pur procedendo da prospettive radicalmente diverse,psicoanalisi e fenomenologia convergono su un identico problema -la comprensione delle strutture invarianti della soggettività\intersoggettività - rispetto al quale si pone lo stesso fine –l’elaborazione, sulla base di questa comprensione, di una“metapsicologia” (per la psicoanalisi) e di una “ontologia delmondo-della-vita” (per la fenomenologia).72Nel perseguimento diqueste finalità, in entrambi gli approcci viene percorsa unastrada “rivoluzionaria” che, in modi diversi, avanza teoricamentein relazione ad un corrispondente allontanamento dalle categoriesedimentate nella cultura e nella scienza della ratio metafisicaoccidentale.Sia nella psicoanalisi sia nella fenomenologia c’è, infatti, comeun doppio movimento: la costruzione teorica avvienecorrelativamente ad una sistematica attività decostruttiva.Per Husserl la fenomenologia è “desiderio di futuro”, per Freud lapsicoanalisi è la “teoria nuova” che, nell’orizzontedell’Aufklärung, bonifica l’Es in favore dell’Io: in entrambi, pur
72 Naturalmente, come si è già rilevato, questi intenti metafisico-ontologici sidefiniscono secondo modalità diverse da quelle della tradizione filosoficaoccidentale. Occorre ulteriormente puntualizzare come per Freud lametapsicologia rappresenta il necessario superamento o trascrizione dellametafisica, fondato sulla costruzione di una “teoria nuova” il cui naturalismooriginario si coniuga in modi epistemologicamente “sconcertanti” con unapproccio di natura opposta ( la co-presenza di una energetica e di una ermeneutica, come rileva Ricoeur).L’intento di Husserl è invece quello di portare ad effettivo compimento ilsuperamento kantiano della metafisica attraverso la fondazione dell’analisifenomenologico-trascendentale che consente di cogliere ed esplorare le strutturenoetico-noematiche della coscienza.
175
partendo da premesse antitetiche, la coscienza teleologicamente sipone “come compito”. 73
L’interrogativo che ora si definisce riguarda la possibilità diun’integrazione tra la psicoanalisi e la fenomenologia. Come èpensabile questa relazione che, considerate le premesse e lecategorie fondanti, appare come totalmente impraticabile?Da quale esigenza può essere posto il problema della lorointegrazione?Sia la psicoanalisi sia la fenomenologia tematizzano ed indaganole strutture della soggettività-intersoggettività in vista di unaloro chiarificazione-realizzazione: la prima procede fondandosi suuna prospettiva fondamentale, quella della natura inconscia-desiderante dell’uomo, la seconda, che vuole annullare ogni tipodi pre-giudizio, cerca di indagare ogni manifestazione della vitapsichica in se stessa senza ridurla a qualcosa d’altro.Ciò comporta che la psicoanalisi ancora si muove, nonostante ilsuo nomadismo epistemologico, in un orizzonte naturalistico-scientifico che pone come suo oggetto di indagine i vissuti psichicidel soggetto, compresi a partire da un principio fondamentale cheli sostanzia e li domina. Sulla base di un cartesianesimoinconsapevole Freud procede a dare spiegazione dei processipsichici come se questi fossero un oggetto in sé concluso: la rescogitans è un “apparato psichico chiuso in se stesso” da indagare, come avviene per la res extensa, secondo il paradigmacausalistico che trova nella dimensione biologico-istintuale ilproprio fondamento.Nella fenomenologia invece non si procede alla formulazione diprincipi unici dai quali dedurre ogni cosa, ma si avanza, con lostrumento dell’epoché, verso la progressiva definizione di unterreno teorico in cui sia consentito attingere ad una visioned’essenza (Wesenschau) della molteplicità degli atti di coscienza.Conseguentemente la battaglia di Husserl contro le forme dipensiero tradizionali converge sulla problematizzazione dell’ideadi coscienza che era ancora prevalente nella sua epoca. Lacoscienza non è un oggetto di indagine tra gli altri, una sferachiusa in sé che può essere indagata al pari di qualsiasi altraentità e che può essere spiegata entro una prospettiva teoricadominata da principi unici. La coscienza ed i suoi atti,equivalendo a coscienza di, essendo essa già da sempre presso le cose(bei den Sachen) non può costituire quindi un campo di “oggetti” diuna scienza positiva che indaga fatti. La coscienza è una
73 Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Jaca book, Milano, 1977
176
“posizione assoluta” che pone una fondamentale esigenza, quella didefinire nuove condizioni teoriche che riescano a superare leprospettive tradizionali (sostanzialmente soggettivismo eoggettivismo, storicismo e naturalismo) entro cui è stata posta.La psicoanalisi invece, quando procede attraverso spiegazioni(l’erklären) che riducono la vita psichica alle connessioni causaliche la determinano, da una parte spoglia la coscienzadell’intenzionalità che le è costitutiva, dall’altra laricostruisce sul terreno, profondamente scavato, delle sue origini“istintuali”. La coscienza è allora una manifestazione derivatadella soggettività, nel senso che essa non opera costituzioni dioggetti intenzionali bensì, al contrario, è essa stessa costituitadal processo di incivilimento resosi necessario per la sopravvivenzadella specie umana. Le sue pure e incontaminate evidenze, radicandosi su un pianoumano, troppo umano, nascondono originarie menzogne. I suoi nessiintenzionali con il mondo, fondandosi su una dimensioneinsondabile ad uno sguardo diretto, quella dell’inconscio, vannoesplorati nelle manifestazioni che da questa dimensione salgonoalla superficie, cioè nei lapsus, negli atti mancati e soprattuttoin ciò che ricordiamo del lavoro onirico. Non è quindi possibileanalizzare la coscienza come tale, cioè, husserlianamente, come“posizione assoluta”.Conseguentemente, per il filosofo che ha sempre pensato la vitapsichica come coscienza, l’incontro con la psicoanalisicostituisce un duplice choc. Innanzi tutto, quale valore ha la riflessione filosofica sullasoggettività senza la considerazione della sua dimensioneinconscia (che è, per Freud, lo “psichico reale”)?In secondo luogo: qual è il valore conoscitivo della coscienza(della ragione) che non è consapevole della sua natura “derivata”dalla dimensione pulsionale-istintuale?Ciò che è messo in discussione non è allora solo uncoscienzialismo teoreticamente sterile( nessuna teoria della soggettività è possibile senza il concettodi inconscio), ma è anche la stessa progettualità conoscitivadella filosofia ad essere posta in crisi.La decostruzione psicoanalitica della coscienza fa sì che sipossano assumere le produzioni filosofiche come momenti di unadinamica teorica interpretabile sia in termini di “ psicografiadella personalità”, sia come Weltanschauungen dettate dallanecessità di com-prendere la realtà. Anche se le produzioni delpensiero filosofico non sono annullate nel loro valore intrinseco,
177
in quanto sono espressioni sia dell’Io del singolo filosofo, siadel tessuto collettivo della cultura, esse ora, alla luce dellescoperte psicoanalitiche, vanno poste sul terreno della Zivilisation,e non su quello del progresso della conoscenza pura, cioè dellascienza.La filosofia, anzi, le filosofie che si sono succedute nel corsodella storia occidentale, sono indagabili, come luoghiparticolarmente alti della Kultur, nel contesto dell’interpretazionepsicoanalitica della cultura.Freud è pronto a riconoscere solo ad alcuni filosofi (inparticolare Schopenhauer e Nietzsche) il merito di aver colto espesso anticipato, con libere intuizioni, concetti faticosamenteguadagnati dal lavoro analitico, ma nega al pensiero filosoficoogni valore realmente conoscitivo.Così, come Marx e Nietzsche, anche Freud, come afferma Ricoeur, èun “protagonista del sospetto” che pone il problema della“menzogna della coscienza e della coscienza come menzogna”.Non è allora pensabile nessuna possibile confluenza o comunquerelazione tra la psicoanalisi e la fenomenologia?Se, da una parte, la fenomenologia pensa la coscienza come“posizione assoluta” (grazie al dubbio cartesiano su di essa chefinisce per renderla inespugnabile) e, dall’altra, la psicoanalisila intende, invece, come “cerchio minore” i cui contenuti sonocompromessi, nella loro pretesa di evidenza, dal “cerchiomaggiore” dell’inconscio, in che modo è possibile una lorointegrazione?La prospettiva psicoanalitica sulla soggettività-intersoggettività, rimanendo nella dimensione del naturalismoobiettivistico che Husserl indica come il male maggiore delpensiero occidentale, è totalmente inconciliabile con l’analisifenomenologica della costituzione?Questi interrogativi possono essere ricondotti, sia per lapsicoanalisi, sia per la fenomenologia, allo stesso problema che,in modo più o meno diretto, li contiene tutti, quello del rapportomente-corpo.Problema che da Freud viene illuminato dal basso di un naturalismoobiettivistico che riduce la coscienza a entità riflessa, a post-datità, mentre, nel pensiero di Husserl, viene assunto dall’altodella certezza cartesiana del cogito da cui, senza ricaderenell’empirismo psicologico, è poi possibile cercare le essenzeeidetiche della coscienza.Ma, da una parte, la ‘realtà’ naturalistica dell’inconscio nonesaurisce l’essere della coscienza, dall’altra, la certezza
178
apodittica della coscienza non corrisponde totalmente alla suaverità.Su quale terreno e secondo quali modalità può essere allora postala relazione tra psicoanalisi e fenomenologia? Tra le prospettive di integrazione tra psicoanalisi efenomenologia che si sono definite negli ultimi decenni, emergono,in particolare, per la progettualità di fondo che li alimenta eper il valore che hanno assunto nel dibattito filosofico del ’900,da una parte, l’opera di radicale rinnovamento teorico emetodologico della psichiatria da parte di Ludwig Binswanger e,dal versante filosofico, il pensiero di Paul Ricoeur, che siassume invece il compito di affrontare, su diversi piani(epistemologico, ermeneutico, riflessivo, dialettico), la“consistenza del discorso freudiano” 74 e la sua valenzafenomenologico-ermeneutica.Qui ci si occuperà dell’antropoanalisi di Binswanger, non essendopossibile, per evidenti motivi, trattare, anche solosommariamente, della complessa quanto preziosa opera diinterpretazione della psicoanalisi che Ricoeur compie dallaprospettiva fenomenologica ed ermeneutica.Lo stesso Ricoeur però ci può introdurre, nel migliore dei modi,alle modalità con cui si presenta l’inevitabile confronto-integrazione della psicoanalisi con la fenomenologia, che si poneanche al di là della sua diretta e specifica tematizzazione,all’interno del progetto binswangeriano di emancipare lapsichiatria dalla sua origine positivistico-naturalista.“La fenomenologia husserliana - scrive Ricoeur nel Conflitto delleinterpretazioni - ha cominciato per suo conto la critica dellacoscienza riflessa ed ha introdotto il tema, oggi ben conosciuto,del preriflessivo e dell’irriflessivo. Il beneficio inestimabile,benché ultimamente solo negativo, di tutta la fenomenologiahusserliana consiste nell’aver chiarito che le ricerche di“costituzione” rimandano a qualcosa di pre-dato, di pre-costituito. Ma la fenomenologia husserliana non può andare fino infondo allo scacco della coscienza; essa rimane nel cerchio dellecorrelazioni tra noesi e noema e non può far posto alla nozione di
74 L. Binswanger, Freud e la costituzione della psichitria clinica in Essere nel mondo p.187,Astrolabio,1973. “ In altre parole, se per noi ‘capire Freud’ significa ‘andare oltre Freud’,fino a dove egli può procedere insieme a noi e a partire da dove dobbiamoinvece proseguire la strada senza di lui?” p.187
179
inconscio se non per la via traversa del tema della “genesipassiva”. Occorre allora “ andare fino in fondo allo scacco dell’approccioriflessivo della coscienza” e “il realismo freudiano rappresentala tappa necessaria” per farlo.75
Come introduzione e, nello stesso tempo, legittimazione deltentativo fenomenologico-psichiatrico di Binswanger, chedirettamente e indirettamente investe anche la psicoanalisi,vediamo, in sintesi, quali sono i nuclei tematici che Ricoeurindividua come elementi fondanti la possibilità teorica, ma anchepratico-terapeutica, di incontro tra la psicoanalisi e lafenomenologia.Ciò, ovviamente, non ci impegna nella analisi e nellaconsiderazione della complessa riflessione che il filosofofrancese fa rispetto alla valenza fenomenologico-ermeneutica dellapsicoanalisi, a cui andrebbe dedicata un’attenzione specifica,anche perché qui si intende solo individuare e definire, agrandissime linee, uno spazio teorico in cui le grandi opere diFreud ed Husserl possono, al di là della loro originariainconciliabilità, dialogare per aprire nuove ed inediteprospettive di ricerca sui temi della soggetività-intersoggettività.Anche se il tentativo di Binswanger non si pone nella prospettivaeminentemente filosofica aperta da Ricoeur, tuttavial’interpretazione della psicoanalisi del filosofo francesecontiene un insieme di temi che sono presenti come elementifondanti la prospettiva della Daseinanalyse.
Intenzionalità ed Inconscio
Che cos’è che “fa ruotare la fenomenologia in direzione dellapsicoanalisi?” E’ questo l’interrogativo che Ricoeur si pone in Della interpretazione,Saggio su Freud ed anche se non è qui certamente possibile ricostruirel’itinerario che conduce Ricoeur a porsi questa domanda decisiva,va però ricordato che, per il filosofo francese, la psicoanalisifa parte - a pieno titolo ed indipendentemente dagli auto-75 Il conflitto delle interpretazioni, cit.p.118
180
riconoscimenti del suo fondatore - del dibattito filosoficonovecentesco, in modo tale che la sua interpretazione diviene uncompito ineludibile e perfino decisivo nella riaperturadell’orizzonte teorico-conoscitivo della tradizione filosofica delpensiero, così fortemente messo in discussione da più parti esecondo diverse prospettive negli ultimi decenni.Quali sono allora, secondo Ricoeur, i fondamentali temi chelegittimano un proficuo confronto tra fenomenologia epsicoanalisi?Innanzi tutto esse trovano un procedimento comune nel superamentodell’idea di coscienza immediata. Da una parte la riduzione,deponendo l’atteggiamento naturale, spossessa la coscienza dellasua verità immediata, del suo essere “ origine e luogo del senso”.76 Dall’altra, il sospetto su di essa e sulle sue certezze, lariconduce ad una dinamica e ad un conflitto costitutivo che siradica nella dimensione del desiderio inconscio. Nella fenomenologia vi è il riconoscimento che c’è una dimensionedell’esperienza che è inattingibile dal sum del cogito “la cuicertezza assoluta racchiude la non risolta questione dellapossibile ampiezza della illusione di se stessi”.77 Certamentel’umiliazione del sapere della coscienza immediata da parte dellafenomenologia non coincide con quella inferta dalla psicoanalisiattraverso il sospetto sulla sua verità. La fenomenologia, purassolutizzando la coscienza come “presenza vivente di sé”,riconosce però che c’è “qualcosa che propriamente non è esperito”ma “necessariamente con- intenzionato”.Ricoeur coglie l’elemento essenziale che fonda la possibilità diun rapporto tra psicoanalisi e fenomenologia proprio nellanecessità, da parte di quest’ultima, di tematizzare l’implicito,il co-intenzionato della coscienza. Tutto ciò allora converge verso l’individuazione di un nesso traintenzionalità ed inconscio fondato sul riconoscimento che c’è unamodalità inconscia che inerisce all’intenzionalità, essendo essavita votata all’altro che “non sa di essere innanzi tutto visioneintenzionate” Come ribadisce Husserl in più parti della sua opera, come adesempio nelle Ideen (Libro I, Sez. II, § 27 e §28), la coscienza èentro un “orizzonte di realtà indeterminata oscuramenteconsaputo”. 78
76 Della interpretazione, cit., p.35477 Ibid.,p.355
181
Nell’intenzionalità si dà cioè l’irriflesso e l’agito come atti‘prioritari’ rispetto al riflesso e all’enunciato: nelle spontaneeattività di coscienza in un “mondo circostante” (Umwelt) che è aportata di mano e che viene colto nell’atteggiamento naturale “c’è necessariamente un orizzonte nebuloso mai completamentedeterminabile, un alone di indeterminatezza infinito”. Secondo Ricoeur “questo non sapere proprio all’irriflesso segna unnuovo passo verso l’inconscio freudiano” che vede anche come,nella Krisis, “l’intenzionalità fungente supera l’intenzionalitàtematica, quella che sa il proprio oggetto e si sa a partire dalproprio oggetto; la prima non può mai essere uguagliata dallaseconda; sempre un senso in atto previene il movimento dellariflessione, senza che questo possa mai raggiungerlo”. Da parte sua, Husserl, attraverso il concetto di corpo proprio, chenon è riducibile né all’io, né a cosa del mondo, indaga la genesidel senso incarnato, della significazione che si radica nellatotalità del nostro essereA questo punto però lasciamo il filosofofrancese - cui si è fatto riferimento sia per introdurre le nostreosservazioni sui modi della configurazione fenomenologia-psicoanalisi nell’ultimo Biswanger, sia anche per legittimare talerelazione - e cerchiamo di vedere come nell’antropoanalisi siconfigurano i nessi tra inconscio, intenzionalità e temporalità.Anche se l’opera dello psichiatra svizzero non si pone nellaprospettiva indicata da Ricoeur, è indubbio che tutti i temisollevati dal filosofo francese si ritrovano, in forme diverse,nel suo tentativo di rendere comprensibile la sofferenza mentalecome sofferenza che scaturisce da forme di vita e di relazioneintersoggettiva.Nel percorso teorico-metodologico che Binswanger intraprende perperseguire questo obiettivo si aprono, al di là delle stesseintenzioni dello psichiatra svizzero, nuove possibilità persuperare l’inconciliabilità originaria tra fenomenologia e psicoanalisi,anche se tali possibilità non si originano, come in Ricouer, dalversante filosofico bensì da quello psichiatrico.D’altra parte, in questo percorso, Binswanger assume duefondamentali riferimenti teorici, l’analitica esistenziale diHeidegger prima e la fenomenologia trascendentale di Husserl, checorrispondono precisamente alle due grandi prospettive entro cuiRicoeur legge l’opera freudiana.
78 Edmund Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einuaudi,Torino, 1976, p.58.
182
Nonostante i veti incrociati dei loro fondatori, l’approcciofenomenologico di Binswanger, rivolto alla emancipazione dellapsichiatria dall’ambito delle scienze naturali, avviene sulterreno delle categorie fondative della psicoanalisi poiché, comemostra Ricoeur nel suo tentativo di fondare una filosofia dellasoggettività, alcune delle questioni filosofiche fondamentali delnovecento ruotano necessariamente intorno alla relazione traermeneutica, fenomenologia e psicoanalisi.Il progetto binswangeriano, anche se procede senza la necessità ditematizzare direttamente il confronto tra fenomenologia epsicoanalisi, mostra, nella sua operatività metodologica econoscitiva, come l’approccio e le categorie della psicoanalisi,pur nella presa di distanza dal loro naturalismo, sonostrutturalmente connessi alla ricerca fenomenologica deglielementi eidetici della soggettività.Cercheremo dunque di leggere in trasparenza come si configuraquesta inevitabile relazione che converge, da prospettiveradicalmente diverse, sugli stessi problemi per la costruzione diun sapere che illumina i processi di costituzione dellasoggettività e della intersoggettività.
La comprensione del Dasein patologico
Il tentativo di Binswanger di fondare, prima ricorrendo alla Daseinsanalyse di Heidegger, poi alla fenomenologia descrittiva di Husserl, una scienza della molteplicità dei modi di essere dell’uomo, avviene su un terreno precedentemente costituito, quello psicoanalitico.Per lo psichiatra Binswanger, formatosi sia alla scuola di Freud che di Husserl ed interessato a comprendere le “malattie mentali” in modo non organicistico e causalistico79, psicoanalisi e fenomenologia costituiscono due grandi modalità di approccio alla
79 Binswanger non ha, però, mai negato che le psicopatologie possano essere fondate anche su alterazioni organiche. La Daseisanalyse non è conseguentemente un modo di comprensione solo delle patologie che scaturiscono da vissuti e da traumi di natura psichica, essendo essa interessata ad apprendere il loro come,cioè i peculiari modi di essere del dasein sofferente, qualsiasi sia il complessodei fattori entro cui si sono manifestate. Nello stesso tempo viene rifiutato ilmodello causalistico perché l’essenza della malattia mentale non è mai totalmente riconducibile a complessi determinati ed individuabili di cause.
183
complessità della vita psichica, che possono trovare una straordinaria opportunità di integrazione “operativa” proprio comecornici di riferimento di una psichiatria rivolta ad emanciparsi dai confini delle scienze naturali. Dopo una serie di opere direttamente riconducibili l’analitica esistenziale di Heidegger, Binswanger torna a ripensare le categorie fenomenologiche husserliane nella prospettiva di una più originaria esplorazione delle modalità patologiche dell’esperire psichico.Gli ultimi due testi, scritti nel 1960 (Melanconia e Mania) e nel 1965 (Delirio), sono la testimonianza di questo ritorno che viene compiuto, oltre Heidegger, non più e non solo per descrivere le modalità in cui si esprime un “universo di trascendenze costituite”, ma in una prospettiva rivolta a cogliere la dinamica strutturale della loro costituzione.A partire dalla considerazione dell’analitica del “ci” dell’Esser-ci, cioè a partire dal fondamento ontologico cui Heidegger vincolaogni psicologia che vuole essere veramente tale, Binswanger, non rinnegando i suoi riferimenti originari, ma integrandoli e sviluppandoli con altre prospettive, opera una svolta decisiva cheva verso un recupero profondo della fenomenologia. Nell’economia enella finalità di questo studio, è a questa ultima parte della suaopera che faremo riferimento, omettendo così di analizzare i contenuti e le prospettive teoriche emerse nella “fase” heideggeriana.80 Il ritorno a Husserl avviene dunque al termine di una vasta opera che, nelle molteplici articolazioni in cui si esprime, ruota tenacemente attorno al progetto di liberare la psichiatria dal naturalismo meccanicistico, affinché possa legittimamente acquisire la sua vera identità di scienza umana. Binswanger, grazie anche alla collaborazione di Wilhelm Szilasi, importante interprete dell’opera di Husserl, vuole fare luce sui processi genetico-costitutivi del soggetto e dei suoi vissuti psichici per comprendere le modalità disfunzionali o difettose di tali processi. Ciò costituisce la premessa per poter poi operare terapeuticamente, rimanendo in una dimensione propriamente umanistica, verso l’essere-nel-mondo della persona bisognosa di aiuto.Per lo psichiatra svizzero l’opera di Husserl offre una straordinaria e decisiva opportunità per l’emancipazione della psichiatria dall’organicismo causalistico e meccanicistico originario. Husserl ha anche il merito di aver elaborato una
80 Tra le diverse ricostruzioni del rapporto Binswanger\Heidegger si rimanda a l’Introduzione critica all’analisi esistenziale di Jacob Needleman, contenuta in L. Binswanger, Essere nel mondo, Roma, Astrolabio, 1973.
184
critica rigorosa alla pretesa egemonia di un sapere che procede esclusivamente attraverso la spiegazione, cioè attraverso la modalitàconoscitiva tipica delle scienze naturali.Naturalmente qui non è possibile minimamente ripercorrere il complesso itinerario teorico di Binswanger, né analizzare in modo dettagliato queste sue due ultime opere; nelle considerazioni seguenti si cercherà solo di cogliere gli elementi costitutivi dello spazio teorico fenomenologico- psicoanalitico che Binswangerdefinisce, in particolare, in questi ultimi due suoi testi finalizzati a comprendere i modi patologici dell’esperire psichico, inafferrabili entro i ristretti ed inadeguati confini della ricerca scientifico-naturalistica.Il punto di partenza di questo itinerario era stato quello freudiano. Binswanger, subito però consapevole dell’origine naturalistica della psicoanalisi e della necessità di superarla per comprendere realmente la complessità e la pluridimensionalità della vita psichica, si chiede se il “completamento” della psicoanalisi (cioè l’esigenza di una considerazione della dimensione spirituale della soggettività) “ lo possiamo compiere insieme a Freud, oppure dobbiamo compierlo senza di lui?” La risposta a questo interrogativo, che Binswanger si poneva fin dagli anni trenta, la possiamo trovare lungo tutto il suo percorsoteorico fino ad arrivare alle due opere prima citate. Qui le complesse analisi fenomenologiche di casi clinici poggiano su un terreno psicoanalitico, essendo gli elementi strutturali del pensiero freudiano, a partire dalla natura inconscia e desiderantedei vissuti psico-fisici, lo sfondo entro cui Binswanger procede. Si può dire allora che l’opera di Binswanger dissolve la radicalità dell’alternativa posta da lui stesso all’inizio del suopercorso, nel senso che certamente la “grande idea della natura istintuale dell’umanità” non viene assolutamente considerata “l’ultima parola detta sull’uomo” ma, nello stesso tempo, l’universo concettuale psicoanalitico fondato sull’inconscio e suldesiderio, continua ad essere una ineliminabile cornice teorica diriferimento del progetto di definire un nuovo spazio teorico dellapsichiatria, unitamente alla individuazione di nuove metodologie terapeutiche.Come si cercherà di mostrare, la prospettiva psicoanalitica lascerà sempre più spazio a quella fenomenologica fino, apparentemente, a dissolversi. In realtà, essa rimane un Grund costante su cui è possibile formulare i nuovi indirizzi di ricercarivolti in primo luogo a liberare la psichiatria da ogni dominio ideologico che la riduce ad apparato categoriale precostituito,
185
sia di natura organicista sia anche sociologica , da applicare meccanicamente e non dialetticamente, al fine di diagnosticare “malattie mentali”come entità oggettive e nosografiche da cui è impossibile guarire per l’assolutezza delle loro cause organico-ereditarie o sociali. La fenomenologia di Husserl, che per Binswanger sta alla psichiatria come la biologia sta alla medicina somatica, è invece“desiderio di futuro” (così la definisce il suo fondatore) che,illuminando i modi di esistenza schizofrenici e maniaco-depressivi, pone in essere indirettamente anche nuove prospettive terapeutiche che aprono al soggetto sofferente possibilità di sviluppo di ciò che egli “è”, al contrario della psichiatria organicista e naturalista che lo condanna alla malattia che oggettivamente “ha”.La psichiatria che si avvale del metodo fenomenologico è dunque ciò che consente, senza ricadere all’interno del modello meccanicistico-causalistico, di penetrare nella dimensione in cui trovano origine le modalità psicotiche dell’esperienza.Non si tratta, come nel modello epistemico della psichiatria classica, di risalire, attraverso un processo induttivo, da una serie di sintomi al disturbo delle funzioni somato-genetiche.Ciò che Binswanger vuole definitivamente superare, senza però rinunciare al rigore scientifico,è proprio l’ideale conoscitivo naturalistico che ha guidato la nascita e lo sviluppo della psichiatria come scienza obiettivante rivolta a fornire spiegazioni dell’oggetto “malattia mentale” in termini di categorie noso-grafiche che diagnosticano ‘stati di cose’ dell’apparato psichico.Mentre nella psichiatria è astrattamente applicato un modello di spiegazione causalistico che opera connessioni tra sintomi e funzioni alterate, prevalentemente di natura somatica, nell’approccio fenomenologico-antropologico non si tematizza alcuno stato di cose come un insieme di sintomi che configurano specifiche “malattie mentali” preindindividuate e descritte dalla nosografia clinica.Semplicemente – ma per conquistare questo ‘semplicemente’ occorre una radicale trasformazione della forma mentis dominante - ci si pone di fronte al senso delle modalità esistenziali dell’essere-malato: solo così è possibile scendere al di sotto della spiegazione fondata sulla manifestazione di sintomi caratteristicidi una patologia già classificata e cogliere la pluridimensionalità e la complessità dell’esperienza psicotica,
186
cioè di quei modi d’essere convenzionalmente qualificati come maniacali, melanconici e schizofrenici.I fondamentali problemi che si pongono di fronte a questo progettosono relativi dunque ad una diversa comprensione e trattamento delle cosiddette “malattie mentali”, il cui fondamento categorialedeve essere dissolto per poterne comprendere sensi e significati nell’intreccio dei nessi intenzionali dell’intersoggettività. Che cos’è la “malattia mentale”? E’ possibile “comprenderla”? In rapporto a quali criteri viene definita? Qual è la sua origine? E’possibile l’intervento terapeutico e qual è la sua efficacia?:Questi fondamentali interrogativi sono ri-assunti nell’approccio fenomenologico alla psichiatria e ricondotti , nella sostanza ultima delle cose, ad un solo problema, cioè quello di una nuova definizione e comprensione della relazione normalità\anormalità, perché è a partire da questa comprensione che possono conseguentemente essere affrontati diversamente anche tutte le problematiche relative alla sofferenza mentale.
Normalità
Dalla nascita della psichiatria si sono dati due grandi paradigmi,fondamentalmente legati a due ideologie dominanti entro cui essi si sono definiti, che hanno storicamente formato le concezioni della sofferenza mentale e le modalità di ‘intervento’ su di esse.Il primo è quello scientifico-naturalistico (o medico-biologico), in cui le manifestazioni dell’esperienza psicotica vengono comprese come “malattie mentali” di origine somatica (nei termini sopra ricordati) , il secondo è quello sociologico, dove invece esse vengono, in modo più o meno diretto, ricondotte ad una genesisociale.Anche se esistono certamente altri indirizzi in psichiatria –come quelli psicodinamici, comportamentisti, cognitivisti, sistemici – è possibile ricondurli alla loro matrice originaria che si definisce nell’ambito delle scienze naturali o in quello delle scienze umane. In ultima analisi si tratta di assumere una prospettiva in cui chi soffre mentalmente è compreso come un malato che presenta alterazioni nel suo organismo fisico o un soggetto che agisce in modo deviante in base a situazioni esistenziali critiche.
187
Secondo Eugenio Borgna entrambe queste concezioni trovano origine in una ragion d’essere ideologica, prima paleopositivista e poi empirista-sociologica, che, occultando il senso della sofferenza mentale, è riconducibile, in ultima analisi, ad una ragione politica incapace di assumere, nella consapevolezza delle antinomie esistenziali e delle contraddizioni storiche, questa ed altre esperienze umane in un orizzonte dialogico e di senso. L’ideologia dell’empirismo sociologico è tale perché riduce la complessità e la pluridimensionalità dell’esperienza della sofferenza mentale entro un’idea o un sistema di idee, assolutizzate come uniche modalità di approccio e spiegazione.Nei termini della critica husserliana al fisicalismo e all’obiettivismo, sia la concezione naturalistica che sociologica,sono espressione di una ragione scientifica che ha smarrito il suocompito originario, riducendosi ad un apparato categoriale che positivamente fornisce spiegazioni di fatti, siano essi colti nella rete dei rapporti sociali o nella dimensione fisico-naturale. Come si è ricordato, la psicologia (ed anche la psichiatria) è scaturita da questa riduzione positivistica dell’idea di scienza, così come è avvenuto per la sociologia che, d’altra parte, per Comte, uno dei principali fondatori del positivismo, è la scienza fondamentale a cui sono subordinate tutte le altre scienze.Certamente l’empirismo sociologico ha avuto molti meriti non solo nel porre il problema della comprensione della sofferenza mentale nella rete di relazioni sociali, economiche e culturali storicamente determinati, ma anche di demistificare il ruolo delleistituzioni psichiatriche, funzionale al controllo sociale, proprio per il suo carattere totalizzante ed ideologico, e non all’intervento terapeutico.81 Nonostante ciò esso, se non si avvede attraverso un metodico procedere critico nei confronti delle sue stesse conoscenze, è destinato a rimanere dentro un orizzonte ideologico in virtù dellaassolutizzazione del proprio universo categoriale che viene fatto valere in generale e al di là della sua funzione di strumento di analisi, di conoscenza e di verifica di fenomeni sociali particolari.Il progetto binswageriano si pone dunque il compito di condurre lapsichiatria fuori di qualsiasi ideologia dominante per renderla 81 Occorre invece fare una diversa valutazione del movimento antipschiatrico e sul ruolo che questo ha avuto nella storia della psichiatria e delle sue istituzioni; si rimanda, anche per questo ordine di problemi, al saggio introduttivo di Eugenio Borgna del testo di U.Galimberti, Psichiatria e fenomenologia,cit
188
pienamente scienza umana che possa consentire una reale esperienzadialogica nella relazione medico-paziente, relazione fondata non su diagnosi prodotte in base ad apparati categoriali precostituitima sulla comprensione del senso profondo dei vissuti.Per portare a compimento questo progetto, in primo luogo, si deve ripensare il rapporto normalità\anormalità al di là dei parametri attraverso cui è stato storicamente definito dai vari indirizzi della psichiatria, in particolare da quello medico-biologico e da quello relativistico della socio-antropologia.Il concetto di norma è, evidentemente, decisivo nella psichiatria perché è a partire dalla sua definizione che essa si dà il propriofondamento epistemico ed autonomia metodologica, legittimandosi anche come realtà istituzionale e prassi terapeutica.I due paradigmi, naturalistico e sociologico, sono in realtà due diversi modi di intendere la norma: per il primo, fondato sulla realtà biologica, la norma è data dalla funzionalità di tutti gli organi del corpo, di cui l’apparato cerebrale ed il sistema neurovegetativo è parte, mentre, per il secondo, basato sulla realtà sociale, la normalità viene relativisticamente pensata in rapporto e in conformità ai sistemi di valore ed ai conseguenti modelli comportamentali che caratterizzano le diverse forme di società nel tempo e nello spazio.Il ricorso di Binswanger alla fenomenologia è un tentativo di pensare la norma, al di là di questa apparente alternativa, in unadimensione diversa da quella immediatamente afferrabile dall’evidenza fisico-naturale o socio-culturale.La fenomenologia, come metodo che indaga gli elementi eidetici della intersoggettività e le strutture costitutive del mondo-della-vita, è rivolta a conquistare il piano teorico in cui risulta possibile operare la decisiva distinzione tra “contenuto” (Inhalt) e “forma” (Form) della norma. Il primo va ricondotto al contesto socio-culturale di formazione, mentre l’altra si autopone in sé stessa come elemento invariante rinvenibile in ogni cultura.Al di là della variabilità spazio-temporale delle culture, in cui si definiscono i contenuti specifici della relazione norma\non norma (un valore in una cultura può essere disvalore nell’altra), la fenomenologia, sulla base del riconoscimento della invariabilità della norma in sé (in ogni cultura esistono comunquesistemi normativi), cerca di comprendere questo tipo di realtà che ritiene più essenziale e più ‘positivamente’ fattuale rispetto sia alla realtà biologica degli organi corporei sia alla realtà socio-culturale delle relazioni tra attori sociali.
189
La ricerca fenomenologica vuole allora comprendere ciò che pre-categorialmente si dà in ogni contesto come struttura eidetica dell’intersoggettività e della spazio-temporalità e come forme costitutive del mondo-della-vita.Come ricorda Enzo Paci, grande interprete italiano di Husserl, “Lanormalità è nascosta nel mondo-della-vita in cui vivo e la riflessione sul mondo-della-vita è il primo costituirsi della norma originaria (Urnorm) ”.La riflessione fenomenologica – soprattutto e non solo - si pensi,ad esempio, all’ultimo Wittgenstein - ci pone così di fronte a ciò che abbiamo incessantemente di fronte, facendoci però scoprire le strutture soggiacenti che nel tempo hanno costituito e sostengono l’immediatezza del già sempre dato.Questo compito di ri-costruzione archeologica della intersoggettività se lo dà anche la psicoanalisi che vuole, attraverso l’analisi economica, topica e dinamica dei processi ‘pre-categoriali’ dell’inconscio e del desiderio, gettare una lucediversa su ciò che è già alla luce, su ciò che si manifesta con evidenza nei vissuti immediati e nelle relazioni sociali.Nella psicoanalisi si pone l’esigenza di comprendere la relazionenormalità\anormalità nella dimensione formale e non contenutistica, poiché è nelle modalità con cui si esprime e si declina il desiderio inconscio che Freud cerca la vera origine delle nevrosi. Come si è visto nella prima parte, in particolare nel riferimento agli Studi sull’isteria, Freud supera la distinzione netta tra normalità e non normalità: il patologico non è un corpo estraneo che si è installato in una soggettività che era e potrà ritornare ad essere, una volta che sia stato estirpato, sostanzialmente sana, poiché i gruppi psichici patogeni si trovanoaggrovigliati “ con elementi dell’io normale e appartengono, propriamente, a quest’ultimo non meno che all’organizzazione patogena”. Come nella psichiatria fenomenologica la psicoanalisi, superandone la dicotomia, pone la relazione normalità\anormalità su un piano in cui il cosiddetto patologico consiste in “modi d’essere” e non in affezioni caratterizzate da specifiche sindromiche oggettivamente colpiscono il paziente. Esistono specifiche modalità di fare esperienza che, per la loro intensità e criticità, possono richiedere la presenza e l’intervento di specialisti che si pongono in una relazione personale ed umana coni ‘pazienti’, nel tentativo di governare questi momenti esistenziali particolarmente importanti e sofferti.
190
Sia la psichiatria fenomenologica che la psicoanalisi intervengonosulle forme della deviazione dalla norma anche se entrambe devono necessariamente convergere sui contenuti specifici dei vissuti; ciò che però le qualifica è il tipo di sguardo che su questi vieneassunto, orientato a descrivere-ricostruire-interpretare i modi incui, da una parte, il desiderio inconscio e, dall’altra, la rete dei nessi intenzionali, presiedono ai processi di costituzione dello spazio, del tempo, del corpo, del sé e dell’altro.La psicoanalisi, così, come afferma anche Ricoeur, trova il massima vicinanza con la fenomenologia nella comune tematizzazionee ricerca dell’intersoggettività ma, inevitabilmente, anche la massima distanza perché lo fa da una prospettiva antitetica ad essa, essendo rivolta a coglierne la legalità in termini naturalistici e causalistici, cioè proprio in quei termini obiettivistici che la fenomenologia vuole radicalmente superare. In sintesi, l’antropoanalisi è innanzitutto liberazione della psichiatria dai suoi lacci ideologici per conquistare pienamente la propria identità ed autonomia di ‘cura delle anime’ (psiché-iatros). In questo percorso, il momento iniziale deve essere quello di indagare la relazione normalità\anormalità nella dimensione, inattingibile dalla psichiatria classica, delle strutture eidetiche della soggettività e del mondo-della-vita.La ri-fondazione epistemologica della norma, che comprende le “deviazioni” rispetto non ai suoi “contenuti” ma alla sua “forma”,è ciò che preliminarmente caratterizza non solo l’approccio fenomenologico in psichiatria, ma, poste le necessarie premesse e individuati i limiti, anche la psicoanalisi.
Melanconia e Mania
A partire da questo concetto di norma, Binswanger analizza casi clinici e formula considerazioni teoriche nel suo penultimo testo- Melanconia e Mania (1960) - che ha come sottotitolo Studi fenomenologici -per raggiungere delle conclusioni sui processi costitutivi delle modalità patologiche prese in esame.
191
L’uso delle categorie fenomenologiche, che talvolta trovano anche un intreccio diretto con quelle psicoanalitiche nella comprensionedei vissuti psichici, è finalizzato, come dichiara l’autore nella Prefazione, a cogliere i momenti strutturali costitutivi delle forme di esistenza patologica nella prospettiva di una ricerca dei fondamenti teorici della psichiatria. Non si tratta quindi di studi solamente clinici, ma del tentativo di fornire basi metodologiche solide alla psichiatria attraverso una considerazione complessiva della fenomenologia husserliana.Sembra che l’ex allievo di Freud metta in pratica una delle convinzioni del suo maestro (“ Soltanto quando si studia il patologico s’impara a conoscere il normale”) perché nella ricerca della genesi della melanconia e della mania emergono, nel loro aspetto distorto e difettoso, i processi profondi e costitutivi della soggettività in generale. Anzi i risultati conoscitivi effettivamente registrati nella comprensione di tali patologie attraverso le categorie fenomenologiche svolgono, come era già avvenuto anche con la psicanalisi, una funzione di conferma, e talvolta anche di revisione, di quest’ultime, che quindi trovano la loro verifica proprio nella loro capacità di illuminare profondi processi patologici della vita psichica. Questa prospettiva che integra la psicopatologia con la fenomenologia, oltre che da Binswanger, è stata assunta dall’altro grande teoricoche ha lavorato in questa direzione, cioè Eugène Minkowski. Entrambi, pur nella specificità delle loro ricerche, convergono sulla questione fondamentale, la temporalità. Naturalmente non è qui possibile ricostruire, per la sua straordinaria complessità e profondità, il percorso di Minkowski, ma va però ricordato come, specialmente in qualche punto importante, le modalità con cui alcuni concetti chiave sono elaborati nell’opera dello psichiatra russo sono presenti anche nelle ricerche di Binswanger. Emerge cioè chiaramente una tendenza di alcuni temi chiave a ripresentarsi, qualsiasi sia l’itinerario teorico seguito. Uno di questi è la relazione tra temporalità e sofferenza mentale. Lo psichiatra svizzero individua , infatti, nei “difetti” delle operazioni di costituzione della temporalità le fonti originarie sia della melanconia che della mania: come processi non determinati dalla volontà conscia del soggetto, ma riconducibili alle dinamiche attuali o pregresse che si radicano nell’attività inconscia della psiche, lo sguardo di Binswanger è allora sia fenomelogico sia psicoanalitico. Distanziandosi dai tentativi di spiegazione solo psicologica della melanconia, Binswanger intende praticare “un’indagine trascendentale-fenomenologica dei
192
turbamenti propri della “melanconia”, nella struttura costitutiva della “coscienza”; di una “coscienza” che, intenzionale e trascendentale, comprende naturalmente in sé stessa l’“inconscio” e il “conscio” “.82
A partire dalla ricerca dei nessi tra conscio ed inconscio, procedendo attraverso l’analisi di alcuni casi clinici, emerge che, in tutte le manifestazioni patologiche considerate, è avvenuta, nella formazione della coscienza temporale soggettiva, una profonda alterazione nei processi costitutivi dell’”oggettività” temporale.Basandosi sulle nozioni di protentio, retentio e praesentatio, che Husserldefinisce nei saggi sulla fenomenologia della coscienza interna del tempo come momenti intenzionali costitutivi e strutturali degli oggetti temporali -futuro, passato, presente , Binswanger procede immediatamente alla loro utilizzazione nel primo caso clinico considerato (Il caso Cécile Munch) in cui emerge come la manifestazione melanconica è espressione dei” modi difettosi” delle tre dimensioni che fondano la coscienza interna del tempo.Normalmente questi si integrano a vicenda e assicurano ad un tempola costruzione del Worüber (“ciò, di cui”), del tema presente, 83 che nell’analisi di Minkowski viene definito come “ io-qui-adesso”.84 , da intendere, sinteticamente, come la sicura consapevolezza del proprio presente.Nelle dinamiche psicopatologiche invece si allentano i nessi tra il soggetto e la situazione reale in cui esso vive, congiuntamenteallo scompaginamento delle correlazioni temporali-intenzionali.“ I processi morbosi sembrano colpire in modo elettivo sia il fattore dell’”io-qui-adesso”, sia le immagini che nella vita normale si raggruppano attorno ad esso.” 85
Il presente, l’adesso, si sostanzia in un processo governato dal principio del dispiegamento, del divenire, della durata, cioè del tempo-qualità indagato da Bergson, a cui Minkowski fa metodicamente riferimento. L’adesso è dunque un “adesso-continuità” – come definito anche dal filosofo Johannes Volkelt nella sua opera Fenomenologia e Metafisica del tempo del 1925, un adesso che si immerge nell’orizzonte fluente-costante (Husserl) e nella “massa fluida” ( Bergson) dell’oceano mobile, misterioso e possente che è il divenire (Minkowski).
82 L. Binswanger, Mania e melanconia,Bollati Boringhieri, p.42.83 Ibid.,cit,p33.84 E. Minkowski, Il tempo vissuto, Einaudi, Torino, 1971,p.282.85 Ibid.,p. 282.
193
La sintesi unitaria delle correlazioni temporali-intenzionali consente una corretta disposizione verso ciò che è passato, ciò che è attualmente e ciò che sarà, mentre la loro alterazione comporta l’allentamento e la confusione tra questi momenti. Il difetto consiste quindi in un” intreccio” di momenti retentivi con momenti protentivi (il melanconico attribuisce la possibilità non al futuro ma al passato “se non avessi fatto questo…”) e di momenti protentivi con retentivi (le vuote intenzioni del delirio melanconico che non si fondano su una visione realistica del presente o l’annullamento di qualsiasi possibilità che riguarda il futuro).“ Se la libera possibilità si ritira nel passato o, a dir meglio, se la retentio si confonde con la protentio, non si giunge più ad un Worüber vero e proprio, ma soltanto ad una vana discussione.(…) Dire che non si può giungere ad un vero e proprio Worüber implica che non si può giungere neppure a una vera e propria praesentatio: questa infatti è possibile solo laddove può appoggiarsi su retentio eprotentio” 86
I momenti protentivi, retentivi e presentativi si infiltrano l’uno con l’altro in modo tale che il melanconico soffre della confusione della dimensione temporale: il passato lo opprime, il presente glisfugge ed il futuro è vuoto.Poiché non si danno differenze qualitative tra queste tre dimensioni conseguentemente si dissolvono le modalità attraverso cui la vita psichica si temporalizza: aspettative, desideri, speranze, tensioni verso il futuro, consapevolezza ‘storica’ delleesperienze avute, ecc.Il melanconico prevede tutto perché, semplicemente, lo conosce già,avendolo vissuto una volta per tutte. Pensare e vivere il futuro senza la dimensione del possibile non solo equivale a cancellare la speranza ed il desiderio, cioè le forme costitutive della trascendenzarispetto ad una situazione data, ma comporta anche vivere il presente come nulla, come vuoto indeterminato, rimanendo, nello stesso tempo, prigionieri di un passato che, inattaccabile da qualsiasi oblio, ossessivamente si ripete come unica modalità di esistenza in cui implode ogni possibilità futura.Ora, questi processi difettivi nella costituzione della temporalità, qui solo tratteggiati a grandissime linee, avvengono perlopiù sullo sfondo della vita cosciente, in una dimensione cioèche l’ex allievo di Freud non può non pensare in termini di “inconscio”. La prospettiva che Binswanger fa propria è quella di cui si è discusso precedentemente a proposito della appendice XXI al § 46 della Krisis elaborata da E.Fink sulla base degli appunti di 86 Ibid., p35.
194
Husserl, cioè il riconoscimento della legittimità del concetto di inconscio e, contemporaneamente, l’esigenza di non pensarlo esclusivamente in termini psicologistici e naturalistici come unico principio che totalizza la vita psichica.Nella seconda parte del testo viene affrontato il problema della mania secondo lo stesso approccio seguito nella prima parte, anchese qui occorre ricercare, premette Binswanger, “ un’altra regione nell’universo di trascendenze costituite, in cui si possano evidenziare i momenti difettosi della costruzione intenzionale dell’oggettività temporale nella mania”.Infatti, considerate le caratteristiche strutturali di questo tipodi patologia che, contrariamente alla tendenza al rivolgimento interno al proprio mondo del melanconico, si rivolge essenzialmente agli altri, è necessario fare riferimento alle dinamiche trascendentali costitutive dell’intersoggettività e del mondo in comune.A differenza del melanconico, che si rapporta all’altro considerandolo solo un ascoltatore passivo dei suoi monologhi e dei suoi lamenti, nel caso della mania c’è una vera e propria tensione verso l’alter-ego e verso il mondo sociale di appartenenza.Anche qui Binswanger trova nel pensiero di Husserl un riferimento decisivo per comprendere non solo i difetti di costituzione temporale (presenti, pur se in altro modo, anche in questa patologia) ma anche e soprattutto le relazioni tra questi e le alterazioni nella definizione trascendentale dell’alter-ego.Disponendosi sul piano teorico su cui Husserl pensa i concetti di appresentazione, di mondo del prossimo (Mit-welt), di co-presenza (Mit-da), di corpo organico (Leib) e di corpo fisico( Körper) Binswanger, nella concretezza del riferimento ai vissuti di alcuni suoi pazienti, si addentra nella complessa rete di rimandi entro cui si definisce e si manifesta la manifestazione patologica, la cui caratteristica comune è rappresentata da un disturbo profondo nella relazione con l’altro. Il soggetto “maniaco” vive infatti l’esperienza dell’altro come “esperienza cosale” ( Dingerfahrung), essendo l’altro non un alter-ego con cui stabilire rapporti di reciprocità e di dialogo, ma un alius, cioè un estraneo senza volto ed identità, un “oggetto” di investimento libidico da usare e consumare.In questa parte del testo risulta in modo ancora più diretto come Binswanger lavora alla definizione di un nuovo spazio teorico-terapeutico della psichiatria, in un intreccio sempre più
195
vincolante di categorie husserliane e freudiane, al fine di accedere ai processi costitutivo-genetici dei mondi esistenziali della sofferenza psicologica.E’ particolarmente significativo, anche perché questo ci rimanda all’inestricabile legame tra teoria e prassi clinico-terapeutica che caratterizza la psicoanalisi, come Binswanger, dopo aver utilizzato con ‘successo’ i concetti e le categorie fenomenologiche nell’analisi e nella comprensione delle patologie psichiche, afferma che ciò rappresenta un contributo allo sviluppodella stessa fenomenologia. (“La fenomenologia della mania fornisce così un contributo, sia pure negativo, alla dottrina di Husserl della costituzione dell’alter-ego”). 87
Confortato da questi progressi Binswanger procede consolidando ulteriormente il suo riferimento ai concetti fenomenologici come, ad esempio, con la nozione di appresentazione (ricordiamo che con essa Husserl intende un atto intenzionale, che avviene, “con un solo sguardo”88, attraverso cui si costituisce un alter-ego, cioè un altro essere psicofisico che ha essenza propria e che è trascendente rispetto all’ego che ne fa esperienza).Con una trasposizione appercettiva fondata su un accoppiamento fenomenale,cioè nell’analogia con il proprio “corpo organico” (Leib) l’ego si dà in relazione ad un altro “corpo organico” che è anche corpo fisico (Körper). In altri termini: io apprendo un corpo esterno come corpo organico percipiente sulla base della sua somiglianza con il mio corpo organico, la cui percezione originaria viene ora estesa e trova conferma nell’altro corpo. Attraverso un continuum di “espressioni corrispondenti” l’ego conferma se stesso nella relazione con l’alter-ego. Il Leibkörper estraneo viene così a conservare l’apprensione originaria dell’esperienza di me stesso.All’interno del caso clinico del Dottor Ambühul, Binswanger mostracome i processi genetico-costitutivi della patologia siano caratterizzati dall’intreccio tra disturbi nella continuità di pensiero e temporale con quelli relativi alla rottura del “sistema” delle rappresentazioni abituali ed ordinate.Il problema è cioè rappresentato dalla mancata coesione degli oggetti intenzionali che espone il soggetto a presenze attuali e momentanee non “organizzate” in sistemi di significazione tra lorocorrelati. La relazione con l’alter-ego viene conseguentemente nonsorretta da strutture consolidate di rapporti che trovano senso e significato in un “insieme biografico unitario” ma “si sussuegono
87 Ibid., p.85.88 Meditazioni cartesiane,cit.,p131
196
completamente senza regole” 89
Come nel Dasein melanconico si manifesta l’impossibilità di vivere il presente nel continuum dell’esperienza temporale, anche nella mania si riproduce la stessa mancanza, pur se con diverse modalità. Infatti qui si vive di istanti, di momenti non strutturati in un organico sistema temporale, di frammenti rapidi ed isolati di tempo in cui si consumano esperienze che si dissolvono immediatamente in modo tale che, anche in questo tipo di sofferenza psichica, il presente perde consistenza ed autenticità. Volubilità, discontinuità sono conseguentemente l’espressione dell’affollarsi disordinato di momenti che non riescono a trovare fondamento, significato e coerenza nell’insiemedegli eventi biografici.Nella relazione con l’altro si manifesta nel modo più evidente questa impossibilità di far presa sul reale: l’altro viene ridottoa cosa da utilizzare per la propria condizione di eccitazione esistenziale.Ciò comporta sprofondare totalmente nella relazione momentanea cheannulla la prospettiva temporale passato-futuro in modo tale che l’esperienza perde ogni consistenza. Da qui la continua ricerca diesperienze che richiedono un’immediata risoluzione e che cercano disperatamente, spostandosi velocemente in avanti (e non nel futuro), qualcosa che riesca finalmente a rendere l’ego e la sua relazione con l’altro significativa e sostanziale. La relazione difettosa nella costituzione dell’alter-ego non è però sconnessa dai problemi riscontrati nella sfera dell’ego: la connessione tra difetti “temporali” e “relazionali” è da ricercarsi infatti, per Binswanger, “nel difetto della costruzioneintenzionale della costituzione temporale dell’ego”, anche se questo si manifesta secondo diverse modalità.Infatti, nella mania si ha un “allentamento”, oppure, addirittura,una “perdita dei fili intenzionali determinanti la costruzione dell’oggettività temporale” (retentio, protentio, praesentatio) mentre, nella malinconia, si deve parlare invece di un “intreccio” di questi fili.Nell’analisi dell’ultimo caso clinico presentato (“Il caso di Olga Blum”) è interessante notare come la disarticolazione dei momenti della processualità intenzionale temporale si manifestino in modo diretto e trasparente anche nel comportamento logico-linguistico: ci si trova di fronte ad un Dasein ‘saltante’ che si esprime attraverso “singolarità sintattiche e grammaticali, nel parlare inrime, nelle associazioni puramente fonetiche, nella frammentazione89 Mania e melanconia,cit.,p.91
197
delle parole, nella preferenza della paratassi”. In uno stretto legame con queste modalità espressive si manifesta, sul piano della logica, un incessante slittamento di un’idea su un’altra oppure un continuo salto, senza continuità , tra i diversi momentiin cui si articola un discorso. In questa “fuga delle idee” il soggetto, secondo Binswanger, manifesta i suoi disturbi nella costruzione dell’oggettività temporale. Si può allora, in sintesi, dire che nel processo genetico-costitutivo delle modalità esistenziali patologiche della melanconia e della mania l’elemento comune è dato sia dalla alterazione di un mondo in comune (Mit-welt), in cui risulta impossibile co-esistere (Mit-dasein), sia dalla mancanza di un continuum spazio-temporale strutturato e coerente. Ciò comporta che la comprensione fenomenologica della sofferenza mentale avviene essenzialmente sul terreno antepredicativo del mondo-della-vita , anche se è il paradigma culturale delle varie formazioni sociali che definisce i confini della sanità e malattiapsichica. E’ nell’esperienza originaria in cui si dipanano i nessi intenzionali che si producono disturbi e difetti costitutivi.Nell’ultima parte del testo Binswanger affronta il problema della mania e della malinconia in modo complessivo, cercando cioè di superare, attraverso la teoria dell’ego puro di Husserl, l’apparente contrapposizione tra queste due forme patologiche che si manifestano in “stati d’animo” opposti ( euforico e disforico).Con grande efficacia “l’antinomia maniaco-depressiva” viene così qualificata:
“L’antinomia maniaco-depressiva va individuata nell’intera struttura di questa contrapposizione.( Euforico-Disforico) Che qualcuno o qualcosa significhi qui Dio là diavolo, qui bene e là male, qui bianco e là nero, qui gioia e là dolore,è solo l’aspetto più rilevante e vistoso di questa antinomia. Essa in effetti abbraccia spazio e tempo, ritmo, consistenza, colorito, luminosità e movimento dell’esistenza. Se nella forma di esistenza maniacale lo spazio diviene ampio e infinito, in quella malinconica è angusto, ristretto e chiuso; se là gli ‘oggetti’ sono più a portata di mano, qui fuoriescono addirittura dallo ‘spazio’ in un’irraggiungibile lontananza; mentre là il tempo è breve, qui è lungo; là il ritmo dell’esperienza vissuta (Erlebnis) è rapido, qui è lento; se là il mondo è effimero (inconsistente, leggero, soffice), roseo e chiaro, qua è duro, pesante, rigido, nero e oscuro; là mobile, qui immobile, quieto. Mentre nella mania si può parlare di una forma di esistenza saltante e scorrevole, nella melanconia essa è statica, ‘ferma’, ‘senza via d’uscita’, viscosa; là
198
si hanno ‘salti’ biografici, intellettuali, sociali, qui la biografia, i pensieri, i rapporti con il mondo circostante non esistono. (…) se nella mania il malato si abbandona alla pura gioia del Dasein, all’esperienza estetica dell’aproblematica unità di Io e mondo, della bellezza e gioiosità del Dasein, nella melanconia soffoca nella problematica del Dasein; là le esperienze non si rinnovano e non portano frutti, poiché a tutte è concesso lo stesso (rapido) ritmo, qui accade diversamente, poiché si concede solo ad alcune una durata ‘infinita’; da una parte l’autoccultamento e la fuga da sé si manifesta nella precipitosità, dall’altra in un interminabile rimuginare. Tutti questi aspetti, e molti altri ancora, risultano dalla struttura antropologica di queste forme esistenziali e non è assolutamente possibile considerarli in maniera isolata.” 90
A questa descrizione del Dasein maniaco-depressivo, resa possibile,precisa Binswanger, dall’analitica esistenziale di Heidegger, deveseguire la comprensione dei “momenti strutturali costitutivi di tali mondi” in modo tale da superare l’antinomia che sembra contrapporli.E’ nell’ultimo paragrafo del testo infatti che viene compiuto questo tentativo, ancora nel segno di un ritorno a Husserl ed allasua teoria dell’ego trascendentale.Si è visto come i mondi maniaco-depressivi convergano, per quanto riguarda il processo genetico-costitutivo da cui hanno origine, sulle due dimensioni indicate precedentemente: quelle della costruzione delle oggettività temporali e quelle relative all’appresentazione, all’alter-ego ed al mondo in comune.Nella mania c’è un allentamento dei nessi intenzionali retentivi eprotentivi a fronte del qualeavviene un opposto restringimento del nesso presentativo; così il maniaco vive nella “pura attualità” in modo talmente intenso e totale da fagocitare ogni esperienza, il cui valore di conoscenza e di crescita viene sistematicamente annullato.In questo incessante fluire di momenti presenti che non lasciano traccia di sé, la relazione con l’altro non può avere sostanzialità poiché è fondata sull’urgenza esistenziale che precipitosamente consuma ogni tipo di esperienza e di incontro.Il maniaco ha a che fare con tutti e con nessuno, nel senso che ilmondo in comune che condivide con gli altri, al pari della dimensione temporale, non riesce a prendere consistenza.Nella malinconia i disturbi di tipo ‘temporale’ e ‘relazionale’ simanifestano invece secondo modalità diverse. Anche qui si produce un “allentamento” che però ha come conseguenza un “intreccio” dei
90 Ibid., pp.109-110
199
momenti retentivi con quelli protentivi (la ripetizione costante del ‘ se non avessi fatto questo…’) o di momenti protentivi con momenti retentivi (il futuro totalizzato dal passato).Queste alterazioni rendono il presente privo di significato e consistenza esistenziale.La conclusione dell’analisi di Binswanger è dunque: non esiste alcuna antinomia tra le modalità esistenziali della melanconia e della mania poiché sono diversi solo i modi di declinare i difettigenetico-costitutivi dei nessi intenzionali ‘temporali’ e ‘relazionali’presenti in entrambi i casi.Binswanger vuole però approfondire la comprensione di questi modi di esistenza avvalendosi ancora, questa volta “fino alle sue estreme conseguenze”, della fenomenologia di Husserl.E’ la teoria dell’ego puro ad essere presa in considerazione nellaprospettiva di illuminare ancora più originariamente e profondamente , procedendo dunque oltre la comprensione dell’esperienza dell’io empirico, i processi costitutivi delle modalità maniaco-depressive di esistenza.Nel riferimento costante alla lettura di Szilasi del pensiero di Husserl, Binswanger pone nell’ego puro la fonte originaria delle patologie considerate, distinguendo quindi questa dimensione da quella dell’io empirico.
“ Possiamo dunque dire preliminarmente: le distimie derivano dall’ego puro, turbato nella sua costituzione, dal suo “disorientamento”, dal suo stato di disagio e costrizione, che consiste nella mancanza di una piena realizzazione della possibilità dell’esperienza, nella mancanza di attuazione del suo scopo o significato. Poiché le istanze inferiori dell’esperienza non hanno realizzato il loro compito, l’istanza superioreè “disorientata”; essa può solo “disperare” a causa dei disturbi dell’esperienza empirica e trascendentale. Questo momento (negativo) di tutta l’esperienza s’insinua nella distimia, rivolgendosi nella melanconia in angoscia e sofferenza, nella mania nella fuga di fronte al compito del pieno controllo di sé e del mondo.” 91
A questa conclusione si giunge dalla distinzione tra ego puro, io trascendentale ed io empirico e dalla definizione di rapporti di interdipendenza e di subordinazione tra queste dimensioni della soggettività; nel momento in cui si verificano alterazioni o difficoltà in una di esse, dovute ad una pluralità di ragioni, viene compromesso l’equilibrio su cui si regge la loro profonda unità.
91 Ibid.,p.116
200
Così, come nella dinamica di un sistema una modificazione di un suo elemento comporta mutamenti in tutti gli altri, è l’istanza inferiore (io empirico), che non ’svolge’ adeguatamente il suo compito, a rendere l’ego puro “disperato” e disturbato nella costituzione dei nessi trascendentali e delle sue correlazioni intenzionali.92
Quest’ultimo però, nonostante gli ostacoli che si frappongono allasua azione costruttrice, non può non mantenere “ la sua funzione regolatrice nella misura in cui serba tutte le possibilità della pienacostituzione dell’esperienza, anche nella sua sconfitta.”Da una parte quindi l’ego puro si dispera e smania, dall’altra però rimane “ancora desto al di là della disperazione e dello smaniare” (p.117) E’ per questo che Binswanger ritiene possibile la “guarigione” in entrambe le patologie: l’ego puro continua, nonpuò non farlo, a tessere la sua tela intenzionale anche se in questa sua esplicazione incontra ostacoli e difficoltà che, nei tempi brevi, appaiono come insormontabili. I “difetti” nella costituzione ‘temporale’ e ‘relazionale’ non sono quindi eventi che irrimediabilmente determinano modi di esistenza definitivi.La stessa manifestazione dell’esperienza psicotica assume una varietà di forme che occorre però comprendere perché questo “ è pur sempre il problema centrale della psichiatria clinica”. (p.127,Melanconia e Mania)In poche pagine, che troveranno una più ampia articolazione nel suo ultimo testo (Delirio, 1965) attraverso la riconsiderazione del caso Suzanne Urban indagato precedentemente entro la prospettiva della Daseinsanalyse heideggeriana, Binswanger, a partire dalle acquisizioni date, cerca di costituire un nuovo spazio teorico in cui possano aprirsi possibilità di una più efficace integrazione tra la dimensione clinica e quella fenomenologica nella comprensione della sofferenza mentale.
92 Come nota Carlo Gentili nella presentazione di Mania e Melanconia risulta alquanto problematico questo tipo di utilizzazione della teoria dell’ego puro poiché esso è per Husserl “ una riduzione metodologica non una riduzione reale: ego puro, ego trascendentale, ego empirico sono aspetti di una gerarchia metodologica, non di una gerarchia reale” Tali fraintendimenti, che non mettono però assolutamente in discussione “ la chiarezza speculativa e la validità “ del tentativo di Binswanger di liberare lapsichiatria dalla suo originario naturalismo , possono prodursi anche in relazione al fatto che l’opera di Husserl ancora oggi, a distanza, di quasi mezzo secolo dal testo di Binswanger, è largamente inedita e ciò che è invece conosciuto ha bisogno, per la sua straordinaria ricchezza e complessità, di un lungo e impegnativo lavoro di elaborazione , organizzazione ed interpretazione.
201
Dopo aver assunto la fenomenologia husserliana “fino alle sue estreme conseguenze” per quanto riguarda l’indagine sui modi maniacali-depressivi dell’esistenza occorre ora assolvere fino in fondo il compito di trovare i nessi che collegano, al di là delle loro diversità, anche profonde, le diverse forme in cui si manifesta l’esperienza psicotica.Va, in altri termini, riconsiderato, alla luce della fenomenologiatrascendentale, il problema delle relazioni tra mania, melanconia e schizofrenia in una prospettiva che unitariamente sappia cogliere i loro comuni elementi di fondo. Posto che, come risultava dagli studi precedenti, la schizofrenia (o, come precisa Kurt Schneider, “ciò che si chiama abitualmente schizofrenia”) è una condizione esistenziale in cui si perde la naturalità, l’aproblematicità e la continuità dell’esperienza (il “sostare indisturbato” presso le cose), Binswanger procede mostrando come sia i modi maniaco-depressivi di esistenza sia quelli schizofrenici, siano vissuti costruiti, problematici e discontinui. Nella mania, nella schizofrenia e nella melanconia si manifestanomodalità esistenziali disturbate, anche se, nel primo caso, essa deriva da un’eccessiva aproblematicità ( l’incessante e vuota esperienza relazionale ) e, negli altri, dalla eccessiva problematicità della relazione con se stessi e con l’altro che interrompe il corso vitale dell’esperienza ( la fissazione su una situazione o problema specifico, l’autoaccusa, gli ideali esaltati, ecc)In linea generale, Binswanger avanza perciò l’ipotesi che
“ se la psicosi maniaco-depressiva e la schizofrenia ‘si combinano l’unacon l’altra’ ( il che accade più facilmente e più spesso di quanto non vogliamo ammettere ) la ragione consiste in questo: che entrambe le 'psicosi’ poggiano su piani diversi, più precisamente si fondano su un diverso abito del Dasein, la schizofrenia nell’ambito dell’interruzione della continuità dell’esperienze oggettuale e, con ciò, della storicità, la psicosi maniaco-depressiva invece nell’ambito della deiezione”.93
In termini che possono essere riferiti alla teoria dell’ego trascendentale di Husserl, si può allora dire che nella schizofrenia essomantiene la sua ‘funzione’ regolando la totalità dell’esperienza – pur nella distorsione patologica - mentre nella mania e nella melanconia si manifestano processi di disgregazione di questa totalità imputabili ad una forma generale di deiezione del Dasein.
93 Melanconia e Mania, cit., pp.129-130.
202
Infatti, aggiunge Binswanger, ogni individuo ha la sua propria schizofrenia mentre nel caso della mania e della melanconia si evidenziano forme generali psicopatologiche.Al di là comunque della formulazioni di queste e di altre ipotesi di ricerca, “il problema della diversità tra psicosi maniaco depressiva e schizofrenia, dei loro eventuali rapporti reciproci, è pur sempre il problema centrale della psichiatria clinica.” 94 p.130)
La psicoanalisi, oltre che come cornice teorica fondamentale di riferimento, può utilmente e ulteriormente contribuire a definire questo terreno di ricerca? Come possono definirsi prospettive di integrazione tra il trascendentalismo di Husserl ed il naturalismodi Freud nella comprensione del Dasein maniaco-depressivo e schizofrenico? E’ noto come le manifestazioni psicotiche hanno messo tradizionalmente in difficoltà l‘universo concettuale psicoanalitico che appare teoreticamente sguarnito nei loro confronti.E’ invece proprio nell’ambito della dimensione psicotica della fenomenologia del delirio che invece emergono interessanti motivi di convergenza con l’approccio fenomenologico.
Delirio
Binswanger, dopo cinque anni dalla pubblicazione di Mania e Melanconia ( 1960 ), all’età di 84 anni, prosegue nella sua ricerca rivolta a costruire un orizzonte di senso alla sofferenza psicotica.Wahn ( Delirio ) è l’ultimo momento ( Binswanger muore l’anno successivoalla stesura di questo testo, nel 1966 ) del progetto rivolto allafondazione della psichiatria sul piano propriamente antropologico per sottrarla alla sua originaria appartenenza all’ambito delle scienze naturali. Abbiamo visto come i momenti strutturali di questopercorso sono costituiti dalla iniziale formazione psichiatrico-psicoanalitica, dalla successiva immediata apertura alla fenomenologia descrittiva di Husserl 95, che lo conduce poi ad
94 Ibid.,p.130.95 In questa prima fase della sua opera, attraverso alcune scritti, la cui cornice teorica di riferimento è costituita dalle Ricerche logiche di Husserl, Binswanger ribadisce l’esigenza assoluta di ritornare alla intuizione come metodo conoscitivo e di mettere tra parentesi ogni teoria (come “sistema” di ipotesi); e riconosce alla fenomenologia descrittiva (o eidetica) il compito, e
203
assumere come terreno di riflessione e di elaborazione antropologica l’ontologia di Sein und Zeit, e da un deciso ritorno finale verso la fenomenologia trascendentale di Husserl.La natura dell’interesse dello psichiatra Binswanger verso la fenomenologia ha un duplice fondamento; uno, più diretto, metodologico-epistemologico, l’altro, indiretto, ma non meno importante, terapeutico.In primo luogo la fenomenologia trascendentale di Husserl apre orizzonti di comprensibilità delle profonde ragioni di “senso” contenute nelle manifestazioni psicotiche, poiché, illuminando i processi costitutivo-genetici della soggettività e dell’intersoggettività, consente di coglierne gli aspetti ‘disturbati’.Ciò non significa però che Binswanger abbandona il terreno clinico; questo rimane il fondamento reale di ogni approccio alle psicopatologie, poiché egli è determinato a praticarlo nel modo più effettuale e concreto proprio attraverso il netto superamento della “ forma mentis di ogni psicopatologia clinica ”cioè la distinzione tra “soggetto” ed “oggetto”, “io” e “mondo”.La fenomenologia genetica di Husserl gli offre proprio la possibilitàdi pensare la malattia mentale fuori da questa forma mentis senza però ricadere in una prospettiva opposta e complementare all’organicismo della psichiatria positivistica. La psicopatologiaclinica è cioè da praticare all’interno della più ampia e fondantecornice filosofica che, a sua volta, non è però assolutamente da intendere in termini di universo concettuale predefinito da cui strumentalmente procedere, applicando le sue categorie sul terreno dei vissuti psichici disturbati.Ciò che infatti qualifica essenzialmente l’ideale conoscitivo della fenomenologia husserliana è l’assenza di un apparato categoriale precostituito, organizzato in un sistema concettuale stabile, da cui derivare ipotesi da verificare poi sperimentalmente: il “ritorno alle cose stesse” non può quindi avvenire sulla base della formulazione di una ‘filosofia’ intesa come Weltanschauung o di una teoria consolidata prima di ogni approccio diretto alla evidenza immediata dei vissuti.Uscire fuori dalla forma mentis che scinde il nesso intenzionale della coscienza per indagare ‘oggettivamente’ e separatamente l’ioda una parte ed il mondo dall’altra equivale a disporsi in una il significato, di indurci ad osservare semplicemente i fenomeni ed insegnarci aconsiderare valide solo le cose che vediamo realmente mediante l’intuizione, o la visione delle essenze: evitando drasticamente che, a ciò che si “vede”, si abbia a sovrapporre una qualsiasi “teoria”. ( Eugenio Borgna, Introduzione a L. Binswanger, Delirio, Marsilio, 1990, Venezia, p.XII).
204
prospettiva conoscitiva radicalmente nuova, il cui carattere rivoluzionario, come abbiamo visto nella Krisis, viene esplicitamentee con forza rivendicato da Husserl.Questa condizione di ‘teoria senza teoria’ è dunque ciò a cui aspira anche lo psichiatra Binswanger, alle prese con la sfida conoscitiva posta in essere dall’assurdità, dalla casualità e dall’incomprensibilità delle manifestazioni deliranti e psicotiche.Nel suo percorso vanno però distinti i diversi momenti in cui si dispiega l’interesse verso la filosofia. Essi infatti corrispondono ad altrettanti modi di comprensione dell’esperienza psicotica: da una prima fase orientata alla loro conoscenza statica,che comprende anche il lungo ‘intermezzo’ ermeneutico-ontologico fondato sull’analitica esistenziale di Heidegger, all’ultima fase,in cui si pone l’esigenza di un approccio diverso centrato sul momento costitutivo-genetico dei disturbi psicotici.Come e perché è avvenuta la costituzione del modo psicotico di esistenza? Binswanger articola la ricerca di possibili risposte a questo interrogativo su più piani ( fenomenologico, psicopatologico, clinico ) e con diverse modalità (illustrazione ed analisi di casi clinici, considerazioniteoriche, valutazione e comprensione dell’intreccio tra psicosi e creatività nell’opera di un grande scrittore e drammaturgo, AugustStrindberg ) nella consapevolezza però che le abissali profondità dei vissuti psicotici potranno essere sondate, nel migliore dei casi, solo in parte e non esaustivamente , qualsiasi prospettiva teorico-metodologica venga assunta. Riconosciuto il limite conoscitivo di ogni approccio alla complessità pluridimensionale della sofferenza psichica occorre però far emergere l’orizzonte di senso entro cui essa si manifesta, rendendo così possibile il suo ascolto come specifica modalità di esistenza che trova origine in una rete dei rapporti interumani.Dall’analisi dei casi clinici presentati ( compreso quello di Strindberg, in cui la deriva psicotica si intreccia con la creatività artistica ) emergono due dimensioni strutturali che, invarie forme e modalità, tendono a ripresentarsi: quella relativa ai difetti nella costituzione trascendentale dell’ego e dell’alterego e quella che riguarda i processi di frammentazione e scollamento della continuità temporale.Così come già aveva fatto in Mania e melanconia Binswanger cerca di comprendere la sofferenza psicotica indagandole modalità
205
costitutivo-genetiche della soggettività\intersoggettività e la temporalità in cui essa si esprime e si fonda, arrivando alla conclusione che in entrambi i processi si sono date profonde alterazioni, poi progressivamente emerse nei vissuti quotidiani.Nella prospettiva della compresione ( Verstehen ) fatta propria da Binswanger emerge la verità e la pura evidenza di brani di esistenza; solo allo sguardo fenomenologico si manifestano “le leggi” che presiedono alla fondazione-costruzione del sistema costitutivo della connessione intenzionale io-mondo. Assumendo invece il procedimento della spiegazione (Erklären) è possibile solo cogliere, dall’esterno, nessi causali relativi a forze quantitativamente determinabili secondo leggi e principi pre-costituiti. Naturalmente per Binswanger è quest’ultima prospettivache va decisamente superata per dare ‘senso’ all’esperienza psicotica, al di là del fatto della sua comprensibilità\incomprensibilità.Nell’orizzonte filosofico husserliano, in cui è possibile mettere tra parentesi pregiudizi e paradigmi scientifici, è possibile accedere direttamente alla coscienza pura che trascendentalmente si definisce, nel nesso intenzionale, nell’oggetto fuori di sé.Ma, a questo punto, ci si può interrogare sul ruolo che la psicoanalisi svolge nella costruzione della prospettiva fenomenologica in psichiatria.Contrariamente a Mania e melanconia, in cui abbiamo rilevato l’intreccio anche diretto di categorie psicoanalitiche e fenomenologiche, Delirio non presenta riferimenti espliciti a Freud se non in qualche passaggio del testo ed in modo non particolarmente significativo.Ciò significa che l’orizzonte fenomenologico-trascendentale ha inglobato interamente il tentativo di Binswanger di ‘umanizzare’ la psichiatria?L’universo concettuale psicoanalitico è stato messo fuori causa dalla prospettiva fenomenologica?Per rispondere a questi interrogativi facciamo nuovamente riferimento alle categorie fondamentali della psicoanalisi individuate nel primo capitolo, cioè Inconscio, Desiderio e Fantasma.Sulla base di una valutazione complessiva e strutturale dell’approccio di Binswanger al delirio ed alle altre manifestazioni psicotiche- compresa quindi la stessa modalità maniaco-depressiva di esistenza- si può dire che queste strutture epistemiche della psicoanalisi, pur non essendo direttamente chiamate in causa, costituiscono una specie di basso continuo su cui lo psichiatra svizzero orchestra il suo tema
206
fenomenologico. Naturalmente la prospettiva psicoanalitica in cui Binswanger opera strutturali e decisivi innesti fenomenologici nonè quella fondata su premesse dualistiche e naturalistiche poiché, anche quando, come ora si vedrà, vengono fatte proprie alcune concezioni specifiche di Freud sulle manifestazioni psicopatologiche in generale e sul delirio in particolare, è evidente che è mutato notevolmente il terreno di indagine su cui procede lo psichiatra svizzero.Quali sono, quali possono essere, allora i modi attraverso cui si configura la relazione psicoanalisi-fenomenologia? In base alle precedenti valutazioni sul rifiuto da parte di Binswanger di elaborare sistemi teorici e metodiche terapeutiche in se concluse e funzionalmente applicabili in termini di diagnosi e di psicoterapia, facciamo ora riferimento ad un caso clinico ( Il caso Aline ), cercando di cogliere, nei limiti, ovviamente, di un suo breve resoconto, la specificità antropoanalitica che qualifica l’incontro con una presenza sofferente. Aline, donna francese di 41 anni, sposata con un alto funzionario tedesco a Samoa, in seguito alle vicende belliche della I Guerra mondiale, viene internata insieme al marito in un campo di prigionia ad Aukland,dove si manifesta la sua prima attività delirante.In seguito Aline ritorna in Francia dove viene ricoverata in una casa di cura. Oltre l’esperienza traumatica del campo di prigionianon emergono nella sua vita altre vicissitudini particolarmente critiche, anche se il ritorno in Francia viene definito “come una vera e propria odissea”. Aline soffre di incessanti idee di persecuzione e di annullamento di se stessa da parte di ‘altri’ (sia persone reali del suo ambiente di vita sia potenti entità nonidentificabili ) per congiurano per nuocerle attraverso un congegno elettrico che lei ha nella nuca. Con dei raggi pensanti eparlanti gli ‘altri’ riescono a dominarla totalmente; lei è consapevole di questo e ritiene che potrà guarire solo quando riuscirà a farsi asportare chirurgicamente il congegno elettrico nella nuca.Aline accusa gli ‘altri’ di operare macchinazioni diaboliche attraverso correnti elettriche, fluidi e magnetismi che invadono ogni suo pensiero e sentimento, facendola vivere in una permanentecondizione di sofferenza ( “Vivere sempre così, preferisco morire” dichiara ai suoi medici )La formazione delirante si manifesta come meccanica d’esistenza: gli ‘altri’ possono, attraverso congegni fisici, fare di lei quello
207
che vogliono. Aline paragona il suo cervello ad una “macchina fotografica” che registra le volontà altrui.Questo quadro psicopatologico- qui riassunto nei suoi termini essenziali- viene affrontato da Binswanger attraverso la prospettiva fenomenologica che converge ancora sul concetto di costituzione ( della temporalità, dell’ego e del mondo in comune ), ora però declinato in modi inediti attraverso la sua integrazione con categorie e modalità di approccio che caratterizzano la psicoanalisi in generale e l’analisi freudiana del delirio in particolare.Il primo problema che viene affrontato è la natura delle fantasie della paziente; secondo Binswanger, che rifiuta il modello psichiatrico tradizionale comprendente, in questo caso, anche le concezioni di Jaspers, tale iperattività fantastica non va intesa in termini di una proliferazione quantitativamente superiore di immagini rispetto alla normale produzione dei ‘sani’, poiché qui occorre comprendere come e perché”l’unità sintetica dell’intuizione delirante non segue le stesse regole dell’intuizione normale” 96
Si tratta cioè di capire come la percezione e l’intuizione del delirante non sia qualcosa di essenzialmente diverso dalle forme non patologiche di rappresentazione del mondo, ma solo deviazioni consistenti in “mutamenti di significato” dell’attività intuitivo-percettiva.Ricorrendo ai concetti di àisthesis, mnème e fantasia, riassumibili perBinswanger in quello di phàntasma, il mondo delirante di Aline viene compreso come espressione di un’esperienza esistenziale “vuota ed apparente”.( p. 59 )Nei processi genetico-costitutivi normali il momento dell’àisthesis, cioè della percezione sensibile, quello della mnème, cioè della stratificazione dei ricordi e quello della fantasia ovvero della produzione spontanea di immagini, come momenti interrelati della realtà di fatto ed esistenziale del soggetto, si qualificano in modo dinamico e diversificato, mentre dall’analisi fenomenologica emerge che in Aline si sono come ‘meccanizzati’ ripetendosi in modo monotono e statico. La sua sofferenza non può essere così ricondotta solo all’esperienza traumatica del campo di prigionia, ma deve essere compresa all’interno della complessiva dimensione esistenziale della paziente in cui si sono dati vissuti segnati dalla meccanicità, dalla vuotezza, dalla rigidità di un manchevolerapporto originario io-mondo.
96 Delirio, cit., p.58.
208
Ciò di cui soffre Aline è la mancanza di una spontanea, fertile e immaginativa relazione tra àisthesis, mnème e fantasia che impoverisceil phàntasma fino a renderlo “uno schema indifferente” e sottrae trascendenza ai suoi vissuti appiattendoli progressivamente su un’immanenza rigida e svuotata di senso.Binswanger definisce il concetto di phàntasma senza fare riferimentoa Freud ma citando Aristotele, Kant, Locke e Heidegger, per poi porre il problema della genesi del delirio sul terreno della categoria husserliana di costituzione. Ma, anche se non vi è un alcun coinvolgimento diretto della psicoanalisi nella elaborazione di questo concetto, è possibile agevolmente constatare come la nozione freudiana di fantasma ( phantasie) può essere utilmente impiegata anche come possibile modalità di approccio alla comprensione delle manifestazioni deliranti. Come si è visto precedentemente, il concetto di fantasma, accanto a quelli di desiderio ed inconscio, assume nella psicoanalisi un valore fondante. Freud lo declina su vari piani: conscio, subliminale, inconscio (individuale e collettivo) enucleando, in varie parti della sua opera, aspetti e significati molteplici che però rimandano ad una sua unità profonda. L’attività fantasmatica, infatti, strutturando e modellando l’intera soggettività in quanto punto di passaggio e di connessione tra i vari regimi e sistemi della vita psichica, può essere valutata da una molteplicità di prospettive. Il fantasma è per Freud strettamente connesso al desiderio, in quanto sua messa in scena, sia su un piano individuale che collettivo, non essendo pensabile solo come scenario immaginario in cui vengono rappresentati i desideri inconsci del soggetto poiché è anche concepibile come schema inconscio che va al di là del vissuto individuale ( fantasmi originari ).Nel concetto freudiano di fantasma è quindi presente una dimensione trascendentale che è compresa nella sua relazione costitutiva e dinamica con l’inconscio e il desiderio. Nell’attività fantasmatica s’intrecciano, infatti, ricordi (mnème) dipercezioni (àisthesis) piacevoli che s’immaginano (fantasia) come appagati attraverso processi dinamici che cercano di pervenire ad un’espressione cosciente; nel caso di Aline c’è uno scompaginamento dell’unità di questi momenti che sono spogliati della loro polivocità semantica per la vita psichica e ridotti a meccanismi che ossessivamente si ripetono in modo rigido e non organicamente interrelato.Mancando la fluidità nella dinamica tra l’attività spontanea dell’immaginazione, la fertilità del desiderio e l’energia
209
creativa dell’inconscio, è stato disturbato un momento costitutivo della soggettività: Aline è una cassa di risonanza che gira a vuoto ri-producendo schemi esperenziali privi di contenuti lavorati dalle profondità psichiche. Lo scollamento tra l’attivitàfantasmatica, il desiderio e l’inconscio la rende estranea a se stessa. ( Sono a malapena ancora me stessa, ma anche gli altri. Appartengo in parte a tutto il mondo.(…) Il mio cranio (col cervello) non mi appartiene, come se esso appartenesse a tutto il mondo. Altri mi hanno inviato i miei stessi pensieri nel cervello.(…) Pensieri propri (a me propri) non ne ho. Per il resto mi occupo del mio caso, come se fosse quello di un altro (come se io fossi un’altra.)La disarticolazione dei nessi tra àisthesis, mnème e fantasia è allora interpretabile anche dalla prospettiva psicoanalitica la quale, alpari della fenomenologia, la comprende come mancanza di trascendentalità. Nell’uso del concetto di phàntasma da parte di Binswanger c’è così una chiara eco di quello freudiano, il cui valore fondante dell’universo teorico psicoanalitico è dato proprio dalla sua capacità di cogliere le strutture soggiacenti dei processi genetico-costitutivi della soggettività e dell’intersoggettività. L’analisi fenomenologico-antropologica, cioè la Daseinsanalyse,97 è un metodo che, superando il riduzionismo e il pre-giudizio naturalistico, apre prospettive di comprensione del senso della condizione umana attraverso la costruzione di un insieme di strutture di significato che però, nello stesso tempo, coesistono con l’ineffabilità e la problematicità della presenza. L’antropoanalisi è dunque donazione di senso a ciò che ne appare privo e, nello stesso tempo, apertura a più sensi della presenza, kantianamente pensabili ma non conoscibili, la cui eccedenza rendevano ogni tentativo compiuto per teorizzazioni definitive. Il suo valore non consiste allora solo nell’afferrare e nello scoprire significati in comportamenti altrimenti posti nella dimensione delcasuale e dell’incomprensibile, ma anche e soprattutto nel mostrare che tra ciò che riceve senso e ciò che non ne riceve si estendono universi vasti e profondi, una eccedenza dileguante che chiede di non essere imprigionata dentro categorie e apparati clinico-noosografici, funzionalmente operanti come strumenti diagnostici e di controllo sociale delle istituzioni psichiatriche. La psicoanalisi, come teoria che mostra la complessità della vita psichica, è per Binswanger indispensabile per attraversare i confini tra il conoscibile e l’inconoscibile della presenza, nonostante il suo originario naturalismo e biologismo.
97 Che D.Cargnello in Alterità e alienità, Milano, Feltrinelli,1972 traduce con “analisi della presenza”.
210
Come si è visto in queste schematiche osservazioni sul caso Aline,la psicoanalisi può contribuire, per la sua capacità di definire un terreno di ricerca sostanzialmente contiguo a quello fenomenologico, a questo scopo, rendendo le manifestazioni psicotiche, da una parte, accessibili alla comprensione, (contribuendo, nello stesso tempo, ad aprire ulteriori e nuovi spazi nella ricerca psicoterapica) e, dall’altra, ad accettare l’eccedenza della soggettività nel suo risolversi nel deuten, nel suo aprirsi all’ermeneutica dei vissuti.
Delirio, desiderio, temporalità
Nell’approccio fenomenologico di Binwanger al delirio e, in generale, alle diverse psicopatologie si evidenzia, infatti, una più strutturale convergenza con la psicoanalisi su un aspetto fondamentale del processo di costituzione della soggettività: quello della temporalizzazione.E’ questo, infatti, il tema che inevitabilmente gli stessi maestri di Binswanger, da prospettive antitetiche, avevano incontrato nel loro tentativo di costruzione ontologica della soggettività.L’acquisizione della soggettività\intersoggettività per Freud risulta infatti da un processo dinamico che, sviluppandosi in fasi che richiedono risoluzioni progressive, si caratterizza come incessante lavoro di elaborazione\organizzazione - e, come vedremo, di costante riscrittura - dei vissuti passati (anche attraverso il loro ‘occultamento’ attraverso la rimozione), di confronto con le esigenze del presente e di investimenti nel futuro.Nella fenomenologia il tempo è, kantianamente, non solo la forma universale di ogni genesi egologica ma anche la “legalità formale d’una genesi universale, in conformità alla quale si costituisconoassieme, ogni volta di nuovo (immer wieder), passato presente e
211
futuro in una certa struttura formale noetico-noematica di modi fluenti di datità”.98
Anche se nella psicoanalisi non c’è una tematizzazione specifica esistematica della questione soggettività-tempo – o, perlomeno, nonc’è così come avviene nella fenomenologia, ma in altri modi - è comunque evidente che i vissuti temporali vengono indagati come una attività psichica immanente, nettamente distinta da quella deltempo oggettivo. Nel periodo di intensa elaborazione che precede la stesura dell’Interpretazione dei sogni, di cui è testimonianza preziosa la corrispondenza con Fliess, Freud assume una prospettiva entro la quale, ai fini del tentativo di afferrare le strutture ontologichedella vita psichica, inevitabilmente si trova di fronte ai problemi relativi alla rilevazione e descrizione del processo attraverso cui il soggetto fenomenologicamente vive e si costituisce nella forma “tempo”.In una delle lettere indirizzate all’amico berlinese Fliess così Freud cerca di definire nuovi campi di ricerca genealogica sulla formazione del “meccanismo psichico” 99 dell’uomo:
“ Come sai, sto lavorando all’ipotesi che il nostro meccanismo psichico si sia formato mediante un processo di stratificazione: il materiale di tracce mestiche esistente è di tanto in tanto sottoposto ad una risistemazione in base a nuove relazioni , a una sorta di riscrittura. La novitàessenziale della mia teoria sta dunque nella tesi che la memoria non sia presente in una forma univoca, ma molteplice, e venga fissata in diversi tipi di segni. Una risistemazione di questo genere l’avevo già supposta a suo tempo (afasia) per le vie provenienti dalla periferia.”100
98 Meditazioni cartesiane, cit.,p.100.
99 In questa fase del suo pensiero Freud sta procedendo nel suo tentativo di costruire una “nuova psicologia” ancora dentro il paradigma neurologico-quantitativo del Progetto, anche se è già operante pienamente un dinamismo teoricoche lo condurrà fuori da tale ordine e confine epistemico.
100 S.Freud, Lettere a Wilhelm Fliess (1887-1904), Paolo Boringhieri,1986, p.236. Questalettera viene citata, con una traduzione diversa, da Remo Bodei in Le logiche del delirio, Laterza 2000, dove viene sviluppata, a partire dall’eredità freudiana, un’analisi delle “ragioni” del delirio rivolta ad esplorare quella dimensione dell’ “irrazionale” (fantasie, passioni, credenze, deliri) costitutiva dell’esperienza umana, la cui profondità e complessità rende improponibile ogni tentativo di comprenderla sulla base del modello offerto dalle scienze matematiche e fisiche.
212
Freud continua l’esposizione della sua teoria attraverso uno schema sulla sequenza delle trascrizioni del materiale mestico da cui risulta che “coscienza e memoria si escludono a vicenda”.Anche Husserl, negli stessi anni,101 sta affrontando la stessa questione ritenuta “un’antichissima croce della psicologia descrittiva e della teoria della conoscenza” 102, secondo modalità epremesse radicalmente diverse ma rivolte, come in Freud, a comprendere il costituirsi nella coscienza soggettiva, del tempo, la cui dimensione obiettiva viene subito “messa fuori causa” dall’analisi fenomenologica.Se Freud subito pensa la memoria in relazione ai processi inconscied afferma che la risoluzione di questo problema costituisce il passaggio fondamentale verso la costruzione di una “nuova psicologia”, Husserl, dal canto suo, pur operando sul piano dell’analisi del rapporto tra memoria e coscienza, elabora il concetto di “sprofondamento” che cerca di rendere conto della dimensione stratificata della vita psichica. Anche se qui non è certamente possibile ricostruire il complesso ed articolato tentativo husserliano di aprire nuovi orizzonti teorici sul problema cardine del tempo, va ricordato come il progetto fenomenologico è mosso dall’esigenza di elaborare una psicologia descrittiva dei processi genetico-costitutivi della soggettività, a partire proprio da quella, decisiva, della temporalità.Negli ultimi anni del secolo, da prospettive antitetiche, Freud ed Husserl, appoggiandosi e, nello stesso tempo, rivoluzionando, tradizioni di pensiero in parte diverse e in parte simili (come, ad esempio, il dualismo cartesiano) stanno lavorando allo stesso compito, cioè l’elaborazione di un’ontologia della soggettività che pone subito il problema decisivo, quello della sua costituzione nella dimensione temporale.103
Nei casi clinici presentati da Binswanger emerge, in modo più o meno diretto, questa originaria polivalenza di prospettive sulla questione tempo che costituisce il terreno specifico su cui viene 101 Vedi l’Introduzione a Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, Milano,Franco Angeli 1998 di Rudolf Boehm.102 Ibid., p.43103 Nelle “Note di diario”- pubblicate da Walter Biemel, in “Philosophy and Phenomenological Research”, XVI (1956) p.298-299 Husserl ci informa che, fin dal1894, si era adoperato ad una serie di ricerche confluite poi in “un’opera assaiampia su percezione, fantasia, tempo” non pubblicata ma come tale ma che costituì un terreno estremamente fertile per costruire l’intero progetto fenomenologico. Oltre quindi la questione fondamentale del tempo va sottolineatala concordanza tematica – percezione e fantasia – con i primi tentativi freudiani di definire il nuovo spazio teorico della psicoanalisi.
213
fondato il suo tentativo di comprendere sia le patologie psichichesia i vissuti ‘normali’ del soggetto.Si è visto come, nel caso di Aline, si era manifestato un profondosquilibrio nei momenti costitutivi la cui fluidità naturale ed abituale era come stata congelata e poi frammentata in blocchi rigidi destinati ad una statica e monotona ripetizione senza vitalità.Ora, riprendendo il caso di Suzanne Urban, già trattato da diversianni ed esposto in un testo precedente 104, Binswanger afferma che: “Le distorsioni dei momenti costitutivi àisthesis, mnème e fantasia, appartenenti ad una costituzione assolutamente unitaria, si rendono visibili innanzi tutto nelle anomalie temporali. Sotto questo aspetto troviamo un’alterazione dell’unità del presente con ciò che immaginativamente ci si aspetta e con la ritenzione mnemetica.”Nelle manifestazioni deliranti di Suzanne Urban il presente è sconnesso dal passato e dal futuro, è un presente isolato il “cui ora manca completamente della tensione tra passato e futuro”.105
Nel ricordo di ciò che è accaduto vi è come una rappresentazione che non si radica in una temporalità profondamente vissuta e che ossessivamente mette in scena un unico soggetto.Qui Binswanger, a partire dalle categorie heideggeriane, poi coniugate con quelle husserliane di presentazione, protenzione e ritenzione, sta indagando una specifica forma di delirio (di denigrazione) ma, anche se con diverse modalità, coglie questo scompaginamento del flusso temporale, in ogni forma di manifestazione delirante.La sofferenza mentale si manifesta così come impossibilità a vivere il flusso temporale in modo aperto, diversificato, attraverso nessi intenzionali molteplici e liberi. La conseguenza di questa impossibilità è la precipitazione del soggetto in una dimensione in cui il tempo diviene una potenza negativa che tirannicamente domina come passato opprimente, presente vuoto e assenza di futuro.C’è una caduta (verfallen) del soggetto, come dice Heidegger in Essere e Tempo, che perde la sua originaria apertura all’essere, cioè, propriamente, il suo Dasein temporale. Essendo l’io impensabile senza mondo, ed essendo entrambi immersi in quello che Husserl definisce l’orizzonte fluente-costante, l’origine della sofferenza mentaleva cercata nei difetti costitutivi di questa relazione inscindibile che si esprime come temporalità. La stessa prospettiva è presente anche nell’opera di Minkowski che pensa
104 L. Binswanger, Il caso Suzanne Urban, Storia di una schizofrenia, Saggi Marsilio, 1994.105 Delirio, cit. p. 85
214
la soggettività come ciò che diviene, non come ciò che è; in una delle sue opere più importanti e significative, cioè il Tempo vissuto, lo psichiatra russo ricorre anche ad accenti poetici per tentare di definire ciò che poi riconoscerà, all’interno della ratiometafisica occidentale, come indefinibile, cioè il tempo. Esso è “una potenza misteriosa (…) che ricopre con i suoi flutti tutto ciò che potremmo essere tentati di opporgli; non conosce né soggetti, né oggetti, non ha parti distinte, né direzione, né inizio, né fine. Non è reversibile né irreversibile. E’ universaleed impersonale. Risulta caotico. E purtuttavia risulta vicinissimoa noi, così vicino che costituisce la base stessa della nostra vita.(…) Noi ci confondiamo con le onde possenti, impersonali, direi anonime del divenire, senza difficoltà, senza la minima resistenza, addirittura con un senso di benessere e di quiete”.106
Il soggetto è dunque un soggetto-tempo che per autorappresentarsi a se stesso è chiamato ad una incessante lavoro rivolto a creare eri-creare sensi e significati dei suoi vissuti passati. In una specie di doppio movimento che, da una parte, si protende e si progetta nel futuro e, dall’altra, mobilizza gli eventi passati trasformandone il valore e i significati in relazione alle modalità di soggettivazione nel presente, l’essere-nel-mondo è in realtà un essere-nel-mondo-tempo.Anche nella psicoanalisi la soggettività è sempre pensata come soggettività-tempo: essa è essenzialmente processualità di fasi e stadi, i cui blocchi e resistenze, in quanto interruzioni di una successione e di un flusso di erlebnisse, si qualificano come suoi momenti difettivi. Operate le necessarie distinzioni con l’approccio fenomenologico etornando alla lettera citata prima, Freud abbozza un’ipotesi sui processi genetico-costitutivi della temporalità e sulla natura non univoca della memoria che si “fissa in diversi tipi di segni”,cioè, nel linguaggio della fenomenologia, si potrebbe dire ‘nella molteplicità dei nessi intenzionali’.I contenuti della memoria sono costantemente aperti alla possibilità di una loro “risistemazione” in relazione alle situazioni esistenziali che, nella vita di qualsiasi persona, possono essere considerate come epoche, cioè complessi di vissuti tra loro connessi e caratterizzati da specifiche modalità esperenziali ; nel passaggio da un’epoca all’altra, l’individuo deve procedere ad una nuova interpretazione-organizzazione dei dati della memoria in modo tale da conferire ad essi significati utili per il presente e, soprattutto, in prospettiva, per aprirsi 106 Il tempo vissuto,cit.,p.9
215
a nuove epoche della vita. Il soggetto vive cioè in un processo continuo che crea e ricrea costantemente se stesso nella ineludibile esigenza di ri-comprendere i suoi passati brani di esistenza. Nella lettera Freud aggiunge che
“le successive trascrizioni rappresentano la realizzazione psichica di successive epoche della vita. La traduzione del materiale psichico deve avvenire al confine tra due di tali epoche. Mi spiego le caratteristiche specifiche delle psiconevrosi supponendo che questa traduzione di una parte del materiale non sia avvenuta, il che implicherebbe determinate conseguenze”
.Naturalmente, ancora in parte dentro il paradigma positivistico, Freud pensa queste “determinate conseguenze” della mancanza delle trascrizioni in termini di perturbamento dell’“equilibrio quantitativo”.“Ci troviamo così di fronte ad un anacronismo: in una particolare provincia vigono ancora i fueros 107; siamo cioè in presenza di sopravvivenze del passato.” Ogni epoca richiede trascrizioni che sostituiscono ed inibiscono le precedenti, se ciò non avviene o avviene solo in parte, “l’eccitamento si verificherà secondo le leggi psicologiche valideper il precedente periodo psichico, e lungo le vie allora disponibili”.Perché allora le trascrizioni, anzi la trascrizione (“la difesa patologica insorge solo contro una traccia mestica non ritrascritta”) non avviene?Freud avanza l’ipotesi della “liberazione della sofferenza che risulterebbe da una traduzione”, cioè è come se il soggetto tentasse di evitare un lavoro psichico che può apparire eccessivamente pesante. Meglio quindi tentare di “rimuovere” il ricordo che comporta tale fatica ma “ il successo della rimozione attuata dalla difesa non può dipendere dalla misura in cui viene prodotta della sofferenza”.Infatti, prosegue Freud nella sua comunicazione scientifico-epistolare all’amico berlinese Fliess, “noi spesso lottiamo inutilmente proprio contro ricordi estremamente sgradevoli”. In determinate condizioni psichiche in cui, per un processo di reiterazione del ricordo di un evento particolarmente grave o sgradevole, non è possibile procedere né ad una sua ritrascrizione
107 Un fuero era un’antica legge spagnola, considerata valida in particolari province, la quale ne garantiva i privilegi.
216
né alla sua rimozione, esso “ si comporta come qualcosa di attuale”.Sulla stessa strada che Freud cerca di definire in questa lettera si muove anche Binswanger che cerca di elaborare una genealogia del disagio psichico - nello specifico le varie forme del delirio -che sappia rendere conto dei difetti dei momenti costitutivi dellasoggettività, convergenti, in modo più o meno diretto, sui processi della temporalizzazione.Il problema è dunque quello della effettiva consunzione del passato, cioè di una vita psichica sostenuta da un “autentico flusso temporale…possibile solo sulla base di un’esperienza temporale aperta, dal libero orizzonte e di un’autentica evidenza.”A tale esperienza “ si è sostituita un’evidenza (delirante) “chiusa”, cioè irrigidita su di un unico tema” (Delirio,p.89) che resiste tenacemente ad ogni tentativo di riordino compiuto secondoi nuovi criteri formatisi con “gli avvenimenti recenti”. La presenza di un elemento incompatibile con le prospettive attuali interrompe la fluidità temporale dei momenti costitutivi passato-presente-futuro che, solo nella loro distinzione e singolarità, larendono possibile. Il passato che si presenta con carattere di urgenza al presente mostra l’insuccesso del lavoro rivolto alla sua ritrascrizione, rivolta a renderlo conforme all’ordine dei significati che si è definito nella nuova epoca. Così nella vita psichica emergono luoghi al di fuori del controllo dell’io, zone franche che conservano incapsulati vissuti che non si lasciano integrare, dopo la loro effettiva consunzione, nelle nuove prospettive esistenziali. Tutto ciò comporta allora squilibri che,nelle condizioni più gravi, innestano processi di scissione di tipo psicotico, come nel caso delle manifestazioni deliranti.Per Remo Bodei l’attività delirante rappresenta:
“un tentativo fallito di tradurre se stessi nel presente. Immergendosi inun passato non elaborato, un trauma attuale funge in esso da detonatore di cariche psichiche più profonde, che portano tumultuosamente alla superficie gli incomprensibili relitti del già stato. Mescolati a nuovi frammenti di vissuto questi risultano – per contatto – altrettanto incomprensibili. Il delirante si trova così al centro di una mischia tra logiche che, in differenti periodi, hanno separatamente strutturato l’esperienza allora attingibile e che ora non sanno rendere conto della con-fusione dei relativi contenuti. Preso in mezzo egli è costretto a plasmarsi una personalità ed una realtà di volta in volta sincronizzata con i vari punti di equilibrio raggiunti dalla lotta di queste logiche.
217
La sua mente diventa allora la matrice di ulteriori traduzione improprie,assurde e bizzarre, ma conformi al nuovo modo in cui si imbozzola.” ( Bodei, p.9)
Quest’ipotesi avanzata da Bodei si iscrive nella prospettiva fenomenologica poiché il conflitto tra logiche, che spinge incessantemente il delirante verso nuovi e precari equilibri, sarebbe riconducibile ad una dimensione “paleologica” , ontogenicamente precedente la logica aristotelica fondata sul principio di non-contraddizione.Incrociando la distinzione husserliana tra logica predicativa (cioè aristotelica) ed antepredicativa ( cioè trascendentale), con l’idea che nella genesi del delirio cisia una distorsione dei processi costitutivi della logica pura, neconsegue che il delirante si adopera a costruzioni logiche coerentemente alle modalità originarie in cui esse si sono costituite.Le manifestazioni deliranti hanno dunque pienezza di senso e significato (in una logica predicativa non conforme alla normalità) in quanto espressioni coerenti di particolari modalità costitutive della soggettività (in una logica originaria ed antepredicativa disturbata o incompleta).“ In ogni delirio vi è un nucleo di verità” afferma Freud nel suo primo testo 108 rivolto a comprenderne l’origine e la manifestazione.La fermezza progressivamente crescente con cui il delirante crede alla verità delle sue costruzioni non è per Freud da imputare ad alterazioni della sua capacità di giudizio, come si potrebbe naturalmente credere, ma alla evidenza dei suoi vissuti psichici.. Nella concretezza della realtà psichica c’è una verità storica cheriguarda un brano decisivo d’esistenza. Anche se sul piano logico vi un de-lirare, cioè un uscire dal seminato della ragione, si è posti di fronte ad “un nucleo di verità” che, incapsulato entro lefalse costruzioni del delirio, costituisce “la fonte della persuasione del malato”.“ Questa verità è stata per lungo tempo rimossa; e quando le riesce finalmente di penetrare nella coscienza in forma travisata,il sentimento di convinzione che vi è connesso risulta per compenso rafforzato; esso aderisce ora al surrogato della verità rimossa e lo protegge da ogni attacco critico. E’ come se la convinzione si spostasse dalla verità inconscia all’errore
108 Delirio e sogni della “Gradiva” di Wilhelm Jensen (1906)
218
cosciente che vi è collegato, e vi rimanesse fissata proprio in forza di quello spostamento”La metamorfosi della verità in errore avviene dunque nel tragitto verso la coscienza, ma con ciò questa verità, manifestandosi oltrese stessa “in forma travisata”, non ne è indebolita. Essa si rivela invece in una connessione direttamente proporzionale alla crescita delle costruzioni deliranti, rimanendo così saldamente una evidenza originaria. “ Più il delirio avanza, più il delirante è certo dei suoi contenuti, perché la corazza protettiva del falso avvolge e protegge la verità da cui si è partiti.Tale verità è però soggettivamente troppo importante per essere cancellata, di modo che il camuffamento rappresenta il suo solo lasciapassare” 109
Ed è proprio qui, nel passaggio dall’inconscio alla coscienza, chela relazione psicoanalisi-fenomenologia può trovare la propria giustificazione teorica: essa apre nuovi orizzonti di comprensibilità ai modi con cui i difetti costitutivi della soggettività, radicandosi nei processi inconsci, rendono, paradossalmente, la coscienza luogo dell’errore.La relazione che si definisce tra costruzione di logiche del delirio e contenuto di verità storiche esperite e depositate nell’inconscio è funzionale alla difesa da ciò che “realmente” è avvenuto – si è manifestato - nel soggetto: la deriva che conduce ad una progressivo consolidamento del delirio svolge una “funzionedi irrealtà” che protegge dal pericolo di un avvicinamento al contenuto di verità-realtà degli eventi traumatici o difettivi originari.Si stabilisce così un rapporto inversamente proporzionale tra certezza e verità: più aumenta la prima, più diminuisce la seconda. I fueros non abbandonano la loro presa sul presente e lo impegnano in un incessante quanto improduttivo lavoro ‘logico’ di riordinamento teso alla ri-trascrizione (fallimentare) di se stessi nel presente. Inversamente, nella forma depressiva della psicosi, il tentativo di afferrare il passato, in quanto tale, riesce: annullando presente e futuro si finisce in un vicolo cieco che nonlascia passare più alcuna luce. La terapia per Binswanger è alloraessenzialmente un tentativo di ri-creare le condizioni per vissutitemporali distesi o, meglio, ricorrendo proprio alla doppia definizione agostiniana del tempo come distensio o extensio animi, estesi, cioè disposti in una continuità che riesce a riconquistare spazi,
109 Bodei, cit, p.31
219
superando così le loro patologiche confusioni, tra passato, presente e futuro.In questo intreccio di verità storiche, processi genetico-costitutivi, temporalità, logiche del delirio, inconscio e coscienza, la ricerca di Binswanger opera una connessione profondache rimanda sia alla trascendentalità di Husserl sia al desiderio inconscio di Freud, cioè a quelle due dimensioni costitutive dellavita psichica, indagata dalla fenomenologia e dalla psicoanalisi come dimensioni stratificate di oggetti tanto reali quanto gli oggetti materiali.Naturalmente Binswanger è consapevole che in questo suo progetto si danno solo delle ipotesi di lavoro bisognose di “ molte altre ricerche” poiché “siamo solo agli inizi in questo genere di indagine.” E’ comunque evidente che la direzione verso cui procedere può trovare in una nuova relazione tra la psicoanalisi e la fenomenologia possibilità mai prima d’ora esperite. L’opera di Binswanger, dal versante psicologico, e quella di Ricoeur, dal versante filosofico, costituiscono storicamente le due principali esperienze teoriche in cui, anche se in parte e in modi molto diversi e talvolta antitetici, la relazione psicoanalisi-fenomenologia si è posta aprendo ulteriori possibilità sia ai loro reciproci sviluppi sia, più in generale, al rapporto tra filosofia e psicologia.
Osservazioni conclusive
“ Il metodo fenomenologico non si contrappone alla psicoanalisi, ma piuttosto sembra auspicabile per la sua fondazione come scienzarigorosa” 110
A partire dalla problematizzazione di questa accoglienza, “scientificamente” giustificata, della fenomenologia da parte dello psicoanalista Franco Fornari, vengono qui formulate alcune 110 F Remo Bodei in Le logiche del delirio, Laterza 2000, 1971, p.86.
220
osservazioni conclusive che intendono riprendere, in modo sintetico ed unitario, le questioni, evidentemente ritenute decisive, che si sono poste nella relazione tra la fenomenologia ela psicoanalisi. Ripercorrendo i momenti essenziali e i nodi problematici attraverso cui si è sviluppato l’itinerario teorico di Binswanger, emerge in modo chiaro che la questione centrale, dacui si originano poi una serie di problemi a questa profondamente connessi, è quella relativa al rapporto tra piano ontico dei vissuti psichici - percorribile con un uso non naturalistico dellapsicologia- e piano ontologico delle strutture eidetiche della soggettività – che necessariamente richiede un esplorazione filosofico-trascendentale. Nell’apertura del nuovo orizzonte teorico-metodologico della psichiatria, Binswanger ha trovato, prima in Husserl, poi in Heidegger, poi ancora in Husserl, i punti di riferimento principali e ciò nella permanenza dei suoi debiti teorici alla psicoanalisi freudiana, primo e costitutivo ambito di formazione. Come si è configurata la dinamica teorica dell’opera di Binswangerscaturita da queste grandi prospettive che sono, originariamente, tra loro in aperto contrasto?Questo interrogativo è evidentemente ineludibile per la contrapposizione incrociata tra Heidegger, Husserl e Freud che riguarda, al di là delle diverse prospettive e finalità in generale, la questione fondamentale del soggetto.Da una parte, infatti, il pensiero di Heidegger, pur scaturendo daquello fenomenologico, rifiuta come ancora metafisico il tentativofilosofico-trascendentale di Husserl, mentre, dall’altra, la psicoanalisi freudiana, operando un rivolgimento ontologico del problema della soggettività 111, si pone, anche al di là delle sue stesse intenzioni, al di fuori dello spazio teorico in cui la filosofia lo ha tradizionalmente pensato. Come è allora possibile rinnovare una ‘scienza’ a partire dall’integrazione, pur con i dovuti adattamenti e trasformazioni, tra queste prospettive radicalmente divergenti?Lasciando cadere la problematicità del riferimento congiunto a Husserl ed Heidegger 112, tema qui impossibile da affrontare,
111 Naturalmente anche Husserl ed Heidegger, da altre prospettive e con diversi percorsi, si autocomprendono nei termini di un rivolgimento ontologico nei confronti del tema cardine del soggetto, ma questi non sono evidentemente coniugabili hinc et nunc con quello freudiano. 112 Occorre anche ricordare come lo stesso Heidegger abbia drasticamente sconfessato il tentativo di Binswanger come “un fraintendimento del mio pensiero”. Sulla problematicità di questa accusa a Binswanger si vedano le considerazioni di Mario Galzigna ( Binswanger e le strutture della presenza in L.
221
vediamo, facendo riferimento all’interpretazione di Umberto Galimberti e Carlo Sini, come pensare l’integrazione tra fenomenologia e psicoanalisi nella prospettiva di porre il tema della soggettività su un piano diverso da quelli tradizionalmente percorsi sia dalla psicologia sia dalla filosofia. Per il primo lapsicoanalisi trova nella prassi terapeutica reali possibilità di incontro e di rapporto con la fenomenologia di Husserl, possibilità invece che non possono darsi nella dimensione propriamente teorica.Freud ritrova così nella relazione terapeutica ciò che ha perso nella teoria naturalistica dell’inconscio. La globalità dell’uomo nella sua originaria e immediata presenza è ciò che qualifica talerelazione, sia dalla parte del terapeuta sia da quella dell’analizzato.“ Quando Freud pone l’intera esistenza dell’analista di fronte all’intera esistenza dell’analizzato egli non è più un naturalista”. Ciò che, in sede teorica, mutila il soggetto delle sue qualificazioni propriamente umane per ridurlo alla realtà psichica delle sue dinamiche inconsce biologicamente fondate, viene recuperato nell’incontro terapeutico come incontro tra totalità umane.Al di là dello stesso determinismo della psicoanalisi che domina ogni manifestazione del soggetto -comprese le sue cosiddette “associazioni libere”- nella relazione analitica c’è una “apertura francamente fenomenologica che lascia alle spalle il fisicalismo e il biologismo con cui era stata costruita la teoria”. In questo “poter- essere- insieme l’uno con l’altro”, “nelle modalità dell’enunciazione che traspaiono dall’atteggiamento, nel comportamento, nell’espressione mimico-gestuale” si superano i confini epistemologici della psicoanalisi che, in relazione alle sue inconsapevoli premesse cartesiane, poneva la soggettività comeres da indagare naturalisticamente.Da questa ambivalenza che oscilla, sul piano teorico, dall’ideale esplicativo derivato dalle scienze naturali a quello, sul piano della sua prassi terapeutica, fondato sulla comprensione della globalità del soggetto di essere-nel-mondo, si può uscire, sempre secondo Galimberti, se “la terapia psicoanalitica riconosca nell’analisi esistenziale fenomenologicamente fondata una possibilità per chiarire il proprio statuto epistemologico e per eliminare quella contraddizione che non consenta alla prassi
Binswanger, Il caso Suzanne Urban, Saggi Marsilio, Venezia, 1994, pp. 23-24, oltre aquanto detto più oltre.
222
terapeutica di riconoscersi nell’impianto teorico che ha ereditatodalle scienze naturali”. 113 Ciò allora comporta che l’inconscio nonva più pensato in termini naturalistici, che sono, in ultima analisi, come sottolinea Carlo Sini 114, termini metafisici.Secondo Sini, nel progetto di Binswanger rivolto a comprendere, inmodo non naturalistico e quindi non metafisico, l”essere-nel-mondo” dello schizofrenico, del melanconico, ecc., convergono i nodi fondamentali del dibattito filosofico novecentesco sulla necessitàe, insieme, sulla possibilità di superare il sistema di sapere fondato dalla ratio metafisico-scientifica del pensiero occidentale.Coniugando Heidegger con Husserl si produce però, sempre nella prospettiva interpretativa di Sini, un intreccio inestricabile trapiano ontico e piano ontologico che non solo non viene problematizzato, ma si complica ulteriormente nella sua sostanziale coesistenza con la valenza ontologica della metapsicologia freudiana. Abbiamo visto come Binswanger fonda il suo tentativo di emanciparela psichiatria dalle sue origini fisicaliste e oggettivistiche rivolgendosi, in un primo momento, alla descrizione fenomenologicadei vissuti per poi, in una serrata lettura di Essere e Tempo, procedere all’analisi esistenziale dell’Esserci e dei modi attraverso cui esso si dà come Essere-nel-mondo. Negli ultimi due testi, infine, vi è un ritorno all’origine, cioè a Husserl, compiuto nel segno della necessità di assumere una prospettiva trascendentale entro cui comprendere, come ‘via regia’ finalizzataa fornire un orizzonte di senso ai modi patologici di “essere-nel-mondo”, la processualità genetico-costitutiva della soggettività\intersoggettività.In questo percorso Husserl\Heidegger\Husserl il piano ontico dellariflessione sull’ente come tale rimanda necessariamente alla prospettiva ontologica che vuole cogliere l’essere dell’ente.L’analitica esistenziale di Essere e Tempo ha infatti una doppia valenza: da una parte consente di avvicinarsi ai fenomeni ontici della coscienza empiricamente dati nel mondo-della-vita, dall’altra permette un’indagine ontologica sui modi trascendentali dell’essere di questi fenomeni.
“Per antropoanalisi noi intendiamo un tipo di indagine scientifica di carattere antropologico, avente cioè come oggetto l’essenza dell’essere dell’uomo. Sia la sua denominazione tedesca 113 U.Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit, pp.210-211
114 C.Sini, Le due anime della psichiatria fenomenologica ed esistenziale in Il profondo e l’espressione, Lanfranchi, Milano,1992,pp.55-56.
223
( Daseisanalyse) sia i suoi fondamenti filosofici derivano dall’analitica esistenziale di Heidegger, il cui grande merito, peraltro non ancora riconosciuto come converrebbe, è di aver posto in luce la struttura fondamentale dell’esser-ci (Dasein) dell’uomo, presentandone le articolazionicostitutive, la struttura cioè dell’essere- nel- mondo. Quando Heidegger individua la costituzione o struttura fondamentale della presenza nell’essere-nel-mondo, intende al tempo stesso pronunciarsi sulle condizioni della sua possibilità. Il discorso sull’essere-nel-mondo ha dunque in Heidegger il carattere di una tesi ontologica, cioè di un enunciato su un rapporto modale (Wesenverhalt) determinante l’esserci in generale.Dalla scoperta e dalla definizione di questo rapporto modale di base l’antropoanalisi ha tratto le sue sollecitazioni decisive, il suo fondamento e la sua giustificazione filosofica, nonché le sue direttive metodologiche”115
Il ricorso alla fenomenologia trascendentale di Husserl, allo stesso modo, viene declinato in entrambe le direzioni.
“L’approfondimento di questa indagine conduce al rinvio di ogni “oggettualità” costituita ad una correlativa struttura essenziale dell’intenzionalità che è per essa costitutiva, dunque al rapporto fra ilmondo inteso come “universo di trascendenze costituite” e i momenti “strutturanti” o costitutivi di quest’universo, al rapporto tra noema intenzionale e noesis intenzionale, tra prodotto trascendentale e produrretrascendentale, tra vita vissuta e vita vivente o agente; se, tramite questa “correlazione”, si perviene a un approfondimento dell’analisi strutturale dei mondi schizofrenici, si può procedere allora anche nella ricerca dei momenti strutturali costitutivi dei mondi della mania e dellamelanconia, ricerca che riconduce al rapporto tra intenzionalità e trascendentalità (nel senso husserliano). E in nessun modo si può più agevolmente comprendere la “trama” dei “fili”delle funzioni trascendentali se non considerandole nelle loro stesse deficienze, quali si presentano in quegli esperimenti della natura denominati “psicosi””.116
Binswanger percorre dunque la strada tra il costituito e il costituente come itinerario tra l’ontico e l’ontologico rivolgendosi a quegli “esperimenti della natura” (le psicosi) che,nella loro patologica distorsione, mostrano in trasparenza gli elementi eidetici della soggettività in quanto tale.Come Freud, che indaga le deficienze della soggettività (isteria, nevrosi, fobia, ossessioni, lapsus, rimozioni, ecc.) perché
115 L. Binswanger, Il caso Ellen West ed altri saggi, Bompiani, Milano, 1973,pp.19-20
116 L. Binswanger, Melanconia e Mania, cit., p.22
224
“soltanto quando si studia il patologico s’impara a conoscere il normale”, Binswanger ritiene di poter afferrare sia da un punto divista statico (i mondi psicotici come l’esser-ci e i modi dell’essere dell’esser-ci) sia da quello dinamico (i processi genetico-costitutivi di questi mondi che rimandano ai difetti e ai disturbi della loro costituzione trascendentale) gli elementi eidetici della soggettività\intersoggettività, pur riconoscendo di non poter pervenire a determinare significati ultimi al manifestarsi temporale della relazione inscindibile che lega l’io al mondo. Così questa doppia valenza, ontica ed ontologica, riguarda sia il punto di vista statico, sostanzialmente costruito nel riferimento ad Essere e Tempo, sia quello dinamico, fatto proprio con l’assunzione della prospettiva fenomenologico-trascendentale di Husserl. E’ legittima tale integrazione tra l’ontico e l’ontologico, si chiede Carlo Sini, che vede in essa mostrarsi “la doppia anima della psichiatria fenomenologico-esistenziale” ? La risposta a tale interrogativo non può che essere negativa per il fatto che il problema di fondo su cui esso si fonda “non soltanto non è in alcun modo risolto da Binswanger, ma neppure è avvistato come problema”. 117
La distinzione tra una scienza ontica della psiche dalla dimensione ontologica – che rimanda “ad una partizione tipicamenteheideggeriana tra ciò che è proprio dell’ente e ciò che appartieneall’essere” – definisce la doppia anima della psichiatria binswangeriana, che da una parte è esistenziale e dall’altra fenomenologica.Secondo Sini, non essendo in realtà praticabile questa contaminazione tra Husserl ed Heidegger, si produce un conflitto che però “restando inconsapevole, neppure promuove un processo di chiarificazione liberatrice”. La questione del soggetto nella filosofia del ’900 può essere allora posta solo nel superamento della ratio che ha storicamente formato la prospettiva metafisico-cartesiana ed entro la quale si è costituito, in una pluralità di forme, il suo problema fondamentale, che è quello della relazione uomo-mondo-tempo, che ,a sua volta, gravita su quella corpo-mente.Pur riconoscendo a Binswanger il merito di aver posto la centralità e la concretezza dell’interrogativo “E’il mondo che si
117 C. Sini, Le due anime della psichiatria fenomenologico ed esistenziale in Il profondo el’espressione, cit., p.56
225
definisce a partire dall’uomo, oppure è l’uomo che si definisce a partire dal mondo?”, Sini non ritiene che il suo progetto abbia conseguito quel rivolgimento della prospettiva metafisica necessario ad affrontarlo in termini adeguati alla sua specificitàe natura.Anche la psicoanalisi, essendo totalmente dentro questo orizzonte naturalistico-metafisico, non riesce a pensare l’alterità dell’inconscio che essa però, nello stesso tempo, mostra collocandola in uno spazio al di fuori del confine di quello costituito delle categorie ontologiche tradizionali.118
Ritorna qui lo stesso tema, quello delle modalità originarie in cui si dà la relazione uomo-mondo-tempo che, sempre secondo Sini, “ non si lascia cogliere da un pensiero atteggiato onticamente e naturalisticamente, sia che esso opti per un punto di vista materialistico (come quello per esempio di Lévi-Strauss), sia che opti per un punto di vista trascendentale che pone il mondo come “fenomeno della coscienza””.Tuttavia “la psichiatria fenomenologica vanta sicuramente un primato in ordine al problema della comprensione dell’”altro” e del suo disagio” anche se “non è di per sé sufficiente ad aprire la via per una fattiva soluzione del problema.”119
Se l’intento iniziale della psicoanalisi e della fenomenologia eradi afferrare, tematizzandone l’originarietà,120 le strutture ontologiche della soggettività, le domande che , a questo punto, si pongono, sulla base anche delle considerazioni di Sini, sono: la psicoanalisi e la fenomenologia sono riuscite a indagare, dalleloro reciproche prospettive, l’originario e ad acquisire sapere stabile su di esso? Oppure è solo la loro relazione e il loro intreccio che ha aperto una nuova via di conoscenza dei processicostitutivi della soggettività e delle loro modalità difettive? Edinfine, questa strada, se percorsa con coraggio teorico e immaginazione metodologica, può, wittgensteinamente, risultare
118 Mentre, come si è precedentemente accennato, per Ricoeur lo sconfinamentodella psicoanalisi dalla ratio metafisica tradizionale è dato dalla coesistenzadi una energetica con una ermeneutica.
119 C. Sini, op.cit, p.138120 “ Il tema dell’anteriore è l’ossessione del freudismo” afferma Ricoeur, che coglie la stessa esigenza fondamentale anche nella fenomenologia, rivolta a tematizzare ed indagare il precategoriale, o, meglio, ciò che poi produce e costitusce il categoriale.
226
‘terapeutica’ rispetto alle originarie finalità ontologico-metafisiche di Freud ed Husserl? Una risposta affermativa a quest’ultima domanda (che, in realtà, dovrebbe essere l’unica domanda da porsi, contenendo, in sostanza, le prime due) comporta il dissolvimento (e non la risoluzione) del problema dell’origine perché la nuova luce che proviene dall’incontro con il complesso universo dell’esistenza concreta lo illuminerebbe, cioè lo definirebbe in termini essenzialmente diversi. E’ dunque evidente che la questione della soggettività rimanda alle la modalità con cui viene posta ( costruita) e praticata la relazione tra piano ontico e ontologico che, nell’opera di Binwanger trova immediata ed effettiva applicazione anche nella prassi clinica,. E’ infatti il modo in cui tale relazione vive nel fuoco del lavoro terapeutico che è decisivo rispetto alle preclusioni teoriche che essa porta con sé. Come viene anche rilevato nel saggio introduttivo al testoIl caso Suzanne Urban121 da Mario Galzigna (nel riferimento, a sua volta, ad una Introduzione122 di M. Foucault a Binswanger) , nella Daseinsanalyse viene di fatto a cadere il problema del rapporto o meno tra piano ontologico e piano ontico, perlomeno così come viene posto nelle sue ripartizioni costitutive ed originarie. Binswanger rispetto a tale questione decisiva scrive:
“ L’antropoanalisi di per sé non è né un’ontologia né una filosofia”. Come antropologia fenomenologica “non formula tesi ontologiche circa un rapporto modale che determini l’esserci, ma soltanto degli enunciati ontici: enunciati cioè su constatazioni fattuali circa le forme e le configurazioni [ Gestalten ] della presenza, quali si presentano nella lorofattività. Essa è pertanto una scienza di esperienza empirica, sia pure con un suo metodo e un suo ideale di esattezza, con il metodo, cioè, e l’ideale di esattezza propri delle scienze empiriche fenomenologiche”123
Tuttavia il metodo antropologico-fenomenologico, che Binswanger pensa, come si è ora ricordato, nella sua funzione di via di accesso alla attualità della presenza, conduce poi, necessariamente, oltre questa, sia verso la dimensione apriori dell’esserci sia verso gli interrogativi riguardanti i processi genetico-costitutivi del tessuto intenzionale, cioè verso ciò che rende possibili tutti gli altri fenomeni peculiari, patologici e 121 L. Binswanger, Il caso Su zanne Urban . Storia di una schizofrenia, a cura di E. Borgna e M.Calzigna, Venezia, Marsilio, 1994, 122 M. Foucault, La rêve e l’existence, Bruges, Desclée de Brouwer, 1954123 L. Binwanger, L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria, in Id., Il caso Ellen West e altri saggi,a cura di D. Cargnello e F. Giacanelli, Milano, Bompiani, 1973, p.20.
227
non. Ogni caso clinico mostra come la dimensione ontologica del mondo-spazio-tempo (Welt- Raum- Zeit) si dà in forme specifiche di mondanizzazione, di spazializzazione e di temporalizzazione in un intreccio inestricabile di strutture aprioriche di natura ontologica ed esistenziale. Nei vissuti concreti, empirico e trascendentale coesistono in modo inseparabile; nel caso di Suzanne Urban, ad esempio, Binswanger, attraverso il metodo fenomenologico, individua le modalità con cui la potenza esistenziale sideclina come potenza del terribile alterando la trama del tessuto intenzionale delle correlazioni mondane, spaziali e temporali. Così l’Erlebnis è anche trascendentalità, originarietà, categorialità, Grudformen; ciò che Heidegger rimprovera a Binswanger (l’indebito passaggio dall’ontologico all’ontico) è invece questo continuo rimando tra i due piani che non procede maiall’applicazione delle categorie ontologiche sui casi clinici, nella semplice derivazione dell’indagine antropologica da quella ontologica. Da questo punto di vista il fraintendimento di cui parla Heidegger non riguarda una pretesa contaminazione tra concetti e categorie ontologiche e Erlebnisse ontici, operata in modoscorretto da Binswanger, ma è piuttosto la sua lettura del tentativo antropoanalitico che si rivela inadeguata. Questo tentativo, secondo il suo principale protagonista, si dispiega infatti in uno spazio intermedio tra le forme antropologiche e le condizioni ontologiche come incessante movimento di andata e ritorno, come correlazione necessaria e nello stesso tempo, teoricamente e terapeuticamente fertile, che fa svanire il problema della reciproca contaminazione prorio perché non c’è ontologia definitiva da contaminare. L’approccio fenomenologico alla presenza origina un nuovo tipo di movimento verso le strutture aprioriche contenute in essa e verso le modalità della loro espressione che vanifica ogni possibilità di mantenere rigidamente separati ilpiano ontico da quello ontologico, pur se è ( ancora) necessario elaborare e conservare la loro distinzione concettuale per la perdurante intrascendibilità del linguaggio metafisico occidentale. E’ questo il problema centrale che Binswanger affronta e sviluppa sul piano della erlebnis di un io-mondo. Anche se non è ancora venuto il tempo per una risoluzione definitiva, se mai potrà esserci, perlomeno nei termini in cui oggi la si pensa, è però il modo in cui lo fa che risulta teoreticamente produttivo perché le stesse oscillazioni interpretative rispetto alla fenomenologia di Husserl sono parte inevitabile e necessaria di un processo di pensiero che si sviluppa in un terreno ancora ingombro di categorie, linguaggio e
228
modalità metafisiche di pensiero, ma che tuttavia si muove in unadirezione dove queste iniziano ad indebolirsi. Con ciò non si vuole certo accreditare l’antropoanalisi come esperienza del pensiero debole, se non altro per il fatto che essa nasce essenzialmente come esigenza clinico-terapeutica, ma il tentativo ri-conoscerla, a pieno titolo, come scienza propriamente umana puòessere interpretato anche come tentativo di sottrarsi alla forza metafisica del paradigma naturalistico entro cui si è definita la psichiatria classica (anche se, naturalmente, il peso del nostro passato metafisico attende al varco ogni genere di tentativo futuro di sfuggirvi). Quindi, anche se , ad esempio, come si è già visto,Binswanger forza la distinzione husserliana tra io empirico ed io trascendentale, ciò avviene su un terreno in cui si è già avviato un processo di erosione degli stessi termini in cui il problema del rapporto tra situazioni esistenziali concrete e forme eidetiche della soggettività-intersoggettività, si è storicamente posto nella metafisica occidentale. E’ la necessità di affrontare la complessità problematica del ‘paziente’, l’esigenza di procedere umilmente passo dopo passo nella comprensione dei suoi erlebnisse, degli accadimenti anche minuti della sua vita psichica nel tentativo di ricostruire un mondo, di ordinarlo nella gerarchia dei suoi sensi e significati, che rende la via che conduce agli apriori esistenziali ed ai processi genetico-costitutivi diversa da quella percorsa dal pensiero filosofico tradizionale, messa in discussione, d’altra parte, come abbiamo visto nel secondo capitolo, dall’approccio fenomenologico di Husserl. In altri termini, guardata dal “basso” dei vissuti patologici, la questione della soggettività mostra la sua eccedenza sfidando ogni domanda sulla sua ultima “essenza”, ogni domanda cioè che si pone nella forma del “che cos’è”. Inaugurare un modo non metafisico nei confronti della presenza comporta allora aprirsi alla sua eccedenza nel deuten, rinunciare ad ogni definitività degli status teorici sulla soggettività: sulla base di questa fondamentale esigenza Binswanger può allora rivendicare pienamente libertà epistemologica alla fenomenologia psicopatologica che, nei confronti della filosofia, non considera negativo o improponibile assumere un atteggiamento strumentale. Inmodo esplicito, nel saggio Über Phänomenologie ciò viene rivendicato:lo psichiatra utilizza la teorizzazione filosofica sulle struttureeidetiche e la loro descrizione come formazioni immanenti della coscienza affinché la sua prassi clinica ne possa “trarre giovamento”. Piegandosi alle esigenze della prassi, i saperi teorici non possono però continuare a costituirsi nei modi
229
‘disincarnati’ereditati dalla tradizione filosofica del pensiero; così come avviene nella psicoanalisi, il valore teorico metodologico della antropoanalisi non può essere pensato indipendentemente dalla prassi terapeutica. E’ questa la prospettiva interpretativa anche di M. Galzigna nella già citata introduzione a Il caso Suzanne Urban:
“ E’ nell’esperienza clinica che si scopre l’analogia qualitativa tra l’esistenziale a priori e l’Erlebnis : di conseguenza, sarà necessario, sulterreno della teoria, adattare a questa scoperta l‘armamentario filosofico husserliano, e quindi postulare una sostanziale continuità – anche se all’interno di una ineliminabile differenza- tra l’osservazione sensoriale e la visione eidetica, tra la conoscenza dei fatti e la conoscenza delle essenze, tra l’empiria psicologica e la fenomenologia.”124
Pur se con significative differenze si muove su questa stessa linea anche Minkowski che opera una distinzione tra la ricerca fenomenologica che “fa vibrare corde metafisiche” 125 e la comprensione delle patologie della vita psichica. Per lo psichiatra russo, anche se tra dati fenomenologici e dati psicopatologici c’è una fertile e virtuosa dialettica, al punto tale che si crea un “insieme vivo ed indivisibile”, occorre mantenere separati i due ambiti proprio perché la relazione uomo-mondo-tempo non è certamente conoscibile in tutta la sua profondità dalla ratio metafisica occidentale. Nella questione cardine del tempo lo sguardo filosofico, nel momento in cui diventa più profondo e penetrante, vede progressivamente dissolvere il proprio “oggetto” di studio da cui scaturiscono paradossi ed emergono dimensioni inindagabili. Il pensiero che cerca di comprendere il tempo si trova così di fronte alla impotenza teorica delle proprie categorie concettuali che, nel rivelarsi tali, mostrano i limiti della ratio metafisica entro cui hanno trovato la loro origine. Ciò che interessa a Minkowski è però il contributo che l’approccio fenomenologico può offrire alla psichiatria sia per individuare “un metodo destinato allo studio dei fenomeni psicopatici”, sia per favorire la possibilità di porsi di fronte alla sofferenza mentale con un atteggiamento totalmente diverso da quello che la classifica in base all’oggettività clinico-nosografica. Le due questioni cardine– temporalità e (inter) soggettività – presentano dunque dimensioni che sfuggono ad ogni tipo di presa metafisico-124 M. Galzigna, Binswanger e le strutture della presenza, cit., p.34.125 Il tempo vissuto,cit.,p.178
230
metapsicologica, sempre configurandosi come resto, come eccedenza, come differenza126 non riconducibile a nessuna matrice originaria. E’ per questo che Binswanger ritiene possibile ritrovare l’equilibrio temporaneamente perduto perché l’io trascendentale, pur in una condizione difficile e rigida, continua – non può non farlo - ad essere attivo tessendo i suoi nessi intenzionali, anche se ciò chesi manifesta è una patologica ripetizione di comportamenti apparentemente privi di reale erlebnis. E’ l’ascolto di questa sofferenza che può far ritornare alla luce tale attività, è la rinuncia a fissare definitivamente attraverso le classificazioni psichiatriche a consentire la ri-apertura dell’essere-nel-mondo nella temporalità e nella intersoggettività. Anche per Gadamer la patologia consiste in un ‘appesantimento’ del soggetto che ha difficoltà a ‘muoversi per la perdita dell’equilibrio, consideratoappunto come una “assenza di gravità, in quanto i pesi si annullano reciprocamente”127
Da una prospettiva diversa la patologia, come sistema rigido delfalso Sé, è una non verità che temporaneamente predomina e cheperò è, e qui si evidenzia la fondamentale valenza eticadell’intervento terapeutico, sempre decostruibile in direzione diuna riconquista della verità di sé stessi, verità certamente nonstatica e definitiva ma, al contrario, dinamica e sempre nuova.Per Carlo Sini, che in ciò fa riferimento a Peirce, “la verità nonè qualcosa di statico; la verità è il movimento stesso delle cose,degli eventi che accedono all’interpretazione”128 Nella prospettivadi Peirce la semiotica è in rapporto con la verità nel senso chegli eventi, le cose possono essere fatti segno di interpretazione.Questa concezione di origine heideggeriana della verità comemanifestarsi del fenomeno nel tempo è fatta propria dallaantroponalisi, già, d’altra parte, orientata in questo senso dallaidea di verità presente nella fenomenologia di Husserl.Nell’incontro tra medico e paziente dovrebbe di nuovo accaderequalcosa, non però, metafisicamente, come un ritrovare la veritàperduta o dimenticata, ma come riattivazione di processi chedonano sempre nuovi sensi a ciò che si esperisce. Ricordiamo come,per Freud, non è il diniego o la conferma del paziente alegittimare e verificare la verità o meno delle interpretazionidell’analista ma il prodursi di nuovo “materiale psichico”,
126 Il contesto di riferimento in cui va collocato l’uso del termine differenza è quello delimitato dalle opere di J.Derrida e M.Foucault.127 H.G.Gadamer, Dove si nascode la salute, 1994, Raffaello Cortina Editore, p.123128 C.Sini, Ermeneutica del progetto ed incanto del destino in Il profondo e l’espressione, 1991, Lanfranchi,p.14
231
l’affiorare di segni che di nuovo si offrono al deuten , a quelleche vengono definite da Freud stesso come “costruzioni”. Nel suo tentativo di svincolandosi da vecchie e nuove appartenzemetafisiche, la psichiatria fenomenologica , che da una parte,vuole conservare tutto il suo valore conoscitivo-terapeutico e,dall’altra, vuole porsi direttamente di fronte allapluridimensionalità della presenza, nella sua prassi opera undecisivo mutamento rispetto al paradigma da cui essa stessa si èpur originata. Liberandosi dall’esigenza della legittimazionescientifica delle sue pratiche, fondate dalla incondizionataaccettazione della spiegazione naturalistico-obiettivistica, lapsichiatria fenomenologica conquista una nuova responsabilitàteorica e terapeutica. Nella prospettiva interpretativa diGalimberti è proprio quest’ultimo aspetto che prevale poiché, piùche gli interrogativi metafisici, vi è la preoccupazione per lacomprensione dell’“altro”; da questo punto di vista il progettodi Binswanger viene valutato come un fertile tentativo che riescead aprire orizzonti di comprensibilità e di senso nei confrontidel disagio mentale, attraverso la tematizzazione dell’originariocome “aprioristica struttura dell’umana presenza che rendepossibili tutti i fenomeni”. Ed è proprio sul terreno della prassiterapeutica che psicoanalisi e fenomenologia, al di là di ognivalutazione fondata sulle loro premesse teorico-metodologiche,possono trovare un importante punto di incontro. Qui infattiFreud, liberandosi dalle maglie dell’approccio biologico-casualistico alla soggettività, torna a considerare il soggettonella sua integralità di uomo, in cui sono presenti,inestricabilmente connesse alle sue esigenze istintuali, ledimensioni complesse dell’intera esistenza dell’analizzato, apartire dai principi etico-sociali. Anche nel setting analitico, neivissuti della dinamica transfert-controtransfert, c’è “un modo incomune (…) che smentisce l’impianto teorico casualistico dellapsicoanalisi”.129 Occorre dunque distinguere, nella psicoanalisi,ciò che la riconduce ad una epistemologia naturalistica e ciò cheinvece la colloca, in una “apertura francamente fenomenologica”,nella prospettiva della comprensione dell’originario rapportodell’uomo con il mondo.130 Secondo Galimberti, più che129 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, Milano,Feltrinelli, 1979, p.154 130 Tra i diversi approcci rivolti a superare l’antinomia psicoanalisi-fenomenologia si segnalano anche quelli di A. Dentone e O. Balaban, autori, rispettivamente di due interessanti articoli ( On the Possibile Relationship Between Phenomenology and Psychoanalysis e A Phenomenological Approach to the Unconscious ) comparsi in Analecta Husserliana, The yearbook of Phenomenological Research, Vol XXXV, Book 2, pp. 425-435 e 455-469 ). Per una più approfondita discussione si veda
232
all’analitica di Heidegger, Binswanger è vicino alla “psicoanalisiesistenziale” dell’ultima parte di Essere e il nulla dove la questionedel soggetto viene ricondotta ad una “comprensione preontologica”del “vero irriducibile” in cui non è possibile procedere secondole categorie causalistiche.Sartre, assumendo una prospettiva fenomenologica e, nello stesso tempo, facendo proprio il punto di vista psicoanalitico che pone il desiderio inconscio come datità originaria, cerca un nuovo Freudche sappia procedere, attraverso la ricerca degli a-priori esistenziali, alla costruzione di una filosofia della soggettività e della pluridimensionalità delle sue dimensioni. “I comportamenti studiati da questa psicoanalisi non saranno solamente i sogni, gli atti mancati, le ossessioni e le nevrosi, ma anche e soprattutto i pensieri di quando si è svegli, gli atti riusciti e adatti allo stile ecc. Questa psicoanalisi non ha ancora trovato il suo Freud”Per Galimberti “il Freud atteso da Sartre è Binswanger, se è vero che la sua analisi esistenziale non cerca cause o pulsioni fondamentali, ma piuttosto ciò che nell’individuo rende possibile che queste cause o pulsioni agiscano nel modo che la psicoanalisi freudiana ha accertato che agiscono. Si tratta cioè di trovare l’a-priori esistenziale che dischiude una certa visione del mondo all’interno della quale e per la quale le cose acquistano un certosignificato.” 131
Ritorna dunque, anche nell’interpretazione di Galimberti, la questione decisiva della possibilità di accedere all’originario edall’a-priorico, abbandonando però, correlativamente, ogni residuo causalistico-oggettivistico che, a sua volta, rimanda alla permanenza dell’orizzonte metafisico entro il quale si è dispiegato il pensiero filosofico occidentale rivolto ad afferrareverità universali e necessarie. Abbiamo visto come per Carlo Sini132, che pur riconosce all’antropoanalisi grandissimo valore innovativo sia rispetto ai pregiudizi positivistici e psicologistici, sia rispetto al lavoro terapeutico in psichiatria,l’opera di Binswanger rimane entro questo orizzonte segnato, da una parte, dal riduzionismo naturalistico freudiano, e, dall’altra, dalla permanenza della natura fondazionalista del trascendentalismo husserliano, Non è certamente questa la sede peranche di A.Dentone, Fra conscio ed incoscio, Fenomenologia Psichiatria Psicoanalisi, Bastoni, Foggia, 1996.131 Psichiatria e Fenomenologia, cit., p.209
132 Cfr. Fenomenologia e psichiatria in Il profondo e l’espressione,cit.
233
una sua valutazione definitiva, che è ancora presto per compiersi,ma è evidente come quest’opera comunque costituisce una grande esperienza teorica che non solo pone, operando nella prassi clinico-terapeutica, le questioni essenziali che riguardano la relazione tra fenomenologia e psichiatria, ma anche, e forse soprattutto, il problema decisivo di aprire nuove strade all’evoluzione del rapporto tra pensiero filosofico e ricerca psicologica.Husserl ci ha posto di fronte il problema reale sia del dominio della psicologia sulle altre scienze umane sia, più radicalmente, della sua pericolosità per la permanenza e lo sviluppo dello stesso pensiero filosofico da cui essa stessa è scaturita. Il conflitto tra filosofia e psicologia si è storicamente dato a partire dalla rivendicazione della psicologia di annettere nel suoambito, scientifico e non speculativo, temi e problemi tradizionalmente di pertinenza della filosofia, complessivamente riconducibili a ciò che quest’ultima aveva definito, fin da Platone, con il termine di anima. Non si tratta però, aggiunge Husserl, come si è già precedentemente osservato, di affrontarlo con l’intento di vincere ed imporre la propria egemonia teorica perché la posta in gioco è ben altra. Essa riguarda la possibilitàdi inaugurare un pensiero che proceda, oltre le dicotomie di soggetto-oggetto e psichico-fisico, contro la metafisica sia che questa si esprima nell’ambito filosofico del pensiero sia che si manifesti nella ingenuità dell’ideale obiettivistico della psicologia. C’è veramente un destino comune per il pensiero filosofico e la ricerca psicologica che hanno di fronte un compito arduo ma ineludibile, pena la stanca e improduttiva ripetizione di strade già percorse. Questo compito è quello che Husserl ha perseguito in tutta la sua opera e che viene posto con necessaria radicalità,nella Crisi delle scienze europee. La ricerca di Binswanger costituisce unprimo grande passo nella direzione indicata da Husserl proprio perché, con grande determinazione e creatività teorica, ha voluto e saputo compierlo avvalendosi di un pensiero che per i suoi originari principi e metodi scientifico-oggettivistici sembrava assolutamente in contrasto con l’approccio fenomenologico. “ Volgendomi alla fenomenologia e all’analisi esistenziale, il problema dell’inconscio si è trasformato, allargato e approfonditopoiché sempre meno assume una posizione di contrasto con il conscio (…) che retrocede a favore di una descrizione delle diverse maniere e strutture fenomenologicamente dimostrabili
234
dell’essere-nel-mondo”.133 Binswanger riconosce così il valore dell’opera di Freud134 per il suo percorso teorico che lo conduce verso una più ampia prospettiva dove sia possibile ripensare non naturalisticamente i rapporti tra conscio ed inconscio. D’altra parte, come sottolinea Danilo Cargnello,135 “l’antropoanalisi non è in opposizione con alcuna teoria; è prima di qualsiasi teorizzazione discorsiva nel piano di questa o di quella ipotesi di lavoro (…) Essa è nata soprattutto dal profondo bisogno del suo instauratore di approfondire il significato e la validità del comprendere in psicopatologia”Ponendo al centro il bisogno del paziente e pensando a partire dalla ricerca di un autentico rapporto con questo, Binswanger si muove subito su un terreno sgombro da particolarismi e divisioni teorico-disciplinari in un itinerario che, nella negazione di ognivalore ontologico alla sua Daseisanalyse e nel libero riferimento all’analitica esistenziale di Heidegger, alla fenomenologia trascendentale di Husserl ed alla psicoanalisi di Freud, si pone come esperienza fondamentale di un movimento di pensiero orientatoa superare il conflitto tra filosofia e psicologia. Ci si può allora porre questo interrogativo che può formularsi in due modi: nel percorrere questo itinerario attraverso l’elaborazione teoricae la prassi analitica, Binswanger pone in essere o dà comunque avvio a nuove modalità di risoluzione-dissoluzione di questo conflitto ? O il suo tentativo rivolto a vanificare i termini stessi della opposizione tra filosofia e psicologia è segnato dai confini metafisici che questo conflitto ancora presenta?Una risposta affermativa alla prima domanda (e, conseguentemente, negativa alla seconda) è contenuta nella prospettiva interpretativa dell’opera di Binswanger di Danilo Cargnello che, fin dagli anni quaranta, si adopera ad un profondo rinnovamento della psichiatria italiana, fortemente ancorata al paradigma positivistico dell’oggettività clinico-nosografica, in favore di un’apertura alla psichiatria fenomenologica di origine tedesca. L’opera preziosa di questo psichiatra, confinato in ospedali di
133 Lettera riportata in L. Binswanger, Ricordi di Sigmund Freud, Roma, Astrolabio, 1971, p.66.134 Di cui rimase, d’altra parte, sempre amico, come testimoniano un trentennale carteggio e frequenti collaborazioni professionali. 135 Direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Sondrio e profondo conoscitore dell’opera di Binswanger che per primo introduce in Italia, fin dal primo dopoguerra, attraverso una serie di scritti pubblicati nella Rivista di Psicologia.Il testo da cui è tratta la citazione è D. Cargnello, Dal naturalismo psicoanalitico alla fenomenologia antropologica della daseinsanalyse, Da Freud a Binswanger, Archivio di Filosofia , Padova, Cedam, 1961 ,p.128.
235
provincia, come accade anche in altri casi,136 anche per la valenza politica del rinnovamento scientifico da lui propugnato, si apprezza sempre più proprio nel tempo attuale in cui riemergono tendenze regressive rispetto alle acquisizioni che sembravano ormai consolidate anche nella prassi istituzionale dell’assistenzapsichiatrica. Qui si vuole però ricordare soprattutto il grande valore teorico della sua interpretazione della relazione tra psicoanalisi e fenomenologia che, nella sostanza, anticipa quella, fondamentale per il dibattito filosofico del’900, di Paul Ricoeur a cui si è fatto prima riferimento. Abbiamo ricordato come, a partire della sua riflessione sul linguaggio e sul simbolodi stampo fenomenologico ed ermeneutico, il filosofo francese legge l’opera freudiana come una esperienza fondamentale del pensiero del ‘900, in quanto teoria che non solo interpreta la cultura ma, facendolo, la modifica radicalmente.137 Anche se certamente non è qui possibile ripercorrere il complesso itinerario filosofico di Paul Ricoeur, che dai primi studi e interpretazioni negli anni quaranta rivolti all’analisi della filosofia dell’esistenza di Karl Jaspers approda, alla fine del secolo, all’ermeneutica del sé138, va sottolineata la convergenza del suo lavoro sulla psicoanalisi139 con i testi che Cargnello dedica alla relazione psicoanalisi-feomenologia già a partire dal primo dopoguerra.Come è noto, Freud viene visto da Ricoeur come uno dei tre maggiori rappresentanti di una ‘scuola’ che esercita un profondo sospetto sulla coscienza e sulla sua cartesiana trasparenza. Con la psico-analisi “nasce un problema nuovo, quello della menzogna della coscienza e della coscienza come menzogna”.140 così come era avvenuto, pur da altre prospettive, con Marx e con Nietzsche.
136 Sarà poi proprio da questi ospedali, primo tra gli altri quello di Gorizia diretto da Franco Basaglia, che partirà un movimento politico, culturale e scientifico che metterà in crisi le istituzioni manicomiali e la loro funzione reclusiva-repressiva.137 “La psicoanalisi è un movimento della cultura perché l’interpretazione che essa dà dell’uomo verte principalmente e direttamente sulla cultura nel suo insieme; con essa l’interpretazione diventa un momento della cultura; essa cambia il modo interpretandolo” Ibid., p. 137
138 Cfr. Paul Ricoeur, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993.139 Soprattutto i già citati Dell’interpretazione, Saggio su Freud (1965 ) e Il conflitto delle interpretazioni, Saggio sull’ermeneutica ( 1969 ) dove il filosofo Ricoeur si interroga, ecome tale si confronta, con il senso filosofico di una teoria che non si qualifica come filosofica, cioè la psicoanalisi freudiana140 Il conflitto delle interpretazioni, cit., p.115.
236
Cargnello coglie subito l’intreccio tra psicoanalisi e fenomenologia in Binswanger (il fondo freudiano, che non riguarda solo la sua formazione, è continuamente “ richiamato” anche se in modo spesso “sottaciuto”) ma, contestualmente, puntualizza che l’antropoanalisi, in quanto modalità non teoretica di approccio aldisagio mentale, non si avvale di apporti esterni per costituirsi come un solido corpo categoriale, come un sistema teorico che si oppone ad altri sistemi teorici precedentemente costituiti. Essa cioè non vuole irrobustirsi con l’annessione della psicoanalisi nella sua teoretica. Essa vuole liberare la psichiatria dalla gabbia del naturalismo ottocentesco che la rende scienza applicataalla classificazione e al trattamento delle malattie mentali. Binswanger non approda e non vuole approdare ad un nuovo sistema teorico, che invece rifiuta essendo il suo intento quello di “approfondire il significato e la validità del comprendere in psicopatologia” e fare così “ pulizia in quel cumulo caotico di indirizzi, di nozioni e di dati fattuali che costituiscono l’alienistica” 141
Cargnello mostra come il valore della psicoanalisi per l’approcciodi Binswanger sia costituito dal sostanziale superamento del suo originario naturalismo, al di là delle stesse autocomprensioni freudiane, in favore dalla conquista di un piano ermeneutico nell’analisi e nella comprensione della vita psichica. Tuttavia, nonostante ciò, “per la psicoanalisi è ben difficile rendersi pienamente conto in che cosa consista il suo deuten, il suo interpretare.” 142 La complessità di questo deuten si misura su più piani – dell’esperienza, del giudizio razionale, del comprendere psicologico- per convergere, verso l’universo esperenziale profondo del soggetto, cioè, nel linguaggio dell’antropoanalisi, verso il suo essere-nel-mondo, la cui irripetibile singolarità multidimensionale che viene fatta emergere da uno sguardo minuzioso e profondo vanifica ogni originario intento descrittivo-naturalistico. “E’ davvero sorprendente – nota Binswanger- dover constatare come l’approfondimento scientifico più intensivo della storia interiore, la sua più sistematica e paziente interpretazione psicologico-ermeneutica, e cioè la psicoanalisi, rappresenti in pari tempo il più rigido e puntiglioso tentativo dicondurre questa interpretazione in senso dinamico-funzionale, cioènaturalistico” 143
141 D,Cargnello, Dal naturalismo..,cit.,p.128.142Ib.,p.140.143 L.Binswanger, Il Caso Ellen West, p.135, cit.
237
Per Cargnello è proprio questa capacità della psicoanalisi ad indagare le dimensioni profonde della storia interiore che fa emergere il “come” del loro manifestarsi nella singolarità del soggetto. Nella psicoanalisi la fenomenologia della vita psichica scaturisce proprio da ciò che originariamente la nega, cioè da un naturalismo positivistico che vorrebbe descrivere oggettivamente eventi psichici, ma che poi finisce per offrirsi sia come ascolto-comprensione della polivocità dell’essere-nel-mondo, sia come produttrice-elaboratrice di sensi e significati dell’accadere psichico.Al di là delle sue stesse intenzioni, l’energetica freudiana finisce per attivare un’ermeneutica, così come accade, da altre prospettive, alla fenomenologia, il cui risultato finale, secondo Ricoeur “ è sfuggito al suo progetto iniziale, ed è suo malgrado che essa scopre, al posto del soggetto idealista chiuso nel suo sistema di significazioni, un essere vivente che ha da sempre comeorizzonte di tutti i suoi progetti un mondo, il mondo.”144 Le conclusioni a cui perviene Cargnello sono, nella sostanza, le stesse di Ricoeur: il valore e la forza della psicoanalisi è da ricercare proprio nella contraddittoria coesistenza di un’energetica e di un’ermeneutica. Questa comune concezione trova poi origine in una simile interpretazione del nesso tra accadimento ed erlebnis, dove il primosta per evento inaspettato ed improvviso e il secondo per modo diviverlo come un proprio evento. Cargnello, come poi farà Ricoeur, rifiuta il determinismo causalistico che istituisce nessi univoci tra loro in quanto “accadimenti, per quanto gravi per l’intriseco contenuto tematico, che costringano ineluttabilmente, con assolutacoattività l’individuo ‘a cui capitano’ all’assunzione di quel certo e non altro significato, come per un ineluttabile necessità,e che pertanto non possano non essere ritenuti causali di corrispondenti erlebnisse, non ne esistono.”145
Posto allora che tra accadimento ed erlebnis non c’è rapporto di causalità, cioè come nesso stimolo-risposta, nello stesso tempo, ènecessario non cadere nell’errore opposto, vale a dire nella totale dissoluzione soggettivistica dell’accaduto. Questo tipo di errore, per Cargnello ancora “più insidioso” di quello oggettivistico-causalistico, vede nell’individualità l’unica fonteche può dar senso all’evento, che di per sé non avrebbe alcun valore o sostanza.
144 P.Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, cit.,p.13145 D.Cargnello, cit.p.147
238
A partire dal riconoscimento che ogni uomo è dentro una rete di rapporti causali “oggettivi e naturali”, Cargnello, riprendendo Binswanger, ricorda come l’esperire (erleben) e l’accadere ( geschehen) siano correlativi ad una medesima costituzione ontologica. Lo sfondo immediato di tale prospettiva sul nesso io-mondo è, come è evidente, quello fenomenologico di Husserl. Infatti
“ l’antropoanalista non considera mai il contenuto dell’erlebnis come a sé stante, disgiunto dalla qualità modale che gli inerisce,da quella qualità fenomenica che ‘parla’ della presenza che l’ ha esperito. In breve, egli considera non già il nudo contenuto ma ilcontenuto nella sua intrinsecità fenomenica annunciatrice del mododi essere della presenza, del ‘chi’, del ‘come’ e del ‘mondo’ del suo trascendersi.”146
La ri-meditazione creativa della fenomenologia trascendentale avviene contestualmente alla ri-elaborazione dell’universo concettuale psicoanalitico come corpo teorico unitario che tematizza l’intersoggettività da prospettive mai prima rese possibili.Ed è proprio questa unità teoretica della psicoanalisi, secondo Cargnello - data sia dalla sua sistematicità ed ordine sia dall’assunzione di un principio unitario - che rende possibile e, nello stesso tempo, necessaria ed ineludibile un’attività riflessiva sulla soggettività, assente nella psichiatria come scienza applicata e come insieme non ordinato di psicopatologia, neurologia e biologia. Il valore dell’opera di Freud, da questo punto di vista, è stato quello di aver costruito una potente teoria (metapsicologia) che ha obbligato a pensare contro il suo stesso tendenziale riduzionismo naturalistico. Binswanger, psichiatra che ha saputo produttivamente cogliere le giuste sollecitazione da Husserl , ha saputo anche, nello stesso tempo, in qualità di allievo di Freud, procedere alla definizione della prospettiva della Daseinsanalyse sulla base di un rimando costitutivo,insieme teoretico e critico, alla psicoanalisi.147 Cargnello, introducendo a sua volta,Binswanger in Italia, focalizza l’attenzione degli psichiatri cui si rivolge verso la 146 Ibid.,p.151147 “Se Binswanger non avesse a lungo praticato la psicoanalisi, se non avesse per tanti anni diretto il suo sforzo critico sull’essenza della lezione e dei testi freudiani, probabilmente la stessa Daseinsanalyse non sarebbe stata formulata o, quanto meno, la sua apparizione sulla scena della cultura alienistica avrebbe ritardato di molto.” D.Cargnello, cit.,p.183
239
natura ermeneutica della psicoanalisi, evidente nonostante il suo autofraintendimento scientistico-naturalistico. Concepire la soggettività come intersoggettività fondata su un conflitto interno ed esterno (l’io si scontra con la realtà ostile sia del suo “interno paese straniero” sia di quello esterno) significa pensare l’uomo nella sua problematicità, cioè significa doverlo analizzare-comprendere attraverso un lavoro analitico-ermeneutico rivolto ad esplorare i modi e le forme inevitabilmente storiche diquesto conflitto. Anche se vi è una costante tensione alla riduzione naturalistica della vita psichica, la psicoanalisi si adopera alla sua esplorazione fenomenologica attraverso la considerazione e l’analisi dei suoi più minuti aspetti come i sogni, i lapsus,le fantasie, l’angoscia, ecc ..E’ però nella prospettiva antropoanalitica che con consapevolezza e determinazione si intende superare ogni residuo naturalismo: l’uomo diventa interamente uomo-esistenza, la cui presenza nel mondo si storicizza secondo modalità multidimensionali (Daseinsformen) che si aprono costitutivamente a metamorfosi e trasformazioni. La presenza, come progetto gettato, è, già da sempre, nel meta e nel trans della sua dynamis. Non c’è più un originario da afferrare e denominare con il linguaggio della metafisica. L’originario si dissolve nel suo essere incessantemente presente come differenza mai pensabile e classificabile preventivamente e come incessante oscillazione tra un altrove e un qui. L’originario è lì, immediatamente disponibilenella infinità della sua autoproduzione, nelle sempre nuove modalità storiche della sua gettatezza, nella”trascendenza in sé intranscendibile e costitutiva di ogni senso di vita” 148Cargnello legge in Binswanger soprattutto questa esigenza di comprendere l’essere-nel-mondo come poter –essere (Seinkönnen), contrariamente alla psicoanalisi che, invece, da una parte, indugia nella comprensione-interpretazione della modalità dell’esser-costretto-ad-essere (Seinmüssen) 149 e, dall’altra, elabora interpretazioni e propone mete emancipative dalla necessità
148 C.Sini, La mente e il corpo, Filosofia e Psicologia,Jaca book, Milano, 2004,p.92.149 Questo studio, incentrato su come vive in Binswanger la relazione Freud-Husserl, definita all’interno del rapporto conflittuale più vasto tra filosofia e psicologia, ha necessariamente escluso gli altri approcci possibili, e, anzi, necessari, alle questioni dibattute in queste ultime pagine che convergono, invariabilmente, sul tema decisivo, cioè la possibilità e la praticabilità di pensare il soggetto ( nella infinità della sua fenomenologia) fuori dall’orizzonte metafisico. Tra gli altri, qui si può solo ricordare la centralità degli interrogativi che scaturiscono, sullo sfondo del pensiero di Heidegger, dall’opera di Foucault e Derrida.
240
Si può allora, in conclusione di questo studio e in relazione all’opera di Cargnello, ricordare la natura etica di questa tensione teorica. I tentativi di porre in essere nuovi orizzonti di senso nella comprensione della relazione io-mondo, assumono valore etico in quanto esperienze teoriche che, nel loro accadere,trasformano ed accrescono la consapevolezza dell’uomo. Per Husserloccorre superare il “razionalismo erroneo” dell’obiettivismo e quindi ri-trovare il logos filosofico europeo come riflessione dell’umanità su se stessa, per Freud è necessario proseguire versoil pieno sviluppo dell’Io che bonifica, in un incessante conflitto,luoghi dominati dall’Es. Così, per entrambi, la coscienza diventa compito. Nel loro grande ‘allievo’ non confluisce solo l’approccio e l‘universo categorialedelle loro opere, peraltro creativamente rielaborato e rinnovato, ma anche, e più profondamente, la tensione etica che le muove quale forza agente originaria e fondamentale che consente a Binswanger di superare ogni riduzionismo naturalistico e di porsi di fronte al disagio psichico con un volto chiaro che sa ascoltarela domanda di senso in esso contenuta.
241