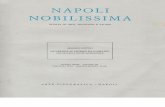F. Miraglia, C. Valente, Nuove acquisizioni sull’articolazione urbanistica del territorio di...
Transcript of F. Miraglia, C. Valente, Nuove acquisizioni sull’articolazione urbanistica del territorio di...
Terra Laboris
Itinerari di ricerca
10
FRANCESCO MIRAGLIA CORRADO VALENTE
NUOVE ACQUISIZIONI SULL’ARTICOLAZIONE URBANISTICADEL TERRITORIO DI CARINOLA ATTRAVERSO L’ANALISI
DELLE “MINUTE DI CAMPAGNA” DEL XIX SECOLO
CONCETTA DI LORENZO
LA LAICITà DELL’AVE GRATIA PLENA DI CARINOLA
ARMANDO CARAMANICA EDITORE
ARCHEOCLUB D’ITALIASEDE LOCALE DI CARINOLA
“PADRE MICHELE PICCIRILLO”
FRANCESCO MIRAGLIA CORRADO VALENTE
NUOVE ACQUISIZIONI SULL’ARTICOLAZIONE URBANISTICADEL TERRITORIO DI CARINOLA ATTRAVERSO L’ANALISI
DELLE “MINUTE DI CAMPAGNA” DEL XIX SECOLO
CONCETTA DI LORENZO
LA LAICITà DELL’AVE GRATIA PLENA DI CARINOLA
Terra Laboris
Itinerari di ricerca
10
ARMANDO CARAMANICA EDITORE
Terra Laboris. Itinerari di ricerca/10
Coordinamento scientifico:
Cesare Crova, Luigi D’Orta, Gennaro Leva, Antonietta Manco, Francesco Miraglia, Corrado Valente
Progetto grafico: Antonietta Manco
Prima edizione: dicembre 2013
ARMANDO CARAMANICA EDITORE
Via Appia, 762 - 04028 Marina di Minturno (LT) - Tel. e Fax 0771.680838
ISBN 978-88-7425-148-3
È vietata la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,anche ad uso interno e didattico, non autorizzata.
I quaderni «Terra Laboris. Itinerari di ricerca» mirano ad offrire un approfondimento critico sullecaratterizzazioni storico-architettoniche, socio-urbanistiche e tecnico-costruttive dell’articolatopanorama culturale dei territori afferenti all’antica provincia di Terra di Lavoro.
In questo quaderno ci si occupa, giovandosi di nuove acquisizioni, di analizzare le articolazioniurbanistiche del territorio di Carinola nel XIX secolo e lo status giuridico della chiesa dell’An-nunziata.
I N D I C E
Nuove acquisizioni sull’articolazione urbanistica del territorio di Carinolaattraverso l’analisi delle “minute di campagna” del XIX secolo p. 5Note p. 14La laicità dell’Ave Gratia Plena di Carinola p. 15Note p. 18
Francesco Miraglia, Corrado Valente
Nuove acquisizioni sull’articolazione urbanistica del territorio di Carinolaattraverso l’analisi delle “minute di campagna” del XIX secolo
Scopo del presente contributo è lumeggiare le caratteriz-zazioni delle cosiddette “minute di campagna”, che inte-ressano gran parte del contesto urbano e rurale diCarinola, nella prospettiva dell’individuazione di unnuovo filone di ricerca, utile a reperire ulteriori acquisi-zioni sulle peculiarità ancora poco note di questo inte-ressante territorio*.
La viabilità della Terra di CarinolaNel settembre 1814 Gioacchino Murat ordinò larealizzazione di una nuova carta topografica delregno, basata su regolari rilevamenti in scala1:20.000, realizzati tramite una nuova triangola-zione e concorrenti alla formazione di una tavolagenerale in scala 1:80.000. L’Officina Topogra-fica, fondata dal geografo e cartografo AntonioRizzi-Zannoni, divenne “Officio topografico”,alle dipendenze dello stato maggiore dell’eser-cito, alla cui direzione fu chiamato il generale Vi-sconti. La redazione della carta, però, a causa deirivolgimenti politici dell’epoca, iniziò solo a par-tire dal 1833 e, all’avvento dell’Unità d’Italia, nes-sun foglio era stato ancora pubblicato. Dellelevate al 20.000 sono custoditi 88 fogli a colori,unici superstiti, dopo che nel 1881 una commis-sione appositamente costituita li dichiarò inutili.
Il foglio 8 raffigura il territorio di Carinola,offrendone una visione esaustiva antecedentealle trasformazioni cui esso sarà sottoposto neglianni successivi. La cittadella risultava ancora bendelimitata dalle sue barriere artificiali, la cui ge-nesi risale verosimilmente alla dominazione lon-gobarda. Nella “minuta” in esame mancano peròporzioni del territorio, precisamente gli insedia-menti di Casale, Nocelleto e Ventaroli, ben indi-viduati, invece, nella “Carta dei dintorni diNapoli”, eseguita dall’Officio Topografico tra il1836 ed il 1840. Di questi, in particolare, Casaleera suddiviso in tre parti: Santo Janni, che si in-contrava giungendo da meridione, dalla stradache si staccava dal Real Cammino; Casale di Ca-rinola, posta a poca distanza verso settentrione;Vignali, la più piccola delle tre, posta al disopradi quest’ultima. Nocelleto, invece, risultava un in-sediamento compatto, sviluppato prevalente-mente lungo la via dell’Annunziata, nelle
vicinanze della chiesa parrocchiale e lungo il vicoAurora. Ventaroli, infine, veniva raffigurato comeun piccolo agglomerato urbano, attraversato dallastrada che, provenendo da San Ruosi, si dirigeva,come accade tuttora, verso il Real Cammino. Tor-nando alle “minute di campagna”, appare utiledefinirne di seguito le caratteristiche, analizzan-dole in riferimento ai luoghi urbani delineati.
Carinola (Fig. 1). Le mura urbane rappresen-tate sono in buona parte visibili ancora oggi, mamanca l’organizzazione intorno al castello. Adogni modo, attraverso la pianta si individua, aproposito del fortilizio, sostanzialmente quantodescritto nell’Apprezzo del feudo carinolese del1690: la struttura era circondata da un fossato,con un ponte che la collegava alla cittadella; laporta del castello era posta all’estremità setten-trionale, mentre quella dell’Annunziata tra lemura che cingevano l’ospedale e la grande torreche ancora oggi domina l’angolo sud-ovest. Laporta del Seggio, infine, era situata tra quest’ul-timo ed il mastio. L’unica porta di cui non si in-dividua chiaramente l’ubicazione è quella diSant’Andrea, anche se è ancora esistente l’anticastrada con ciottolato che da essa usciva per col-legare Carinola alle altre realtà urbane ed al “mo-lino della malerba”.
Accanto al sito che ospitava la porta si in-travede un corridoio murato su uno sperone tu-faceo, una sorta di cammino di ronda che,probabilmente, controllava l’ingresso. L’impiantourbanistico carinolese ritratto nelle “minute dicampagna” è riferibile ad epoca antecedente aglisventramenti che la cittadella subì nel XIX se-colo. Via dei Platani, passando al disopra dellavallata solcata dall’antica arteria stradale per Ca-sanova, si collegava alla vecchia strada interna,passando sul riempimento del fossato del ca-stello, a discapito delle mura che chiudevano lasua corte triangolare su quel versante. L’altra, ret-tilinea, giungeva da Santa Croce e, passando suun altro ponte, che superava la vallata frutto dellasecolare erosione operata dal rio Malerba, tagliavail fitto tessuto urbano medievale, per giungere allavecchia strada che, dal castello, conduceva allapiazza della cattedrale ed alla porta di Sant’An-
5
drea. All’incrocio tra le due vie un altro sventra-mento configurava piazza Osvaldo Mazza.
La strada che usciva dalla porta dell’Annun-ziata, superato il ponte ed il convento della Mad-
dalena, proseguiva (come peraltro avviene tut-tora) all’interno di due alte pareti tufacee, incon-trava un altro ponte e, poco dopo, subiva unadiramazione. Invece, la strada che si dirigeva
Fig. 1 – I.G.M., Minute originali di campagna..., Carinola(CE), ingrandimenti urbani. Periodi precedente (A) e suc-cessivo (B) allo sventramento operato nella seconda metàdel XIX secolo (elab. C. Valente).
6
Fig. 2 – I.G.M., Minute originali di campagna..., Carinola (CE),casali di Santa Croce e San Bartolomeo, ingrandimentourbano. Si noti la nuova strada provinciale Carinola-No-celleto, tuttora esistente (elab. C. Valente).
verso meridione – anch’essa all’interno di unagola tufacea – lambiva il rudere di una cappella dicui non si riesce ad individuare l’intitolazione. In-fine, la strada che continuava verso oriente, incon-
trava un’arteria che giungeva da meridione (ap-prossimativamente l’attuale via Novelli).
Santa Croce e San Bartolomeo (Fig. 2). Al-l’incrocio, la via per Capua – approssimativa-
7
Fig. 3 – I.G.M., Minute originali di campagna..., Carinola (CE),borgo di San Ruosi, ingrandimento urbano. In evidenza,l’insediamento (al centro) e le masserie Gentile (in alto), Ce-raldi (al centro) e Ciocchi (in basso). Si noti, altresì, la stradache collegava Carinola al Real Cammino (elab. C. Valente).
Fig. 4 – Carinola (CE), Episcopio di Ventaroli. In alto adestra è ben evidente il tracciato del Real Cammino.
mente ripresa dall’attuale strada comunale – pro-seguiva verso oriente e giungeva al borgo di SantaCroce, anche se in prossimità della chiesa parroc-chiale del piccolo abitato non seguiva il percorsoattuale, ma lambiva l’edificio sacro dall’altro lato,dove si apriva una porta, all’attualità murata.
In prossimità del largo antistante la chiesagiungeva anche la strada proveniente dall’abitatodi San Bartolomeo, posto a settentrione e pocodistante. Superata la piccola chiesa, poi, a destrauna strada conduceva ad alcune antiche abita-zioni ancora esistenti e probabilmente ad un’al-trettanto antica ed imponente masseria, anch’essaancora esistente, mentre ad oriente si dirigevaverso la frazione di Nocelleto, non rilevata.
San Ruosi (Fig. 3). La strada che giungevada sud (attuale via Novelli) proseguiva a setten-trione dove, come accade all’attualità, si staccavaun percorso secondario, diretto a San Donato.Continuava, con andamento diverso da quello at-tuale, fino a giungere all’abitato di San Ruosi, checosteggiava lungo il versante orientale, passandodavanti alla masseria Ceraldi. All’ingresso delborgo si staccava la strada che conduceva alla
masseria Gentile e lì, attraversato il tratto tra il pa-lazzo e la cappella, scendeva verso Carinola, pas-sando per la Cappella Vecchia sino a discendere– costeggiando il rio Malerba – nei pressi del con-vento della Maddalena. Dopo la masseria Ceraldila strada riprendeva il percorso attuale e, pocodopo, deviava verso la vicina masseria Ciocchi.
La carta, purtroppo, non riporta l’abitato diVentaroli ma solo l’Episcopio (Fig. 4), raggiun-gibile dal borgo soprastante e da una strada checollegava quest’ultimo col vicino Real Camminoin direzione Capua. La breve distanza dall’impor-tante strada vicereale dovette risultare particolar-mente favorevole per la chiesa parrocchiale diVentaroli, tale fino al 1722, anno della costru-zione della nuova parrocchiale dei santi Filippoe Giacomo. L’importanza del Real Cammino, pe-raltro, nelle “minute di campagna” è ben evi-dente, in considerazione della precisione con cuiesso viene raffigurato rispetto al resto della via-bilità del territorio carinolese.
Casanova (Fig. 5). L’abitato di questa fra-zione, come descritto nei vari documenti storici,era ben individuato attraverso tre nuclei separati:
8
Fig. 5 – I.G.M., Minute originali di campagna..., Carinola (CE),casale di Casanova, ingrandimenti urbani. Periodi prece-dente (A) e successivo (B) allo sventramento operato nellaseconda metà del XIX secolo (elab. C. Valente).
Carani, Lorenzi e Casanova. Carani, il primo chesi incontrava da sud, era il più grande. La stradaantica, proveniente da Falciano, all’inizio delborgo si divideva in tre rami: a destra, divenival’attuale via Budetti, al centro l’attuale via Appia,e, a sinistra, una strada che scendeva per colle-garsi alla via Vinella. Via Montano, all’incontrocon via Budetti, proseguiva per i campi e si col-legava anche con la strada che conduceva al con-vento di S. Francesco. La via centrale,denominata Appia, proseguiva invece in dire-zione rettilinea verso nord, tagliando in due ilborgo, per arrestarsi in prossimità di un canale,generato dall’azione erosiva delle acque discen-denti dalla Grancelsa che, trovando un terrenopoco compatto, avevano creato una profondadepressione nel tufo, oggi superata dal ponte cheunisce la zona di Cappelle con piazza De Rosa.
In questo punto vi era una diramazione: adoriente, la via che conduce al convento di SanFrancesco e a Carinola; ad Occidente, l’attualevia Troianiello, che costeggiava la chiesa parroc-chiale, uscendo in prossimità del campanile, dovescendeva incontrando via Vinella. Il versante set-tentrionale della chiesa, quindi, quando non eraancora affiancato dalla cappella della Confrater-nita del Purgatorio, costeggiava il grande canalenaturale. Li separava lo spazio corrispondenteall’attuale piano stradale, sino all’imbocco dellarampa di scale che conduce all’antica strada.
Queste due arterie, quindi, segnavano il li-mite a nord dell’abitato in quanto, come già rile-vato, vi era una depressione dovuta ad un canaleben visibile nella pianta. La chiesa di S. PietroApostolo appare come un elemento architetto-nico isolato dal contesto. La zona absidale, in-fatti, è lambita da una piccola strada che costeggiail versante meridionale e, in prossimità del cam-panile, si unisce con la rampa che da via Vinellaporta al sagrato attuale. Questo spiegherebbe per-ché la parte esterna della zona absidale dellachiesa, ancora visibile perché non occlusa dall’edi-ficio addossatole, presenta cornici in prossimitàdel basamento che continuano verso l’interno.
Oggi quello spazio è occupato da un edificionovecentesco che ospita al piano terra la Caritas
e al primo l’ufficio parrocchiale. Un palinsestomurario di questa porzione della chiesa era infattiben visibile nella sua interezza. La stradina con-sentiva, in sostanza, l’accesso all’edificio sacroanche dall’attuale traversa Troianiello, altrimentinon consentito perché la strada più avanti scen-deva e l’edificio sacro sul quel versante non sem-bra accessibile1. Dalla via Vinella, poi, altre duestrade entravano a Carani: la prima corrispondea parte della grande rampa di fronte via Mon-tano; la seconda è la piccola via del Pino, che sichiudeva all’interno di proprietà private. In pros-simità della Cappella di Santa Lucia, ai marginioccidentali del grande canale, una strada, supe-rato un ponte, si dirige verso piazza De Rosa,collegandosi al percorso principale che attraver-sava Casanova.
Sempre nella zona di Santa Lucia la stradagrande, superati due corsi d’acqua, con l’attualesalita giunge alle estremità dell’abitato di Casa-nova con un bivio. Ad occidente si evidenzia lastrada che, superato il ponte, conduce al borgodei Lorenzi ed alla Grancelsa; ad oriente attra-versa invece Casanova, lungo il versante setten-trionale e sino alla villa comunale, dove leabitazioni si sviluppano su entrambi i lati. Daquesta, poi, tramite vico Valle e vico Sciaudone,si entra nel corpo del casale. In prossimità dellazona Spinaruccoli, il borgo terminava con unabiforcazione: la strada ad oriente2, via Spinaruc-coli, giungeva alla porta del Castello; la strada asettentrione (attuale tratto di via Nazionale) pro-seguiva sino all’incrocio con parte dell’attuale viache conduce a Carinola. Non è segnata la stradapedemontana per Cascano, che attualmente siorigina in quel punto. L’immagine di Casanovaconsente anche di comprendere l’inizio dell’at-tuale via Nazionale, che, dall’imbocco con le vieAppia e Budetti, giunge in linea pressoché rettaa piazza De Rosa.
Si tratta, in sostanza, di un’operazione disventramento del borgo Carani, realizzata vero-similmente alla fine del XIX secolo, che lo sud-divise in due parti: la prima, costituita daproprietà private libere; la seconda, con inizio davia Budetti fino al vicolo del Pino, densa di abi-
9
tazioni separate dalla nuova sede stradale. All’im-bocco con via del Pino, la nuova Nazionale oc-cupa parte della sede di una stradina chegiungeva al limite dell’abitato, all’incrocio con learterie stradali che conducono rispettivamente alconvento francescano ed alla chiesa parrocchiale.Di lì, poi, tramite un grosso ponte, supera il ca-nale e si collega con le due strade provenienti daSanta Lucia e dai Lorenzi (piazza De Ruosi).Nella citata biforcazione la nuova strada seguel’attuale sede, sino a giungere al bivio per Cari-nola e Cascano. Da questo momento la vecchiaviabilità inizia lentamente a perdere la sua fun-zione e, quindi, ad essere abbandonata.
San Donato e Sant’Agnello (Fig. 6). I dueabitati si raggiungevano provenendo da Carinolada una strada che si staccava da quella che colle-gava la cittadella al borgo di San Ruosi. L’attualestrada è stata in parte realizzata sul tracciato diquella antica, limitatamente all’ingresso al casaledi San Donato. Quest’ultimo, poi, consiste dipoche abitazioni raggruppate ai lati di una pic-
cola strada che si conclude in una corte chiusa.Del resto, agli inizi dell’Ottocento gli abitanti deidue casali erano 2803. La strada succitata, tra l’al-tro, in prossimità dell’abitato si immetteva in unincrocio: a nord, dava origine all’arteria che lam-biva il borgo e conduceva a Sant’Agnello; a sud,alla strada per San Bartolomeo; ad est, invece, aquella per Nocelleto.
Prima di giungere al secondo casale, si in-contrava in un largo la chiesa parrocchiale, fattaedificare dal vescovo Della Marra agli inizi delSettecento. Poco distante, sulla sinistra, si ri-trova l’abitato di Sant’Agnello, anch’esso costi-tuito da uno scarso numero di abitazioni,disposte ai lati di una strada che si collegava allaprincipale e, fuori l’abitato, subiva una dirama-zione: a nord, per la masseria Bove; ad ovest,per i campi. La strada principale, invece, prose-guiva sino a raggiungere il Real Cammino, pocodistante dai due abitati.
San Salvatore (Fig. 7). L’amena collina vieneraffigurata indicandone l’originaria strada che,
10
Fig. 6 – I.G.M., Minute originali di campagna..., Carinola (CE),San Donato (in basso) e Sant’Angello (in alto), ingrandi-mento urbano.
staccandosi da quella principale da Casanova perFalciano, la costeggiava sul versante orientale,giungendo direttamente sotto il terrapieno delconvento ed alla rampa di scale che conducevaalla chiesa. Nel XIX secolo la struttura era pro-prietà della famiglia Saraceni, che la sistemò, adi-bendola a “casino abitabile” e coltivando lacollina a vigneto ed agrumeto4.
Il territorio carinolese mostrava anche unafitta trama di strade secondarie, che mettevanoin collegamento le strutture agricole ed i terrenicon l’ambiente urbano. Tra le prime, oltre alle giàcitate grandi masserie poste a San Ruosi, si ritro-vano anche: una masseria tuttora esistente, all’an-golo tra la via dell’Annunziata e la strada checonduceva a San Ruosi; la masseria Barrera, adovest della cittadella carinolese; la citata masseriaCiocchi, di minori dimensioni rispetto a quella diSan Ruosi; la masseria Bove, a nord del casale diSant’Agnello; la masseria Sant’Arcangelo, pocodistante dal convento di S. Francesco; le masserieFava e Bergamino, ad oriente rispetto ai casali di
San Bartolomeo e San Donato; la masseria Sar-racino, lungo la strada secondaria che da SantaCroce conduceva a Nocelleto; le masserie Di-nella e Angiolillo, in territorio di Falciano. Eranopoi presenti nel territorio il “molino della Ma-lerba”, a sud di Carinola, lungo il rio da cui traevail nome in prossimità del ponte dell’Abbazia edil “molino delli Spinaruccoli”, ad est della collinadi San Francesco, lungo la strada che dalla portadel castello conduceva a Casanova. Poco distanteda Nocelleto vi era, poi, la peschiera, in prossi-mità della cava Ciaraldi.
La raffigurazione del castello di CarinolaConsistenti in rilievi delineati a colori nel periodo1801-50 in scala 1:20.000, le “minute” sono staterinvenute negli archivi dell’Istituto GeograficoMilitare (I.G.M.)5 e rappresentano una porzionedella “Carta del Reame di Napoli” (Fig. 8). Comeaccennato, analizzate da un’apposita commis-sione nel 1881 furono considerate inutilizzabili,
11
Fig. 7 – I.G.M., Minute originali di campagna..., Carinola(CE), collina di San Salvatore, ingrandimento urbano. Inevidenza, l’omonimo convento, oggi ormai allo stato dirudere imponente.
perché, con tutta evidenza, non ritenute deltutto funzionali ad una corretta definizione dellacomplessità del territorio che si prefiggevano didescrivere.
Questi grafici, mai prima d’ora compiuta-mente anatomizzati, pur se caratterizzati da evi-denti inesattezze – soprattutto per quantoriguarda la delineazione del tessuto edilizio dellediverse realtà esaminate, in molti tratti incompiutao palesemente errata rispetto alla sua reale consi-stenza – appaiono comunque utili allo scopo diarricchire in via ulteriore la conoscenza dell’anticoassetto dell’ager Falernus, di cui il territorio carino-lese rappresenta un peculiare distretto.
L’analisi delle “minute”, relativamente alladelineazione della cittadella di Carinola, fa emer-gere diversi interessanti particolari, soprattuttocirca il castello, oggi in gran parte allo stato dirudere. In esse, infatti, è proposta una rappre-sentazione del fortilizio leggermente diversa ri-spetto a quelle note, contenute nelle mappestilate nei decenni successivi a quella esaminatae culminate nel più preciso e dettagliato catastod’impianto6.
Ha interesse constatare, anzitutto, comenelle “minute di campagna” il fortilizio sia statoraffigurato facendo ricorso ad una chiara formageometrica triangolare, con ingresso sulla fronteovest ed un’articolazione planimetrica che, mas-simamente, rispetta quella reale; ciò che differi-sce con le rappresentazioni seriori, invece, è ilrapporto tra pieni e vuoti, qui enfatizzato sullefronti sud e nord.
Sulla fronte sud, infatti, si evidenzia unampio spazio scoperto, una sorta di belvedere,scandito dai grevi muri posti a destra e a sinistra,purtroppo all’attualità non più riscontrabile. Sullafronte est, invece, il castello era – come peraltrogià ampiamente noto – protetto dal fossato, sulquale dominava l’alto mastio. Su questo lato eraposto anche uno degli ingressi alla cittadella piùimportanti dal punto di vista strategico, al qualesi perveniva dalle antiche vie per Capua e perSessa, dopo aver impegnato un ponte che tra-guardava uno dei due corsi d’acqua che circon-dano Carinola: il rio Pozzano.
A nord, invece, si segnala una figura geome-trica non campita, a differenza di quelle indicanti
Fig. 8 – I.G.M., Minute originali di campagna..., Carinola (CE),ingrandimento urbano. Si notino il castello, a nord, e la cat-tedrale, posta nel quadrante meridionale della cittadella.
12
Fig. 9 – I.G.M., Carinola, foto aerea, 1942 (part.). Si noti,evidenziato in grigio, il bastione poligonale posto sullafronte nord del castello (da M. ROSI, Carinola. Pompeiquattrocentesca, Napoli 1979).
i fabbricati, disegnata con la forma di un perfettoesagono, posta al culmine della struttura. Essa è,con tutta evidenza, un’iniziale costruzione graficautile a delineare un bastione poligonale – riferi-bile all’età moderna – unito al castello.
La presenza di questo bastione è rilevabileosservando una foto aerea degli anni quaranta delNovecento, sempre riferibile all’I.G.M.7, che ne ri-trae in linea di massima – essendo purtroppo sfo-cata – le caratteristiche planimetriche (Fig. 9). Lasingolare struttura, che presenta il vertice orien-tato a settentrione, oggi non più esistente, è se-gnalata da una breccia muraria posta sul murod’ambito del castello (Fig. 10).
In occasione dello sventramento operatonella seconda metà del XIX secolo (Figg. 1 e11), una porzione del fortilizio, in corrispon-denza della fronte ovest – probabilmente già allostato di semi-rudere – fu realisticamente abbat-tuta per l’allargamento dell’arteria di collega-mento viario che attraversava longitudinalmentegran parte della cittadella in direzione nord-sud,per poi cambiare rotta e dirigersi verso est, co-steggiando l’area della cattedrale e raccordan-
dosi, infine, con una delle strade che conduce-vano all’esterno del sito.
L’utilità delle “minute di campagna”, perquanto riguarda il caso qui indagato, è dunqueda ricercarsi nella delineazione dell’assetto del ca-stello in epoca antecedente alla distruzione diparte della sua fronte ovest. Allo stato attualedella ricerca, però, di null’altro si dispone peravallare, soprattutto in termini documentari, que-sti recenti ed interessanti riscontri. Sotto questoprofilo, l’importanza delle campagne di rilievo siconfigura in particolare perché, sinora, esse rap-presentano l’unica delineazione grafica del ca-stello nella sua interezza, oggi ormai perduta.
Ne deriva che, pur essendo incomplete econsegnando innegabili inesattezze – giustificatedal fatto che si tratta di disegni allo stato embrio-nale – colmano un vuoto documentario, of-frendo agli studiosi del composito territoriofalerno la possibilità di condurre l’analisi di unaporzione del fortilizio non più esistente, aprendoulteriori fronti di ricerca, soprattutto in ordinealla fase post-medievale delle sue complesse vi-cende storico-costruttive.
13
Fig. 10 – Carinola (CE), castello, fronte est, muro d’am-bito. In evidenza, la breccia muraria riferibile al bastioneun tempo posto in corrispondenza della fronte nord dellastruttura castellare.
Fig. 11 – Carinola (CE), stralcio della mappa catastaled’impianto (1881-1907). Il castello è contrassegnato dallaparticella 6. Archivio Agenzia del Territorio di Caserta,Mappa di Carinola, Sezione Urbana.
Note:
* Pur nella piena collaborazione tra gli autori, si segnala cheF. Miraglia ha redatto il paragrafo La raffigurazione del castello di
Carinola e C. Valente quello La viabilità della Terra di Carinola.
1 La realizzazione della rampa di scale, con la quale dallatraversa si scende sino a via Vinella-Santa Lucia, è serioreal rilievo preso in esame.2 All’inizio di questa strada sorge un edificio riferibile alXV secolo che esibisce un interessante portale di foggiacatalana.
3 L. MENNA, Saggio istorico della città di Carinola (rist. anast. acura di A. Marini Ceraldi), I, Scauri 1980, p. 101.4 L. MENNA, op. cit., II, p. 125.5 I.G.M., Minute originali di campagna delle levate al 20.000 peril Foglio 18 della Carta del Reame di Napoli alla scala di 1:80.000- Carinola, file A0001889.6 Nella mappa catastale d’impianto (1881-1907) si può no-tare la pianta del castello, indicato con la particella 6, conla fronte est ancora integra. Della porzione prospiciente lastrada, invece, non vi è traccia (Archivio Agenzia del Ter-ritorio di Caserta, Mappa di Carinola, Sezione Urbana).7 La foto è rinvenibile in M. Rosi, Carinola. Pompei quattro-centesca, Napoli 1979, p. 147.
14
Stampato nel mese di dicembre 2013presso le ARTI GRAFICHE CARAMANICA
Via Appia, 814 - tel. 0771.680838MARINA DI MINTURNO (Latina)