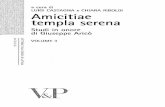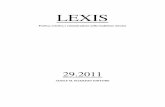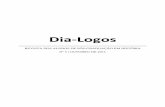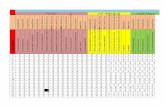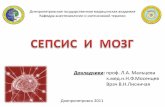Modelli omerici nell'Alcesti di Euripide: testo e intertesto
Euripide, da Bibliothéke (2011)
Transcript of Euripide, da Bibliothéke (2011)
Euripide
Euri
pide
Lrsquoautore e le opere
La vita
Euripide (Εὐριπίδης) nacque a Salamina secondo alcune fonti nel 480 (in re-lazione a un sincronismo per cui sarebbe nato in quello stesso giorno della
battaglia di Salamina a cui Eschilo prese parte e che Sofocle avrebbe celebrato guidando la danza per la vittoria) ma piugrave probabilmente secondo la cronologia del Marmor Parium (forse perograve anchrsquoessa viziata dal sincronismo con la prima vittoria di Eschilo) nel 485-484 Il padre Mnesarco o Mnesarchide e la ma-dre Clito erano del demo di Phyle e dovevano essere benestanti se il giovane Euripide (che si dedicograve al pancrazio al pugilato e alla pittura) ebbe un ruolo di danzatore e tedoforo nel culto di Apollo Zosterio
La tradizione biografica egrave rappresentata dal peripatetico Satiro di Callatide il cui bios euripideo ci egrave stato in parte conservato da P Oxy 1176 e da alcune Vite anonime presenti in codici del XIV secolo Ed egrave ricca di aneddoti inattendibili spesso risalenti agli scherni e alle malignitagrave dei commediografi che dei suoi genitori fecero un bottegaio e unrsquoerbivendola e raccontarono delle infelici espe-rienze matrimoniali del poeta prima con Melito e poi con Cherine Secondo il clicheacute romanzesco tratteggiato da Satiro (fr 39 col IX rr 4-19) amava ritirarsi spesso a Salamina in una grotta aperta sul mare per meditare e comporre i suoi drammi laquoavendo ripudiato tutto ciograve che non fosse grande ed elevatoraquo (cfr anche la Vita anonima 5 e Aulo Gellio XV 20)
Anche prescindendo dalla dubbia notizia di unrsquoaccusa di empietagrave mossagli da Cle-one il rapporto fra Euripide e il suo pubblico fu caratterizzato da incomprensioni e insuccessi ottenne il suo primo coro nel 455 con la tetralogia di cui facevano parte le Peliadi ma conquistograve il primo premio non prima del 441 a questa vittoria ne sa-rebbero seguite solo altre tre oltre a una postuma con la trilogia che comprendeva Ifigenia in Aulide Alcmeone a Corinto e Baccanti presentata dal figlio o nipote omonimo poche se si pensa alle 23 tetralogie per le quali avrebbe ottenuto il coro
La biografia caricaturale
di ascendenza comica
Il controverso rapporto
con il pubblico
420 EURIPIDE
Euri
pide
420420 EE
1 Del 405 a C2 Invero Dioniso egrave una di quelle figure mitiche e divine che assumono diversi aspetti Arriano avverte che gli Ateniesi venerano un altro Dioniso rispetto a quello tebano figlio di Zeus e Semele Il dio ateniese egrave figlio di Zeus e di Core e il canto Iacco dei misteri viene intonato a questo non a quello tebano (Anabasi di Ales-sandro 2 16 3) Anche Nietzsche riconosce questa duplicitagrave ldquoDal sorriso di questo Dioniso sono nati gli degravei olimpici dalle sue lacrime gli uomini In quellrsquoesistenza in quanto dio smembrato Dioniso ha la doppia natura di un demone crudele e selvagio e di un dominatore mite e dolcerdquo (La nascita della tragedia p 72)Cosigrave forse si spiega la differenza tra il Dioniso feroce delle Baccanti e quello di Omero cui allude Nietzsche un dio impaurito (Iliade 6 135 Diwvnuso~ de fobhqeiv~) e infantile che minacciato da Licurgo si getta in mare dove Tetide lo accolse in seno spaventato e tremante per le grida dellrsquouomo feroce Poi crsquoegrave il Dioniso pauroso e ridicolo delle Rane di Aristofane Questo dio fugge terrorizzato da Empusa tra le braccia del suo sacerdote (v 297) quindi viene apostrofato dal servo Xantia con ldquooh tu davvero il piugrave vigliacco degli degravei e degli uominirdquo(v 486) Il dio se lrsquoera voluta cacandosi addosso dalla paura (v 479) nd r3 F Nietzsche La nascita della tragedia pp 85 e ss
La nascita della tragedia di Nietzsche euripide egrave il poeta del socratismo estetico
Lrsquoautore della Medea sarebbe stato discepolo di Anassagora e amico di Socrate secondo una tradizione critica priva per quanto ne sappiamo di fondamenti sicuri che lo assimila ai filosofi contemporanei e lo considera il portavoce della sofistica Secondo questa ldquovulgatardquo nessuna certezza quasi nessun punto fermo egrave possibile trovare nelle sue tra-gedie animate da eterni cercatori di qualche cosa che non trovano Euripide e alcuni dei suoi personaggi non avrebbero nemmeno la certezza della vita e della morte Nel Frisso (fr 833) e nel Poliido (fr 638) compare una famosa questione laquochi sa se il vivere non sia essere morti ed essere morti invece laggiugrave non venga considerato vivereraquoSotto il segno della sofistica Euripide arebbe dunque imparato a dubitare di tutto Anche la storia del sodalizio con Socrate e addirittura della loro complicitagrave che Nietzsche considera foriera di morte per la tragedia classica parte da Aristofane il quale nelle Rane fa dire al coro soddisfatto per la vittoria di Eschilo su Euripide laquobella cosa egrave dunque non stare seduto a chiacchierare con Socrate disprezzando la musica e trascurando la grandezza dellrsquoarte tragicaraquo (vv 1492-1496)Sentiamo la rielaborazione di Nietzsche laquoSe abbiamo dunque riconosciuto che Euripide non riuscigrave in genere a fondare il dramma soltanto sullrsquoapollineo che anzi la sua tendenza antidionisiaca si sviograve in una tendenza naturalistica e non artistica potremo ormai avvicinarci allrsquoessenza del socratismo estetico la cui legge suprema suona a un dipresso laquoTutto deve essere razionale per essere belloraquo come propo-sizione parallela al socratico laquosolo chi sa egrave virtuosoraquo Con questo canone alla mano Euripide misurograve ogni particolare rettificandolo secondo tale legge la lingua i caratteri la costruzione drammaturgica la musica corale Ciograve che noi sogliamo tanto spesso imputare a Euripide come difetto e regresso poetico in confronto alla tragedia sofoclea egrave per lo piugrave il prodotto di quellrsquoincalzante processo critico di quella temeraria razionalitagravehellip Euripide si accinse a mostrare al mondo come anche fece Platone lrsquoopposto del poeta laquoirragionevoleraquo il suo principio estetico laquotutto deve essere cosciente per essere belloraquo egrave come ho detto la proposizione parallela al precetto socratico laquotutto deve essere cosciente per essere buo-noraquo Per conseguenza Euripide puograve essere da noi considerato come il poeta del socratismo estetico Ma Socrate era quel secondo spettatore che non capiva la tragedia antica e perciograve non lrsquoapprezzava in lega con lui Euripide osograve essere lrsquoaraldo di una nuova creazione artistica Se a causa di essa la tragedia antica perigrave il principio micidiale fu dunque il socratismo estetico in quanto peraltro la lotta era rivolta contro il dionisiaco dellrsquoarte antica riconosciamo in Socrate lrsquoavversario di Dioniso il nuovo Orfeo che si leva contro Dioniso e bencheacute destinato a essere dilaniato dalle Menadi del tribunale ateniese costringe alla fuga lo stesso potentissimo dio Questrsquoultimo come nel tempo in cui era fuggito di fronte al re degli Edoni Licurgo si salva nelle profonditagrave del mare cioegrave nei flutti mistici di un culto segreto che a poco a poco invaderagrave il mondo interoraquo
[da G Ghiselli Euripide Medea Cappelli Bologna 2008]
LA FABBriCA deLLe idee
421
Euri
pide
421421LrsquoAUTORE E LE OPERE
Il dato concorda con i 92 drammi che gli vengono attribuiti da altre fonti tre dei quali perograve considerati spuricirc giagrave nellrsquoantichitagrave mentre anche lrsquoautenticitagrave del Reso egrave stata giustamente messa in dubbio in etagrave modernaEuripide avrebbe anche composto un epinicio per una vittoria olimpica con la quadriga ottenuta da Alcibiade forse nel 416 del quale ci restano alcuni versi (fr 3 Diehl3) e un epigramma per i caduti ateniesi a Siracusa
La frequentazione dei grandi intellettuali del suo tempo ndash Anassagora Prodi-co Protagora ndash che la tradizione indicava come suoi maestri se anche in talu-ni casi poteacute essere intensa non va considerata nella luce di legami di scuola
Come Eschilo morigrave fuori di Atene donde partigrave subito dopo la primavera del 408 (data di rappresentazione dellrsquoOreste) per recarsi dapprima a Magnesia e poi a Pella in Macedonia presso la corte del sovrano Archelao fra i cui ospiti furono anche il tragico Agatone il ditirambografo Timoteo e il pittore Zeuxis Fra gli aneddoti sorti in margine alla sua morte si diceva che fosse stato sbra-nato da cani molossi nati da un cane da caccia che per intervento del poeta Archelao non aveva punito e che la sua tomba o il suo cenotafio ad Atene sulla via del Pireo fosse stato colpito da un fulmineLa notizia della morte del poeta fu conosciuta ad Atene nella primavera del 406 prima delle Grandi Dionisie ed egrave credibile la notizia secondo cui Sofo-cle in occasione del proagone si sarebbe presentato vestito a lutto e avrebbe fatto sfilare coreuti e attori senza corona
Le opere
Di Euripide sopravvive oltre a numerosissimi frammenti anche di notevo-le estensione un corpus di 19 drammi (compresi il Reso probabilmente
spurio e un dramma satiresco il Ciclope) La cronologia egrave nota con sicurezza solo per lrsquoAlcesti rappresentata nel 438 per la Medea (431) lrsquoIppolito inco-ronato (428) le Troiane (415) lrsquoElena (412) lrsquoOreste (408) e con qualche approssimazione per le Fenicie (fra 411 e 409) dellrsquoIfigenia in Aulide e delle Baccanti giagrave si egrave detto che furono rappresentate postume
Per la datazione delle altre si fa riferimento ai dati piugrave svariati dalle allusio-ni della commedia contemporanea ai riferimenti agli avvenimenti politici dallrsquoanalisi stilistica a quella metrica alla quale ultima si deve un ausilio abbastanza attendibile da quando Th Zielinski riconobbe la tendenza di Eu-ripide ad aumentare progressivamente nel corso della sua produzione le so-luzioni e le sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico
Le opere attribuite
La conoscenza degli intellettuali
dellrsquoepoca
La morte fra realtagrave e aneddotica
Cronologia sicurahellip
hellipe ricostruita con criteri interni
422 EURIPIDE
Euri
pide
422422 EE
i drammi superstiti
Alcesti
LrsquoAlcesti (Ἄλκηστις) egrave il piugrave antico dramma che di Euripide ci sia pervenuto pur appartenendo giagrave alla maturitagrave del poeta (438 aC) Nella tetralogia di cui
faceva parte ndash insieme con Cretesi Alcmeone a Psofide e Telefo ndash e che ottenne il secondo premio occupava il quarto posto una anomalia quella di porre in luogo del dramma satiresco una tragedia sia pure a lieto fine che non dovette essere isolata nella produzione euripideaViene qui ripresa una leggenda costruita sui due motivi folclorici della sposa che offre la vita per il marito e della lotta di un eroe col demone della morte (giagrave il tragico Frinico aveva portato in scena la figura del demone Thaacutenatos)
Al principio del dramma ambientato a Fere in Tessaglia Apollo che presta servizio presso il re Admeto per espiare lo sterminio dei Ciclopi e dal quale Admeto stesso ha ottenuto di poter prolungare la propria vita purcheacute qualcuno si offra di morire al suo posto racconta che solo la sposa di Admeto Alcesti si egrave dichiarata pronta a morire mentre neppure gli anziani genitori del sovrano hanno voluto dare la propria vita in cambio di quella del figlio Ora che egrave arrivato il momento supremo interviene Thaacutenatos il demone della morte a re-clamare la sua vittima e Apollo si allontana Il coro formato da vecchi cittadini di Fere entra nellrsquoorchestra in preda allrsquoansia per la sorte di Alcesti e viene informato da unrsquoan-cella che allrsquointerno della casa la donna si sta congedando dalla famiglia e dai servi Entrano in scena i due coniugi Alcesti sostenuta dal marito egrave in preda a una visione in cui le sembra che lo stesso Caronte (il traghettatore dei morti) la chiami per lrsquoultimo viaggio (vv 244-279) Adornata come a festa essa prende congedo da tutti soprattutto dai figli e dal letto nuziale rimasta poi sola col marito lo supplica in nome del sacrifi-
tram
a
T1
Loutrophoacuteros apula della cerchia del Pittore di Dario 350-325 aC Provenienza sconosciuta ora a Basilea Antikenmuseum Rappresentazioni del mito di Alcesti sono rare nonostante lrsquointeresse per la storia promosso dallrsquoomonima tragedia di Euripide (andata in scena nel 438 aC) Allrsquointerno del palazzo reale di Fere in Tessaglia suggerito dalle due colon-ne che sorreggono il frontone Alcesti egrave seduta sul letto nuziale Egrave il momento traumatico del commiato A sinistra egrave il marito Admeto stante e drappeggiato nellrsquohimaacutetion che porta una ma-no alla fronte in segno di tristezza La sovrappo-sizione con il dramma euripideo si ferma qui i personaggi vicini non sono i suoceri di Alcesti A destra egrave la vecchia nutrice il suo sguardo egrave ab-bassato mentre con la mano si sorregge il mento in segno di dolore Dietro di lei il pedagogo vec-chio e canuto si appoggia a un bastone Al centro Alcesti ndash lrsquounica figura di cui sia indicato il nome (ordmAlkhstiv) ndash sta salutando per lrsquoultima volta i figli In disparte ad arricchire il quadro sono due serve lrsquouna porta sulla spalla un cesto di vimini lrsquoaltra ha un nastro e un ventaglio
423
Euri
pide
423423I DRAMMI SUPERSTITI
cio che ha fatto per lui di non risposarsi e non dare ai figli una matrigna che potrebbe addirittura odiarli se dalle seconde nozze ne nascessero altri Dopo il commo Admeto promette solennemente alla moglie che non si risposeragrave anzi che si faragrave forgiare da un artista unrsquoimmagine di Alcesti che terragrave sempre con se per avere lrsquoillusione di avere ancora la moglie a fianco poi lo sfinimento assale definitiva-mente Alcesti che viene portata via da Thanatos lasciando la reggia immersa nel luttoIntanto Eracle nel suo peregrinare ha bussato per chiedere ospitalitagrave e Admeto pur immerso nel lutto non puograve venire meno ai doveri di ospite e lo accoglie nella sua casa senza rivelargli la sorte di Alcesti Eracle si rifocilla mangiando e bevendo senza rite-gno mentre giagrave si preparano le esequie Admeto riceve allora la visita del padre Ferete venuto a piangere la nuora il colloquio degenera ben presto in violento alterco nel quale Admeto rimprovera lrsquoegoismo del vecchio che non ha voluto sacrificarsi per il proprio figlio spingendolo ad accettare il sacrificio di Alcesti ma Ferete ribatte a tutte le accuse ritorcendo sul figlio lrsquoaccusa di egoismo Padre e figlio si separano pieni di rancore Quando tutti i personaggi e gli stessi coreuti si sono avviati per accompagnare il fune-rale si presenta in scena Eracle ormai sazio del pranzo che viene a conoscenza della veritagrave dal racconto di un servo Decide allora di ricambiare la generositagrave dellrsquoamico e parte alla volta dellrsquoAde per strappare Alcesti a Thaacutenatos Di ritorno dalle esequie Admeto si abbandona alla piugrave cupa disperazione solo ora ela-bora il significato della sciagura che gli egrave capitata con la perdita della moglie e lamenta la solitudine in cui egrave stato precipitato Solo ora sembra rendersi conto che la vita per lui non ha piugrave scopo Nellrsquoesodo ritorna Eracle con una donna coperta da un velo che egli dice aver conqui-stato come premio in una gara di lotta chiede quindi allrsquoamico di trattenerla con seacute e ospitarla nella reggia fino al suo ritorno Admeto in un primo tempo rifiuta ma si vede costretto a cedere alle insistenze dellrsquoeroe Sollevato il velo la donna si rivela essere Alcesti restituita alla vita dopo essere stata strappata da Eracle alle grinfie di Thana-tos Cosigrave mentre Eracle riparte per le sue avventure i due sposi rientrano a palazzo di nuovo uniti
Tragedia dai contorni quanto mai sfuggenti e passibile di interpretazioni contraddittorie lrsquoAlcesti egrave stata additata da Platone (Simposio 179-180) co-me un fulgido esempio di dedizione e di φιλία da parte della protagonista a dimostrazione di come solo chi ama egrave disposto a sacrificare la vita per la persona amata Complementare alla φιλία egrave la virtugrave dellrsquoospitalitagrave peculiare di Admeto e delle persone a lui piugrave vicine sotto il segno dellrsquoospitalitagrave si apre il dramma nel congedo di Apollo dalla dimora che lo ha accolto per un anno e alla fine della vicenda lrsquoospitalitagrave concessa a Eracle saragrave elemento risolutivo
Indissolubilmente legato a questi vi egrave il tema della gloria che costituisce mo-vente fondamentale dellrsquoazione per i personaggi (ad esclusione di Ferete) nel κλέος rivendicato in primo luogo dalla protagonista si puograve individuare quel prestigio che deriva dal riconoscimento sociale della virtugrave che costituisce un surrogato dellrsquoimmortalitagrave e un compenso postumo dopo la riduzione dellrsquoindi-viduo al nulla
T2
Tragedia della φιλία e dellrsquoospitalitagravehellip
hellipdella gloriahellip
424 EURIPIDE
Euri
pide
424424 EE
In questa ldquostranardquo tragedia ha centralitagrave drammatica soprattutto il problema della morte destino comune degli uomini che viene evidenziato proprio da quellrsquouni-cum ldquomiracolosordquo costituito dalla resurrezione della protagonista Il confronto con la morte ha effetto rivelatore del carattere delle persone consentendo di ve-rificare la consistenza dei legami famigliari e sociali coloro che sembrano φίλοι o che tali si rivelavano a parole di fronte alla morte dimostrano la loro vera natura di esseri tenacemente attaccati alla propria ψυχή a scapito di quella altrui anche a costo di perpetuare unrsquoesistenza ingloriosa (un destino che accomuna Admeto e Ferete nella grettezza del loro scontro verbale) Nel delirio di Alcesti davanti al terribile laquodemone alatoraquo emerge lrsquoaspetto ambi-valente dellrsquoaldilagrave che da una parte sottrae le gioie della vita oscurando la luce del sole ma dallrsquoaltra prospetta una insensibilitagrave liberatoria dal dolore (οὐδέν ἐσθ᾽ ὁ κατθανών laquochi muore non egrave piugrave nullaraquo osserva Alcesti al v 380) che colloca il defunto in una condizione privilegiata rispetto ai suoi cari costretti a perpetuare un πόθος (laquostruggimento di desiderioraquo) destinato a rimanere inap-pagato Per loro rimane lrsquoinsipida consolazione ndash che egrave anche un ldquodovererdquo ndash di perpetuare il ricordo degli estinti o tuttrsquoal piugrave la laquofredda gioiaraquo di abbracciare simulacri che restituiscono vane parvenzelaquoIl motivo centrale della tragedia ndash secondo le parole di C M J Sicking ndash egrave il carattere limitato di ogni potere umano lrsquouomo non vinceragrave mai la morte sacrifi-carsi per un altro non ha dunque sensoraquo Il dono divino offerto a un essere umano di laquosfuggire al κύριον ἧμαρ sostituendo un altro al suo posto si rivela fallimen-tare la vita di chi resta dopo aver accettato il sacrificio dei propri φίλοι egrave pura esistenza biologica ἀβίωτον χρόνον (vv 242-3)raquo (S Barbantani)
Medea
Egrave singolare come una tragedia dellrsquoaltezza della Medea (Μήδεια) rappresentata nel 431 insieme con Filottete Dictys e Mietitori ottenesse solo il terzo premio
Euripide ha rielaborato una vecchia tradizione cultuale secondo la quale Medea nel tentativo di rendere immortali i propri figli li avrebbe involontariamente uccisi nel tempio di Era Akraia a Corinto Probabilmente egli egrave stato il primo a introdurre lrsquoinfanticidio perpetrato dalla maga della Colchide contro il marito Giasone anche se non si puograve dire definitivamente risolta la questione del rap-porto cronologico fra la sua Medea e la Medea di Neofrone al quale ndash secondo lrsquoopinione del peripatetico Dicearco riportata dallrsquoargumentum ndash spetterebbe la prioritagrave ma i resti del dramma di Neofrone sembrano indicarne un imitatore di Euripide
Lrsquoazione si svolge a Corinto dove reduci dalla Colchide vivono Medea e Giaso-ne Allrsquoinizio del dramma dopo il prologo espositivo recitato dalla nutrice si odono dallrsquointerno della casa le grida di Medea per il tradimento di Giasone che ora intende sposare Glauce la giovane principessa figlia di Creonte sovrano di Corinto Ma poi dopo i lamenti e le invettive Medea compare in scena con mutato atteggiamento e
hellip e del comportamento umano davanti
alla morte
tram
a
425
Euri
pide
425425I DRAMMI SUPERSTITI
parla con grande luciditagrave alle donne corinzie che compongono il coro dellrsquouniversale condizione della donna e della propria personale vicenda Ella egrave giagrave decisa a vendicarsi del marito ma ancora ignora la via per tradurre in azione il suo impulso Innanzi tutto si assicura il silenzio del coro poi in un dialogo con Creonte riesce a ottenere che il bando di espulsione da Corinto da cui egrave stata colpita sia differito di un giorno Segue un tumultuoso dialogo con Giasone dopo il quale insperatamente Medea trova un decisivo alleato nel sovrano ateniese Egeo che egrave di passaggio a Corinto reduce da Delfi (dove ha interrogato lrsquooracolo) egli si offre di ospitarla in Atene e farla sua spo-sa e cosigrave Medea puograve elaborare un piano minutamente articolato Incontra nuovamente Giasone e finge di volersi riconciliare con lui anche per evitare lrsquoesilio almeno ai loro figli E in questa prospettiva invia tramite loro un dono a Glauce ndash una veste e un dia-dema ndash che in realtagrave grazie alle sue arti di maga ha trasformato in strumenti di morteDopo un canto corale i fanciulli tornano dalla loro missione ora Medea sa che Glauce egrave perduta e che per portare al suo ultimo stadio lrsquoatroce vendetta che ha meditato deve uccidere le sue stesse creature Le ragioni della vendetta e dellrsquoamore materno si alter-nano e si scontrano in un grande monologo (vv 1021-1080)Dopo il monologo giunge un messaggero che riferisce della terribile morte di Glauce e dello stesso Creonte entrambi arsi dalle fiamme che si sono sprigionate da veste e diadema Medea rientra in casa e dopo un breve interludio corale si odono dallrsquointerno le grida dei figli colpiti a morte Giasone accorso puograve solo esprimere la sua rabbia frustrata mentre Medea sul carro del Sole srsquoinvola portando con seacute le salme dei figli
Il dramma si articola in una struttura a dittico nella prima parte il desiderio di vendetta di Medea egrave focalizzato contro i diretti responsabili della sventura Giasone Glauce e Creonte nella seconda parte il piano si delinea in maniera sottilmente atroce per colpire Giasone non nella sua persona ma nella sua di-scendenza sia attuale (i figli che ha avuto con Medea) sia futura (quelli che non potragrave mai avere da Glauce)
Chiave della tragedia egrave il cuore (thumos) di Medea al contempo moglie ripudia-ta madre e maga personaggio caratterizzato dalle stigmate di una ldquodiversitagraverdquo che egrave acuita dalla condizione stessa di essere donna e straniera che agli occhi degli spettatori ateniesi la rende unica nella sua solitudine di emarginata Tutti gli altri personaggi escono annientati dal confronto con la grandezza solitaria della personalitagrave di Medea che presenta tratti comuni con i grandi eroi sofoclei e in particolare Aiace col quale condivide sentimenti vissuti in modo esasperato orgoglio ira amore della gloria timore dello scherno del nemico
Al contempo Medea egrave modello di personaggio complesso in cui raziocinio e irrazionalitagrave coesistono in direzione antisocratica la conoscenza razionale non porta al bene e alla sua conseguente attuazione ma diviene strumento per raffor-zare un impulso incoercibile verso il male hellipe il significato del dramma Molto si egrave discusso sul significato profondo del dramma nel quale lrsquoinfanticidio attraverso il quale si consuma la vendetta non ha effetto liberatorio Anche lrsquoAgamennone eschileo si era fatto carnefice della figlia ma nel caso di Agamennone la costrizione derivava da un oracolo ed era esterna alla volontagrave del personaggio in Medea la decisione avviene allrsquointerno
T2
La struttura a dittico
Il thumos di Medea
La lotta tra ragione e irrazionalitagravehellip
426 EURIPIDE
Euri
pide
426426 EE
in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000
Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre
Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea
appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas
Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo
LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
420 EURIPIDE
Euri
pide
420420 EE
1 Del 405 a C2 Invero Dioniso egrave una di quelle figure mitiche e divine che assumono diversi aspetti Arriano avverte che gli Ateniesi venerano un altro Dioniso rispetto a quello tebano figlio di Zeus e Semele Il dio ateniese egrave figlio di Zeus e di Core e il canto Iacco dei misteri viene intonato a questo non a quello tebano (Anabasi di Ales-sandro 2 16 3) Anche Nietzsche riconosce questa duplicitagrave ldquoDal sorriso di questo Dioniso sono nati gli degravei olimpici dalle sue lacrime gli uomini In quellrsquoesistenza in quanto dio smembrato Dioniso ha la doppia natura di un demone crudele e selvagio e di un dominatore mite e dolcerdquo (La nascita della tragedia p 72)Cosigrave forse si spiega la differenza tra il Dioniso feroce delle Baccanti e quello di Omero cui allude Nietzsche un dio impaurito (Iliade 6 135 Diwvnuso~ de fobhqeiv~) e infantile che minacciato da Licurgo si getta in mare dove Tetide lo accolse in seno spaventato e tremante per le grida dellrsquouomo feroce Poi crsquoegrave il Dioniso pauroso e ridicolo delle Rane di Aristofane Questo dio fugge terrorizzato da Empusa tra le braccia del suo sacerdote (v 297) quindi viene apostrofato dal servo Xantia con ldquooh tu davvero il piugrave vigliacco degli degravei e degli uominirdquo(v 486) Il dio se lrsquoera voluta cacandosi addosso dalla paura (v 479) nd r3 F Nietzsche La nascita della tragedia pp 85 e ss
La nascita della tragedia di Nietzsche euripide egrave il poeta del socratismo estetico
Lrsquoautore della Medea sarebbe stato discepolo di Anassagora e amico di Socrate secondo una tradizione critica priva per quanto ne sappiamo di fondamenti sicuri che lo assimila ai filosofi contemporanei e lo considera il portavoce della sofistica Secondo questa ldquovulgatardquo nessuna certezza quasi nessun punto fermo egrave possibile trovare nelle sue tra-gedie animate da eterni cercatori di qualche cosa che non trovano Euripide e alcuni dei suoi personaggi non avrebbero nemmeno la certezza della vita e della morte Nel Frisso (fr 833) e nel Poliido (fr 638) compare una famosa questione laquochi sa se il vivere non sia essere morti ed essere morti invece laggiugrave non venga considerato vivereraquoSotto il segno della sofistica Euripide arebbe dunque imparato a dubitare di tutto Anche la storia del sodalizio con Socrate e addirittura della loro complicitagrave che Nietzsche considera foriera di morte per la tragedia classica parte da Aristofane il quale nelle Rane fa dire al coro soddisfatto per la vittoria di Eschilo su Euripide laquobella cosa egrave dunque non stare seduto a chiacchierare con Socrate disprezzando la musica e trascurando la grandezza dellrsquoarte tragicaraquo (vv 1492-1496)Sentiamo la rielaborazione di Nietzsche laquoSe abbiamo dunque riconosciuto che Euripide non riuscigrave in genere a fondare il dramma soltanto sullrsquoapollineo che anzi la sua tendenza antidionisiaca si sviograve in una tendenza naturalistica e non artistica potremo ormai avvicinarci allrsquoessenza del socratismo estetico la cui legge suprema suona a un dipresso laquoTutto deve essere razionale per essere belloraquo come propo-sizione parallela al socratico laquosolo chi sa egrave virtuosoraquo Con questo canone alla mano Euripide misurograve ogni particolare rettificandolo secondo tale legge la lingua i caratteri la costruzione drammaturgica la musica corale Ciograve che noi sogliamo tanto spesso imputare a Euripide come difetto e regresso poetico in confronto alla tragedia sofoclea egrave per lo piugrave il prodotto di quellrsquoincalzante processo critico di quella temeraria razionalitagravehellip Euripide si accinse a mostrare al mondo come anche fece Platone lrsquoopposto del poeta laquoirragionevoleraquo il suo principio estetico laquotutto deve essere cosciente per essere belloraquo egrave come ho detto la proposizione parallela al precetto socratico laquotutto deve essere cosciente per essere buo-noraquo Per conseguenza Euripide puograve essere da noi considerato come il poeta del socratismo estetico Ma Socrate era quel secondo spettatore che non capiva la tragedia antica e perciograve non lrsquoapprezzava in lega con lui Euripide osograve essere lrsquoaraldo di una nuova creazione artistica Se a causa di essa la tragedia antica perigrave il principio micidiale fu dunque il socratismo estetico in quanto peraltro la lotta era rivolta contro il dionisiaco dellrsquoarte antica riconosciamo in Socrate lrsquoavversario di Dioniso il nuovo Orfeo che si leva contro Dioniso e bencheacute destinato a essere dilaniato dalle Menadi del tribunale ateniese costringe alla fuga lo stesso potentissimo dio Questrsquoultimo come nel tempo in cui era fuggito di fronte al re degli Edoni Licurgo si salva nelle profonditagrave del mare cioegrave nei flutti mistici di un culto segreto che a poco a poco invaderagrave il mondo interoraquo
[da G Ghiselli Euripide Medea Cappelli Bologna 2008]
LA FABBriCA deLLe idee
421
Euri
pide
421421LrsquoAUTORE E LE OPERE
Il dato concorda con i 92 drammi che gli vengono attribuiti da altre fonti tre dei quali perograve considerati spuricirc giagrave nellrsquoantichitagrave mentre anche lrsquoautenticitagrave del Reso egrave stata giustamente messa in dubbio in etagrave modernaEuripide avrebbe anche composto un epinicio per una vittoria olimpica con la quadriga ottenuta da Alcibiade forse nel 416 del quale ci restano alcuni versi (fr 3 Diehl3) e un epigramma per i caduti ateniesi a Siracusa
La frequentazione dei grandi intellettuali del suo tempo ndash Anassagora Prodi-co Protagora ndash che la tradizione indicava come suoi maestri se anche in talu-ni casi poteacute essere intensa non va considerata nella luce di legami di scuola
Come Eschilo morigrave fuori di Atene donde partigrave subito dopo la primavera del 408 (data di rappresentazione dellrsquoOreste) per recarsi dapprima a Magnesia e poi a Pella in Macedonia presso la corte del sovrano Archelao fra i cui ospiti furono anche il tragico Agatone il ditirambografo Timoteo e il pittore Zeuxis Fra gli aneddoti sorti in margine alla sua morte si diceva che fosse stato sbra-nato da cani molossi nati da un cane da caccia che per intervento del poeta Archelao non aveva punito e che la sua tomba o il suo cenotafio ad Atene sulla via del Pireo fosse stato colpito da un fulmineLa notizia della morte del poeta fu conosciuta ad Atene nella primavera del 406 prima delle Grandi Dionisie ed egrave credibile la notizia secondo cui Sofo-cle in occasione del proagone si sarebbe presentato vestito a lutto e avrebbe fatto sfilare coreuti e attori senza corona
Le opere
Di Euripide sopravvive oltre a numerosissimi frammenti anche di notevo-le estensione un corpus di 19 drammi (compresi il Reso probabilmente
spurio e un dramma satiresco il Ciclope) La cronologia egrave nota con sicurezza solo per lrsquoAlcesti rappresentata nel 438 per la Medea (431) lrsquoIppolito inco-ronato (428) le Troiane (415) lrsquoElena (412) lrsquoOreste (408) e con qualche approssimazione per le Fenicie (fra 411 e 409) dellrsquoIfigenia in Aulide e delle Baccanti giagrave si egrave detto che furono rappresentate postume
Per la datazione delle altre si fa riferimento ai dati piugrave svariati dalle allusio-ni della commedia contemporanea ai riferimenti agli avvenimenti politici dallrsquoanalisi stilistica a quella metrica alla quale ultima si deve un ausilio abbastanza attendibile da quando Th Zielinski riconobbe la tendenza di Eu-ripide ad aumentare progressivamente nel corso della sua produzione le so-luzioni e le sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico
Le opere attribuite
La conoscenza degli intellettuali
dellrsquoepoca
La morte fra realtagrave e aneddotica
Cronologia sicurahellip
hellipe ricostruita con criteri interni
422 EURIPIDE
Euri
pide
422422 EE
i drammi superstiti
Alcesti
LrsquoAlcesti (Ἄλκηστις) egrave il piugrave antico dramma che di Euripide ci sia pervenuto pur appartenendo giagrave alla maturitagrave del poeta (438 aC) Nella tetralogia di cui
faceva parte ndash insieme con Cretesi Alcmeone a Psofide e Telefo ndash e che ottenne il secondo premio occupava il quarto posto una anomalia quella di porre in luogo del dramma satiresco una tragedia sia pure a lieto fine che non dovette essere isolata nella produzione euripideaViene qui ripresa una leggenda costruita sui due motivi folclorici della sposa che offre la vita per il marito e della lotta di un eroe col demone della morte (giagrave il tragico Frinico aveva portato in scena la figura del demone Thaacutenatos)
Al principio del dramma ambientato a Fere in Tessaglia Apollo che presta servizio presso il re Admeto per espiare lo sterminio dei Ciclopi e dal quale Admeto stesso ha ottenuto di poter prolungare la propria vita purcheacute qualcuno si offra di morire al suo posto racconta che solo la sposa di Admeto Alcesti si egrave dichiarata pronta a morire mentre neppure gli anziani genitori del sovrano hanno voluto dare la propria vita in cambio di quella del figlio Ora che egrave arrivato il momento supremo interviene Thaacutenatos il demone della morte a re-clamare la sua vittima e Apollo si allontana Il coro formato da vecchi cittadini di Fere entra nellrsquoorchestra in preda allrsquoansia per la sorte di Alcesti e viene informato da unrsquoan-cella che allrsquointerno della casa la donna si sta congedando dalla famiglia e dai servi Entrano in scena i due coniugi Alcesti sostenuta dal marito egrave in preda a una visione in cui le sembra che lo stesso Caronte (il traghettatore dei morti) la chiami per lrsquoultimo viaggio (vv 244-279) Adornata come a festa essa prende congedo da tutti soprattutto dai figli e dal letto nuziale rimasta poi sola col marito lo supplica in nome del sacrifi-
tram
a
T1
Loutrophoacuteros apula della cerchia del Pittore di Dario 350-325 aC Provenienza sconosciuta ora a Basilea Antikenmuseum Rappresentazioni del mito di Alcesti sono rare nonostante lrsquointeresse per la storia promosso dallrsquoomonima tragedia di Euripide (andata in scena nel 438 aC) Allrsquointerno del palazzo reale di Fere in Tessaglia suggerito dalle due colon-ne che sorreggono il frontone Alcesti egrave seduta sul letto nuziale Egrave il momento traumatico del commiato A sinistra egrave il marito Admeto stante e drappeggiato nellrsquohimaacutetion che porta una ma-no alla fronte in segno di tristezza La sovrappo-sizione con il dramma euripideo si ferma qui i personaggi vicini non sono i suoceri di Alcesti A destra egrave la vecchia nutrice il suo sguardo egrave ab-bassato mentre con la mano si sorregge il mento in segno di dolore Dietro di lei il pedagogo vec-chio e canuto si appoggia a un bastone Al centro Alcesti ndash lrsquounica figura di cui sia indicato il nome (ordmAlkhstiv) ndash sta salutando per lrsquoultima volta i figli In disparte ad arricchire il quadro sono due serve lrsquouna porta sulla spalla un cesto di vimini lrsquoaltra ha un nastro e un ventaglio
423
Euri
pide
423423I DRAMMI SUPERSTITI
cio che ha fatto per lui di non risposarsi e non dare ai figli una matrigna che potrebbe addirittura odiarli se dalle seconde nozze ne nascessero altri Dopo il commo Admeto promette solennemente alla moglie che non si risposeragrave anzi che si faragrave forgiare da un artista unrsquoimmagine di Alcesti che terragrave sempre con se per avere lrsquoillusione di avere ancora la moglie a fianco poi lo sfinimento assale definitiva-mente Alcesti che viene portata via da Thanatos lasciando la reggia immersa nel luttoIntanto Eracle nel suo peregrinare ha bussato per chiedere ospitalitagrave e Admeto pur immerso nel lutto non puograve venire meno ai doveri di ospite e lo accoglie nella sua casa senza rivelargli la sorte di Alcesti Eracle si rifocilla mangiando e bevendo senza rite-gno mentre giagrave si preparano le esequie Admeto riceve allora la visita del padre Ferete venuto a piangere la nuora il colloquio degenera ben presto in violento alterco nel quale Admeto rimprovera lrsquoegoismo del vecchio che non ha voluto sacrificarsi per il proprio figlio spingendolo ad accettare il sacrificio di Alcesti ma Ferete ribatte a tutte le accuse ritorcendo sul figlio lrsquoaccusa di egoismo Padre e figlio si separano pieni di rancore Quando tutti i personaggi e gli stessi coreuti si sono avviati per accompagnare il fune-rale si presenta in scena Eracle ormai sazio del pranzo che viene a conoscenza della veritagrave dal racconto di un servo Decide allora di ricambiare la generositagrave dellrsquoamico e parte alla volta dellrsquoAde per strappare Alcesti a Thaacutenatos Di ritorno dalle esequie Admeto si abbandona alla piugrave cupa disperazione solo ora ela-bora il significato della sciagura che gli egrave capitata con la perdita della moglie e lamenta la solitudine in cui egrave stato precipitato Solo ora sembra rendersi conto che la vita per lui non ha piugrave scopo Nellrsquoesodo ritorna Eracle con una donna coperta da un velo che egli dice aver conqui-stato come premio in una gara di lotta chiede quindi allrsquoamico di trattenerla con seacute e ospitarla nella reggia fino al suo ritorno Admeto in un primo tempo rifiuta ma si vede costretto a cedere alle insistenze dellrsquoeroe Sollevato il velo la donna si rivela essere Alcesti restituita alla vita dopo essere stata strappata da Eracle alle grinfie di Thana-tos Cosigrave mentre Eracle riparte per le sue avventure i due sposi rientrano a palazzo di nuovo uniti
Tragedia dai contorni quanto mai sfuggenti e passibile di interpretazioni contraddittorie lrsquoAlcesti egrave stata additata da Platone (Simposio 179-180) co-me un fulgido esempio di dedizione e di φιλία da parte della protagonista a dimostrazione di come solo chi ama egrave disposto a sacrificare la vita per la persona amata Complementare alla φιλία egrave la virtugrave dellrsquoospitalitagrave peculiare di Admeto e delle persone a lui piugrave vicine sotto il segno dellrsquoospitalitagrave si apre il dramma nel congedo di Apollo dalla dimora che lo ha accolto per un anno e alla fine della vicenda lrsquoospitalitagrave concessa a Eracle saragrave elemento risolutivo
Indissolubilmente legato a questi vi egrave il tema della gloria che costituisce mo-vente fondamentale dellrsquoazione per i personaggi (ad esclusione di Ferete) nel κλέος rivendicato in primo luogo dalla protagonista si puograve individuare quel prestigio che deriva dal riconoscimento sociale della virtugrave che costituisce un surrogato dellrsquoimmortalitagrave e un compenso postumo dopo la riduzione dellrsquoindi-viduo al nulla
T2
Tragedia della φιλία e dellrsquoospitalitagravehellip
hellipdella gloriahellip
424 EURIPIDE
Euri
pide
424424 EE
In questa ldquostranardquo tragedia ha centralitagrave drammatica soprattutto il problema della morte destino comune degli uomini che viene evidenziato proprio da quellrsquouni-cum ldquomiracolosordquo costituito dalla resurrezione della protagonista Il confronto con la morte ha effetto rivelatore del carattere delle persone consentendo di ve-rificare la consistenza dei legami famigliari e sociali coloro che sembrano φίλοι o che tali si rivelavano a parole di fronte alla morte dimostrano la loro vera natura di esseri tenacemente attaccati alla propria ψυχή a scapito di quella altrui anche a costo di perpetuare unrsquoesistenza ingloriosa (un destino che accomuna Admeto e Ferete nella grettezza del loro scontro verbale) Nel delirio di Alcesti davanti al terribile laquodemone alatoraquo emerge lrsquoaspetto ambi-valente dellrsquoaldilagrave che da una parte sottrae le gioie della vita oscurando la luce del sole ma dallrsquoaltra prospetta una insensibilitagrave liberatoria dal dolore (οὐδέν ἐσθ᾽ ὁ κατθανών laquochi muore non egrave piugrave nullaraquo osserva Alcesti al v 380) che colloca il defunto in una condizione privilegiata rispetto ai suoi cari costretti a perpetuare un πόθος (laquostruggimento di desiderioraquo) destinato a rimanere inap-pagato Per loro rimane lrsquoinsipida consolazione ndash che egrave anche un ldquodovererdquo ndash di perpetuare il ricordo degli estinti o tuttrsquoal piugrave la laquofredda gioiaraquo di abbracciare simulacri che restituiscono vane parvenzelaquoIl motivo centrale della tragedia ndash secondo le parole di C M J Sicking ndash egrave il carattere limitato di ogni potere umano lrsquouomo non vinceragrave mai la morte sacrifi-carsi per un altro non ha dunque sensoraquo Il dono divino offerto a un essere umano di laquosfuggire al κύριον ἧμαρ sostituendo un altro al suo posto si rivela fallimen-tare la vita di chi resta dopo aver accettato il sacrificio dei propri φίλοι egrave pura esistenza biologica ἀβίωτον χρόνον (vv 242-3)raquo (S Barbantani)
Medea
Egrave singolare come una tragedia dellrsquoaltezza della Medea (Μήδεια) rappresentata nel 431 insieme con Filottete Dictys e Mietitori ottenesse solo il terzo premio
Euripide ha rielaborato una vecchia tradizione cultuale secondo la quale Medea nel tentativo di rendere immortali i propri figli li avrebbe involontariamente uccisi nel tempio di Era Akraia a Corinto Probabilmente egli egrave stato il primo a introdurre lrsquoinfanticidio perpetrato dalla maga della Colchide contro il marito Giasone anche se non si puograve dire definitivamente risolta la questione del rap-porto cronologico fra la sua Medea e la Medea di Neofrone al quale ndash secondo lrsquoopinione del peripatetico Dicearco riportata dallrsquoargumentum ndash spetterebbe la prioritagrave ma i resti del dramma di Neofrone sembrano indicarne un imitatore di Euripide
Lrsquoazione si svolge a Corinto dove reduci dalla Colchide vivono Medea e Giaso-ne Allrsquoinizio del dramma dopo il prologo espositivo recitato dalla nutrice si odono dallrsquointerno della casa le grida di Medea per il tradimento di Giasone che ora intende sposare Glauce la giovane principessa figlia di Creonte sovrano di Corinto Ma poi dopo i lamenti e le invettive Medea compare in scena con mutato atteggiamento e
hellip e del comportamento umano davanti
alla morte
tram
a
425
Euri
pide
425425I DRAMMI SUPERSTITI
parla con grande luciditagrave alle donne corinzie che compongono il coro dellrsquouniversale condizione della donna e della propria personale vicenda Ella egrave giagrave decisa a vendicarsi del marito ma ancora ignora la via per tradurre in azione il suo impulso Innanzi tutto si assicura il silenzio del coro poi in un dialogo con Creonte riesce a ottenere che il bando di espulsione da Corinto da cui egrave stata colpita sia differito di un giorno Segue un tumultuoso dialogo con Giasone dopo il quale insperatamente Medea trova un decisivo alleato nel sovrano ateniese Egeo che egrave di passaggio a Corinto reduce da Delfi (dove ha interrogato lrsquooracolo) egli si offre di ospitarla in Atene e farla sua spo-sa e cosigrave Medea puograve elaborare un piano minutamente articolato Incontra nuovamente Giasone e finge di volersi riconciliare con lui anche per evitare lrsquoesilio almeno ai loro figli E in questa prospettiva invia tramite loro un dono a Glauce ndash una veste e un dia-dema ndash che in realtagrave grazie alle sue arti di maga ha trasformato in strumenti di morteDopo un canto corale i fanciulli tornano dalla loro missione ora Medea sa che Glauce egrave perduta e che per portare al suo ultimo stadio lrsquoatroce vendetta che ha meditato deve uccidere le sue stesse creature Le ragioni della vendetta e dellrsquoamore materno si alter-nano e si scontrano in un grande monologo (vv 1021-1080)Dopo il monologo giunge un messaggero che riferisce della terribile morte di Glauce e dello stesso Creonte entrambi arsi dalle fiamme che si sono sprigionate da veste e diadema Medea rientra in casa e dopo un breve interludio corale si odono dallrsquointerno le grida dei figli colpiti a morte Giasone accorso puograve solo esprimere la sua rabbia frustrata mentre Medea sul carro del Sole srsquoinvola portando con seacute le salme dei figli
Il dramma si articola in una struttura a dittico nella prima parte il desiderio di vendetta di Medea egrave focalizzato contro i diretti responsabili della sventura Giasone Glauce e Creonte nella seconda parte il piano si delinea in maniera sottilmente atroce per colpire Giasone non nella sua persona ma nella sua di-scendenza sia attuale (i figli che ha avuto con Medea) sia futura (quelli che non potragrave mai avere da Glauce)
Chiave della tragedia egrave il cuore (thumos) di Medea al contempo moglie ripudia-ta madre e maga personaggio caratterizzato dalle stigmate di una ldquodiversitagraverdquo che egrave acuita dalla condizione stessa di essere donna e straniera che agli occhi degli spettatori ateniesi la rende unica nella sua solitudine di emarginata Tutti gli altri personaggi escono annientati dal confronto con la grandezza solitaria della personalitagrave di Medea che presenta tratti comuni con i grandi eroi sofoclei e in particolare Aiace col quale condivide sentimenti vissuti in modo esasperato orgoglio ira amore della gloria timore dello scherno del nemico
Al contempo Medea egrave modello di personaggio complesso in cui raziocinio e irrazionalitagrave coesistono in direzione antisocratica la conoscenza razionale non porta al bene e alla sua conseguente attuazione ma diviene strumento per raffor-zare un impulso incoercibile verso il male hellipe il significato del dramma Molto si egrave discusso sul significato profondo del dramma nel quale lrsquoinfanticidio attraverso il quale si consuma la vendetta non ha effetto liberatorio Anche lrsquoAgamennone eschileo si era fatto carnefice della figlia ma nel caso di Agamennone la costrizione derivava da un oracolo ed era esterna alla volontagrave del personaggio in Medea la decisione avviene allrsquointerno
T2
La struttura a dittico
Il thumos di Medea
La lotta tra ragione e irrazionalitagravehellip
426 EURIPIDE
Euri
pide
426426 EE
in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000
Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre
Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea
appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas
Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo
LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
421
Euri
pide
421421LrsquoAUTORE E LE OPERE
Il dato concorda con i 92 drammi che gli vengono attribuiti da altre fonti tre dei quali perograve considerati spuricirc giagrave nellrsquoantichitagrave mentre anche lrsquoautenticitagrave del Reso egrave stata giustamente messa in dubbio in etagrave modernaEuripide avrebbe anche composto un epinicio per una vittoria olimpica con la quadriga ottenuta da Alcibiade forse nel 416 del quale ci restano alcuni versi (fr 3 Diehl3) e un epigramma per i caduti ateniesi a Siracusa
La frequentazione dei grandi intellettuali del suo tempo ndash Anassagora Prodi-co Protagora ndash che la tradizione indicava come suoi maestri se anche in talu-ni casi poteacute essere intensa non va considerata nella luce di legami di scuola
Come Eschilo morigrave fuori di Atene donde partigrave subito dopo la primavera del 408 (data di rappresentazione dellrsquoOreste) per recarsi dapprima a Magnesia e poi a Pella in Macedonia presso la corte del sovrano Archelao fra i cui ospiti furono anche il tragico Agatone il ditirambografo Timoteo e il pittore Zeuxis Fra gli aneddoti sorti in margine alla sua morte si diceva che fosse stato sbra-nato da cani molossi nati da un cane da caccia che per intervento del poeta Archelao non aveva punito e che la sua tomba o il suo cenotafio ad Atene sulla via del Pireo fosse stato colpito da un fulmineLa notizia della morte del poeta fu conosciuta ad Atene nella primavera del 406 prima delle Grandi Dionisie ed egrave credibile la notizia secondo cui Sofo-cle in occasione del proagone si sarebbe presentato vestito a lutto e avrebbe fatto sfilare coreuti e attori senza corona
Le opere
Di Euripide sopravvive oltre a numerosissimi frammenti anche di notevo-le estensione un corpus di 19 drammi (compresi il Reso probabilmente
spurio e un dramma satiresco il Ciclope) La cronologia egrave nota con sicurezza solo per lrsquoAlcesti rappresentata nel 438 per la Medea (431) lrsquoIppolito inco-ronato (428) le Troiane (415) lrsquoElena (412) lrsquoOreste (408) e con qualche approssimazione per le Fenicie (fra 411 e 409) dellrsquoIfigenia in Aulide e delle Baccanti giagrave si egrave detto che furono rappresentate postume
Per la datazione delle altre si fa riferimento ai dati piugrave svariati dalle allusio-ni della commedia contemporanea ai riferimenti agli avvenimenti politici dallrsquoanalisi stilistica a quella metrica alla quale ultima si deve un ausilio abbastanza attendibile da quando Th Zielinski riconobbe la tendenza di Eu-ripide ad aumentare progressivamente nel corso della sua produzione le so-luzioni e le sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico
Le opere attribuite
La conoscenza degli intellettuali
dellrsquoepoca
La morte fra realtagrave e aneddotica
Cronologia sicurahellip
hellipe ricostruita con criteri interni
422 EURIPIDE
Euri
pide
422422 EE
i drammi superstiti
Alcesti
LrsquoAlcesti (Ἄλκηστις) egrave il piugrave antico dramma che di Euripide ci sia pervenuto pur appartenendo giagrave alla maturitagrave del poeta (438 aC) Nella tetralogia di cui
faceva parte ndash insieme con Cretesi Alcmeone a Psofide e Telefo ndash e che ottenne il secondo premio occupava il quarto posto una anomalia quella di porre in luogo del dramma satiresco una tragedia sia pure a lieto fine che non dovette essere isolata nella produzione euripideaViene qui ripresa una leggenda costruita sui due motivi folclorici della sposa che offre la vita per il marito e della lotta di un eroe col demone della morte (giagrave il tragico Frinico aveva portato in scena la figura del demone Thaacutenatos)
Al principio del dramma ambientato a Fere in Tessaglia Apollo che presta servizio presso il re Admeto per espiare lo sterminio dei Ciclopi e dal quale Admeto stesso ha ottenuto di poter prolungare la propria vita purcheacute qualcuno si offra di morire al suo posto racconta che solo la sposa di Admeto Alcesti si egrave dichiarata pronta a morire mentre neppure gli anziani genitori del sovrano hanno voluto dare la propria vita in cambio di quella del figlio Ora che egrave arrivato il momento supremo interviene Thaacutenatos il demone della morte a re-clamare la sua vittima e Apollo si allontana Il coro formato da vecchi cittadini di Fere entra nellrsquoorchestra in preda allrsquoansia per la sorte di Alcesti e viene informato da unrsquoan-cella che allrsquointerno della casa la donna si sta congedando dalla famiglia e dai servi Entrano in scena i due coniugi Alcesti sostenuta dal marito egrave in preda a una visione in cui le sembra che lo stesso Caronte (il traghettatore dei morti) la chiami per lrsquoultimo viaggio (vv 244-279) Adornata come a festa essa prende congedo da tutti soprattutto dai figli e dal letto nuziale rimasta poi sola col marito lo supplica in nome del sacrifi-
tram
a
T1
Loutrophoacuteros apula della cerchia del Pittore di Dario 350-325 aC Provenienza sconosciuta ora a Basilea Antikenmuseum Rappresentazioni del mito di Alcesti sono rare nonostante lrsquointeresse per la storia promosso dallrsquoomonima tragedia di Euripide (andata in scena nel 438 aC) Allrsquointerno del palazzo reale di Fere in Tessaglia suggerito dalle due colon-ne che sorreggono il frontone Alcesti egrave seduta sul letto nuziale Egrave il momento traumatico del commiato A sinistra egrave il marito Admeto stante e drappeggiato nellrsquohimaacutetion che porta una ma-no alla fronte in segno di tristezza La sovrappo-sizione con il dramma euripideo si ferma qui i personaggi vicini non sono i suoceri di Alcesti A destra egrave la vecchia nutrice il suo sguardo egrave ab-bassato mentre con la mano si sorregge il mento in segno di dolore Dietro di lei il pedagogo vec-chio e canuto si appoggia a un bastone Al centro Alcesti ndash lrsquounica figura di cui sia indicato il nome (ordmAlkhstiv) ndash sta salutando per lrsquoultima volta i figli In disparte ad arricchire il quadro sono due serve lrsquouna porta sulla spalla un cesto di vimini lrsquoaltra ha un nastro e un ventaglio
423
Euri
pide
423423I DRAMMI SUPERSTITI
cio che ha fatto per lui di non risposarsi e non dare ai figli una matrigna che potrebbe addirittura odiarli se dalle seconde nozze ne nascessero altri Dopo il commo Admeto promette solennemente alla moglie che non si risposeragrave anzi che si faragrave forgiare da un artista unrsquoimmagine di Alcesti che terragrave sempre con se per avere lrsquoillusione di avere ancora la moglie a fianco poi lo sfinimento assale definitiva-mente Alcesti che viene portata via da Thanatos lasciando la reggia immersa nel luttoIntanto Eracle nel suo peregrinare ha bussato per chiedere ospitalitagrave e Admeto pur immerso nel lutto non puograve venire meno ai doveri di ospite e lo accoglie nella sua casa senza rivelargli la sorte di Alcesti Eracle si rifocilla mangiando e bevendo senza rite-gno mentre giagrave si preparano le esequie Admeto riceve allora la visita del padre Ferete venuto a piangere la nuora il colloquio degenera ben presto in violento alterco nel quale Admeto rimprovera lrsquoegoismo del vecchio che non ha voluto sacrificarsi per il proprio figlio spingendolo ad accettare il sacrificio di Alcesti ma Ferete ribatte a tutte le accuse ritorcendo sul figlio lrsquoaccusa di egoismo Padre e figlio si separano pieni di rancore Quando tutti i personaggi e gli stessi coreuti si sono avviati per accompagnare il fune-rale si presenta in scena Eracle ormai sazio del pranzo che viene a conoscenza della veritagrave dal racconto di un servo Decide allora di ricambiare la generositagrave dellrsquoamico e parte alla volta dellrsquoAde per strappare Alcesti a Thaacutenatos Di ritorno dalle esequie Admeto si abbandona alla piugrave cupa disperazione solo ora ela-bora il significato della sciagura che gli egrave capitata con la perdita della moglie e lamenta la solitudine in cui egrave stato precipitato Solo ora sembra rendersi conto che la vita per lui non ha piugrave scopo Nellrsquoesodo ritorna Eracle con una donna coperta da un velo che egli dice aver conqui-stato come premio in una gara di lotta chiede quindi allrsquoamico di trattenerla con seacute e ospitarla nella reggia fino al suo ritorno Admeto in un primo tempo rifiuta ma si vede costretto a cedere alle insistenze dellrsquoeroe Sollevato il velo la donna si rivela essere Alcesti restituita alla vita dopo essere stata strappata da Eracle alle grinfie di Thana-tos Cosigrave mentre Eracle riparte per le sue avventure i due sposi rientrano a palazzo di nuovo uniti
Tragedia dai contorni quanto mai sfuggenti e passibile di interpretazioni contraddittorie lrsquoAlcesti egrave stata additata da Platone (Simposio 179-180) co-me un fulgido esempio di dedizione e di φιλία da parte della protagonista a dimostrazione di come solo chi ama egrave disposto a sacrificare la vita per la persona amata Complementare alla φιλία egrave la virtugrave dellrsquoospitalitagrave peculiare di Admeto e delle persone a lui piugrave vicine sotto il segno dellrsquoospitalitagrave si apre il dramma nel congedo di Apollo dalla dimora che lo ha accolto per un anno e alla fine della vicenda lrsquoospitalitagrave concessa a Eracle saragrave elemento risolutivo
Indissolubilmente legato a questi vi egrave il tema della gloria che costituisce mo-vente fondamentale dellrsquoazione per i personaggi (ad esclusione di Ferete) nel κλέος rivendicato in primo luogo dalla protagonista si puograve individuare quel prestigio che deriva dal riconoscimento sociale della virtugrave che costituisce un surrogato dellrsquoimmortalitagrave e un compenso postumo dopo la riduzione dellrsquoindi-viduo al nulla
T2
Tragedia della φιλία e dellrsquoospitalitagravehellip
hellipdella gloriahellip
424 EURIPIDE
Euri
pide
424424 EE
In questa ldquostranardquo tragedia ha centralitagrave drammatica soprattutto il problema della morte destino comune degli uomini che viene evidenziato proprio da quellrsquouni-cum ldquomiracolosordquo costituito dalla resurrezione della protagonista Il confronto con la morte ha effetto rivelatore del carattere delle persone consentendo di ve-rificare la consistenza dei legami famigliari e sociali coloro che sembrano φίλοι o che tali si rivelavano a parole di fronte alla morte dimostrano la loro vera natura di esseri tenacemente attaccati alla propria ψυχή a scapito di quella altrui anche a costo di perpetuare unrsquoesistenza ingloriosa (un destino che accomuna Admeto e Ferete nella grettezza del loro scontro verbale) Nel delirio di Alcesti davanti al terribile laquodemone alatoraquo emerge lrsquoaspetto ambi-valente dellrsquoaldilagrave che da una parte sottrae le gioie della vita oscurando la luce del sole ma dallrsquoaltra prospetta una insensibilitagrave liberatoria dal dolore (οὐδέν ἐσθ᾽ ὁ κατθανών laquochi muore non egrave piugrave nullaraquo osserva Alcesti al v 380) che colloca il defunto in una condizione privilegiata rispetto ai suoi cari costretti a perpetuare un πόθος (laquostruggimento di desiderioraquo) destinato a rimanere inap-pagato Per loro rimane lrsquoinsipida consolazione ndash che egrave anche un ldquodovererdquo ndash di perpetuare il ricordo degli estinti o tuttrsquoal piugrave la laquofredda gioiaraquo di abbracciare simulacri che restituiscono vane parvenzelaquoIl motivo centrale della tragedia ndash secondo le parole di C M J Sicking ndash egrave il carattere limitato di ogni potere umano lrsquouomo non vinceragrave mai la morte sacrifi-carsi per un altro non ha dunque sensoraquo Il dono divino offerto a un essere umano di laquosfuggire al κύριον ἧμαρ sostituendo un altro al suo posto si rivela fallimen-tare la vita di chi resta dopo aver accettato il sacrificio dei propri φίλοι egrave pura esistenza biologica ἀβίωτον χρόνον (vv 242-3)raquo (S Barbantani)
Medea
Egrave singolare come una tragedia dellrsquoaltezza della Medea (Μήδεια) rappresentata nel 431 insieme con Filottete Dictys e Mietitori ottenesse solo il terzo premio
Euripide ha rielaborato una vecchia tradizione cultuale secondo la quale Medea nel tentativo di rendere immortali i propri figli li avrebbe involontariamente uccisi nel tempio di Era Akraia a Corinto Probabilmente egli egrave stato il primo a introdurre lrsquoinfanticidio perpetrato dalla maga della Colchide contro il marito Giasone anche se non si puograve dire definitivamente risolta la questione del rap-porto cronologico fra la sua Medea e la Medea di Neofrone al quale ndash secondo lrsquoopinione del peripatetico Dicearco riportata dallrsquoargumentum ndash spetterebbe la prioritagrave ma i resti del dramma di Neofrone sembrano indicarne un imitatore di Euripide
Lrsquoazione si svolge a Corinto dove reduci dalla Colchide vivono Medea e Giaso-ne Allrsquoinizio del dramma dopo il prologo espositivo recitato dalla nutrice si odono dallrsquointerno della casa le grida di Medea per il tradimento di Giasone che ora intende sposare Glauce la giovane principessa figlia di Creonte sovrano di Corinto Ma poi dopo i lamenti e le invettive Medea compare in scena con mutato atteggiamento e
hellip e del comportamento umano davanti
alla morte
tram
a
425
Euri
pide
425425I DRAMMI SUPERSTITI
parla con grande luciditagrave alle donne corinzie che compongono il coro dellrsquouniversale condizione della donna e della propria personale vicenda Ella egrave giagrave decisa a vendicarsi del marito ma ancora ignora la via per tradurre in azione il suo impulso Innanzi tutto si assicura il silenzio del coro poi in un dialogo con Creonte riesce a ottenere che il bando di espulsione da Corinto da cui egrave stata colpita sia differito di un giorno Segue un tumultuoso dialogo con Giasone dopo il quale insperatamente Medea trova un decisivo alleato nel sovrano ateniese Egeo che egrave di passaggio a Corinto reduce da Delfi (dove ha interrogato lrsquooracolo) egli si offre di ospitarla in Atene e farla sua spo-sa e cosigrave Medea puograve elaborare un piano minutamente articolato Incontra nuovamente Giasone e finge di volersi riconciliare con lui anche per evitare lrsquoesilio almeno ai loro figli E in questa prospettiva invia tramite loro un dono a Glauce ndash una veste e un dia-dema ndash che in realtagrave grazie alle sue arti di maga ha trasformato in strumenti di morteDopo un canto corale i fanciulli tornano dalla loro missione ora Medea sa che Glauce egrave perduta e che per portare al suo ultimo stadio lrsquoatroce vendetta che ha meditato deve uccidere le sue stesse creature Le ragioni della vendetta e dellrsquoamore materno si alter-nano e si scontrano in un grande monologo (vv 1021-1080)Dopo il monologo giunge un messaggero che riferisce della terribile morte di Glauce e dello stesso Creonte entrambi arsi dalle fiamme che si sono sprigionate da veste e diadema Medea rientra in casa e dopo un breve interludio corale si odono dallrsquointerno le grida dei figli colpiti a morte Giasone accorso puograve solo esprimere la sua rabbia frustrata mentre Medea sul carro del Sole srsquoinvola portando con seacute le salme dei figli
Il dramma si articola in una struttura a dittico nella prima parte il desiderio di vendetta di Medea egrave focalizzato contro i diretti responsabili della sventura Giasone Glauce e Creonte nella seconda parte il piano si delinea in maniera sottilmente atroce per colpire Giasone non nella sua persona ma nella sua di-scendenza sia attuale (i figli che ha avuto con Medea) sia futura (quelli che non potragrave mai avere da Glauce)
Chiave della tragedia egrave il cuore (thumos) di Medea al contempo moglie ripudia-ta madre e maga personaggio caratterizzato dalle stigmate di una ldquodiversitagraverdquo che egrave acuita dalla condizione stessa di essere donna e straniera che agli occhi degli spettatori ateniesi la rende unica nella sua solitudine di emarginata Tutti gli altri personaggi escono annientati dal confronto con la grandezza solitaria della personalitagrave di Medea che presenta tratti comuni con i grandi eroi sofoclei e in particolare Aiace col quale condivide sentimenti vissuti in modo esasperato orgoglio ira amore della gloria timore dello scherno del nemico
Al contempo Medea egrave modello di personaggio complesso in cui raziocinio e irrazionalitagrave coesistono in direzione antisocratica la conoscenza razionale non porta al bene e alla sua conseguente attuazione ma diviene strumento per raffor-zare un impulso incoercibile verso il male hellipe il significato del dramma Molto si egrave discusso sul significato profondo del dramma nel quale lrsquoinfanticidio attraverso il quale si consuma la vendetta non ha effetto liberatorio Anche lrsquoAgamennone eschileo si era fatto carnefice della figlia ma nel caso di Agamennone la costrizione derivava da un oracolo ed era esterna alla volontagrave del personaggio in Medea la decisione avviene allrsquointerno
T2
La struttura a dittico
Il thumos di Medea
La lotta tra ragione e irrazionalitagravehellip
426 EURIPIDE
Euri
pide
426426 EE
in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000
Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre
Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea
appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas
Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo
LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
422 EURIPIDE
Euri
pide
422422 EE
i drammi superstiti
Alcesti
LrsquoAlcesti (Ἄλκηστις) egrave il piugrave antico dramma che di Euripide ci sia pervenuto pur appartenendo giagrave alla maturitagrave del poeta (438 aC) Nella tetralogia di cui
faceva parte ndash insieme con Cretesi Alcmeone a Psofide e Telefo ndash e che ottenne il secondo premio occupava il quarto posto una anomalia quella di porre in luogo del dramma satiresco una tragedia sia pure a lieto fine che non dovette essere isolata nella produzione euripideaViene qui ripresa una leggenda costruita sui due motivi folclorici della sposa che offre la vita per il marito e della lotta di un eroe col demone della morte (giagrave il tragico Frinico aveva portato in scena la figura del demone Thaacutenatos)
Al principio del dramma ambientato a Fere in Tessaglia Apollo che presta servizio presso il re Admeto per espiare lo sterminio dei Ciclopi e dal quale Admeto stesso ha ottenuto di poter prolungare la propria vita purcheacute qualcuno si offra di morire al suo posto racconta che solo la sposa di Admeto Alcesti si egrave dichiarata pronta a morire mentre neppure gli anziani genitori del sovrano hanno voluto dare la propria vita in cambio di quella del figlio Ora che egrave arrivato il momento supremo interviene Thaacutenatos il demone della morte a re-clamare la sua vittima e Apollo si allontana Il coro formato da vecchi cittadini di Fere entra nellrsquoorchestra in preda allrsquoansia per la sorte di Alcesti e viene informato da unrsquoan-cella che allrsquointerno della casa la donna si sta congedando dalla famiglia e dai servi Entrano in scena i due coniugi Alcesti sostenuta dal marito egrave in preda a una visione in cui le sembra che lo stesso Caronte (il traghettatore dei morti) la chiami per lrsquoultimo viaggio (vv 244-279) Adornata come a festa essa prende congedo da tutti soprattutto dai figli e dal letto nuziale rimasta poi sola col marito lo supplica in nome del sacrifi-
tram
a
T1
Loutrophoacuteros apula della cerchia del Pittore di Dario 350-325 aC Provenienza sconosciuta ora a Basilea Antikenmuseum Rappresentazioni del mito di Alcesti sono rare nonostante lrsquointeresse per la storia promosso dallrsquoomonima tragedia di Euripide (andata in scena nel 438 aC) Allrsquointerno del palazzo reale di Fere in Tessaglia suggerito dalle due colon-ne che sorreggono il frontone Alcesti egrave seduta sul letto nuziale Egrave il momento traumatico del commiato A sinistra egrave il marito Admeto stante e drappeggiato nellrsquohimaacutetion che porta una ma-no alla fronte in segno di tristezza La sovrappo-sizione con il dramma euripideo si ferma qui i personaggi vicini non sono i suoceri di Alcesti A destra egrave la vecchia nutrice il suo sguardo egrave ab-bassato mentre con la mano si sorregge il mento in segno di dolore Dietro di lei il pedagogo vec-chio e canuto si appoggia a un bastone Al centro Alcesti ndash lrsquounica figura di cui sia indicato il nome (ordmAlkhstiv) ndash sta salutando per lrsquoultima volta i figli In disparte ad arricchire il quadro sono due serve lrsquouna porta sulla spalla un cesto di vimini lrsquoaltra ha un nastro e un ventaglio
423
Euri
pide
423423I DRAMMI SUPERSTITI
cio che ha fatto per lui di non risposarsi e non dare ai figli una matrigna che potrebbe addirittura odiarli se dalle seconde nozze ne nascessero altri Dopo il commo Admeto promette solennemente alla moglie che non si risposeragrave anzi che si faragrave forgiare da un artista unrsquoimmagine di Alcesti che terragrave sempre con se per avere lrsquoillusione di avere ancora la moglie a fianco poi lo sfinimento assale definitiva-mente Alcesti che viene portata via da Thanatos lasciando la reggia immersa nel luttoIntanto Eracle nel suo peregrinare ha bussato per chiedere ospitalitagrave e Admeto pur immerso nel lutto non puograve venire meno ai doveri di ospite e lo accoglie nella sua casa senza rivelargli la sorte di Alcesti Eracle si rifocilla mangiando e bevendo senza rite-gno mentre giagrave si preparano le esequie Admeto riceve allora la visita del padre Ferete venuto a piangere la nuora il colloquio degenera ben presto in violento alterco nel quale Admeto rimprovera lrsquoegoismo del vecchio che non ha voluto sacrificarsi per il proprio figlio spingendolo ad accettare il sacrificio di Alcesti ma Ferete ribatte a tutte le accuse ritorcendo sul figlio lrsquoaccusa di egoismo Padre e figlio si separano pieni di rancore Quando tutti i personaggi e gli stessi coreuti si sono avviati per accompagnare il fune-rale si presenta in scena Eracle ormai sazio del pranzo che viene a conoscenza della veritagrave dal racconto di un servo Decide allora di ricambiare la generositagrave dellrsquoamico e parte alla volta dellrsquoAde per strappare Alcesti a Thaacutenatos Di ritorno dalle esequie Admeto si abbandona alla piugrave cupa disperazione solo ora ela-bora il significato della sciagura che gli egrave capitata con la perdita della moglie e lamenta la solitudine in cui egrave stato precipitato Solo ora sembra rendersi conto che la vita per lui non ha piugrave scopo Nellrsquoesodo ritorna Eracle con una donna coperta da un velo che egli dice aver conqui-stato come premio in una gara di lotta chiede quindi allrsquoamico di trattenerla con seacute e ospitarla nella reggia fino al suo ritorno Admeto in un primo tempo rifiuta ma si vede costretto a cedere alle insistenze dellrsquoeroe Sollevato il velo la donna si rivela essere Alcesti restituita alla vita dopo essere stata strappata da Eracle alle grinfie di Thana-tos Cosigrave mentre Eracle riparte per le sue avventure i due sposi rientrano a palazzo di nuovo uniti
Tragedia dai contorni quanto mai sfuggenti e passibile di interpretazioni contraddittorie lrsquoAlcesti egrave stata additata da Platone (Simposio 179-180) co-me un fulgido esempio di dedizione e di φιλία da parte della protagonista a dimostrazione di come solo chi ama egrave disposto a sacrificare la vita per la persona amata Complementare alla φιλία egrave la virtugrave dellrsquoospitalitagrave peculiare di Admeto e delle persone a lui piugrave vicine sotto il segno dellrsquoospitalitagrave si apre il dramma nel congedo di Apollo dalla dimora che lo ha accolto per un anno e alla fine della vicenda lrsquoospitalitagrave concessa a Eracle saragrave elemento risolutivo
Indissolubilmente legato a questi vi egrave il tema della gloria che costituisce mo-vente fondamentale dellrsquoazione per i personaggi (ad esclusione di Ferete) nel κλέος rivendicato in primo luogo dalla protagonista si puograve individuare quel prestigio che deriva dal riconoscimento sociale della virtugrave che costituisce un surrogato dellrsquoimmortalitagrave e un compenso postumo dopo la riduzione dellrsquoindi-viduo al nulla
T2
Tragedia della φιλία e dellrsquoospitalitagravehellip
hellipdella gloriahellip
424 EURIPIDE
Euri
pide
424424 EE
In questa ldquostranardquo tragedia ha centralitagrave drammatica soprattutto il problema della morte destino comune degli uomini che viene evidenziato proprio da quellrsquouni-cum ldquomiracolosordquo costituito dalla resurrezione della protagonista Il confronto con la morte ha effetto rivelatore del carattere delle persone consentendo di ve-rificare la consistenza dei legami famigliari e sociali coloro che sembrano φίλοι o che tali si rivelavano a parole di fronte alla morte dimostrano la loro vera natura di esseri tenacemente attaccati alla propria ψυχή a scapito di quella altrui anche a costo di perpetuare unrsquoesistenza ingloriosa (un destino che accomuna Admeto e Ferete nella grettezza del loro scontro verbale) Nel delirio di Alcesti davanti al terribile laquodemone alatoraquo emerge lrsquoaspetto ambi-valente dellrsquoaldilagrave che da una parte sottrae le gioie della vita oscurando la luce del sole ma dallrsquoaltra prospetta una insensibilitagrave liberatoria dal dolore (οὐδέν ἐσθ᾽ ὁ κατθανών laquochi muore non egrave piugrave nullaraquo osserva Alcesti al v 380) che colloca il defunto in una condizione privilegiata rispetto ai suoi cari costretti a perpetuare un πόθος (laquostruggimento di desiderioraquo) destinato a rimanere inap-pagato Per loro rimane lrsquoinsipida consolazione ndash che egrave anche un ldquodovererdquo ndash di perpetuare il ricordo degli estinti o tuttrsquoal piugrave la laquofredda gioiaraquo di abbracciare simulacri che restituiscono vane parvenzelaquoIl motivo centrale della tragedia ndash secondo le parole di C M J Sicking ndash egrave il carattere limitato di ogni potere umano lrsquouomo non vinceragrave mai la morte sacrifi-carsi per un altro non ha dunque sensoraquo Il dono divino offerto a un essere umano di laquosfuggire al κύριον ἧμαρ sostituendo un altro al suo posto si rivela fallimen-tare la vita di chi resta dopo aver accettato il sacrificio dei propri φίλοι egrave pura esistenza biologica ἀβίωτον χρόνον (vv 242-3)raquo (S Barbantani)
Medea
Egrave singolare come una tragedia dellrsquoaltezza della Medea (Μήδεια) rappresentata nel 431 insieme con Filottete Dictys e Mietitori ottenesse solo il terzo premio
Euripide ha rielaborato una vecchia tradizione cultuale secondo la quale Medea nel tentativo di rendere immortali i propri figli li avrebbe involontariamente uccisi nel tempio di Era Akraia a Corinto Probabilmente egli egrave stato il primo a introdurre lrsquoinfanticidio perpetrato dalla maga della Colchide contro il marito Giasone anche se non si puograve dire definitivamente risolta la questione del rap-porto cronologico fra la sua Medea e la Medea di Neofrone al quale ndash secondo lrsquoopinione del peripatetico Dicearco riportata dallrsquoargumentum ndash spetterebbe la prioritagrave ma i resti del dramma di Neofrone sembrano indicarne un imitatore di Euripide
Lrsquoazione si svolge a Corinto dove reduci dalla Colchide vivono Medea e Giaso-ne Allrsquoinizio del dramma dopo il prologo espositivo recitato dalla nutrice si odono dallrsquointerno della casa le grida di Medea per il tradimento di Giasone che ora intende sposare Glauce la giovane principessa figlia di Creonte sovrano di Corinto Ma poi dopo i lamenti e le invettive Medea compare in scena con mutato atteggiamento e
hellip e del comportamento umano davanti
alla morte
tram
a
425
Euri
pide
425425I DRAMMI SUPERSTITI
parla con grande luciditagrave alle donne corinzie che compongono il coro dellrsquouniversale condizione della donna e della propria personale vicenda Ella egrave giagrave decisa a vendicarsi del marito ma ancora ignora la via per tradurre in azione il suo impulso Innanzi tutto si assicura il silenzio del coro poi in un dialogo con Creonte riesce a ottenere che il bando di espulsione da Corinto da cui egrave stata colpita sia differito di un giorno Segue un tumultuoso dialogo con Giasone dopo il quale insperatamente Medea trova un decisivo alleato nel sovrano ateniese Egeo che egrave di passaggio a Corinto reduce da Delfi (dove ha interrogato lrsquooracolo) egli si offre di ospitarla in Atene e farla sua spo-sa e cosigrave Medea puograve elaborare un piano minutamente articolato Incontra nuovamente Giasone e finge di volersi riconciliare con lui anche per evitare lrsquoesilio almeno ai loro figli E in questa prospettiva invia tramite loro un dono a Glauce ndash una veste e un dia-dema ndash che in realtagrave grazie alle sue arti di maga ha trasformato in strumenti di morteDopo un canto corale i fanciulli tornano dalla loro missione ora Medea sa che Glauce egrave perduta e che per portare al suo ultimo stadio lrsquoatroce vendetta che ha meditato deve uccidere le sue stesse creature Le ragioni della vendetta e dellrsquoamore materno si alter-nano e si scontrano in un grande monologo (vv 1021-1080)Dopo il monologo giunge un messaggero che riferisce della terribile morte di Glauce e dello stesso Creonte entrambi arsi dalle fiamme che si sono sprigionate da veste e diadema Medea rientra in casa e dopo un breve interludio corale si odono dallrsquointerno le grida dei figli colpiti a morte Giasone accorso puograve solo esprimere la sua rabbia frustrata mentre Medea sul carro del Sole srsquoinvola portando con seacute le salme dei figli
Il dramma si articola in una struttura a dittico nella prima parte il desiderio di vendetta di Medea egrave focalizzato contro i diretti responsabili della sventura Giasone Glauce e Creonte nella seconda parte il piano si delinea in maniera sottilmente atroce per colpire Giasone non nella sua persona ma nella sua di-scendenza sia attuale (i figli che ha avuto con Medea) sia futura (quelli che non potragrave mai avere da Glauce)
Chiave della tragedia egrave il cuore (thumos) di Medea al contempo moglie ripudia-ta madre e maga personaggio caratterizzato dalle stigmate di una ldquodiversitagraverdquo che egrave acuita dalla condizione stessa di essere donna e straniera che agli occhi degli spettatori ateniesi la rende unica nella sua solitudine di emarginata Tutti gli altri personaggi escono annientati dal confronto con la grandezza solitaria della personalitagrave di Medea che presenta tratti comuni con i grandi eroi sofoclei e in particolare Aiace col quale condivide sentimenti vissuti in modo esasperato orgoglio ira amore della gloria timore dello scherno del nemico
Al contempo Medea egrave modello di personaggio complesso in cui raziocinio e irrazionalitagrave coesistono in direzione antisocratica la conoscenza razionale non porta al bene e alla sua conseguente attuazione ma diviene strumento per raffor-zare un impulso incoercibile verso il male hellipe il significato del dramma Molto si egrave discusso sul significato profondo del dramma nel quale lrsquoinfanticidio attraverso il quale si consuma la vendetta non ha effetto liberatorio Anche lrsquoAgamennone eschileo si era fatto carnefice della figlia ma nel caso di Agamennone la costrizione derivava da un oracolo ed era esterna alla volontagrave del personaggio in Medea la decisione avviene allrsquointerno
T2
La struttura a dittico
Il thumos di Medea
La lotta tra ragione e irrazionalitagravehellip
426 EURIPIDE
Euri
pide
426426 EE
in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000
Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre
Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea
appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas
Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo
LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
423
Euri
pide
423423I DRAMMI SUPERSTITI
cio che ha fatto per lui di non risposarsi e non dare ai figli una matrigna che potrebbe addirittura odiarli se dalle seconde nozze ne nascessero altri Dopo il commo Admeto promette solennemente alla moglie che non si risposeragrave anzi che si faragrave forgiare da un artista unrsquoimmagine di Alcesti che terragrave sempre con se per avere lrsquoillusione di avere ancora la moglie a fianco poi lo sfinimento assale definitiva-mente Alcesti che viene portata via da Thanatos lasciando la reggia immersa nel luttoIntanto Eracle nel suo peregrinare ha bussato per chiedere ospitalitagrave e Admeto pur immerso nel lutto non puograve venire meno ai doveri di ospite e lo accoglie nella sua casa senza rivelargli la sorte di Alcesti Eracle si rifocilla mangiando e bevendo senza rite-gno mentre giagrave si preparano le esequie Admeto riceve allora la visita del padre Ferete venuto a piangere la nuora il colloquio degenera ben presto in violento alterco nel quale Admeto rimprovera lrsquoegoismo del vecchio che non ha voluto sacrificarsi per il proprio figlio spingendolo ad accettare il sacrificio di Alcesti ma Ferete ribatte a tutte le accuse ritorcendo sul figlio lrsquoaccusa di egoismo Padre e figlio si separano pieni di rancore Quando tutti i personaggi e gli stessi coreuti si sono avviati per accompagnare il fune-rale si presenta in scena Eracle ormai sazio del pranzo che viene a conoscenza della veritagrave dal racconto di un servo Decide allora di ricambiare la generositagrave dellrsquoamico e parte alla volta dellrsquoAde per strappare Alcesti a Thaacutenatos Di ritorno dalle esequie Admeto si abbandona alla piugrave cupa disperazione solo ora ela-bora il significato della sciagura che gli egrave capitata con la perdita della moglie e lamenta la solitudine in cui egrave stato precipitato Solo ora sembra rendersi conto che la vita per lui non ha piugrave scopo Nellrsquoesodo ritorna Eracle con una donna coperta da un velo che egli dice aver conqui-stato come premio in una gara di lotta chiede quindi allrsquoamico di trattenerla con seacute e ospitarla nella reggia fino al suo ritorno Admeto in un primo tempo rifiuta ma si vede costretto a cedere alle insistenze dellrsquoeroe Sollevato il velo la donna si rivela essere Alcesti restituita alla vita dopo essere stata strappata da Eracle alle grinfie di Thana-tos Cosigrave mentre Eracle riparte per le sue avventure i due sposi rientrano a palazzo di nuovo uniti
Tragedia dai contorni quanto mai sfuggenti e passibile di interpretazioni contraddittorie lrsquoAlcesti egrave stata additata da Platone (Simposio 179-180) co-me un fulgido esempio di dedizione e di φιλία da parte della protagonista a dimostrazione di come solo chi ama egrave disposto a sacrificare la vita per la persona amata Complementare alla φιλία egrave la virtugrave dellrsquoospitalitagrave peculiare di Admeto e delle persone a lui piugrave vicine sotto il segno dellrsquoospitalitagrave si apre il dramma nel congedo di Apollo dalla dimora che lo ha accolto per un anno e alla fine della vicenda lrsquoospitalitagrave concessa a Eracle saragrave elemento risolutivo
Indissolubilmente legato a questi vi egrave il tema della gloria che costituisce mo-vente fondamentale dellrsquoazione per i personaggi (ad esclusione di Ferete) nel κλέος rivendicato in primo luogo dalla protagonista si puograve individuare quel prestigio che deriva dal riconoscimento sociale della virtugrave che costituisce un surrogato dellrsquoimmortalitagrave e un compenso postumo dopo la riduzione dellrsquoindi-viduo al nulla
T2
Tragedia della φιλία e dellrsquoospitalitagravehellip
hellipdella gloriahellip
424 EURIPIDE
Euri
pide
424424 EE
In questa ldquostranardquo tragedia ha centralitagrave drammatica soprattutto il problema della morte destino comune degli uomini che viene evidenziato proprio da quellrsquouni-cum ldquomiracolosordquo costituito dalla resurrezione della protagonista Il confronto con la morte ha effetto rivelatore del carattere delle persone consentendo di ve-rificare la consistenza dei legami famigliari e sociali coloro che sembrano φίλοι o che tali si rivelavano a parole di fronte alla morte dimostrano la loro vera natura di esseri tenacemente attaccati alla propria ψυχή a scapito di quella altrui anche a costo di perpetuare unrsquoesistenza ingloriosa (un destino che accomuna Admeto e Ferete nella grettezza del loro scontro verbale) Nel delirio di Alcesti davanti al terribile laquodemone alatoraquo emerge lrsquoaspetto ambi-valente dellrsquoaldilagrave che da una parte sottrae le gioie della vita oscurando la luce del sole ma dallrsquoaltra prospetta una insensibilitagrave liberatoria dal dolore (οὐδέν ἐσθ᾽ ὁ κατθανών laquochi muore non egrave piugrave nullaraquo osserva Alcesti al v 380) che colloca il defunto in una condizione privilegiata rispetto ai suoi cari costretti a perpetuare un πόθος (laquostruggimento di desiderioraquo) destinato a rimanere inap-pagato Per loro rimane lrsquoinsipida consolazione ndash che egrave anche un ldquodovererdquo ndash di perpetuare il ricordo degli estinti o tuttrsquoal piugrave la laquofredda gioiaraquo di abbracciare simulacri che restituiscono vane parvenzelaquoIl motivo centrale della tragedia ndash secondo le parole di C M J Sicking ndash egrave il carattere limitato di ogni potere umano lrsquouomo non vinceragrave mai la morte sacrifi-carsi per un altro non ha dunque sensoraquo Il dono divino offerto a un essere umano di laquosfuggire al κύριον ἧμαρ sostituendo un altro al suo posto si rivela fallimen-tare la vita di chi resta dopo aver accettato il sacrificio dei propri φίλοι egrave pura esistenza biologica ἀβίωτον χρόνον (vv 242-3)raquo (S Barbantani)
Medea
Egrave singolare come una tragedia dellrsquoaltezza della Medea (Μήδεια) rappresentata nel 431 insieme con Filottete Dictys e Mietitori ottenesse solo il terzo premio
Euripide ha rielaborato una vecchia tradizione cultuale secondo la quale Medea nel tentativo di rendere immortali i propri figli li avrebbe involontariamente uccisi nel tempio di Era Akraia a Corinto Probabilmente egli egrave stato il primo a introdurre lrsquoinfanticidio perpetrato dalla maga della Colchide contro il marito Giasone anche se non si puograve dire definitivamente risolta la questione del rap-porto cronologico fra la sua Medea e la Medea di Neofrone al quale ndash secondo lrsquoopinione del peripatetico Dicearco riportata dallrsquoargumentum ndash spetterebbe la prioritagrave ma i resti del dramma di Neofrone sembrano indicarne un imitatore di Euripide
Lrsquoazione si svolge a Corinto dove reduci dalla Colchide vivono Medea e Giaso-ne Allrsquoinizio del dramma dopo il prologo espositivo recitato dalla nutrice si odono dallrsquointerno della casa le grida di Medea per il tradimento di Giasone che ora intende sposare Glauce la giovane principessa figlia di Creonte sovrano di Corinto Ma poi dopo i lamenti e le invettive Medea compare in scena con mutato atteggiamento e
hellip e del comportamento umano davanti
alla morte
tram
a
425
Euri
pide
425425I DRAMMI SUPERSTITI
parla con grande luciditagrave alle donne corinzie che compongono il coro dellrsquouniversale condizione della donna e della propria personale vicenda Ella egrave giagrave decisa a vendicarsi del marito ma ancora ignora la via per tradurre in azione il suo impulso Innanzi tutto si assicura il silenzio del coro poi in un dialogo con Creonte riesce a ottenere che il bando di espulsione da Corinto da cui egrave stata colpita sia differito di un giorno Segue un tumultuoso dialogo con Giasone dopo il quale insperatamente Medea trova un decisivo alleato nel sovrano ateniese Egeo che egrave di passaggio a Corinto reduce da Delfi (dove ha interrogato lrsquooracolo) egli si offre di ospitarla in Atene e farla sua spo-sa e cosigrave Medea puograve elaborare un piano minutamente articolato Incontra nuovamente Giasone e finge di volersi riconciliare con lui anche per evitare lrsquoesilio almeno ai loro figli E in questa prospettiva invia tramite loro un dono a Glauce ndash una veste e un dia-dema ndash che in realtagrave grazie alle sue arti di maga ha trasformato in strumenti di morteDopo un canto corale i fanciulli tornano dalla loro missione ora Medea sa che Glauce egrave perduta e che per portare al suo ultimo stadio lrsquoatroce vendetta che ha meditato deve uccidere le sue stesse creature Le ragioni della vendetta e dellrsquoamore materno si alter-nano e si scontrano in un grande monologo (vv 1021-1080)Dopo il monologo giunge un messaggero che riferisce della terribile morte di Glauce e dello stesso Creonte entrambi arsi dalle fiamme che si sono sprigionate da veste e diadema Medea rientra in casa e dopo un breve interludio corale si odono dallrsquointerno le grida dei figli colpiti a morte Giasone accorso puograve solo esprimere la sua rabbia frustrata mentre Medea sul carro del Sole srsquoinvola portando con seacute le salme dei figli
Il dramma si articola in una struttura a dittico nella prima parte il desiderio di vendetta di Medea egrave focalizzato contro i diretti responsabili della sventura Giasone Glauce e Creonte nella seconda parte il piano si delinea in maniera sottilmente atroce per colpire Giasone non nella sua persona ma nella sua di-scendenza sia attuale (i figli che ha avuto con Medea) sia futura (quelli che non potragrave mai avere da Glauce)
Chiave della tragedia egrave il cuore (thumos) di Medea al contempo moglie ripudia-ta madre e maga personaggio caratterizzato dalle stigmate di una ldquodiversitagraverdquo che egrave acuita dalla condizione stessa di essere donna e straniera che agli occhi degli spettatori ateniesi la rende unica nella sua solitudine di emarginata Tutti gli altri personaggi escono annientati dal confronto con la grandezza solitaria della personalitagrave di Medea che presenta tratti comuni con i grandi eroi sofoclei e in particolare Aiace col quale condivide sentimenti vissuti in modo esasperato orgoglio ira amore della gloria timore dello scherno del nemico
Al contempo Medea egrave modello di personaggio complesso in cui raziocinio e irrazionalitagrave coesistono in direzione antisocratica la conoscenza razionale non porta al bene e alla sua conseguente attuazione ma diviene strumento per raffor-zare un impulso incoercibile verso il male hellipe il significato del dramma Molto si egrave discusso sul significato profondo del dramma nel quale lrsquoinfanticidio attraverso il quale si consuma la vendetta non ha effetto liberatorio Anche lrsquoAgamennone eschileo si era fatto carnefice della figlia ma nel caso di Agamennone la costrizione derivava da un oracolo ed era esterna alla volontagrave del personaggio in Medea la decisione avviene allrsquointerno
T2
La struttura a dittico
Il thumos di Medea
La lotta tra ragione e irrazionalitagravehellip
426 EURIPIDE
Euri
pide
426426 EE
in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000
Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre
Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea
appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas
Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo
LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
424 EURIPIDE
Euri
pide
424424 EE
In questa ldquostranardquo tragedia ha centralitagrave drammatica soprattutto il problema della morte destino comune degli uomini che viene evidenziato proprio da quellrsquouni-cum ldquomiracolosordquo costituito dalla resurrezione della protagonista Il confronto con la morte ha effetto rivelatore del carattere delle persone consentendo di ve-rificare la consistenza dei legami famigliari e sociali coloro che sembrano φίλοι o che tali si rivelavano a parole di fronte alla morte dimostrano la loro vera natura di esseri tenacemente attaccati alla propria ψυχή a scapito di quella altrui anche a costo di perpetuare unrsquoesistenza ingloriosa (un destino che accomuna Admeto e Ferete nella grettezza del loro scontro verbale) Nel delirio di Alcesti davanti al terribile laquodemone alatoraquo emerge lrsquoaspetto ambi-valente dellrsquoaldilagrave che da una parte sottrae le gioie della vita oscurando la luce del sole ma dallrsquoaltra prospetta una insensibilitagrave liberatoria dal dolore (οὐδέν ἐσθ᾽ ὁ κατθανών laquochi muore non egrave piugrave nullaraquo osserva Alcesti al v 380) che colloca il defunto in una condizione privilegiata rispetto ai suoi cari costretti a perpetuare un πόθος (laquostruggimento di desiderioraquo) destinato a rimanere inap-pagato Per loro rimane lrsquoinsipida consolazione ndash che egrave anche un ldquodovererdquo ndash di perpetuare il ricordo degli estinti o tuttrsquoal piugrave la laquofredda gioiaraquo di abbracciare simulacri che restituiscono vane parvenzelaquoIl motivo centrale della tragedia ndash secondo le parole di C M J Sicking ndash egrave il carattere limitato di ogni potere umano lrsquouomo non vinceragrave mai la morte sacrifi-carsi per un altro non ha dunque sensoraquo Il dono divino offerto a un essere umano di laquosfuggire al κύριον ἧμαρ sostituendo un altro al suo posto si rivela fallimen-tare la vita di chi resta dopo aver accettato il sacrificio dei propri φίλοι egrave pura esistenza biologica ἀβίωτον χρόνον (vv 242-3)raquo (S Barbantani)
Medea
Egrave singolare come una tragedia dellrsquoaltezza della Medea (Μήδεια) rappresentata nel 431 insieme con Filottete Dictys e Mietitori ottenesse solo il terzo premio
Euripide ha rielaborato una vecchia tradizione cultuale secondo la quale Medea nel tentativo di rendere immortali i propri figli li avrebbe involontariamente uccisi nel tempio di Era Akraia a Corinto Probabilmente egli egrave stato il primo a introdurre lrsquoinfanticidio perpetrato dalla maga della Colchide contro il marito Giasone anche se non si puograve dire definitivamente risolta la questione del rap-porto cronologico fra la sua Medea e la Medea di Neofrone al quale ndash secondo lrsquoopinione del peripatetico Dicearco riportata dallrsquoargumentum ndash spetterebbe la prioritagrave ma i resti del dramma di Neofrone sembrano indicarne un imitatore di Euripide
Lrsquoazione si svolge a Corinto dove reduci dalla Colchide vivono Medea e Giaso-ne Allrsquoinizio del dramma dopo il prologo espositivo recitato dalla nutrice si odono dallrsquointerno della casa le grida di Medea per il tradimento di Giasone che ora intende sposare Glauce la giovane principessa figlia di Creonte sovrano di Corinto Ma poi dopo i lamenti e le invettive Medea compare in scena con mutato atteggiamento e
hellip e del comportamento umano davanti
alla morte
tram
a
425
Euri
pide
425425I DRAMMI SUPERSTITI
parla con grande luciditagrave alle donne corinzie che compongono il coro dellrsquouniversale condizione della donna e della propria personale vicenda Ella egrave giagrave decisa a vendicarsi del marito ma ancora ignora la via per tradurre in azione il suo impulso Innanzi tutto si assicura il silenzio del coro poi in un dialogo con Creonte riesce a ottenere che il bando di espulsione da Corinto da cui egrave stata colpita sia differito di un giorno Segue un tumultuoso dialogo con Giasone dopo il quale insperatamente Medea trova un decisivo alleato nel sovrano ateniese Egeo che egrave di passaggio a Corinto reduce da Delfi (dove ha interrogato lrsquooracolo) egli si offre di ospitarla in Atene e farla sua spo-sa e cosigrave Medea puograve elaborare un piano minutamente articolato Incontra nuovamente Giasone e finge di volersi riconciliare con lui anche per evitare lrsquoesilio almeno ai loro figli E in questa prospettiva invia tramite loro un dono a Glauce ndash una veste e un dia-dema ndash che in realtagrave grazie alle sue arti di maga ha trasformato in strumenti di morteDopo un canto corale i fanciulli tornano dalla loro missione ora Medea sa che Glauce egrave perduta e che per portare al suo ultimo stadio lrsquoatroce vendetta che ha meditato deve uccidere le sue stesse creature Le ragioni della vendetta e dellrsquoamore materno si alter-nano e si scontrano in un grande monologo (vv 1021-1080)Dopo il monologo giunge un messaggero che riferisce della terribile morte di Glauce e dello stesso Creonte entrambi arsi dalle fiamme che si sono sprigionate da veste e diadema Medea rientra in casa e dopo un breve interludio corale si odono dallrsquointerno le grida dei figli colpiti a morte Giasone accorso puograve solo esprimere la sua rabbia frustrata mentre Medea sul carro del Sole srsquoinvola portando con seacute le salme dei figli
Il dramma si articola in una struttura a dittico nella prima parte il desiderio di vendetta di Medea egrave focalizzato contro i diretti responsabili della sventura Giasone Glauce e Creonte nella seconda parte il piano si delinea in maniera sottilmente atroce per colpire Giasone non nella sua persona ma nella sua di-scendenza sia attuale (i figli che ha avuto con Medea) sia futura (quelli che non potragrave mai avere da Glauce)
Chiave della tragedia egrave il cuore (thumos) di Medea al contempo moglie ripudia-ta madre e maga personaggio caratterizzato dalle stigmate di una ldquodiversitagraverdquo che egrave acuita dalla condizione stessa di essere donna e straniera che agli occhi degli spettatori ateniesi la rende unica nella sua solitudine di emarginata Tutti gli altri personaggi escono annientati dal confronto con la grandezza solitaria della personalitagrave di Medea che presenta tratti comuni con i grandi eroi sofoclei e in particolare Aiace col quale condivide sentimenti vissuti in modo esasperato orgoglio ira amore della gloria timore dello scherno del nemico
Al contempo Medea egrave modello di personaggio complesso in cui raziocinio e irrazionalitagrave coesistono in direzione antisocratica la conoscenza razionale non porta al bene e alla sua conseguente attuazione ma diviene strumento per raffor-zare un impulso incoercibile verso il male hellipe il significato del dramma Molto si egrave discusso sul significato profondo del dramma nel quale lrsquoinfanticidio attraverso il quale si consuma la vendetta non ha effetto liberatorio Anche lrsquoAgamennone eschileo si era fatto carnefice della figlia ma nel caso di Agamennone la costrizione derivava da un oracolo ed era esterna alla volontagrave del personaggio in Medea la decisione avviene allrsquointerno
T2
La struttura a dittico
Il thumos di Medea
La lotta tra ragione e irrazionalitagravehellip
426 EURIPIDE
Euri
pide
426426 EE
in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000
Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre
Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea
appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas
Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo
LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
425
Euri
pide
425425I DRAMMI SUPERSTITI
parla con grande luciditagrave alle donne corinzie che compongono il coro dellrsquouniversale condizione della donna e della propria personale vicenda Ella egrave giagrave decisa a vendicarsi del marito ma ancora ignora la via per tradurre in azione il suo impulso Innanzi tutto si assicura il silenzio del coro poi in un dialogo con Creonte riesce a ottenere che il bando di espulsione da Corinto da cui egrave stata colpita sia differito di un giorno Segue un tumultuoso dialogo con Giasone dopo il quale insperatamente Medea trova un decisivo alleato nel sovrano ateniese Egeo che egrave di passaggio a Corinto reduce da Delfi (dove ha interrogato lrsquooracolo) egli si offre di ospitarla in Atene e farla sua spo-sa e cosigrave Medea puograve elaborare un piano minutamente articolato Incontra nuovamente Giasone e finge di volersi riconciliare con lui anche per evitare lrsquoesilio almeno ai loro figli E in questa prospettiva invia tramite loro un dono a Glauce ndash una veste e un dia-dema ndash che in realtagrave grazie alle sue arti di maga ha trasformato in strumenti di morteDopo un canto corale i fanciulli tornano dalla loro missione ora Medea sa che Glauce egrave perduta e che per portare al suo ultimo stadio lrsquoatroce vendetta che ha meditato deve uccidere le sue stesse creature Le ragioni della vendetta e dellrsquoamore materno si alter-nano e si scontrano in un grande monologo (vv 1021-1080)Dopo il monologo giunge un messaggero che riferisce della terribile morte di Glauce e dello stesso Creonte entrambi arsi dalle fiamme che si sono sprigionate da veste e diadema Medea rientra in casa e dopo un breve interludio corale si odono dallrsquointerno le grida dei figli colpiti a morte Giasone accorso puograve solo esprimere la sua rabbia frustrata mentre Medea sul carro del Sole srsquoinvola portando con seacute le salme dei figli
Il dramma si articola in una struttura a dittico nella prima parte il desiderio di vendetta di Medea egrave focalizzato contro i diretti responsabili della sventura Giasone Glauce e Creonte nella seconda parte il piano si delinea in maniera sottilmente atroce per colpire Giasone non nella sua persona ma nella sua di-scendenza sia attuale (i figli che ha avuto con Medea) sia futura (quelli che non potragrave mai avere da Glauce)
Chiave della tragedia egrave il cuore (thumos) di Medea al contempo moglie ripudia-ta madre e maga personaggio caratterizzato dalle stigmate di una ldquodiversitagraverdquo che egrave acuita dalla condizione stessa di essere donna e straniera che agli occhi degli spettatori ateniesi la rende unica nella sua solitudine di emarginata Tutti gli altri personaggi escono annientati dal confronto con la grandezza solitaria della personalitagrave di Medea che presenta tratti comuni con i grandi eroi sofoclei e in particolare Aiace col quale condivide sentimenti vissuti in modo esasperato orgoglio ira amore della gloria timore dello scherno del nemico
Al contempo Medea egrave modello di personaggio complesso in cui raziocinio e irrazionalitagrave coesistono in direzione antisocratica la conoscenza razionale non porta al bene e alla sua conseguente attuazione ma diviene strumento per raffor-zare un impulso incoercibile verso il male hellipe il significato del dramma Molto si egrave discusso sul significato profondo del dramma nel quale lrsquoinfanticidio attraverso il quale si consuma la vendetta non ha effetto liberatorio Anche lrsquoAgamennone eschileo si era fatto carnefice della figlia ma nel caso di Agamennone la costrizione derivava da un oracolo ed era esterna alla volontagrave del personaggio in Medea la decisione avviene allrsquointerno
T2
La struttura a dittico
Il thumos di Medea
La lotta tra ragione e irrazionalitagravehellip
426 EURIPIDE
Euri
pide
426426 EE
in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000
Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre
Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea
appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas
Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo
LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
426 EURIPIDE
Euri
pide
426426 EE
in un atto decisionale che chiama in causa lrsquoἦθος dellrsquoindividuo alle prese con il travaglio psicologico della propria coscienza che produce la metamorfosi della figura materna in assassina dei propri figli laquoNeacute siamo piugrave nellrsquoambito della sto-ria sacra e del mito se nellrsquoOrestea la morte di Ifigenia o Clitennestra era funzio-nale rispettivamente alla ldquoragion di statordquo e a quella del genos qui lrsquoinfanticidio egrave solo un fatto privato di una donna ripudiata dal marito lrsquoesplicitazione del quotidiano ordinario sentimento di vendetta di una persona vilipesa nel proprio intimoraquo (G Monaco)Nella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-lianaT000
Eugegravene Delacroix La furia di Medea 1838 Parigi Museacutee du Louvre
Medea egrave senza dubbio una delle piugrave note tragedie dellrsquoantichitagrave La figura della donna ingannata che si vendica sui propri figli ha colpito artisti scrittori di ogni tempo entrando a pieno nellrsquoimmaginario della civiltagrave occidentale Possiamo ricostruire questo percorso a partire dalla lettura di Bruno Gentili - Franca Perusino (a cura di) Medea nella letteratura e nellrsquoarte Venezia Marsilio Editori 2000 Fra le numerosissime riprese del dramma possiamo rapidamente ricordare quella latina di Seneca e a partire dal XVII secolo quella di Pierre Corneille dellrsquoaustriaco Franz Grillparzer (XIX secolo) e nel Novecento quella di Jean Anhouil Oltre a riproposizioni antiche del mito in forma epica ndash Le Argonautiche di Apollonio Rodio per cui vedi vol 3 ndash e di epillio ndash lrsquoeroina descritta nelle Heroides di Ovidio ndash Medea
appare come protagonista di un roman-zo di grande successo della scrittrice tedesca contemporanea Christa Wolf Meda VociUna menzione a parte merita il melo-dramma di Luigi Cherubini (Medeacutee 1797 tradotto e rappresentato in italiano nel 1802 rivisto nel 1809) tornato nel re-pertorio lirico contemporaneo grazie alle memorabili interpretazioni di Maria Callas E nel nome di questa interprete mitica in ogni senso ci colleghiamo a una delle riproposizioni cinematografi-che piugrave giustamente celebri Medea di Pier Paolo Pasolini lrsquointellettuale che abbiamo giagrave incontrato nella mise en scegravene dellrsquoOrestiade nella trasposizione dellrsquoEdipo Il regista proseguigrave il suo per-sonale incontro con la tragedia proprio grazie allo straordinario incontro con Maria Callas
Potete leggere trama commenti e interventi relativi a questa realizzazione cinematografica del dram-ma euripideo
LA FOrTuNA NeLLrsquoArTe
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
427
Euri
pide
427427I DRAMMI SUPERSTITI
Eraclidi
Indizi metrici e riferimenti allrsquoattualitagrave politica ndash in particolare la profezia di Euristeo ndash permettono di collocare la datazione non documentata degli Era-
clidi (Ἡρακλεῖδαι) verso il 430 fra Medea e Ippolito secondo
Lasciata Argo percheacute perseguitati da Euristeo i figli di Eracle e Alcmena la madre dellrsquoeroe sono giunti a Maratona presso lrsquoaltare di Zeus guidati da Iolao vecchio compagno di lotte di Eracle e siedono supplici meditando di chiedere asilo Iolao sostiene le ragioni dei supplici dinanzi al re Demofonte figlio di Teseo appena sopraggiunto che accoglie la preghiera e caccia lrsquoaraldo di Euristeo che minaccia-va di strappare gli Eraclidi dallrsquoaltare Atene si prepara dunque alla guerra con gli Argivi ma un oracolo vuole che solo il sacrificio di una vergine possa garantire la vittoriaUna delle figlie di Eracle anonima nel testo ma che lrsquoargumentum chiama Macaria an-nuncia lrsquointenzione di immolarsi per salvare i fratelli e dimostrare che gli Eraclidi sono pronti non meno degli alleati Ateniesi ad affrontare la morte poi abbandona la scena dopo un commosso congedo dai familiari Viene annunciato lrsquoarrivo di Illo figlio di Eracle con truppe di rinforzo e Iolao decide di partecipare alla battagliaGiunge dopo il canto corale che ribadisce i diritti dei supplici la notizia della vittoria e dello strabiliante episodio del ringiovanimento di Iolao concesso per un solo giorno da Zeus ed Ebe che gli consente di far prigioniero Euristeo Egrave Alcmena a chiederne la vita nonostante la riluttanza degli Ateniesi Euristeo viene dunque ucciso ma non prima di aver rivelato un oracolo di Apollo secondo cui il suo corpo se verragrave sepolto presso il santuario di Atena a Pallene garantiragrave perenne protezione alla terra attica
Per il motivo dei figli di Eracle che guidati da Iolao e da Alcmena ottengono asi-lo in Atene Euripide dovette avere come punto di riferimento i perduti Eraclidi di Eschilo dove sappiamo che compariva anche lrsquoepisodio del ringiovanimento di Iolao durante la battaglia contro gli Argivi Ma piugrave in generale appare eschilea negli Eraclidi di Euripide la stessa concezione della polis come organismo uni-tario in cui domina la concordia fra i cittadini motivo che si aggancia al clicheacute propagandistico sorto in ambiente pericleo secondo il quale Atene egrave la cittagrave che
offre aiuto ai supplici e ai perseguitati
tram
a
Il motivo eschileo e lrsquoatmosfera
periclea
Cratere a colonnette lucano 410-400 aC Provenienza sconosciuta ora a Berlino Staatliche Museen-Antikenmu-seum Il mito degli Eraclidi egrave raffigurato con enfasi diversa rispetto alla scena precedente sebbene il santuario di Ma-ratona sia indicato dalla colonna e dallrsquoaltare su cui si egrave rifugiato Iolao caratterizzato ancora una volta dal chitone a maniche con ricami di tipo teatrale Lrsquoamico di Eracle egrave un vecchio ormai canuto i figli dellrsquoeroe sono ridotti a due soltanto mentre lrsquoaraldo di Euristeo ndash unrsquoinconsueta figura giovanile e imberbe ndash egrave salito sullrsquoara e tenta di allontanare i supplici A sinistra Alcmena egrave seduta su un pilastrino di pietra quasi certamente un cippo di confine del santuario di Zeus A destra invece accorrono due cavalieri sono i principi ateniesi Demofonte e Acamante che giungono tempestiva-mente a portare soccorso
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
428 EURIPIDE
Euri
pide
428428 EE
La linea compositiva del dramma consta di una serie di elementi non del tut-to felicemente amalgamati la ricerca di aiuto dei supplicanti lrsquoannuncio di un oracolo che promuove il sacrificio di Macaria la vittoria ateniese che consegna Euristeo nelle mani di Alcmena la quale si tramuta in persecutrice non meno spietata del suo persecutore
Pesa per altro sul dramma lrsquoipotesi su cui non si egrave ancora raggiunta una decisio-ne concorde di una lacuna dopo il v 629 che avrebbe inghiottito il racconto della morte di Macaria e gli onori funebri resi alla giovane la lacuna fu ipotizzata da A Kirchhoff e dal Wilamowitz e parrebbe confortata da un passo dellrsquoargumen-tum dove egrave riferito che Macaria veniva onorata per la sua nobile morte Inoltre lrsquoantologista Stobeo cita come tratti dagli Eraclidi euripidei passi che non com-paiono nel testo che noi possediamo
Ippolito incoronato
Del 428 egrave lrsquoIppolito incoronato (Ἱππόλυτος στεφανηφόρος) con cui Euri-pide ottenne il primo premio rifacimento di un precedente Ippolito velato
(Ἰππόλυτος καλυπτόμενος) che aveva scandalizzato il pubblico Ben poco sap-piamo del primo Ippolito e resta indimostrata la vecchia tesi secondo cui avrebbe costituito il modello della Phaedra di Seneca Egrave comunque certo che in esso la scena era collocata in Atene non a Trezene e che Fedra rivelava direttamente non attraverso la nutrice la propria passione al figliastro il quale per la vergogna si velava il capo (di qui il titolo)
LrsquoIppolito incoronato egrave ambientato come detto a Trezene dinanzi alla reggia di Pit-teo nonno materno di Teseo il coro egrave appunto costituito da giovani donne del luogo Nel prologo Afrodite offesa per il dispregio in cui egrave tenuta dal giovane Ippolito uni-camente dedito al culto di Artemide annuncia che si vendicheragrave ispirando a Fedra ndash attuale moglie di Teseo e matrigna di Ippolito ndash una passione irresistibile verso di lui Dopo una scena in cui vediamo il giovane di ritorno dalla caccia rinnovare la sua de-vozione ad Artemide viene trasportata in scena Fedra oppressa da un morbo oscuro di cui la nutrice le chiede invano lrsquoorigine (vv 198-249)Finalmente Fedra sotto lrsquoincalzare delle domande della nutrice confessa la causa della sua prostrazione Drsquoaltra parte dopo un breve inserto corale vediamo proporsi lrsquoaltro versante del personaggio di Fedra la sua matura e robusta razionalitagrave nel discorso che ella rivolge alle donne di Trezene che compongono il coro (vv 373-430)La nutrice cerca di ridimensionare il problema riconducendolo a una situazione di tra-dizionale routine e poi di propria iniziativa rivela a Ippolito la passione della matrigna Il giovane reagisce con orrore e fugge dalla reggia mentre Fedra che ha udito com-prende che per lei tutto egrave perduto e compie il gesto supremo ma non senza lasciare una lettera in cui accusa Ippolito di aver attentato al suo onoreQuando la regina egrave stata deposta sul letto funebre giunge Teseo e scopre la tavoletta scritta dalla defunta (egrave il motivo detto dalla storia biblica laquodi Potifarraquo esso compa-riva in Euripide anche nella Stenebea dove tuttavia Bellerofonte non restava vittima
Mancanza di amalgama
compositivohellip
hellipe probabile lacunositagrave del testo
pervenuto
tram
a
T3
T4
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
429
Euri
pide
429429I DRAMMI SUPERSTITI
dellrsquoinnamorata colpevole ma la puniva egli stesso con la morte) Teseo caccia via il figlio (che si protesta innocente ma che drsquoaltra parte tiene fede al giuramento fatto alla nutrice di non rivelare i veri motivi del gesto di Fedra) e scaglia su di lui come male-dizione uno dei tre desideri di cui suo padre Posidone gli ha promesso lrsquoesaudimento come racconta un messaggero un gigantesco toro mandato da Posidone fa imbizzarrire i cavalli del carro di Ippolito che resta impigliato nelle redini e viene mortalmente dilaniato Egrave portato in fin di vita sulla scena dove Artemide apparsa ex machina spie-ga a Teseo la veritagrave e consola il giovane Teseo fonderagrave quel culto di Ippolito che era appunto celebrato a Trezene
Egrave stata giustamente riconosciuta una strutturazione quasi geometrica nellrsquoIppo-lito incoronato primo e terzo episodio si corrispondono in quanto preparano lrsquouno la rovina di Fedra e lrsquoaltro quella di Ippolito analoga corrispondenza esiste fra secondo e quarto episodio segnati rispettivamente dalla morte di Fedra e da quella di Ippolito infine il prologo e lrsquoepilogo formano una cornice caratterizzata dalla presenza di una divinitagrave (rispettivamente Afrodite e Artemide)
Ancora una volta Euripide scandaglia lrsquoanimo femminile rivelandone lrsquointi-mitagrave ed evidenziando gli sconvolgimenti cui puograve portare una pulsione inap-pagata nella fattispecie quella erotica Diversamente che in Medea perograve in questo caso la scena egrave divisa tra i due protagonisti confinati in una vicenda che non ha spazi di conciliazione da una parte Fedra consumata fino allo spasimo dai turbamenti della passione dallrsquoaltra Ippolito il castissimo ser-vitore di Artemide
La contraddizione insanabile in cui si consuma il dramma di Fedra deriva da una passione viziata dalla duplice connotazione di essere adulterina e ndash in quanto ri-volta al figliastro ndash pericolosamente confinante con lrsquoincesto allo stesso tempo perograve non le si puograve imputare colpa nel momento in cui la donna cerca in ogni modo di occultare la pulsione erotica e di resistervi fino a quando gli eventi non precipiteranno trasformandola in inconsapevole strumento della vendetta di Afrodite su Ippolito La rivelazione del segreto ad opera della nutrice e la durissima reazione del fi-gliastro innescano il meccanismo di distruzione e autodistruzione con cui Fedra vuole salvaguardare il proprio onore anche dopo la morte impartendo a Ippolito una lezione di σωφροσύνη (σωφρονεῖν μαθήσεται v 731) ma al contempo macchiandosi del gesto ignobile di accusare un innocente
Drsquoaltra parte un altro innocente Ippolito Nella sua esperienza si contrappongono due ordini di valori castitagrave ed eros Ar-temide e Afrodite Il mondo della natura incontaminata dei boschi e dei monti inaccessibili degli animali selvaggi e della caccia costituisce lrsquoambiente in cui si svolge unilateralmente lrsquoesperienza di Ippolito Ma la purezza che il giovane ostenta ha un che di irriverente nel rifiuto categorico di Afrodite con un estremi-smo che sconfina nella ὕβρις e che richiama lrsquoanalogo atteggiamento dellrsquoAiace sofocleo nei confronti di Atena
Una costruzione simmetrica
Lrsquoanalisi dellrsquoanimo femminilehellip
hellipdilaniato dalle pulsionihellip
hellipe lrsquoinnocenza del casto
ma in eccesso
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
430 EURIPIDE
Euri
pide
430430 EE
Andromaca
Composta probabilmente fra il 428 e il 425 lrsquoAndromaca (Ἀνδρομάχη) egrave un dramma fitto di riferimenti allrsquoattualitagrave politica sia per la serie di violenti
attacchi contro la politica spartana sia per lrsquoaugurio che rispecchia la situazione interna post-periclea che il governo della cittagrave sia posto nelle mani di una sola ldquomenterdquo per quanto modesta e cessi la laquoduplice tirannideraquo costituita dal con-trasto tra forze radicali e moderate Secondo la notizia di uno scolio al v 445 il dramma sarebbe stato rappresentato per la prima volta fuori di Atene verosi-milmente sotto la regia di un certo Democrate a cui lrsquoopera veniva ascritta negli esemplari noti a Callimaco
Andromaca vedova di Ettore vive a Ftia in Tessaglia come concubina assegnata a Neottolemo figlio di Achille quale preda di guerra A lui la donna ha generato un figlio mentre Ermione la figlia di Menelao e di Elena che Neottolemo ha sposato si egrave rivelata sterile ed egrave pertanto ferocemente gelosa della maternitagrave di Andromaca Lrsquoas-senza del marito che si egrave recato a Delfi per chiedere perdono al dio di un suo prece-dente atto di hybris offre ad Ermione lrsquooccasione per attentare alla vita di Andromaca la quale per sfuggirle si egrave rifugiata presso lrsquoaltare del santuario di Tetide dopo aver messo in salvo il figlio In un dialogo vivacissimo Ermione accusa la sventurata troiana di aver causato la sua sterilitagrave con arti magiche La giovane egrave appoggiata dal padre accorso da Sparta che ha appena catturato il fanciullo e minaccia la madre di ucciderlo se non abbandoneragrave la protezione dellrsquoaltare Cosigrave Andromaca sacrifica la propria vita per la salvezza del figlio e abbandona lrsquoaltare non si tratta in realtagrave che di un meschino tranello percheacute Menelao si appresta a uccidere anche il fanciullo Ma interviene il vecchio Peleo che in un violento alterco con Menelao gli infligge un tale scacco morale che lrsquoAtride pianta in asso la figlia e si ritira ignominiosamente Ora Andromaca egrave salva ed egrave invece Ermione in pericolo timorosa dellrsquoimminente pu-nizione del marito Tuttavia sopraggiunge Oreste suo antico pretendente che odia Ne-ottolemo e ha giagrave ordito un piano destinato a far perire il rivale per mano degli abitanti di Delfi E appunto arriva un messaggero a raccontare come Neottolemo sia stato mas-
tram
a
il motivo folclorico della moglie di potifar o del laquocasto insidiatoraquo
Il tema del giovane accusato ingiustamente dalla donna da lui respinta ha una ampia attestazione folclo-rica a partire dalla vicenda biblica dellrsquoinsidia subita da Giuseppe da parte della moglie di Potifar (Genesi 39) di cui esistono esempi anche nel mondo greco Bellerofonte e Stenebea Peleo e la moglie di Acasto Fenice e lrsquoamante del padre Rispetto a loro ciograve che distingue Ippolito egrave il disprezzo per lrsquoamore e per le donne che lo porta irrimediabilmente alla rovina Quello che in ambito mitico e folclorico era lo scontro tra una colpevole e un innocente diviene in Euripide piugrave sfumato e complesso matrigna e figliastro sono accomunati da questa ambiguitagrave bifronte di una vita sospesa fra innocenza e colpa
Puoi leggere un intervento e alcune testimonianze a questo proposito
MeMOriA LeTTerAriA
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
431
Euri
pide
431431I DRAMMI SUPERSTITI
sacrato a Delfi in seguito alle diffamazioni di cui Oreste lo ha fatto oggetto Il cadavere del figlio di Achille viene portato sulla scena ed egrave pianto con grande pathos dal nonno e dal coro formato da giovani donne di Ftia Ma Tetide apparsa ex machina consola lrsquoantico consorte e annuncia gli eventi futuri Andromaca diventeragrave sposa di Eleno suo figlio saragrave capostipite della dinastia dei sovrani della Molossia (Epiro) e Peleo innal-zato al rango di divinitagrave vivragrave con lei nel suo palazzo marino e potragrave rivedere Achille nellrsquoIsola Bianca
Discussa e spesso negata egrave lrsquounitagrave del dramma giagrave svalutato dalla critica antica secondo la testimonianza dellrsquoargumentum come laquodi seconda categoriaraquo (τῶν δευτέρων) unitagrave ricercata ora nella figura di Andromaca ora in quella di Ermio-ne ora nel contrasto fra le due donne Ma Euripide ha prodotto un tipo di dramma che prelude alle tragedie di intrigo e che appare dotato di unrsquoabile articolazione compositiva in quanto costruito sul rinnovarsi ndash per Andromaca per Ermione e in certa misura anche per Peleo ndash di una medesima dinamica che poggia su uno stato di impotenza e di disperazione (ἀμηχανία) seguito da unrsquoinopinata salvez-za (σωτηρία) ripetizione accompagnata dal riproporsi di analoghe immagini e dalla simmetrica inserzione di brani commaticiSul piano registico egrave controversa la presenza sulla scena di Andromaca e del figlio nel corso dellrsquoesodo ma alcuni indizi (fra cui la formulazione del v 1243) sembrano smentire unrsquoipotesi nata dallrsquointento di far gravitare lrsquounitagrave dellrsquoopera intorno alla figura di Andromaca
Ecuba
Due allusioni di Aristofane nelle Nuvole (vv 718 e 1165) del 423 allrsquoEcuba (Ἑκάβη) rispettivamente ai vv 160 e 172-174 permettono insieme con al-
tri indizi di collocare questo dramma nel 425 o nel 424 Lrsquoopera consta di due ldquoazionirdquo concentrate attorno alla figura della protagonista da un lato il sacrificio della giovane Polissena sulla tomba di Achille desunto dai Canti cipricirc e dalla Presa di Ilio e forse anche dalla perduta Polissena di Sofocle dallrsquoaltro la ven-detta di Ecuba nei confronti di Polimestore per lrsquoassassinio di Polidoro motivo inattestato prima di Euripide
Con la caduta di Troia Polidoro figlio di Priamo ed Ecuba egrave stato assassinato dal re tracio Polimestore per impossessarsi impunemente del tesoro affidatogli in custodia insieme col fanciullo il corpo del quale gettato in mare attende ora sepoltura La scena egrave collocata nel Chersoneso tracio durante una sosta della flotta greca imposta dai venti sfavorevoli e nel prologo proprio lrsquoombra di Polidoro racconta della sua morte e annuncia la sorte che incombe sulla sorella Polissena (il fantasma di Achille ha chiesto che gli sia sacrificata) Scomparso Polidoro entra in scena Ecuba angosciata da un sogno (una cerva sbranata da un lupo) che ella sente riguardare i propri figli La prima sventura che le viene an-nunciata egrave infatti la decisione presa dai Greci di sacrificare sua figlia Polissena Odisseo viene a prelevare la fanciulla per il sacrificio e invano Ecuba lo supplica di risparmiarla
La mancanza di unitagrave di una tragedia
laquodi intrigoraquo
tram
a
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
432 EURIPIDE
Euri
pide
432432 EE
Ma Polissena stessa interrompe la preghiera della madre convinta di dover anteporre la morte al destino di schiavitugrave che lrsquoattende Dopo il commiato della giovane lrsquoaraldo Taltibio riferisce della morte di Polissena e dellrsquoammirazione che gli stessi nemici han-no provato dinanzi al suo coraggio Mentre Ecuba e le donne troiane che compongono il coro (anchrsquoesse ridotte in schia-vitugrave) apprestano le esequie viene introdotto un cadavere che si scopre essere quello di Polidoro rinvenuto sulla riva del mare Lrsquoira suscitata dalla scoperta della misera fine del figlio induce Ecuba a chiedere la collaborazione di Agamennone per vendicarsi del traditore Polimestore Lrsquoavido assassino mandato a chiamare da Ecuba cade nel tranello che gli viene teso col miraggio di un altro tesoro entra disarmato nella tenda dove la vecchia regina e le altre donne accecano lui e ne uccidono i figli Invano Polimestore implora vendetta da Agamennone lrsquoAtride si mostra solidale con Ecuba e a Polimestore altro non resta che predire a costei la metamorfosi in cagna
Lrsquoimpegno a saldare in unitagrave compositiva le due sequenze rispettivamente in-centrate sulle sorti di Polissena e di Polidoro egrave riconoscibile in vari tratti come lrsquoapparizione dellrsquoOmbra di Polidoro giagrave nel prologo e soprattutto lrsquoincastro del-le due vicende in modo che lrsquoaccumulo di sofferenze valga da motivazione per la graduale trasformazione di Ecuba da vittima prostrata (quale appare al principio nella monodia anapestica dei vv 59 ss) in spietata esecutrice di un piano di vendetta da lei abilmente architettato Uno sbocco che approfondisce uno spunto giagrave toccato nella conclusione degli Eraclidi (Alcmena punitrice di Euristeo) con-frontabile anche percheacute in entrambi i casi le vittime della punizione assumono improvvisa capacitagrave profetica
Dramma fosco e senza aperture anche lrsquoEcuba egrave densa ndash al pari dellrsquoAndromaca ndash di riferimenti alla situazione politica attuale Euripide si schiera apertamente contro i demagoghi e in particolare Odisseo egrave definito δημοχαριστής (laquocolui che compiace il popoloraquo) al v 132 e a questa critica indirizzata ai demagoghi si associa una sfiducia nella massa che denuncia unrsquoevidente involuzione rispetto allrsquoelogio del demos ai vv 699-702 dellrsquoAndromaca dove ancora si sottolineava la potenziale superioritagrave dei governati su coloro che detengono le cariche pub-bliche
Supplici
Del 423 o del 422 sono le Supplici (Ἱκέτιδες) che presuppongono la sconfitta subita dagli Ateniesi a Delio nel novembre del 424 e non possono essere po-
steriori alla battaglia per la conquista di Anfipoli (appunto del 422) nella quale perigrave Cleone (al quale si allude per contrasto nel singolare ldquoappello elettoralerdquo dei vv 726-730) Euripide ha ripreso un tema ndash il recupero delle salme degli Argivi caduti nella spedizione di Adrasto e Polinice contro Tebe ndash che era giagrave stato trat-tato da Eschilo negli Eleusinicirc senoncheacute mentre in Eschilo Teseo otteneva per via pacifica la restituzione dei corpi Euripide ha scelto la versione bellicistica
Il tentativo di conferire unitagrave
compositiva
Allusioni alla fosca attualitagrave ateniese
La pietas per caduti in battaglia
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
433
Euri
pide
433433I DRAMMI SUPERSTITI
che troviamo attestata anche in Erodoto (IX 27 3) e che ha permesso di presen-tare il re ateniese come risoluto difensore di una norma panellenica
Guidate da Adrasto le madri degli eroi argivi caduti sotto le mura di Tebe si recano ad Eleusi per sostenere i diritti alle esequie dei propri figli e davanti allrsquoaltare di Demetra supplicano insieme con le loro ancelle Teseo sovrano di Atene percheacute ottenga la resti-tuzione dei cadaveri insepolti Dopo il prologo recitato da Etra madre di Teseo che prende contatto con le madri supplicanti un dialogo tra Teseo e le supplici e una lunga discussione polemica tra lo stesso Teseo e Adrasto (accusato di aver intrapreso la spedizione in contrasto con la volontagrave divina) alla fine anche su insistenza della madre Etra il re ateniese accoglie la richiesta e manda a Tebe un araldo per saggiare la possibilitagrave di riottenere le salme per via diplomatica ma sopraggiunge un araldo tebano che presentandosi come portavoce di Creonte e chiedendo lrsquoespulsione di Adrasto suscita lrsquoimmediata reazione di Teseo espressa in unrsquoappassionata apologia della democrazia ateniese e il dialogo fra i due si conclude in sostanza con una dichiarazione di guerra da parte di Teseo Dopo la battaglia in cui gli Ateniesi riescono vincitori lrsquoattesa dei corpi dei campioni argivi alimenta uno stasimo che egrave di gioia per la vittoria ma anche di dolore sia per i figli uccisi sia piugrave in generale per la miseria della condizione umana Segue un acceso dibattito fra Adrasto e Teseo sullrsquoutilitagrave di quella guerra che aveva immolato tanti eroi illustri e sui valori a cui vanno educati i figli La preparazione della pira per le salme (da cui per decisione di Teseo ma contro la volontagrave di Adrasto le madri vengono tenute lontane) promuove uno stasimo che costituisce un vero e proprio lamento funebre Nellrsquoultimo episodio Evadne invano dissuasa dal padre Ifi si getta nella pira dove arde il corpo del marito Capaneo (lrsquoeroe che era stato colpito dalla folgore di Zeus e che per decisione di Teseo egrave stato collocato in disparte dagli altri) Segue un altro sviluppo luttuoso percheacute appare un secondo coro costituito dai figli de-gli Argivi caduti che portano le urne con le ceneri dei padri e in un nuovo threcircnos uni-scono i propri lamenti a quello delle nonne Adrasto si congeda da Atene promettendo la fedeltagrave di Argo ma Atena apparsa ex machina pretende che gli Argivi confermino la promessa con un patto solenne
La tragedia ha unrsquoindubitabile motivazione politica nellrsquoesaltazione dei valori etici e umanitari (il diritto alla sepoltura) difesi da Teseo come sottolineava giagrave lrsquoargumentum dove lrsquoopera egrave definita un laquoencomio di Ateneraquo e in ef-fetti nelle Supplici si teorizza il ruolo di Atene come garante di una norma panellenica in quanto soccorritrice degli oppressi secondo un clicheacute propa-gandistico (attestato anche in Erodoto IX 27) formatosi in etagrave periclea drsquoaltra parte lrsquoelemento patriottico risulta da ultimo come svuotato dallrsquointerno sia percheacute la tragedia trova il suo centro emozionale laquonella rappresentazione del lutto delle madriraquo sia per la laquopresa di posizione contro lrsquoidealizzazione della battaglia in quanto spettacolo in cui si puograve fare sfoggio di valore militareraquo15 e δοριμανής (laquofolle di guerraraquo) egrave detta la Grecia al v 485 Una serie di orien-tamenti antibellicisti erano del resto affiorati in alcuni drammi perduti di poco anteriori alle Supplici quali lrsquoEretteo (con lrsquoaugurio di pace contenuto nel fr 60 Austin) e il Cresfonte (con lrsquoinvocazione a Eirene nel fr 453 N2 come laquodispensatrice di ricchezzaraquo)
tram
a
Valori umanitari e antibellicisti
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
434 EURIPIDE
Euri
pide
434434 EE
Sul piano compositivo le Supplici si configurano come un dramma singolar-mente statico ricco di elementi rituali (le lamentazioni delle madri nella parodo il threcircnos conclusivo) e con unrsquoanalisi del dolore che smentisce di fatto lrsquootti-mismo di superficie espresso anche nellrsquoexcursus di Teseo (vv 195 ss) sulla condizione umana
Elettra
Si era soliti fissare la data di rappresentazione dellrsquoElettra (Ἠλέκτρα) al 413 in ragione di un supposto riferimento dei Dioscuri ai vv 1347-1356 alla
grande spedizione ateniese in Sicilia e piugrave in particolare alla spedizione di soc-corso guidata da Demostene (cfr Tucidide VII 17 1) fincheacute G Zuntz mostrograve il carattere aleatorio della presunta allusione e sulla base della frequenza di solu-zioni nellrsquouso del trimetro giambico ricondusse lrsquoopera a un momento anteriore alla trilogia troiana del 415
Uno dei problemi piugrave dibattuti egrave poi quello rappresentato dal rapporto cronologi-co con lrsquoElettra di Sofocle che probabilmente egrave posteriore anche se non esisto-no argomenti decisivi a favore dellrsquouna o dellrsquoaltra soluzione
La scena con audace innovazione rispetto alle Coefore di Eschilo non egrave collocata dinanzi al palazzo degli Atridi ma nella campagna argiva di fronte a una modesta di-mora dove Elettra vive fra le ristrettezze economiche come sposa di un contadino che per rispetto della condizione principesca della consorte non lrsquoha mai toccata (le nozze erano state imposte ad Elettra dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto cosigrave da impedire che da lei nascesse un figlio di stirpe regale che potesse un giorno vendicare lrsquouccisione di Agamennone) Adesso Oreste che si era rifugiato in Focide egrave tornato in incognito accompagnato dallrsquoamico Pilade appurata lrsquoidentitagrave di Elettra si finge un amico del fratello da questi inviato per accertarsi della situazione e organizzare un piano di vendettaMentre dunque Oreste e Pilade sono entrati per rifocillarsi nella casupola di Elettra la donna dopo un canto del coro esce allrsquoesterno raggiunta da un vecchio servo di Aga-mennone che lungo la via si era recato a offrire libagioni sulla tomba dellrsquoAtride e ligrave aveva scorto stupito lrsquoofferta di una ciocca di capelli egrave proprio questo dato ad offrire lo spunto per una disputa fra il vecchio ed Elettra sul possibile valore del ricciolo e di altri segni come indizi del ritorno di Oreste (vv 503-546)Il riconoscimento avviene comunque (sul modello dellrsquoepisodio di Odisseo e di Eu-riclea nel canto XIX dellrsquoOdissea) attraverso la messa in evidenza di una cicatrice al sopracciglio che Oreste si era prodotto rincorrendo un tempo un cerbiatto di qui lrsquoesultanza di Elettra sia per aver ritrovato il fratello sia per poter realizzare una ven-detta lungamente attesa Primo a cadere egrave Egisto colto a tradimento da Oreste mentre compie un sacrificio fra i campiIntanto Elettra egrave riuscita ad attirare la madre presso il suo tugurio con la falsa notizia di aver partorito (vv 998-1146)Clitennestra entra nel tugurio Oreste egrave in agguato e subito la colpisce a morte Poi compiuto il delitto lrsquoardore dei fratelli matricidi si trasforma nellrsquoangoscia espressa
Una tragica analisi del dolore
La datazionehellip
hellipe il rapporto con la tragedia
di Sofocle
tram
a
T5
T6
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
435
Euri
pide
435435I DRAMMI SUPERSTITI
in un commo per il peso dellrsquoatto compiuto Ma i Dioscuri fratelli di Clitennestra appaiono drsquoimprovviso ex machina e riconducono la vicenda sui binari tradizionali Oreste dovragrave dare Elettra in moglie a Pilade ed egli stesso saragrave assolto del suo delitto dal tribunale ateniese dellrsquoAreopago
Euripide rielabora il mito attuando un processo di ldquoimborghesimentordquo della vi-cenda e dei personaggi Lrsquoambientazione agreste colloca gli avvenimenti in una cornice che contrasta con il clima di orrore che il duplice omicidio comporterebbe alcune scenette di gusto schiettamente campagnolo sarebbero anzi piugrave adatte alla commedia che alla tragedia come quando entra in scena il pedagogo trafelato per la salita e carico di cibarie di cui decanta la bontagrave (una caciotta un agnellino da latte un vinello dalla fragranza squisita)
Ancor piugrave evidente il processo di demitizzazione degli eroi
Elettra non ha piugrave nulla della grandiositagrave furiosa e ossessiva dellrsquoeroina so-foclea ma egrave presentata come una donna tormentata dal rancore nei confronti della madre che lrsquoha relegata a una vita miserabile e non consona al suo rango imponendole il matrimonio con un uomo di ceto inferiore nel perso-naggio non mancano addirittura tratti di civetteria come quando allrsquoinizio del dramma Elettra inveisce quando impresentabile per i vestiti di stracci e lrsquoaspetto scarmigliato si vede costretta a rifiutare lrsquoinvito alla festa in onore di Hera
Clitennestra che nellrsquoAgamennone si ergeva con la sua figura di gigante e che mostrava in scena lrsquoascia insanguinata professandosi demone vendicatore della casa dei Tantalidi qui appare come una povera donna invecchiata nel rimorso del crimine commesso e frustrata per sapersi inadeguata al suo ruolo di madre e consapevole di non poter in nessun modo conquistare lrsquoaffetto della figlia che pure desidererebbe
Oreste egrave svuotato di caratura eroica anche dopo aver consumato la vendetta insieme con la sorella non percepisce come in Eschilo lrsquoorrore religioso per aver infranto il tabugrave del matricidio e nemmeno condivide con la sorella la fe-roce soddisfazione liberatoria come in Sofocle quello che avverte egrave solo un ldquoumanordquo raccapriccio per il sangue versato accompagnato da un vago senso di rimorso per un gesto che mai si sarebbe dovuto commettere
In questo contesto emerge la superioritagrave morale del contadino che non tocca Elettra e cerca di alleviarne il dolore con autentica comprensione umana Egli costituisce una di quelle figure umili che rappresentano lrsquoirrompere di valori nuovi la critica al sistema dei valori tradizionali sta qui nellrsquoopposizione fra no-biltagrave drsquoanimo e nobiltagrave che proviene dal γένος e dalle ricchezze proposta espli-citamente nellrsquoantitesi φύσις χρήματα (v 940 s) che giagrave era stata avanzata in ambito filosofico da Ippia e da Antifonte
Verso un laquodramma borgheseraquo
Personaggi senza mito
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
436 EURIPIDE
Euri
pide
436436 EE
Nel finale lrsquointervento ex machina dei Dioscuri sembra riportare il mito sul binario rassicurante della tradizione Elettra sposeragrave Pilade e Oreste saragrave assolto dallrsquoAreopago In realtagrave come osserva A Lesky laquoal poeta importava dire attra-verso la voce dei gemelli divini che Clitennestra aveva subito una sorte giusta ma Oreste non aveva agito giustamente Il saggio dio di Delfi ha dato un ordine non saggio Lagrave dove Eschilo trovava una problematica profonda ma tutta com-presa nel suo pensiero religioso Euripide vede soltanto lrsquoinsostenibilitagrave di un mito che fa impugnare al figlio lrsquoarma omicida contro la madreraquo
Eracle furente
Del periodo intorno al 415 egrave lrsquoEracle furente (Ἡρακλῆς μαινόμενος) uno
dei drammi piugrave sconcertanti di Euripide a causa dellrsquoimprovvisa metamorfosi laquoper cui il salvatore dei cari ne diviene omi-cida lrsquoinfallibile arciere egrave saettato dallo strale della follia il consolatore degli al-tri ha bisogno del piugrave pietoso conforto il possente eroe si riduce a una misera larva annichilita la speranza si cangia in orro-re lrsquoesultanza in allibito lamentoraquo (FM Pontani) Cospira con questo risultato anche il ro-vesciamento della tradizionale biografia dellrsquoeroe che secondo la versione pre-eu-ripidea realizzava le sue famose ldquofaticherdquo dopo aver ucciso in un accesso di follia la moglie Megara e i figli mentre in Euri-pide egli si egrave sottoposto volontariamente alle varie imprese per consentire al padre Anfitrione e a se stesso il ritorno in patria (Argo)
Quando Eracle compiuta lrsquoultima fatica (la discesa aglrsquoinferi e la cattura di Cerbe-ro) torna a Tebe e salva i propri familiari dalla persecuzione di Lico (re dellrsquoEubea costui aveva ucciso Creonte e usurpato il trono tebano) egli egrave lrsquoeroe generoso e integerrimo e nessun presentimento lascia sospettare il suo crollo imminente nella folliaQuesta follia viene rappresentata sulla scena da Euripide come effetto dellrsquointervento esterno di Iride e di Lyssa inviate da Era che instillano nellrsquoeroe un devastante delirio senza altra motivazione che lrsquoostilitagrave della sposa di Zeus e anzi da parte di Lyssa con la precisa consapevolezza della nobiltagrave di Eracle (cfr vv 849 s laquoQuestrsquouomo egrave insigne sulla terra e fra gli degraveiraquo) In tal modo lrsquointervento divino egrave spogliato di qualsiasi razionalitagrave e si propone quale assurda interferenza nella realtagrave umana
Una colpa non risolvibile con la
religione razionale
Un Eracle sconcertante
tram
a
La follia di Eracle facciata A del raquoCratere di Madridraquo opera firmata da Astea proveniente da Salerno (340 aC) Madrid Museo Archeologico Nazionale di Spagna
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
437
Euri
pide
437437I DRAMMI SUPERSTITI
Perciograve questo dramma riprende quella linea di desolato pessimismo che giagrave do-minava lrsquoEcuba drsquoaltra parte affiora nellrsquoEracle una concezione della divinitagrave che smentisce clamorosamente la stessa vicenda scenica (laquoIo non credo ndash af-ferma Eracle ai vv 1341-1346 ndash che gli degravei amino unioni illecite o che si met-tano in catene o che lrsquouno divenga padrone dellrsquoaltro La divinitagrave se veramente egrave tale non ha bisogno di niente tutto il resto non egrave che assurda invenzione dei poetiraquo) mentre nella fase conclusiva della tragedia lrsquointervento pietoso di Teseo che conforta lrsquoamico inducendolo a rinunciare alla prospettiva del suicidio propone unrsquoipotesi di accettazione del destino e di coraggio di vivere che apre uno spiraglio sia pur esiguo di umanistica fiducia nelle risorse della persona in quanto capace di sottrarsi alla morsa in cui gli degravei tenderebbero a soffocarlo (come ha scritto il poeta neogreco Giorgio Seferis Euripide laquovide le vene degli uomini come una rete ove gli degravei ci prendono come le belve e cercograve di forarlaraquo)
Coerente con lrsquoorientamento tematico egrave lrsquoarchitettura dellrsquoopera un dittico in-tenzionalmente simmetrico la cui seconda sezione inizia col v 815 (e il nuovo avvio egrave sottolineato formalmente dal carattere prologico del dialogo fra Iride e Lyssa)
Troiane
Del 415 sono le Troiane o Troadi (Τρῳάδες) ultimo dramma di una trilo-gia di argomento troiano comprendente anche lrsquoAlessandro e il Palamede
NellrsquoAlessandro Alessandro (Paride) allevato dai pastori dellrsquoIda subiva un agguato tesogli da Ecuba e Deifobo
Rifugiatosi presso un altare era riconosciuto dalla madre e accolto a Troia Notevole doveva essere il ruolo di Cassandra che profetizzava le future di-sgrazie Nel secondo dramma Odisseo provocava la rovina di Palamede accusandolo falsamente di tradimento ma il fratello di Palamede Eace riu-
sciva a informare il padre Nauplio che si sarebbe vendicato dei Greci facendoli naufragare sulla via del ritorno contro gli scogli del capo Cafereo
Nelle Troiane le ultime ore di Ilio sono rappresentate attraverso le sofferenze di Ecuba costantemente presente sulla scena e i successivi incontri della vec-chia regina con Cassandra con Andromaca e con Elena tre ldquoattirdquo giustapposti lrsquouno allrsquoaltro secondo unrsquoinedita struttura paratattica che tuttavia non pregiudica lrsquoomogeneitagrave del dramma caratterizzato da una ricerca esasperata di effetti pa-tetici
Un pessimismo che coinvolge anche
la sfera divina
Un altro dittico simmetrico
La trilogia su Troiahellip
hellipe le sue ultime ore disperate
Maschera tragica di terracotta di Ecuba (IV
secolo aC)
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
438 EURIPIDE
Euri
pide
438438 EE
Nel prologo Posidone e Atena preannunciano la catastrofe che distruggeragrave la flotta gre-ca durante il ritorno e dissemineragrave di cadaveri le acque dellrsquoEgeo Poi la scena colloca-ta nel campo greco dinanzi a Troia ormai conquistata vede le donne troiane sorteggiate come schiave insieme con Ecuba Lrsquoaraldo Taltibio finemente caratterizzato come sensibile alle sofferenze dei vinti vie-ne ad annunciare ad Ecuba quale sorte attende lei e le altre prigioniere lrsquoattenzione si appunta su Cassandra la profetessa di Apollo assegnata ad Agamennone come sua concubinaEd ecco che Cassandra colta da un improvviso delirio agita la fiaccola nuziale e intona per se stessa lrsquoimeneo Poi dopo che Ecuba ha lamentato la fine dellrsquoimmenso potere della sua famiglia Andromaca esprime il suo desiderio di morire ora che egrave stata asse-gnata al figlio dellrsquouccisore di Ettore Neottolemo Ecuba la esorta a sopportare la sua sorte per il bene del figlio ma proprio il piccolo Astianatte viene sottratto alla madre dato che i Greci dietro consiglio di Odisseo hanno deciso di gettarlo dalle mura di Troia essi temono che il figlio di Ettore possa divenire una volta cresciuto ciograve che il padre si augurava un guerriero ancora piugrave forte di lui Quando Menelao che sembra risoluto a punire Elena finalmente riconquistata si pre-senta in scena Ecuba lo esorta a guardarsi dal fascino di lei Ed egrave proprio Ecuba a con-futare lrsquoautodifesa della bellissima donna per cui si sono avuti tanti lutti Elena non egrave come vorrebbe sostenere una vittima di Afrodite anzi chiama col nome della dea ciograve che non egrave altro che la sua lussuria Attratta da Paride e dalle ricchezze troiane ella lo ha seguito di sua volontagrave anche se ora invoca la gara di bellezza fra le tre dee e il giudizio favorevole ad Afrodite da parte di Paride come causa prima delle sventure della guerra Menelao sembra concordare con Ecuba e acconsente alla richiesta di non far salire Ele-na sulla sua stessa nave egrave chiaro perograve che gli egrave bastato rivederla per rimanerne ancora irretito e rinviare a dopo il ritorno in patria la condanna a morte che intendeva eseguire immediatamente La tragedia si chiude sulla disperazione di Ecuba alla quale toccano dopo la partenza di Andromaca insieme con Neottolemo le esequie del nipotino Astianatte la madre ha chiesto per lui che venga sepolto sullo scudo di Ettore e il pianto di Ecuba sottolinea lo stravolgimento di un ordine naturale che avrebbe previsto che fosse piuttosto il nipote a rendere onore alla sua tomba Il dolore della regina sembra trovare come unica solu-zione quella di lanciarsi tra le fiamme della cittagrave a cui Taltibio ha ordinato di appiccare lrsquoincendio Ma mentre Troia crolla ella viene avviata insieme con le altre donne verso le navi che la condurranno oltre il mare alla schiavitugrave
laquoContrariamente a quanto si crederaquo osserva U Albini laquole Troiane sono un pre-zioso meccanismo di orologeria Gli episodi si agganciano e si preparano lrsquoun contro lrsquoaltro A Cassandra protesa verso lrsquoavvenire segue Andromaca con cui lrsquoavvenire si estingue Elena che rappresenta il passato e al centro della scena crsquoegrave sempre Ecuba il filo ininterrotto che connette gli eventiraquo
Il poeta dimostra una sensibilitagrave innovativa nellrsquoaffrontare il tema della guerra senza nessuna concessione ai valori della tradizione eroica al centro della scena le donne di Troia costituiscono un quadro luttuoso che caratterizza la condizione degli sconfitti ma coinvolge nella stessa sorte di dolore universale i vinti e i vin-citori Come appare evidente fin dal prologo la guerra non risparmia nessuno
tram
a
Una perfetta connessione fra
episodi
Le conseguenze della guerra
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
439
Euri
pide
439439I DRAMMI SUPERSTITI
Posidone e Atena concertano la disastrosa tempesta che annienteragrave la flotta gre-ca nel delirio di Cassandra egrave presagita la fine che attende il capo della spedizio-ne Agamennone al ritorno in patria E drsquoaltra parte la condanna della guerra e della conquista egrave denuncia di un dolore piugrave ampio che pervade lrsquoesistenza umana e che costituisce la tonalitagrave di fondo della tragedia Quella proposta da Euripide egrave unrsquoimmagine della guerra alternativa al bellicismo dominante e che stride con il clima di invasamento collettivo che colpisce il δῆμος ateniese nel fervore dei preparativi per la disastrosa spedizione in Sicilia (415) che avragrave inizio pochi mesi dopo la rappresentazione delle Troiane La tragedia sembra essere quasi un monito del poeta ai concittadini nel pieno del dibattito che riguarda il destino dellrsquoimpero marittimo quando ancora era viva lrsquoeco dellrsquooperazione conclusasi in un bagno di sangue a Melo (416-415) quan-do Atene aveva rivendicato i suoi diritti di potenza egemone in virtugrave della legge del piugrave forte (vedi Tucidide ldquoDialogo degli Ateniesi e dei Melicircrdquo p 000)
Accanto alla guerra torna ricorrente il leitmotiv dellrsquooro immagine funesta che sim-boleggia tutto ciograve che egrave oggetto smodato di desiderio in realtagrave nullrsquoaltro che illusoria apparenza che cela in seacute lrsquoinsidia che porta alla rovina Sul piano delle figure uma-ne Elena che con il suo volto imbellettato e luminoso egrave stata causa della catastrofe per i Troiani e per i suoi esercita una seduzione assimilabile a quella dellrsquooro Nel processo che ha come giudice il marito Menelao nessuno spazio sembra lasciato a una ldquogiustiziardquo che riconosca agli offesi almeno la soddisfazione di vedere punita la responsabile della rovina gli spettatori sanno bene giagrave in partenza che il sovrano si lasceragrave di nuovo irretire dalle lusinghe e dalla bellezza della moglieNella sezione antologica la tragedia egrave proposta integralmente in traduzione ita-liana
Elena
LrsquoElena (Ἑλένη) fu rappresentata nel 412 aC nellrsquoambito di una trilogia di cui faceva parte anche la perduta Andromeda Sulle orme della Palinodia di
Stesicoro e con libera e innovatrice rielaborazione del mito tradizionale il poeta immagina che non la vera Elena ma un suo simulacro (εἴδωλον) copia perfetta della Tindaride abbia seguito Paride e che ella sia stata invece trasportata in Egitto da Ermes e qui accolta come ospite dal vecchio re Proteo
La scena del dramma egrave collocata appunto in Egitto lungo il Nilo presso il palazzo di Teo-climeno (figlio del defunto Proteo) che ambisce alle nozze con Elena nonostante il deciso rifiuto della donna Cosigrave Elena egrave stata costretta a rifugiarsi presso la tomba di Proteo La falsa notizia recatale da Teucro in viaggio verso Cipro che il suo sposo egrave perito in mare nel viaggio di ritorno da Troia la induce a meditare il suicidio e a mala pena il coro (un gruppo di fanciulle greche rapite dai pirati) la convince a consultare la profetessa Teonoe sorella del re dotata di profetiche virtugrave il suo responso egrave che lrsquoAtride egrave vivoNel frattempo giunge proprio Menelao fortunosamente scampato a un naufragio e ligrave
La fallace luce dellrsquooro
e della bellezza
T5
La ripresa della Palinodia
stesicorea
tram
a
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
440 EURIPIDE
Euri
pide
440440 EE
approdato insieme con la falsa Elena Ora egli si imbatte nella vera moglie tornata sulla scena insieme con il coro ma essendo sicuro di averla appena lasciata in una grotta crede di essere vittima di unrsquoallucinazione (vv 528-596)Entra in scena un messaggero che riferisce come la ldquofalsardquo Elena che era stata na-scosta in una grotta si sia improvvisamente sollevata in aria scomparendo dalla vista dei compagni dellrsquoAtride Allora Menelao si rende finalmente conto della veritagrave e puograve abbracciare la sposa ritrovata Di qui lrsquoavvio di un prolungato duetto semilirico (vv 625-697)La situazione incalza Infatti Teoclimeno egrave solito mandare a morte tutti gli stranieri che approdino nel suo paese e la sorte di Menelao sarebbe irrimediabilmente segnata se i due sposi non riuscissero ad architettare con lrsquoaiuto di Teonoe un audace piano di fuga Menelao sotto mentite spoglie va ad annunciare a Teoclimeno la propria morte in mare di qui un simulato scoppio di disperazione di Elena che poi finge di accettare ora che suo marito egrave dato per morto le nuove nozze col sovrano egizio al quale chiede perograve il permesso di poter prima celebrare un sacrificio in mare per onorare la memoria dello sposo Teoclimeno non solo acconsente ma fornisce una nave e su di essa gli sposi ritrovati possono prendere la via della fugaArriva sulla scena un messo a raccontare che in alto mare i marinai egiziani sono stati resi inoffensivi dagli uomini dellrsquoAtride e che la nave corre ormai sulla rotta per la Grecia la rabbia di Teoclimeno egrave cosigrave terribile che rischierebbe di restarne vittima sua sorella Teonoe ma i Dioscuri apparsi ex machina come alla fine dellrsquoElettra lo placano rivelandogli le linee di un destino a cui non gli egrave dato opporsi e che prevede la divinizzazione di Elena e per Menelao unrsquoesistenza dopo la morte nellrsquoIsola dei Beati
Egrave piugrave che mai evidente in questo dramma la volontagrave di Euripide di innovare la tra-dizione scegliendo una variante giagrave nota del mito di Elena ma meno conosciuta rispetto a quella tradizionale personaggio sfuggente e ambiguo al contempo oggetto di ammirazione e di esecrazione sia nellrsquoepos che nella lirica in Euripi-de Elena era giagrave stata oggetto di esecrazione e riprovazione morale nellrsquoEcuba e nelle Troiane
In questa sorta di divertissement euripideo Elena si riscopre sposa appassionata e fedele affettuosa e strenuamente gelosa della propria castitagrave bencheacute caratte-rizzata da quella scaltrezza tradizionale che le consentiragrave di congegnare il piano risolutivo per la salvezza Sembra quasi di assistere a un ldquoesperimento antropo-logicordquo operato dal poeta nello stravolgere e rimodulare il personaggio in un gioco illusionistico di parvenze
Contrapposto a lei il marito Menelao personaggio maschile oggetto di una dis-sacrazione corrosiva che vanifica il significato dellrsquoimpresa decennale Achei e Troiani alla fine si sono massacrati per anni per un εἴδωλον Egrave evidente il con-trasto fra la laquoveritagraveraquo ἀλήθεια e lrsquolaquoapparenzaraquo δόξα secondo una contrapposi-zione che egrave elemento chiave della riflessione sofistica Come osserva LE Rossi laquonellrsquoElena la realtagrave egrave incerta e lrsquouomo dubitando addirittura della correttezza della sua percezione stenta a definire la veritagrave vedendola contraddetta addirittu-ra da una sua inquietante duplicazioneraquo
T00
T00
Un personaggio amato da Euripidehellip
hellipche ne capovolge le caratteristiche
Gli uomini si massacrano
per un εἴδωλον
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
441
Euri
pide
441441I DRAMMI SUPERSTITI
Rappresentata lrsquoindomani della disfatta in Sicilia lrsquoElena propone unrsquoulteriore riflessione sulla guerra e sullrsquoillusorietagrave delle certezze soprattutto quelle legate alla religione tradizionale trattate con disincantato scetticismo (vv 1137-1143)
Cosrsquoegrave dio o non dioo quel che sta in mezzoChi dei mortali puograve diredi averlo trovatoalla fine di una lunga ricercaquando vede le opere degli dei procederein una direzione e poi nellrsquoaltrae volgersi di colpo in modo contraddittorio e inatteso
Rimane da rilevare lrsquoambientazione in un ambiente esotico in un paese abitato da stranieri dalle usanze barbariche nel quale Euripide colloca una fiaba orche-strata dal ruolo imprevedibile della τύχη Le strutture narrative regolate sul gusto per lrsquoavventura e i colpi di scena con il riconoscimento dellrsquoeroina e le peripezie preludono a un gusto teatrale e a situa-zioni che saranno caratteristiche della commedia nuova
Ifigenia fra i Tauri
LrsquoIfigenia fra i Tauri (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις) egrave accomunata allrsquoElena sia da fittissime analogie compositive sia dalla prossimitagrave cronologica in entrambi
i drammi un uomo e una donna legati da un vincolo parentale ritrovatisi in terra straniera e minacciati dal sovrano del luogo riescono a fuggire e a tornare in pa-tria grazie a uno stratagemma da essi stessi ideato e consistente in un finto rituale da eseguire in mare
Lrsquoillusorietagrave delle certezze
(anche religiose)
Ambientazioni e forme anticipatrici
della Nea
Un altro dramma laquoesoticoraquo
Oreste e Pilade incontrano Ifigenia nella Tauride Particolare di un cratere campano a figure
rosse (330-320 aC) Parigi Museacutee du Louvre
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
442 EURIPIDE
Euri
pide
442442 EE
Nel prologo Ifigenia stessa racconta quanto era successo dopo il mancato sacrificio in Aulide (argomento dellrsquoIfigenia in Aulide) salvata da Artemide e trasferita nel paese dei Tauri (odierna Crimea) ella egrave diventata sacerdotessa della dea Ligrave regna il sanguinario Toante che le impone di sacrificare ad Artemide qualsiasi greco arrivi nella contrada Ora poi Ifigenia si trova di fronte a una nuova pena ha sognato di toccare con il coltello sacrificale il capo del fratello che aveva lasciato bambino ad Argo Di ligrave a poco compare sulla scena Oreste insieme con lrsquoamico Pilade perseguitato da una parte delle Erinni anche dopo il verdetto di assoluzione dellrsquoAreopago egli deve portare in Attica per ordine di Apollo la statua di Artemide taurica I due sono stati catturati al momento dellrsquoapprodo dalle guardie di Toante Ifigenia va ad incontrarli appena sa che sono argivi interroga Oreste senza rico-noscerlo sulle atroci vicende della casa di Agamennone e gli propone in cambio della salvezza di portare ad Argo una lettera che informi i familiari di lei che ella egrave ancora in vita Oreste rifiuta di salvarsi egli solo e Pilade pur a malincuore deve acconsentire ad aver lui salva la vita in cambio del ruolo di messaggero Prima perograve di consegnare la lettera a Pilade Ifigenia gliela legge e allora i due fratelli si riconoscono Poi Ifigenia escogita un tranello per raggirare Toante e fuggire con Oreste Pilade e la statua garantitasi lrsquoappoggio del coro (formato da schiave greche) dice a To-ante che prima del sacrificio devono essere purificati in mare sia i due stranieri in quanto colpevoli di un delitto sia la statua di Artemide che egrave stata contaminata dal loro contatto Toante acconsente e viene informato della loro fuga (a bordo della nave che aveva portato Oreste e Pilade) quando ancora sarebbe in tempo a fermarli (unrsquoondata ha infatti respinto i fuggiaschi verso la spiaggia) ma interviene Atena ex machina a bloccarlo e a spiegare a Toante che egrave volere divino che Ifigenia giunga in Attica dove fonderagrave il tempio di Artemide ad Ale
Giagrave la tradizione epica post-omerica sapeva della leggenda della figlia di Aga-mennone sottratta da Artemide al sacrificio in Aulide e trasferita nella terra dei Tauri mentre dei Tauri stessi Erodoto (IV 103) racconta che onoravano una dea a cui offrivano sacrifici umani Sulla base di questi dati leggendari e antropolo-gici Euripide ha costruito unrsquoazione che nella prima e piugrave ampia parte tende al riconoscimento fra la protagonista e Oreste e nella seconda si snoda attraverso la beffa ai danni di Toante
Lrsquoefficacia del congegno drammaturgico egrave garantita dal fatto che il trapasso dal-la fase tesa al riconoscimento tra i fratelli a quella incentrata sullo stratagemma viene realizzato attraverso una sapiente modulazione che di una linea tesa alla meta dellrsquouccisione sacrificale di Oreste riesce a fare lo strumento per realizzare la meta contraria (la fuga) un gioco che non egrave tutto della Τύχη ma non appartie-ne del tutto neppure alla τέχνη umana in quanto si snoda entro una percezione della realtagrave come sostanza sfuggente ed enigmatica caleidoscopica labilitagrave di momenti su cui i personaggi cercano ansiosamente di far presa e prodigiosamen-te vi riescono solo al termine di romanzesche vicissitudini
tram
a
Una tradizione post-omerica
Ingredienti e motori romanzeschi
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
443
Euri
pide
443443I DRAMMI SUPERSTITI
Ione
Ragioni metriche e compositive collocano anche lo Ione (Ἴων) accanto allrsquoEle- na e quindi intorno al 412 Euripide rielabora una tradizione di cui troviamo
traccia in Erodoto (VIII 44) secondo cui gli Ateniesi erano chiamati Ioni da Ione figlio di Xuto e giagrave nel Catalogo attribuito ad Esiodo (fr 9 Merk-West) Xuto era ricordato come figlio di Elleno insieme con Doro ed Eolo
Ione figlio di Apollo e di Creusa figlia a sua volta del re ateniese Eretteo egrave stato espo-sto in una grotta dalla madre che temeva la reazione dei propri parenti e che sapeva di affidare in tal modo il fanciullo alla protezione di Apollo E in effetti Apollo (che recita il prologo) ha mandato Ermes a salvare Ione e lo ha affidato alle cure della Pizia a Delfi Piugrave tardi Creusa ha sposato Xuto (principe attico di origine straniera resosi benemerito verso gli Ateniesi nella guerra contro gli abitanti dellrsquoEubea) ma il matrimonio egrave ri-masto sterile Afflitti da questa mancanza di figli i due si recano a Delfi Mentre Xuto va a consultare lrsquooracolo di Trofonio Creusa (inquieta per le memorie che suscita in lei il luogo dovrsquoera avvenuta lrsquounione col dio) si imbatte in Ione ormai adulto che ha consacrato la sua esistenza al servizio di Apollo e i due prendono a dialogare Creusa rivela al giovane la sua tristezza per essere priva di figli e udendo che egli non conosce la propria madre avverte verso di lui un immediato moto di simpatia Intanto Xuto egrave tornato dallrsquooracolo di Trofonio dove ha saputo che non ripartiragrave da Delfi senza prole e lrsquooracolo della Pizia gli precisa che la prima persona che incontreragrave uscendo dal tem-pio saragrave proprio suo figlio Allrsquouscita Xuto incontra Ione e immagina cosigrave che questi sia il frutto della violenza che ubriaco aveva commesso su una giovane molti anni prima Allora persuade il giovane a seguirlo ad Atene senza nulla rivelare a Creusa ma costei viene informata dal coro (costituito dalle sue ancelle) e di fronte alla prospettiva di non aver piugrave figli suoi e di dovere per giunta sopportare in casa un figliastro reagisce con ira e istigata da un vecchio pedagogo decide di avvelenare Ione Proprio mentre il giovane sta portando alla bocca il calice col vino avvelenato qualcuno degli astanti pronuncia una frase di cattivo augurio Ione getta il vino a terra una colomba che se ne abbevera muore allrsquoistante Ione costringe allora il vecchio che gli ha portato la coppa a confessare il tentato delitto e si precipita a punire Creusa Inseguita la donna si rifugia nel tempio di Apollo dove la Pizia esorta il giovane a non macchiarsi del sangue della donna e gli consegna per ordine di Apollo il cesto in cui era stato esposto neonato Alla vista del cesto Creusa comprende che Ione egrave figlio suo Allora gli narra della sua antica unione con Apollo e infine i dubbi residui di Ione sono dissolti da Atena che apparsa ex machina conferma la versione di Creusa e rivela la volontagrave di Apollo per il futuro dovragrave restare segreto che Ione egrave figlio di Apollo e a Xuto bisogneragrave far credere che egrave figlio suo cosigrave che Ione stesso possa poi ricevere in ereditagrave il trono di Atene
Lrsquoazione intricata e avventurosa si basa su una serie di riconoscimenti veri o presunti allrsquointerno e ai margini dei quali Euripide realizza momenti di notevole suggestione nel prologo il canto intonato da Ione mentre spazza il tempio di Apollo mescola realismo (le minacce agli uccelli che nidificano sui cornicioni) e disteso lirismo (lrsquoincipit con la descrizione dellrsquoalba) piugrave innanzi allrsquointerno dello stratagemma ai danni di Ione la monodia di Creusa con la rievocazio-ne dellrsquounione col dio mostra uno scavo penetrante nella sensibilitagrave del per-
tram
a
Trama romanzesca e disteso lirismo
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
444 EURIPIDE
Euri
pide
444444 EE
sonaggio da ultimo il definitivo riconoscimento IoneCreusa dispiega quella esaltazione degli affetti familiari vissuti in chiave intensamente edonistica che costituisce un elemento caratterizzante del mondo poetico dellrsquoultimo Euripide
Fenicie
Nelle Fenicie (Φοίνισσαι) rappresentate fra il 411 e il 409 insieme con lrsquoEno- mao e il Crisippo egrave ripreso il motivo della lotta fratricida fra Eteocle e Poli-
nice figli di Edipo giagrave trattato da Eschilo nei Sette contro Tebe
La scena egrave a Tebe dove Eteocle egrave venuto meno al patto di regnare ad anni alterni stipu-lato col fratello Polinice Esule ad Argo questi ha sposato la figlia del re Adrasto e ora egrave giunto sotto le mura tebane alla guida di un grande esercito Dopo il prologo espositivo recitato da Giocasta Antigone guidata dal pedagogo sale sul tetto del palazzo e chiede ragguagli sui condottieri dellrsquoesercito nemico Assistiamo poi a un tentativo orchestrato da Giocasta di riconciliare i figli dato che Polinice egrave venuto in cittagrave su richiesta della madre per trattare la pace col fratello Ma il tentativo fallisce poicheacute Eteocle si propone come un despota adoratore del potere a qualsiasi prezzo Viene interrogato anche lrsquoindovino Tiresia che profetizza a Creonte fratello di Gio-casta che lrsquoarmata tebana potragrave prevalere solo se saragrave immolato il giovane Meneceo figlio di Creonte Questi sprona il figlio a rifugiarsi a Delfi ma Meneceo dopo aver finto obbedienza sacrifica volontariamente la propria vita Giunge un messaggero a raccontare che lrsquoassalto argivo egrave fallito ma i fratelli si prepara-no al duello decisivo in mezzo ai due eserciti schierati Pertanto Giocasta accompagna-ta da Antigone si porta precipitosamente sul campo di battaglia per tentare di impedire il duello ma quando vi arriva trova i figli caduti lrsquouno per mano dellrsquoaltro e si uccide sui loro corpi Creonte nuovo signore di Tebe di ritorno col cadavere del figlio vieta che Polinice sia seppellito in terra tebana e caccia via dalla cittagrave il vecchio Edipo ma Antigone si oppone con ardore a che suo fratello Polinice resti insepolto e rotto il fidanzamento con Emone figlio di Creonte si appresta ad accompagnare il padre sulla via dellrsquoesilio
Un critico antico (probabilmente Aristofane di Bisanzio) il cui giudizio egrave ripor-tato nellrsquoargumentum osservava che allrsquoefficacia scenica del dramma corrispon-deva una struttura disorganica e sovrabbondante e in particolare censurava come estranei al corpo dellrsquoopera sia la τειχοσκοπία (lo laquospettacolo dalle muraraquo con Antigone e il pedagogo che osservano i condottieri argivi sul modello di ciograve che fanno Elena e Priamo nel III canto dellrsquoIliade) sia lrsquoincontro di Polinice con Giocasta sia infine la presenza di Edipo che si appresta a partire per lrsquoesilio nella parte finale Senoncheacute anche queste scene superflue o eccentriche in relazione al progresso dellrsquoazione ribadiscono lrsquointeresse che giagrave abbiamo riscontrato come caratteristico dellrsquoultimo Euripide per la rappresentazione degli affetti familiari la teichoskopia culmina sullrsquoesultanza di Antigone nel riconoscere il fratello lrsquoarrivo di Polinice in cittagrave incorpora lrsquoincontro con la madre segnato da una mo-
tram
a
Disarmonia programmatica
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
445
Euri
pide
445445I DRAMMI SUPERSTITI
nodia di Giocasta che produce un effetto complesso e vibrante grazie alla fusione fra elementi patetici e inventivitagrave espressiva la partenza di Edipo mette in luce il vincolo che lega Antigone cosigrave al fratello come al padre E in effetti tutta lrsquoopera che esteriormente gravita sulla sorte di Tebe risolta per il meglio dal sacrificio di Meneceo verte sulla rovina di una famiglia quella dei Labdacidi ai cui estremi poli generazionali si pongono Antigone e Edipo da ultimo accomunati nellrsquoesi-lio imminente (una situazione che anticipa lrsquoEdipo a Colono sofocleo) mentre al centro del quadro sta la grande figura di Giocasta promotrice frustrata e infine suicida di una riconciliazione impossibile
Un problema particolare egrave posto dallrsquoesodo dove si sovrappongono in modo a tratti sconcertante i due motivi della sepoltura (divieto di Creonte relativo al cadavere di Polinice) e dellrsquoesilio (ci si chiede in particolare come Antigone potesse ad un tempo abbandonare Tebe e ribadire il suo proposito di seppellire il fratello)
Si egrave cercato a piugrave riprese e in vario modo di eliminare dissonanze e contraddizio-ni ad esempio espungendo come interpolazioni i brani collegati al motivo della sepoltura ma non si egrave giunti a conclusioni davvero convincenti Lrsquounica inter-polazione di cui si puograve essere sostanzialmente sicuri egrave quella dellrsquoultima sezione (vv 1737-fine) che non egrave compresa nel papiro di Strasburgo il quale invece riporta la precedente parte lirica dellrsquoesodo (vv 1710-1736)
Oreste
Uno scolio al v 371 ci informa che lrsquoOreste (Ὀρέστης) fu rappresentato nel 408 Si dovette trattare dellrsquoultimo dramma messo in scena da Euripide in
Atene prima di partire alla volta della Macedonia
Ad Argo dinanzi al palazzo degli Atridi Elettra accudisce il fratello Oreste che dopo il matricidio giace gravemente malato Dopo il prologo entra un coro di donne argive che Elettra invita a non far rumore per non destare il fratello appena assopitosi Poi Oreste prostrato dagli assalti intermittenti di un cupo delirio si risveglia e ha un incontro con Menelao reduce da Ilio con Elena e venuto ad Argo per riprendersi la figlia Ermione dallrsquoAtride dipendono le superstiti speranze di salvezza per i due fratelli ora che egrave venuto il momento del processo fissato dagli Argivi ma su proposta di un demagogo (solo un onesto contadino difende i diritti di Oreste) i matricidi vengono condannati a morte Per loro sembra non esservi alcuna via di scampo perduta ogni speranza pensano allora di vendicarsi di Menelao per il mancato aiuto Si decide in primo luogo per il rapimento di Ermione che viene catturata mentre sopraggiunge dopo aver visitato la tomba di Clitennestra poi Oreste e Pilade ndash come egrave raccontato da uno schiavo frigio che fugge atterrito dal palazzo ndash cercano di colpire la stessa Elena che perograve scompare prodigiosamente Sopraggiunge Menelao costringendo i tre disperati a barricarsi nel palazzo trascinan-
Un fi nale sovrabbondantehellip
hellipforse interpolato
tram
a
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
446 EURIPIDE
Euri
pide
446446 EE
dosi dietro come ostaggio Ermione vediamo Oreste sul tetto puntare la spada al collo della ragazza cosigrave da convincere Menelao a intercedere presso gli Argivi ma poi pro-prio quando lrsquoAtride ha ceduto lo stesso Oreste con un moto irrazionale si appresta ad appiccare lrsquoincendio al palazzo Sarebbe la fine per tutti se Apollo intervenuto ex machina non mettesse a posto ogni cosa Oreste scontato un anno di esilio si recheragrave ad Atene per essere giudicato dal tribunale dellrsquoAreopago (che lo assolveragrave) poi sposeragrave Ermione mentre Elettra avragrave come marito Pilade quanto a Elena egrave stata accolta sullrsquoOlimpo dove vivragrave immortale accanto ai Dioscuri
Ha pesato sul dramma il giudizio sostanzialmente negativo di Aristofane di Bi-sanzio che nellrsquoargumentum lo definiva laquopessimo nella caratterizzazione dei personaggiraquo bencheacute spettacolare (τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων χείριστον δὲ τοῖς ἤθεσι) Drsquoaltra parte Euripide ha rappresentato con arte ma-gistrale almeno la prostrazione di Oreste disteso come Fedra su un letto a princi-pio dellrsquoopera mostrando una consumata capacitagrave di scavo introspettivo per cui in particolare il personaggio stesso giunge a individuare ndash dietro le Erinni della tradizione ndash la propria laquocoscienzaraquo (σύνεσις) (v 396) quale vera matrice delle allucinazioni e dei tormenti che lo perseguitano
Non si puograve certo disconoscere una sfasatura fra la prima parte tesa alla ca-ratterizzazione attenta e sfumata e la seconda in cui i medesimi personaggi (Oreste Elettra Pilade) appaiono trasformati in disinvolti esecutori di un in-tricato μηχάνημα che solo lrsquointervento di Apollo egrave in grado di dipanare Non a caso egrave inserita in questo ambito quellrsquoldquoariardquo dello schiavo frigio che nel suo isterico balbettio rappresenta il pezzo lirico piugrave bizzarro mai composto da Eu-ripide giocato su un accumulo di immagini strane e su una serie inesauribile di variazioni ritmiche che richiamano le predilezioni dei contemporanei diti-rambografi
LrsquoOreste egrave perograve anche un dramma politico che si affianca alle Fenicie nel tra-durre lrsquoorientamento ideologico di Euripide dopo il tentativo oligarchico del 411 e la restaurazione della piena democrazia mentre perograve nelle Fenicie lrsquoaccento batteva sul pericolo della ldquotiranniderdquo e sullrsquoelogio della Ἰσότης (laquoUguaglian-zaraquo) nellrsquoOreste la critica allrsquooratoria sfrenata (cfr vv 902 ss) e la diffidenza nei confronti del demos sentito come un corpo sociale di cui occorre saper con-trollare le violente reazioni mostrano come Euripide tendesse ormai a dissociarsi tanto dai gruppi oligarchici quanto dai nuovi demagoghi (Cleofonte in particola-re come giagrave interpretavano gli scolicirc al v 904)
Ifigenia in Aulide
Dei drammi composti da Euripide in Macedonia ci restano lrsquoIfigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) e le Baccanti
La presa di coscienza di Oreste
Una seconda parte movimentata
Il disincanto politico dellrsquoultimo Euripide
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
447
Euri
pide
447447I DRAMMI SUPERSTITI
Ifigenia in Aulide si apre con una scena anapestica fra Agamennone e un suo servo La flotta degli Achei egrave alla fonda in Aulide in attesa di salpare alla volta di Troia ma venti contrari continuano ad impedirne la partenza Calcante ha dichiarato che questi venti sono provocati da Artemide che non egrave disposta a lasciar partire la flotta se prima non le saragrave immolata Ifigenia figlia di Agamennone lrsquoAtride ha quindi convocato al campo di Aulide Clitennestra e Ifigenia col pretesto di voler dare la fanciulla in sposa
ad Achille ma in realtagrave per sacrificarla ad Artemide Ora perograve ha cambiato idea e vuole spedire il servo ad Argo con una seconda lettera che annulli lrsquoordine contenuto nella prima Entra poi il coro costituito da giovani spose di Au-lide che offre una sorta di catalogo epico-lirico delle navi e degli eroi
Intanto Menelao ha intercettato il servo di Agamennone con in mano la seconda missiva e perciograve accorre per aggredire il fra-tello con dure accuse di tradimento salvo pentirsi subito dopo e convincersi delle buone ragioni di Agamennone proprio men-tre questrsquoultimo in una completa inversione delle parti dichia-ra che ormai non egrave piugrave possibile arrestare il corso degli eventi Poi Clitennestra e Ifigenia arrivano al campo Agamennone sente di non potersi svergognare davanti a tutto lrsquoesercito e di dover portare a compimento il sacrificio della figlia Non appena viene a conoscenza da Achille (che ella saluta come futuro genero) di
come stiano realmente le cose Clitennestra supplica il Pelide di aiutarla a salvare la figlia e Achille le garantisce il suo appoggio
Ma Agamennone egrave ormai irremovibile e non cede di fronte alle mi-nacce di Clitennestra e alle preghiere di Ifigenia
Achille poi per essersi opposto al progettato sacrificio della fanciulla rischia addirittura di essere lapidato dallrsquoesercito (che egrave stato sobillato da
Odisseo) A questo punto tuttavia la stessa Ifigenia che pur aveva cercato di far recedere il padre dal suo criminale proposito si dichiara pronta a essere immolata per il bene dellrsquoimpresa
tram
a
Cratere a volute apulo del Gruppo del Pittore dellrsquoIliupeacutersis Dalla Basilicata ora a Londra British Museum In alto sono presenti Apollo seduto con la fronda di alloro e Artemide cacciatrice con lrsquoarco e due lance A destra Ifigenia avanza rassegnata a capo chino verso lrsquoaltare Ma dietro di lei giagrave si intravede una cerva dalla pelle maculata ritta sulle zampe posteriori Agamennone ignaro della prossima sostituzione leva il coltello sacrificale sopra la testa della figlia e della bestia Le altre due figure a sinistra dellrsquoaltare possono essere intese in coerenza con lrsquoepilogo dellrsquoIfigenia in Aulide di Euripide come Clitennestra ed Achille bencheacute prive di attributi specifici che le caratterizzino in misura sufficiente
Eliano (Historia animalium VII 39) ci ha trasmesso un frammento che provie-ne probabilmente dalla chiusa autentica in cui Artemide appariva ex machina annunciando di aver salvato Ifigenia sostituendola con una cerva Lrsquoesodo che possediamo tramite la tradizione manoscritta egrave invece il racconto fatto a Cli-tennestra da un messo del prodigio avvenuto durante il sacrificio un racconto che sembra costituito dalla conglutinazione fra un brano composto per una piugrave recente rappresentazione e una coda ancora piugrave tarda forse addirittura di epoca bizantina
Unrsquoaltra chiusa problematica
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
448 EURIPIDE
Euri
pide
448448 EE
Aristotele nella Poetica (XV 1454a31-33) definiva lrsquoIfigenia di questo dram-ma un modello di laquoincoerenzaraquo in quanto laquola figura che supplica non assomi-glia in nulla a quella delle scene successiveraquo (τοῦ δὲ ἀνωμάλου [sc ἐστὶν παράδειγμα] ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἰκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ) E in effetti il cambiamento egrave tanto piugrave sconcertante se consideriamo che fra il momento del lamento e della supplica e quello della decisione di sacri-ficarsi per la Grecia intercorre solo la breve scena fra Clitennestra e Achille (che lrsquoesercito ha minacciato di lapidazione) Drsquoaltra parte non assistiamo da parte di Ifigenia a un vero cambiamento di decisione non a caso ella dice al v 1375 laquoho deciso (μοι δέδοκται) di morireraquo senza evidenziare alcuna modificazione ri-spetto a una precedente risoluzione Ella ha ldquodecisordquo dopo lo sfogo appassionato della monodia e la sua decisione anche se in termini oggettivi si prospetta come una radicale modificazione delle sue intenzioni dal punto di vista soggettivo si articola piuttosto come presa di coscienza per la prima volta della situazione reale e dellrsquounica risposta che essa consente (vv 1368-1401)
Μῆτερ εἰσακούσατετῶν ἐμῶν λόγωνmiddot μάτην γάρ σrsquo εἰσορῶ θυμουμένηνσῷ πόσειmiddot τὰ δrsquo ἀδύναθrsquo ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥᾴδιονΤὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίαςmiddotἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθrsquo ὁρᾶν χρή μὴ διαβληθῇ στρατῷκαὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃΟἷα δrsquo εἰσῆλθέν μrsquo ἄκουσον μῆτερ ἐννοουμένηνmiddotκατθανεῖν μέν μοι δέδοκταιmiddot τοῦτο δrsquo αὐτὸ βούλομαιεὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γrsquo ἐκποδὼν τὸ δυσγενέςΔεῦρο δὴ σκέψαι μεθrsquo ἡμῶν μῆτερ ὡς καλῶς λέγωmiddotεἰς ἔμrsquo Ἑλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπεικἀν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαὶτάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροιμηκέθrsquo ἁρπάζειν ἐᾶν τούσδ᾽ ὀλβίας ἐξ Ἑλλάδοςτὸν Ἑλένης τείσαντας ὄλεθρον ἣν ἀνήρπασεν ΠάριςΤαῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι καί μου κλέοςἙλλάδrsquo ὡς ἠλευθέρωσα μακάριον γενήσεται
Lo sconcertante cambio di posizione
di Ifi genia
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1370
1375
1380
Madre Ascoltatemi Vedo che ti adiri invano contro il tuo sposo ma non egrave facile resistere allrsquoinevitabile Sigrave egrave doveroso ringraziare lo straniero [cioegrave Achille] per la sua devozione ma devi pure preoccuparti che lui non sia messo sotto accusa dalle truppe col risultato che noi non ne ricaviamo alcun vantaggio e lui ne ab-bia un danno Ascolta piuttosto madre mia quello che riflettendo mi egrave avve-nuto di pensare Ho deciso di morire e di andare incontro nobilmente a questa fine allontanando da me ogni ombra di viltagrave Coraggio madre mia considera insieme a me quanto ho ragione Ora tutta lrsquoEllade immensa volge gli occhi a me e da me dipende la partenza della flotta e la rovina dei Frigi e che mai piugrave i barbari possano rapire dallrsquoEllade felice le donne a venire una volta che abbia-no pagato caro lrsquooltraggio di Elena che fu rapita da Paride Tutto ciograve io salverograve con la mia morte e saragrave benedetta la mia gloria di liberatrice dellrsquoEllade Ecco
IFIGENIA
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
449
Euri
pide
449449I DRAMMI SUPERSTITI
Καὶ γὰρ οὐδέ τοί lsaquoτιrsaquo λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεώνmiddotπᾶσι γάρ μrsquo Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες οὐχὶ σοὶ μόνῃἈλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφαργμένοι μυρίοι δrsquo ἐρέτμrsquo ἔχοντες πατρίδος ἠδικημένηςδρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ Ἑλλάδος θανεῖνἡ δrsquo ἐμὴ ψυχὴ μίrsquo οὖσα πάντα κωλύσει τάδεΤί τὸ δίκαιον τοῦτό γrsquo Ἆρrsquo ἔχοιμ᾽ ἂν ἀντειπεῖν ἔποςΚἀπrsquo ἐκεῖνrsquo ἔλθωμεν Οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖνπᾶσιν Ἀργείοις γυναικὸς εἵνεκrsquo οὐδὲ κατθανεῖνΕἷς γrsquo ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάοςΕἰ δrsquo ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖνἐμποδὼν γενήσομαι rsquoγὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷἈλλrsquo ἀμήχανονmiddot δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι
1385
1390
1395
percheacute non devo essere troppo attaccata alla vita Tu mi hai partorito per il bene di tutti gli Elleni non di te soltanto Guarda Migliaia di soldati in armi migliaia di marinai pronti a vogare ardono dal desiderio di affrontare i nemici e di mo-rire per lrsquoEllade E la vita la mia unica vita impediragrave tutto questo Con quale diritto Che cosa potrei contrapporre Veniamo a un altro punto [Indica Achille] Lui non deve mettersi in contrasto con tutti gli Argivi non deve morire a causa di una donna Un uomo solo merita di vedere la luce del sole piugrave che migliaia di donne E se Artemide vuole prendersi il mio corpo io che sono mortale resisterograve a una dea No non egrave possibile Io offro il mio corpo allrsquoEllade Sacrificatelo
Analisi del testoSi tratta in parte del recupero da parte del vecchio Euripide dellrsquoantico modello di personaggio costruito sulla giustapposi-zione tra effusione lirica e lucida riflessione intellettuale anche se indubbiamente Ifigenia egrave ben lungi dal possedere lo spessore ideologico di Medea o di Fedra e giagrave nellrsquoEcuba Polissena che alla notizia di dover essere immolata sulla tomba di Achille si era abbandonata a un vibrante lamento lirico (vv 197-210) riflet-teva poi pacatamente nella rhesis in trimetri dei vv 342-378 sullrsquoopportunitagrave di morire pur di non finire schiava e disonorata e infine come viene riferito dallrsquoaraldo Taltibio offriva corag-giosamente il proprio collo al coltello sacrificale un parallelismo fra le due situazioni che giunge allrsquoautocitazione letterale Ecuba 549 = Ifigenia in Aulide 1560 παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως laquooffrirograve coraggiosamente il colloraquoNon riconosciamo dunque nella ldquodecisionerdquo di Ifigenia il pas-saggio da un orientamento mentale a un altro non vediamo lrsquoattuarsi di un mutamento decisionale ma piugrave limitatamente ndash sulla linea di un motivo che si incontra anche in Ifigenia fra i Tauri 468 s ndash osserviamo la metamorfosi di chi si lamenta e recalcitra in vittima pacificata e consenzienteLrsquoldquoanomaliardquo di carattere di cui parlava Aristotele era stata piut-tosto rappresentata da Euripide nella fase iniziale del dramma attraverso i bruschi cambiamenti decisionali della coppia di
Atridi entrambi marcati da una tale fragilitagrave psichica da vole-re e disvolere opposte alternative in un gioco delle parti che il testo ironicamente evidenzia sia attraverso esplicite sotto-lineature (cfr ad esempio v 480 laquoAdesso mi trovo al punto dove sei turaquo) sia col ricorso a termini con prefisso μετα- (cfr vv 343 μεταβαλών 346 μεθιστάναι 388 μετετέθην 500 μεταβολάς 502 μετέπεσον)Ciograve non toglie che lrsquoautosacrificio della figlia di Agamennone suoni pur avviandosi sul tono fermo di un pacato raziocinare in buona misura irrazionale e anche Achille pur commosso di am-mirazione di fronte a un gesto che oltretutto lo toglie dai guai non potragrave esimersi dal metterne in evidenza il carattere dissen-nato lrsquoἀφροσύνη (v 1430) Senoncheacute era certo intenzione del poeta non tanto di rendere del tutto convincente la decisione della giovane quanto di lasciarle un margine di esaltazione in-dispensabile percheacute non si riscattasse il quadro di degradazione dei valori eroici offerto da entrambi gli Atridi nelle fasi prece-denti della tragedia Cosigrave il dramma veniva a sfociare in un ldquolieto finerdquo favoloso e improbabile in un gioco illusionistico ndash rimarcato dalla sosti-tuzione di Ifigenia con una cerva ndash che doveva sottolineare nei modi di una distanziata ironia che la chiusa spuria lascia solo indovinare lrsquoimpossibilitagrave di qualsiasi autentica conclusione
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
450 EURIPIDE
Euri
pide
450450 EE
Espugnate Troia Questo sacrificio egrave un ricordo di me che vivragrave nel tempo ecco i miei figli le mie nozze la mia fama Egrave giusto madre mia che gli Elleni dominino sui barbari non i barbari sugli Elleni quelli sono schiavi questi sono uomini liberi
Baccanti
Nelle Baccanti (Βάκχαι) Euripide ndash come informa lrsquoargumentum ndash dovette avere come punto di riferimento il Penteo di Eschilo (ma egrave probabile anche
la ripresa di spunti desunti da una trilogia di Eschilo la Licurgia anchrsquoessa de-dicata allrsquoopposizione incontrata dal culto dionisiaco)Argomento del dramma egrave il rifiuto da parte di Penteo sovrano di Tebe di acco-gliere i riti in onore di Dioniso Il titolo deriva dalle giovani donne che compon-gono il coro baccanti venute dalla Lidia al seguito di un personaggio che altri non egrave che Dioniso in sembianze umane
Il dio rivela nel prologo di essere venuto a Tebe patria di sua madre Semele oltre che per introdurvi il culto bacchico per punire le sorelle di lei fra le quali Agave (madre
di Penteo) di aver dubitato della sua origine divina per questo ha infu-so in loro e nelle altre donne tebane un invasamento che le ha indotte a lasciare le case e a correre verso il Citerone Dopo una scena in cui le ragioni del nuovo culto sono difese contro Penteo da suo nonno Cadmo e dallrsquoindovino Tiresia il re fa chiudere in carcere lo straniero sotto le cui sembianze si cela Dioniso Questi perograve si libera dalle catene provocando un terremoto che scuote il palazzo e riesce a convincere Penteo ndash piugrave che mai deciso a ricondurre allrsquoordine le nuove baccanti tebane dopo aver ascoltato da un messo un resoconto sulle loro azioni ndash a recarsi travestito da donna sul CiteroneCosigrave Penteo segue Dioniso sul Citerone verso lrsquoanfratto dove le menadi sono raccolte ma lagrave come apprendiamo dal racconto del messo viene abbandonato dal dio alla furia delle donne invasate che lo ldquovedonordquo come un leone Ed egrave proprio sua madre Agave che nellrsquoesaltazione con-ficca la testa del figlio su un tirso e mostra alle compagne la macabra predaNella parte finale della tragedia che ci egrave pervenuta lacunosa compare Agave ancora in preda a uno stato di allucinazione reggendo sul tirso
Il rifi uto del culto di Dioniso
tram
a
Θύετrsquo ἐκπορθεῖτε Τροίανmiddot ταῦτα γὰρ μνημεῖά μουδιὰ μακροῦ καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξrsquo ἐμήΒαρβάρων δrsquo Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός ἀλλrsquo οὐ βαρβάρουςμῆτερ Ἑλλήνωνmiddot τὸ μὲν γὰρ δοῦλον οἱ δrsquo ἐλεύθεροι
1400
Unrsquoevidente prova della diffusione del culto dionisiaco egrave il soggetto di questa Menade danzante copia romana di un originale greco di etagrave classica (fine V secolo aC) Madrid Museo del Prado
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
451
Euri
pide
451451I DRAMMI SUPERSTITI
la testa del figlio il suo progressivo riprendere coscienza di fronte alla rivelazione della veritagrave a cui la guida pazientemente il padre Cadmo riduce la donna a uno stato di estrema disperazione
Perduta egrave una scena attestata da Apsine di Gadara (un retore del III secolo dC) in cui la madre ritornata in seacute ricomponeva i resti di Penteo fatti recupe-rare da Cadmo esprimendo il suo dolore con un lamento del cui testo qualcosa egrave ricostruibile sulla base di un centone euripideo il Christus Patiens
Infine appare Dioniso stesso che condanna Agave e le sorelle allrsquoesilio e annuncia a Cadmo che saragrave trasformato in drago e sposeragrave Armonia ma la tragedia si chiude sulle accuse al dio di eccessiva durezza e di comportamento troppo simile a quello di un mortale e sui lamenti di Agave e Cadmo che abbandonano la cittagrave
Tradizionale nella critica egrave la controversia sullrsquoeventuale atteggiamento di Euri-pide nei confronti del misticismo bacchico contro la tesi della palinodia dellrsquoan-tico razionalista si egrave puntato il dito sulla conclusione del dramma non privo di censure contro la crudeltagrave di Dioniso si veda in particolare il v 1348 pronun-ciato da Cadmo ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς laquoGli degravei non devono farsi simili ai mortali nellrsquoiraraquo
Ma ciograve che piugrave conta egrave lrsquoindividuazione del complesso intreccio di motivi che attraversa lrsquoopera Crsquoegrave innanzi tutto un vivo interesse per
i fenomeni mistici e irrazionali che corrisponde a una voga diffusasi in Atene negli ultimi de-
cenni del V secolo aC in concomitanza con lo sbocco fallimentare della guerra
del Peloponneso I soggetti dionisiaci risultano particolarmente frequen-
ti in questo periodo anche nellrsquoambito della pittura va-scolare mentre nello stesso
Euripide spunti bacchici af-fiorano non di rado nei drammi
piugrave tardi (cfr ad es Elena 1358 ss Fe-nicie 784 ss) Un interesse anzi una par-
tecipazione che allrsquointerno delle Baccanti trova espressione nella parodo tutta intessuta di
moduli cultuali e nei racconti dei messaggeri (vv 677-774 e 1043-1152) Drsquoaltra parte lo stesso dionisismo non egrave visto in chiave esclusivamente irrazionalistica Tiresia in particolare introduce quella equazione fra Dioniso e il vino (cfr vv 284 s) che sembra riecheggiare le teorie di Prodico (84 B 5 D-K) e in ogni caso si pone su una linea argomentativa di tipo squisitamente intellettualistico
Per altro verso la concezione del dionisismo si allarga nel corso della tragedia in quanto Dioniso egrave interpretato non solo come il dio dellrsquoestasi e del delirio ma an-che come il nume tutelare di una tranquillitagrave edonistica fondata sul saper vivere
Euripide e il culto di Dioniso
Il ripiegamento verso una religiositagrave
mistica
La serenitagrave attraverso il dionisismohellip
La ldquoMorte di Penteordquo vaso attico a figure rosse di Duride Su questo lato sono rappresentate alcune donne tebane intente a dilaniare il re mentre dallrsquoaltra (non visibile) Dioniso seduto beve vino insieme a un satiro
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
452 EURIPIDE
Euri
pide
452452 EE
serenamente giorno dopo giorno (cfr vv 416 ss 902 ss 1006 ss) accettando i valori tradizionali senza valicare i limiti della condizione umana conforme a un quadro di pensiero caratteristico della cultura arcaica
Di fronte a una tale convergenza fra misticismo ed etica tradizionale lrsquointransi-genza di Penteo viene a prospettarsi come un atto di ὕβρις che attira la punizione del dio (cfr vv 537-555 997 ss) ed egrave proprio Penteo a cui il coro attribuisce un atteggiamento ldquoirrazionalerdquo congiunto con una sottile quanto improduttiva laquosapienzaraquo (σοφόν) (v 1005 cfr vv 395 s)Nella sezione antologica egrave proposta ampia scelta della tragedia con testo com-mentato e ampi passi in traduzione italiana
Ciclope
Il Ciclope (Κύκλωψ) egrave lrsquounico dramma satiresco che si sia conservato inte- gro Lrsquoargomento egrave tratto dallrsquoepisodio di Odisseo e Polifemo del IX canto
dellrsquoOdissea con lrsquoinserimento del coro dei satiri guidati dal loro padre Sileno La cronologia egrave molto incerta ma si propende in genere ad assegnare lrsquoopera alla tarda produzione euripidea
Presso i satiri che sono tenuti schiavi da Polifemo giunge Odisseo affamato e grazie al vino che porta con seacute si conquista lrsquoamicizia del vecchio Sileno che in cambio di essa offre allrsquoospite ovini e formaggi proprietagrave del Ciclope Quando questi compare Sileno cerca di di-scolparsi accusando del furto Odisseo e i suoi compagni Per salvarsi dal mostro intenzionato a divorarli questi sono costretti ad accecarlo lrsquooperazione riesce grazie alla cooperazione dei satiri desiderosi di riconquistare la libertagrave e allrsquoubria-catura a cui soggiace il Ciclope grazie al vino offertogli dal Laerziade Cosigrave i Greci riprendono il mare incalzati dalle vane minacce di Polifemo
Il dramma non manca di spunti comici felici e di invenzioni buffonesche (ad es lo sconclusionato affaccendarsi dei satiri per accecare il gigante) ma piugrave che sul comico Euripide punta sullrsquoarguzia e sul paradosso caratteristico in questa direzione il dialogo fra Odisseo che elogia enfaticamente i valori della civiltagrave e il Ciclope che replica proponendo una visione edonistica dellrsquoesistenza che in chiave seria percorre tutta lrsquoultima produzione euripidea (e alle Baccanti in par-ticolare ci riporta lrsquoequazione fra Dioniso e il vino che impreziosisce di un gioco intellettualistico la sticomitia dei vv 519 ss)
Reso
Il Reso (Ῥῆσος) dove si riprendono le vicende narrate nel canto X dellrsquoIliade egrave una tragedia che ci egrave stata tramandata insieme con quelle di Euripide ma la
cui attribuzione al poeta era considerata dubbia giagrave nellrsquoantichitagrave come rivela
hellipe la hybris come eccesso
di intransigenza
T00
tram
a
Il contrasto tra civiltagrave urbana
e vita serena
Una tragedia spuria
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
453
Euri
pide
453453UN TEATRO DI RICERCA
il primo argumentum premesso allrsquoopera oggi nonostante qualche tentativo in senso contrario egrave per lo piugrave ritenuta spuria
Ettore che trascorre la notte sorvegliando da lontano lrsquoaccampamento dei Greci viene persuaso da Enea a non attaccare subito ma a cercare di apprendere quali siano le reali intenzioni dei nemici Cosigrave Ettore invia Dolone che si era offerto per questo compito Preceduto dallrsquoannuncio di un pastore arriva Reso re di Tracia che guida il suo eser-cito in aiuto ai Troiani rimproverato da Ettore per il suo ritardo Reso si giustifica dichiarando di essere stato fermato da una guerra improvvisa mossagli dagli Sciti ed esprime fieri propositi di battaglia Quando lrsquoalba egrave prossima i due si ritirano per riposarsi ma ecco che entrano nel cam-po troiano Odisseo e Diomede (imbattutisi in Dolone prima di ucciderlo si sono fatti rivelare la parola drsquoordine) Guidati da Atena che interviene direttamente sulla scena aggrediscono Reso addormentato lo uccidono e riescono a fuggire portandosi dietro i suoi cavalli Cosigrave quando lrsquoauriga di Reso viene ad annunciare la morte del suo signore assassinato da mani ignote egrave lo stesso Ettore a essere accusato del delitto a discolparlo interviene perograve ex machina la Musa madre di Reso discesa dalle sue sedi divine a prelevare il corpo del figlio
un teatro di ricerca
idee ideologie pensiero
Egrave impossibile irrigidire lrsquoopera di Euripide in uno schema o in una formula e ogni tentativo della critica di costruire una caratterizzazione unitaria e omo-
genea della sua produzione ha condotto a immagini riduttive o false Neacute drsquoaltra parte Euripide egrave semplicisticamente il poeta delle dissonanze e delle contraddi-zioni occorre piuttosto cogliere nellrsquoarco della sua produzione costanti e varia-zioni anche in rapporto alle profonde trasformazioni subite dalla societagrave e dalla cultura ateniesi nella seconda metagrave del V secolo aC
Piugrave specificamente lrsquoopera di Euripide tende a rispecchiare in un primo tempo la cultura periclea in quanto concezione della polis basata sulla conciliazione inter-classista e su quel lucido razionalismo che caratterizza personaggi come Alcesti Medea Fedra
La dissoluzione di questo modello in concomitanza con lo sviluppo della guerra peloponnesiaca pone successivamente Euripide di fronte a una radicalizzazione dei contrasti tra forze democratiche e oligarchiche ciograve lo induce a quella teoriz-zazione della classe media come la sola in grado di salvare le sorti dello stato che viene formulata da Teseo nelle Supplici e a cui il poeta resteragrave sostanzialmente fedele fino ai drammi piugrave tardi Di qui da un lato la sfiducia nei confronti del
tram
a
Una produzione in progress
Gli originari ideali periclei
La classe media ancora di salvataggio
dellrsquoAtene in crisi
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
454 EURIPIDE
Euri
pide
454454 EE
demos e dei demagoghi dallrsquoaltro lrsquoesecrazione della tirannide Ma in quanto proposta incapace di far presa su una realtagrave politica e sociale refrattaria a tentativi di mediazione o di compromesso la teoria della classe media favorisce il gradua-le disimpegno politico di Euripide compensato dalla ricerca di valori privati (la rivalutazione in chiave edonistica degli affetti familiari) e dallrsquoevasione nel piugrave raffinato lirismo
Nellrsquoantichitagrave Euripide fu definito laquofilosofo della scenaraquo e Euripide poeta dellrsquoilluminismo greco suona il titolo di un saggio del 1901 di W Nestle che muovendo soprattutto dallrsquoesame dei frammenti cercava di ricostruire una uni-taria concezione filosofica che sarebbe sottesa a tutta la produzione euripidea Era quella di Nestle una pretesa decisamente eccessiva ma ciograve non toglie che il teatro euripideo ci appaia effettivamente ricco di dibattiti e di prese di posizione sui problemi del tempo spesso riecheggiando formulazioni e spunti di singoli pensatori
Si egrave sottolineato in special modo il gusto per i laquodiscorsi dupliciraquo tipici della pratica sofistica e in particolare delle Antilogie di Protagora ed evidente egrave lrsquoin-contro con Gorgia quando Ecuba nel dramma omonimo (vv 814 ss) definisce la persuasione come unica sovrana degli uomini
Senoncheacute la concezione del logos che compare ripetutamente in Euripide si muo-ve piuttosto nel senso di un ribaltamento delle dottrine protagoree Protagora in-segnava infatti a rendere laquopiugrave forteraquo (κρείττω) il discorso laquopiugrave deboleraquo (ἥττω) conforme a unrsquoimpostazione in base alla quale non esisterebbe un criterio per discriminare il vero dal falso dal momento che tutte le opinioni sono egualmente vere Euripide invece sottolinea lrsquoopposizione tra le cose e le parole fra i reali rapporti di forza e il loro mascheramento dialettico (cfr fr 439 N2 [dal primo Ippolito] Medea 465 ss Andromaca 186-191 Ippolito 490 ss Supplici 486 ss) allrsquointerno di una tale opposizione la parola risulta svalutata in quanto insuf-ficiente a modificare le situazioni oggettive
Analogo distacco si avverte fra Euripide e quel filone sofistico che valorizzava la natura (φύσις) contro la convenzione (νόμος) e le cui prospettive appaiono riecheggiate dal poeta (cfr frr 52 e 168 N 2) in relazione al problema della no-biltagrave di nascita ma bencheacute affiori in lui una decisa rivalutazione degli schiavi e piugrave in generale delle classi subalterne e almeno in certe tragedie come lrsquoEcuba e le Troiane venga prospettato un senso di universale solidarietagrave fra gli uomini nondimeno le strutture sociali esistenti non sembrano messe in discussione e non si nega alla radice la legittimitagrave della differenza fra liberi e schiavi e quanto allrsquoantitesi fra Greci e barbari assistiamo anzi negli ultimi anni della produzione euripidea a unrsquoinvoluzione che culmina nellrsquoaffermazione (Ifigenia in Aulide 1400 s) secondo cui laquoegrave logico che i Greci dominino sui barbari i barbari sono servi i Greci sono liberiraquo
Il laquofi losofo della scenaraquo
Il logos per quanto sovranohellip
hellipnon riesce a coincidere con la realtagrave
Il sostanziale rispetto della convenzione
(νόμος)
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
455
Euri
pide
455455UN TEATRO DI RICERCA
Oscillazioni non dissimili si manifestano nellrsquoatteggiamento euripideo di fronte alla scienza ionica della natura e in particolare alla filosofia di Anas-sagora Quasi certamente ldquoanassagoreordquo egrave lrsquoelogio del saggio indagatore dellrsquolaquoordi-ne che non invecchiaraquo della natura che compare nel fr 910 N2 (probabil-mente dallrsquoAntiope) e spunti della dottrina materialistica di Anassagora sono evidenti nel fr 839 N 2 (dal Crisippo) dove si dice (vv 12 ss) che laquonulla di ciograve che nasce muore ma ogni cosa lrsquouna dallrsquoaltra dividendosi nuova forma rivelaraquo (e cfr anche i frr 783 N 2 sul sole dal Fetonte e il fr 228 N 2 sulle piene del Nilo dallrsquoArchelao) Drsquoaltra parte anche lrsquoamore della ricerca egrave sentito come inadeguato e se giagrave nellrsquoultimo stasimo dellrsquoAlcesti (vv 962 ss) le laquomoltissime dottrineraquo incon-trano un limite invalicabile nella forza della Necessitagrave egrave soprattutto nella fa-se tarda della sua produzione che Euripide mostra una rivalutazione del senso comune e delle tradizioni fino al motto delle Baccanti (v 395) τὸ σοφόν οὐ σοφία laquoil σοφόν [la conoscenza sottile e sofisticata] non egrave σοφία [vera saggezza]raquo
Sbocco naturale della formazione razionalistica di Euripide era anche la cri-tica degli degravei e la ricerca di una diversa immagine del divino Sulla linea di Senofane Eracle nega che gli degravei possano compiere azioni immorali (Eracle 1345 s cfr Ifigenia fra i Tauri 391) e ancor piugrave radi-calmente si asserisce in un frammento dal Bellerofonte (fr 292 N 2) che se gli degravei compiono alcuncheacute di biasimevole allora non sono degravei (e cfr Elettra 583 s laquoNon si dovragrave piugrave credere agli degravei se lrsquoingiustizia saragrave piugrave forte del giustoraquo) Questa ricerca di una nuova prospettiva religiosa puograve allora sfociare in una forma di agnosticismo in cui lrsquoarcaica formula liturgica ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ (laquochiunque tu siaraquo) viene desacralizzata come espressione di autentico dub-bio (cfr Eracle 1263 Ζεύς ὅστις ὁ Ζεύς Oreste 418 ὅτι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοί Baccanti 894 ὅτι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον) e tuttavia anche nella grande preghiera di Ecuba (Troiane 884-888) che riecheggia motivi anassa-gorei (Zeus come Νοῦς) lo spunto scettico viene da ultimo fideisticamente corretto
Ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν ὅστις ποτrsquo εἶ σύ δυστόπαστος εἰδέναιΖεύς εἴτrsquo ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶνπροσηυξάμην σεmiddot πάντα γὰρ διrsquo ἀψόφουβαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτrsquo ἄγεις
O sostegno della terra e che sulla terra hai sede chiunque tu sia arduo da conoscereZeus che tu sia la necessitagrave della natura o la mente dei mortalia te io rivolgo la mia preghiera per un silenzioso camminomuovendo tu guidi tutte le cose mortali secondo giustizia
Dalla laquofi losofi araquo al buon senso
Analisi e critica della religione
tradizionale
885
885
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
456 EURIPIDE
Euri
pide
456456 EE
Analoga dinamica concettuale in un passo dellrsquoElena che si ispira in modo aper-tamente dichiarato a uno scetticismo di tipo protagoreo(1137-1143)
Ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσοντίς φησrsquo ἐρευνάσας βροτῶν μακρότατον πέρας ηὗρεν ὃς τὰ θεῶν ἐσορᾷδεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀμφιλόγοιςΠηδῶντrsquo ἀνελπίστοις τύχαις
Che cosa sia dio o non-dio o ciograve che egrave intermediochi dei mortali puograve dire dopo aver indagatofino al limite estremo drsquoaverlo scopertoquando vede le manifestazioni degli degravei di qua e poi di lagrave balzaree di nuovo allrsquoinverso con contrastantiimprevedibili vicissitudini
Subito dopo la riflessione del coro trapassa attraverso la constatazione del gioco imprevedibile della tyche e lrsquoimplicito riconoscimento della debolezza umana in un recupero della fede tradizionale la strofe si chiude infatti sulla contrap-posizione fra lrsquoincertezza delle umane sorti e la veridica laquoparola degli degraveiraquo (vv 1148-1150)
οὐδrsquo ἔχωτί τὸ σαφὲς ἔτι ποτrsquo ἐν βροτοῖςτὸ τῶν θεῶν ἔπος ἀλαθὲς ηὗρον
e non so piugrave che cosa sia sicuro fra i mortali ma riconosco veridica la parola degli degravei
Anche nellrsquoambito religioso si prospetta cosigrave una parabola lungo la quale le po-sizioni razionalistiche subiscono uno svuotamento che permette il recupero delle tradizioni e della fede comuni (i νομισθέντα di Baccanti 71)
Lrsquoinnovatore della forma tragica
La drammaturgia euripidea contempla una serie di ristrutturazioni delle parti tradizionali della tragedia
Il prologo egrave costituito molto spesso da un discorso orientativo generalmente re-citato dal protagonista o da una divinitagrave che informa sugli antefatti del dramma e sulle innovazioni introdotte dal poeta nei confronti della tradizione mitica Il tono distaccato di molte fra queste rheseis rispondeva allrsquoesigenza di concentrare lrsquoattenzione dello spettatore sulle reazioni dei personaggi alle situazioni piuttosto che sugli eventi in seacute Egrave incerto se si debba vedere in questa forma drsquoesordio un re-cupero dellrsquoantico prologo espositivo di Tespi e quindi un consapevole arcaismo
1140
1140
Recupero della tradizionehellip
hellipe delle fedi comuni
Prologo
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
457
Euri
pide
457457UN TEATRO DI RICERCA
Nelle parti dialogate particolare risalto assume lrsquolaquoagoneraquo con la nitida con-trapposizione dei discorsi antagonistici nei quali i personaggi in contesa dan-no fondo a ogni piugrave sofisticata risorsa dialettica per sostenere le proprie tesi Sempre piugrave marcata appare col tempo la ripartizione dei discorsi in sezioni ben definite e in seacute concluse talora coincidenti con le nascenti partizioni retori-che Per i dialoghi piugrave serrati soccorre la sticomitia spesso vivace o violenta ma funzionale anche ad altri obiettivi (espositivi parenetici ecc) A partire dallrsquoEracle (vv 855-873) appare frequente lrsquoimpiego del tetrametro trocaico catalettico e dellrsquo ἀντιλαβή (ripartizione dello stesso verso fra due o piugrave inter-locutori)
Monologhi in senso stretto (cioegrave a scena vuota) compaiono solo nel prologo ma situazioni sostanzialmente monologiche con un personaggio che pur al cospetto di altri si rivolge in realtagrave a se stesso sono largamente diffuse soprattutto per lrsquoespressione di forti tensioni emotive caratteristiche in queste parti le preghiere e le apostrofi a personaggi o entitagrave assenti
Evidente ascendenza epica ndash sia per la tecnica narrativa sia per alcune peculiaritagrave linguistiche (ad es lrsquouso ridotto dellrsquoarticolo) ndash rivelano le narrazioni dei mes-saggeri spesso ampie e ricercate e caratterizzate da una realistica precisione di dettagli
Simmetrico rispetto al prologo espositivo e stilisticamente affine egrave lrsquoimpiego del deus ex machina nellrsquoepilogo con la prevalente funzione di informare sulla futura condizione dei personaggi e di correlare la vicenda rappresentata a tradi-zioni e culti noti agli spettatori ma talora come nella chiusa dellrsquoOreste anche con quella di risolvere una situazione altrimenti bloccata
Nellrsquoambito delle parti liriche spicca innanzi tutto a partire dal 420 circa lrsquoin-serzione di intermezzi corali di carattere narrativo definiti da W Kranz con riferimento al Nuovo Ditirambo attico laquostasimi ditirambiciraquo (cfr Elettra 432 ss e 699 ss Troiane 511 ss Ifigenia fra i Tauri 1234 ss Elena 1301 ss Fenicie 638 ss 1019 ss Ifigenia in Aulide 1036 ss) brani accomunati dalla successione di quadri in seacute conclusi da un gusto calligrafico per i particolari dalla ricerca del chiaroscuro suggestivo
Accanto a questi brani si pongono quali manifestazioni della nuova lirica eu-ripidea le monodie (dallrsquoelegia di Andromaca nel dramma omonimo allrsquoaria anapestica di Ecuba a principio delle Troiane dalle melodie patetiche di Creu-sa nello Ione e di Giocasta nelle Fenicie alla bizzarra esibizione dello schiavo frigio nellrsquoOreste) e i duetti lirici (ἀμοιβαῖα) fra cui assumono speciale rile-vanza ndash come giagrave abbiamo osservato per il dialogo fra la protagonista e Menelao nellrsquoElena ndash quelli che accompagnano le scene di riconoscimento (cfr Ifigenia fra i Tauri 827-899 Elena 625-697 Ione 1439-1509)
Lrsquoagone
Monologhi o discorsi a se stesso
Narrazioni dei messaggeri
Lrsquoepilogo con il deus ex machina
Intermezzi corali laquoditirambiciraquo
Monodie e duetti lirici
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche
458 EURIPIDE
Euri
pide
458458 EE
LLLLLeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHeeTTure CriTiCHe La concezione dellrsquouomo
Protagonista del teatro euripideo egrave lrsquouomo con la sua piena indivi-dualitagrave il suo mondo psichico i suoi sentimenti un uomo assolu-tamente laico disposto a mettere in discussione tutto e tutti dagli degravei alle convenzioni alla morale alla giustizia Questo antropome-trismo di fondo egrave rimarcato nei vari drammi dalla costante presen-za dellrsquoagone verbale che testimonia il dominio del relativismo e dimostra come non vi sia nulla che non possa essere oppugnabile modificabile o addirittura reversibile nel suo contrario un eserci-zio intellettuale-sottile e raffinato che stimolava il pubblico ndash in gran parte composto da persone che non potevano permettersi le costose lezioni dei Sofisti ndash a esaminare di ogni questione il pro e il contro e a decidere di conseguenza Ne deriva che essendo lrsquoago-ne verbale il luogo deputato allrsquoesame concettuale della vicenda in Euripide ancor piugrave che negli altri tragici vale la considerazione espressa dallrsquoAgamennone di Eschilo sulla difficoltagrave di giudicare chi ha ragione e chi no lrsquoimportante egrave il dibattito Un tipo di tea-tro quindi alternativo alla contemporanea produzione sofoclea nel quale lrsquoasse del tragico risulta spostato in una direzione an-cor piugrave interna ai personaggi esteriormente vestiti con i costumi del tempo eroico ma guidati da norme e atteggiamenti consoni al tempo reale Nessun elemento della tradizione si sottrae alla revisione euripidea dagli oracoli di Apollo ai personaggi principali delle saghe piugrave conosciute (Elettra Oreste Eteocle Eracle Elena Ifigenia) Le premesse sia religiose sia morali da cui i precedenti
miti traevano le loro motivazioni rivelano calate nella realtagrave con-temporanea tutto il loro carattere fiabesco (le laquovane ciance dei poetiraquo in Eracle 1346) Cosigrave facendo si sfaldava perograve una buona parte della struttura tragica in altre parole una tragedia in cui il dato mitico di partenza veniva messo in discussione e i personaggi agivano non piugrave secondo norme e impulsi di valore paradigmatico bensigrave in base a sentimenti ordinari e comuni a tanta parte della gente seduta sui gradini della platea risultava qualcosa di pro-fondamente diverso dallo spettacolo lsquoritualersquo portato sulla scena da Eschilo Quando Nietzsche afferma che Euripide ha ucciso lo spirito dionisiaco decretando cosigrave anche la morte della tragedia dice in un certo senso la veritagrave dissolvere i presupposti ideologi-ci dellrsquoazione attraverso lo scardinamento del mito equivaleva a tagliare le radici stesse da cui era germogliato il dramma attico Ma Euripide egrave solo lrsquoinconsapevole esecutore di una sentenza giagrave emessa nei circoli sofistici e nelle assemblee dominate dai dema-goghi in unrsquoAtene avviata verso la disfatta politica e morale prima che militare In tal senso lrsquoopera di Euripide egrave vicinissima al teatro moderno percheacute diversamente dallo spirito originario del genere essa egrave soprattutto la rappresentazione di una tranche de vie di un frammento di esistenza non descritto sulla base di parametri ide-ologici precostituiti ma modellato sul carattere dei protagonisti [G Monaco Lrsquoattivitagrave letteraria nellrsquoantica Grecia Palumbo Paler-
mo 1997 310-11]
Lingua sintassi e metricaLa lingua euripidea si presenta come meno originale di quella eschilea e meno imprevedibile di quella di Sofocle Tra i neologismi diffusi specialmente nelle parti liriche spiccano gli aggettivi con funzione decorativa mentre nelle parti recitate si avverte una forte tendenza sia allrsquouso di termini astratti sia allrsquoim-missione entro il tessuto della dizione tragica di parole e di nessi caratteristici della lingua parlata del tempo (seppur talora impreziositi attraverso variazioni o accostamenti inediti)
La sintassi appare generalmente sorvegliata talora perfino puntigliosa nella sot-tolineatura di antitesi e parallelismi ma nelle parti liriche delle tragedie tarde si riscontra una spiccata tendenza allrsquoagglutinazione paratattica o comunque a una grande semplificazione dei nessi
La metrica delle parti recitate egrave marcata da un costante incremento nel corso del tempo delle soluzioni e sostituzioni allrsquointerno del trimetro giambico mentre nelle parti liriche si osserva una crescente polimetria con lrsquoassociazione talora virtuosistica fra ritmi disomogenei Non infrequenti le responsioni libere e altre ldquolicenzerdquo quali la soluzione trisillabica della base eolica
Una lingua meno laquotragicaraquo
La cura dei membri sintattici
Sostituzioni e soluzioni
nel recitativo e polimetria nelle
parti liriche